LA FILOSOFIA SCOLASTICA
“Non tento, o Signore, di penetrare la tua altezza perché non paragono affatto ad essa il mio intelletto, ma desidero in qualche modo di intendere la tua volontà, che il mio cuore crede ed ama. Né cerco di intendere per credere; ma credo per intendere. E anche per questo credo: che se prima non crederò, non potrò intendere” (Anselmo da Aosta, Proslogion)

INTRODUZIONE
CRONOLOGIA
La filosofia scolastica occupa un periodo molto ampio che va dalla rinascita carolingia fino al 1400 con l’ avvento dell’ Umanesimo in Italia e del Rinascimento , in seguito , nel resto dell’ Europa ; generalmente la filosofia scolastica viene suddivisa in 3 periodi ; il primo periodo é piuttosto povero ed emerge solo la figura di Scoto Eriugena , che é tuttavia circondata da una miriade di personaggi inferiori , per lo più persone colte e maestri finalizzati a dare l’ insegnamento di base , riprendendo la filosofia antica , ai cosiddetti ” rudes ” , ossia ai rozzi , che dovevano a tutti i costi resi più colti : bisognava almeno dar loro gli strumenti indispensabili per avere un minimo di cultura . Nasce così un vero e propria sistema scolastico con tanto di metodo , che tempi addietro esisteva solo in modo marginale : bisogna dissodare un’ età percorsa da barbarie quale é quella che sconvolge il mondo latino a partire dal sesto secolo ; questa prima fase va collocata tra l’ 800 e il 900 . Il secondo periodo é quello detto ” argenteo ” , in cui emergono effettivamente grandi figure : siamo nel 1000 e nel 1100 ; accanto alle grandi figure vi sono anche le grandi scuole , e la vera novità é che la cultura esce dai monasteri e dalle scuole cattedrali e capitolari , ossia quelle formate dai capitoli delle chiese . Nascono così le Università e si crea il ” cetus studiorum ” : l’ intero corpo delle arti viene notevolmente approfondito . Il 1200 é il secolo d’ oro della scolastica , in cui si raccolgono i frutti del 1000 e del 1100 ; però una volta raggiunto l’ apice é difficile mantenerlo , e così dopo lo splendido 1200 vi é un rapido tramonto , ossia il 1300 , che rappresenta la dissoluzione della filosofia medioevale : quando sembra che tutto sia già stato detto , ecco che invece nasce la seconda scolastica , che vede tra i suoi protagonisti la figura di Guglielmo di Ockham . Dopo di che vi sarà effettivamente la totale dissoluzione della filosofia medioevale , sulle cui ceneri nascerà la filosofia moderna .
CARATTERI FONDAMENTALI
Il primo carattere da evidenziare é che questa filosofia si esprime tutta nelle ” scholae ” , sebbene esse siano molto diverse tra loro : tuttavia presentano anche molte analogie ; con esse la cultura ha trovato un luogo di trasmissione , di formazione e di ricerca ; i maestri entrano come allievi , poi diventano trasmettitori e infine ricercatori . Va detto che é una cultura limitata alla scuola e a chi si reca a scuola : essa riguarda quindi un numero ristretto di persone e non sarà mai un fenomeno di massa ; ricordiamoci che il mondo medioevale é essenzialmente un mondo di analfabeti , anche se non di stupidi : Caterina da Siena , per esempio , pur essendo stata analfabeta , fu personaggio di gran carisma , consigliera di papi ; ma che cosa si insegna in queste scuole ? Il trivio e il quadrivio , le famose sette materie medioevali che Dante identifica con il castello presente nel limbo . Il trivio fornisce gli elementi fondamentali , il quadrivio si apre ad una prospettiva che comporta la riflessione filosofica . Le tre materie del trivio sono la logica , che insegna come ragionare e costruire discorsi , la dialettica , che insegna il dialogo in forma di domanda e risposta , e infine la retorica , il grado sommo del trivio , che insegna come dire le cose bene , in modo conveniente ed elegante , sulla scia dei sofisti che dicevano ” la parola può tutto ” . E’ con Boezio che torna in uso il sillogismo , usato soprattutto in una logica formale , quasi al fine di dimostrare l’ impossibile . Il quadrivio comprende invece 4 materie , che sono : la geometria , l’ aritmetica , l’ astronomia e la musica . Viene spontaneo chiedersi perchè la geometria sia prima dell’ aritmetica : prima di misurare , infatti , bisogna saper contare . Va però detto che il quadrivio veniva insegnato dopo al trivio , era un insegnamento superiore che voleva portare gli studenti al ragionamento ; gli antichi e così anche i medioevali vedevano l’ ordine e il rapporto tra varie realtà sotto forma di relazione e quindi la geometria andava insegnata prima delle altre tre , che altro non sono , in fondo , che applicazioni della geometria : nell’ aritmetica , che si propone di contare , é chiaro che tra l’ 1 e il 2 , per dire , vi sono rapporti : posso fare 1 + 2 , 1 : 2 , 1 – 2 , etc . Da qui si passa poi anche all’ algebra : a + b , a – b , etc . Discorso analogo va fatto per l’ astronomia , la scienza che studia gli astri : l’ uomo é proiettato nel mondo , il mondo a sua volta é proiettato nell’ universo , che per i medioevali era vivo , come già spiegava Platone . La musica , poi , non é altro che un insieme di rapporti numerici . Tra l’ uomo stesso e i suoi organi c’ é armonia e rapporto . Il maestro che impartiva questi insegnamenti era lo ” scholasticus ” e a lui succedeva o il ” magister philosophiae ” o il ” magister artium ” o il ” magister teologiae ” . L’ insegnamento della filosofia e quello della teologia procedeva di pari passo , e si suddivideva in 2 tipi di insegnamento : la lectio , ossia il commento al testo letto dal ” lector ” , colui che aveva raggiunto il primo grado di insegnamento , e la disputatio ossia i commentio che scaturivano dalla lettura ( lectio ) dei testi . Il secondo carattere da sottolineare é che la scolastica é una filosofia che interessa l’ Occidente , é radicata nella ” civitas cristiana ” occidentale e quindi riguarda solo una piccola parte del mondo : contemporaneamente fiorisce la cultura bizantina e slava , e soprattutto quella araba , nata intorno alla figura di Maometto . Va però detto che se la filosofia medioevale si sviluppa nella civitas cristiana , bisogna però precisare due momenti diversi : nel primo il mondo cristiano si chiude in se stesso di fronte all’ Oriente , in quanto non ha più nulla da ricevere da tal cultura ; solo la Chiesa romana ha sempre contatti con la Chiesa orientale , ma sono sempre contatti più bruschi e avversi ; il cristianesimo se la deve vedere con l’ islam della guerra santa e della conquista ; gli arabi sono padroni dell’ Africa e dell’ Arabia e tramite la Spagna insidiano il mondo occidentale ; solo con la battaglia di Poitiers del 732 il pericolo arabo verrà stornato . Proprio dopo la battaglia di Poitiers l’ Occidente comincia ad aprirsi , specie nella cultura : il Turco non fa più paura e neppure l’ Ebreo . Questo si nota nella filosofia scolastica in quanto vi é una sintesi di 3 culture : quella cristiana , quella araba e quella ebrea ; nel 1200 vi sono maestri nelle università che si appellano a queste diverse culture . Altro carattere da sottolineare é che per tutto il medioevo non si scrive mai ” adversus ” , ma ” contra ” : adversus implica l’ esclusione totale delle ragioni dell’ avversario , come a dire ” io ho la verità , tu no : non ti ascolto neanche ” . Il contra , invece , presume uno scambio di pareri e di teorie , un dialogo : tu mi dici questo , ebbene io in contrapposizione ti dico quest’ altro : é una cultura dialogica , dove si dà spazio anche a posizione divergenti dalle proprie .
LE TEORIE
Va subito detto che la filosofia cristiana scolastica , a differenza della patristica , si muove ormai su un cristianesimo consolidato , che si é già affermato ; si cerca di vedere se usando l’ armamentario della filosofia antica si può argomentare in favore del cristianesimo ; la filosofia diventa ” ancilla teologiae ” , ossia serva del cristianesimo . I temi trattati più significativi sono essenzialmente questi : rapporto fede e ragione , dimostrazione dell’ esistenza di Dio in termini razionali , disputa sugli universali aristotelici . Per quel che riguarda il rapporto fede e ragione vi sarà chi riprenderà la tesi di Agostino di assoluto non contrasto tra le due : la ragione e la fede si compensano ; Galileo sarà di questo parere : la ragione da sola non può scoprire tutte le verità , altrimenti sarebbero già state scoperte da altri grandi pensatori del passato , come Platone e Aristotele : Dante stesso sarà di questo parere e dirà : ” matto é chi spera che nostra ragione possa trascorrer la infinita via che tiene una sustanza in tre persone ” ( Purgatorio , III 34 ) . Vi saranno però anche persone che proporranno variazioni , come San Tommaso D’ Aquino , che divide le possibili verità e i possibili ambiti della ragione , individuandone 3 : 1 ) Ci sono verità che con la fede hanno ben poco a che fare , come per esempio il teorema di Pitagora , che é irrilevante per la fede : in questo ambito la ragione si muove da sola . 2 ) Vi é poi l’ ambito delle cose che possono essere spiegate sia con la fede , sia con la ragione , i cosiddetti ” PREAMBULA FIDEI ” ; un esempio é l’ esistenza di Dio , che può essere accettata per fede o dimostrata razionalmente . 3 ) Il terzo ambito é quello delle cose che vanno accettate per fede , ma che tuttavia possono essere chiarite con la ragione , come per esempio la Trinità , ossia le tre persone della divinità : esse non sono dimostrabili con la ragione , ma vanno accettate con un atto di fede , tuttavia sono chiarificabili con la filosofia , per esempio quella aristotelica . E’ interessante notare che per Tommaso nulla é inaccessibile alla ragione . Dante stesso , nell’ Inferno , ha gran rispetto per coloro che , pur non essendo vissuti in un contesto cristiano , tuttavia fecero buon uso della ragione , come Platone , Aristotele , Socrate , Democrito e altri : il castello che sorge nel limbo é un’ esaltazione stessa del logos , della ragione , una luce nel buio infernale . Vi furono anche grandi pensatori razionalisti , come per esempio Abelardo . Vi fu anche chi disse che tra ragione e fede non c’é alcun rapporto : la separazione tra fede e ragione può essere dimostrata in vari modi , ma tuttavia la cosa più interessante da notare é che nel momento in cui esse vengono separate , ciascuna é libera di procedere autonomamente per la sua strada ; tra i maggiori sostenitori di questa separazione radicale c’é Guglielmo di Ockham , che sul piano religioso sosterrà una tesi fideistica : la fede é fede e non ha nulla a che vedere con la ragione : si tratta chiaramente di una posizione molto conservatrice , tipicamente francescana : i francescani , infatti , sono portati a rifiutare la ragione ” intellettualistica ” : a loro non importa come é fatto Dio , ma come si comporta : la loro é una fede che punta solo sull’ amore per Dio . Però separando fede e ragione , così come la fede , anche la ragione resta autonoma : da un lato é un modo di vedere piuttosto retrogrado , però va detto che comporta anche elementi di modernità : la ragione diventa ” pura ” , senza avere più nulla a che fare con la fede . Non a caso si usa definire Guglielmo di Ockham ” l’ ultimo pensatore medioevale e il primo moderno ” . Altra posizione é quella di Averroè , esponente della scolastica araba : egli elabora una dottrina della doppia verità : la vera verità é quella portata dalla filosofia e dalla ragione ( che per lui era essenzialmente Aristotele ) , tuttavia anche quella della religione é utile perchè dice le cose in modo comprensibile per tutti : i migliori , tramite la filosofia , accedono alla vera verità , mentre la massa degli ignoranti accede ad una verità di secondo livello , trasmessa dalla religione . Con Averroè siamo chiaramente di fronte ad una concezione aristocratica ; la filosofia araba , ed in particolare quella di Averroè riuscì a penetrare nell’ Occidente e diede vita all’ averroismo latino , che riprende soprattutto la dottrina della doppia verità : uno dei massimi esponenti fu Sigieri di Brabante , che chiaramente dovette scontrarsi con le autorità religiose ; stranamente Dante lo colloca in Paradiso , definendolo come colui ” che sillogizzò insidiosi veri ” , ossia colui che argomentò verità pericolose per la Chiesa , però pare più logica la lettura ” invidiosi veri ” , ossia verità che lo misero in cattiva luce : altrimenti perchè mai dovrebbe essere in Paradiso uno che andò contro la Chiesa ? In effetti l’ Occidente interpreta la dottrina della doppia verità in modo ” invidioso ” per la Chiesa : si diceva ” io sono studioso di Aristotele e la ragione mi insegna che il mondo é eterno , ma da buon cristiano penso e dico che é stato creato ” : é una concezione addirittura più radicale di quella di Averroè : probabilmente questi filosofi , per non essere processati come eretici , si mascheravano con la fede , ma in realtà non credevano a una parola di quel che diceva il cristianesimo , per loro la verità era solo quella data dalla ragione , però non potevano dirlo pubblicamente , e allora fingevano di essere religiosi ; si é però scoperto che Sigieri , a lungo ritenuto il maggior sostenitore della dottrina della doppia verità , in realtà non la sostenne mai , ma gli fu attribuita dai suoi avversari , in particolare il vescovo Tempier . Un altro aspetto che va notato é che questa filosofia di derivazione averroistica e quindi di derivazione aristotelica , chiaramente , nega l’ immortalità dell’ anima , come quella del corpo : l’ uomo é un sinolo di materia ( il corpo ) e forma ( l’ anima ) e quando viene meno la materia viene meno la forma . A questo proposito va ricordata la questione del nous poietikòs aristotelico : a differenza di Alessandro di Afrodisia , che voleva il nous poietikos parte integrante del corpo umano e quindi destinato a morire , Averroè sosteneva che il nous non appartenesse al corpo umano , ma fosse un qualcosa di esterno ed eterno , che interviene ogni qual volta che l’ uomo usa il cervello : quindi Averroè ipotizza l’ immortalità non del singolo , ma del collettivo : é come se l’ uomo , pensando , godesse di una sorta di immortalità : chi più pensa , più fa subentrare il nous e di conseguenza chi più pensa più é immortale ; é una concezione aristocratica dell’ immortalità . Tornando alla scolastica cristiana , essa può essere definita , abbiamo detto , come il tentativo di difendere il cristianesimo servendosi della filosofia antica : i due principali filosofi antichi erano Platone e Aristotele ; in un primo tempo si preferì Platone , soprattutto per via di due sue dottrine : quella dell’ immortalità dell’ anima , esposta nel Fedone , e quella della creazione del mondo , esposta nel Timeo , sebbene Platone parlando della creazione effettuata dal Demiurgo non vada preso alla lettera . L’ idea di un dio ” architetto ” , quale é il Demiurgo , che ad un certo punto ordina il mondo é piuttosto vicina a quella cristiana ( sebbene Platone parli di ” plasmare ” servendosi di materia già esistente , mentre il cristianesimo parli di una creazione avvenuta dal nulla ) , soprattutto se messa a confronto con quella aristotelica dell’ eternità del mondo . Lo stesso per quel che concerne l’ anima : per Aristotele é mortale , in quanto facente parte del sinolo corpo , mentre per Platone é immortale , così come é per il cristianesimo . Però per Platone l’ anima é eterna , ossia é sempre esistita e sempre esisterà , per i cristiani é perenne , ma non eterna : Dio la crea ad un certo punto , e da allora non morirà mai , però non é che sia sempre esistita . Tuttavia in un secondo tempo penetrerà anche la filosofia aristotelica , a partire dal XII secolo , nel periodo delle crociate , quando vi saranno contatti con il mondo arabo , dove Aristotele era il filosofo più ” di moda ” . Comincerà a penetrare Aristotele soprattutto a partire dalla terza crociata , che di fatto fu una non-crociata : vi furono contatti culturali con l’ Oriente e così Aristotele potè penetrare ed affermarsi anche ad Occidente , fino ad arrivare a surclassare Platone . I due ordini più importanti nel Medioevo erano i Francescani e i Domenicani , e non a caso gli insegnanti universitari o erano francescani o erano domenicani : i Francescani tenderanno a prediligere le teorie di Platone , per via della mistica meno razionalista , mentre i Domenicani preferiranno Aristotele , per via della sua grande razionalità : i Domenicani erano più ” intellettuali ” : non a caso mentre Tommaso , che era domenicano , cercherà di dimostrare razionalmente l’ esistenza di Dio , Bonaventura , che era francescano , descriverà l’ itinerario mentale verso Dio . Non a caso i Domenicani sono i successori di Domenico , un ottimo predicatore , mentre i Francescani sono i successori di Francesco , più legato alla mistica . Servendosi delle teorie di Platone e di Aristotele , si cercherà di dimostrare in termini razionali l’ esistenza di Dio , sebbene molti fossero del parere che essa fosse indimostrabile e accettabile solo con un atto di fede : uno dei tentativi più apprezzabili e interessanti é senza dubbio quello di Anselmo da Aosta : la sua é una dimostrazione ” pura ” dell’ esistenza di Dio , che non si riallaccia alle esperienze : é una dimostrazione che parte dal puro concetto di Dio e che sembra davvero solida : Anselmo immagina un discorso con un ateo , ossia con una persona che in cuor suo nega l’ esistenza di Dio ; per negare qualcosa si deve sapere per forza che cosa sia , altrimenti non lo si può negare : per negare l’ esistenza di un drago devo pur sapere che cosa sia : c’ é differenza tra esistenza ed essenza . Quindi l’ ateo deve sapere che cosa é Dio : e che cosa é Dio ? Dio é ciò di cui nulla si può pensare di maggiore . Il drago , pur non esistendo nella realtà , ha un suo tasso di essere in quanto ente immaginario , pensato ; certo il suo tasso di essere sarà inferiore rispetto a quello di un cavallo , che esiste sia come ente pensato sia come ente reale ; immaginiamo che il drago esista : al tasso di essere che ha in quanto pensato , si aggiunge quello che ha in quanto esistente . Ora passiamo a Dio come puro concetto e ammettiamo che esista : prendiamo in esame il Dio come puramente pensato , che é quello che ha in mente l’ ateo : Dio é ciò di cui nulla si può pensare di maggiore , ma se lo si vede come esistente avrà un tasso più elevato di essere e quindi sarà maggiore : quindi rispetto all’ essere di cui nulla si può pensare di maggiore si può pensare qualcosa di maggiore : il ragionamento dell’ ateo cade in contraddizione . In fondo il ragionamento di Anselmo può così riassumersi : l’ essere perfettissimo , per essere tale , non può mancare di esistenza , altrimenti non sarebbe il più perfetto . Bonaventura dirà : ” Se Dio é Dio , non può che esistere ” . Però la dimostrazione razionale di Anselmo fu criticata da Gaunilone , che scrisse un ” Pro insipiente ” , ossia un trattato in cui difendeva l’ ateo , o , meglio , mostrava come la dimostrazione di Anselmo fosse contradditoria : egli attaccava la dimostrazione con due argomentazioni : a ) la dimostrazione dovrebbe allora valere per ogni forma di perfezione : se parliamo di un’ isola felice , perfetta , allora a rigore , secondo Gaunilone , seguendo il ragionamento di Anselmo , si dovrebbe arrivare a dire che esiste : e questo dovrebbe valere per tutti gli enti perfetti . Ma Anselmo fa notare che il suo ragionamento vale solo per l’ essere perfetto in assoluto , Dio , e non per i perfettissimi di ogni categoria : nell’ essere perfetto assoluto ci sarà la sapienza , nell’ isola perfetta non ci sarà . b ) Anche ammesso che funzioni , il ragionamento di Anselmo deve partire da un concetto corretto di Dio e solo chi ha fede può avere un corretto concetto di Dio ; il ragionamento funziona , ma solo per chi già ha la fede , per l’ ateo no . Anselmo dovrà riconoscere che Gaunilone ha ragione e dovrà ammettere che il suo ragionamento serve solo a chiarire al credente i fondamenti della sua fede : chiarisce che Dio é ” causa sui ” , ossia non é creato , ma crea , e che in lui ( e solo in lui ) l’ essenza implica l’ esistenza : ecco allora che rientra in gioco il ” credo per capire e capisco per credere ” di Agostino : la ragione da sola non potrà mai dimostrare l’ esistenza di Dio e necessita quindi della fede . Altro tentativo di dimostrare l’ esistenza di Dio in termini razionali sarà quello di Tommaso , vissuto due secoli dopo ad Anselmo , in un’ epoca in cui ormai si era affermato , a fianco del platonismo , anche l’ aristotelismo . Tommaso cercherà di dimostrare l’ esistenza di Dio tramite 5 vie , dove nessuna delle 5 é totalmente originale : infatti riprende le teorie platoniche e aristoteliche e se ne serve in termini cristiani . Due di queste vie sono platoniche e le restanti tre sono aristoteliche : 1 ) ” I GRADI ” : é la più platonica di tutte , é una delle tante con cui Platone é arrivato ad ammettere il mondo delle idee : siccome nella realtà ci sono diversi gradi di perfezione e di uguaglianza ( due libri si assomigliano di più che non un libro e una penna ) , Platone aveva immaginato l’ esistenza di un’ idea di uguaglianza : ci deve essere un grado di perfezione assoluta e Platone l’ aveva identificato nell’ Idea del Bene , Tommaso lo identifica in Dio . 2 ) ” L’ ORDINE ” che c’è nel mondo ( e che non può essere casuale ) implica l’ esistenza di un ordinatore divino , che Platone aveva identificato con il Demiurgo e Tommaso identifica con Dio . 3 ) ” IL MOTORE ” : questa é la classica dimostrazione dell’esistenza di Dio di Aristotele : dal momento che ” omne movens , ab alio movetur ” , teoricamente la ricerca di ciò che mette in moto i pianeti e tutte le realtà andrebbe avanti all’ infinito e di fatto nulla si muoverebbe : bisogna ammettere l’ esistenza di un motore immobile , che muove senza essere mosso : questo é per Tommaso Dio . 4 ) ” LE CAUSE ” : é la stessa prova del motore , ma vista sotto chiave di cause : tutto ciò che esiste é causato da qualcosa , ma non si può andare all’ infinito alla ricerca delle cause e bisogna ammettere una causa che causi senza essere causata : questa é per Tommaso Dio . 5 ) ” LA CONTINGENZA ” : contingente é una cosa che pur esistendo potrebbe benissimo non esistere : se tutto fosse contingente , nulla potrebbe esistere perchè nulla creerebbe nulla : dalla catena delle cose contingenti si deve risalire ad un ente non contingente , vale a dire necessario , ossia che ha la causa della sua esistenza in sé : Dio é ” causa sui ” , é necessario e si crea da solo . Da notare che le ultime 2 ” vie ” di Tommaso , pur se di derivazione aristotelica , Aristotele non le avrebbe accettate perchè in esse é presente l’ idea di creazione , che non é invece presente nelle prime 3 . Ben diversa sarà la posizione di Guglielmo da Ockham : per lui non si può argomentare nè l’ esistenza nè l’ essenza di Dio . Soffermiamoci ora sulla cosiddetta ” disputa sugli universali ” , ossia le idee platoniche e le forme aristoteliche : le idee erano trascendenti , ossia stavano al di fuori , avevano esistenza indipendente dalle cose empiriche , mentre invece le forme erano immanenti , ossia esistevano dentro alle cose materiali . La disputa scaturisce da un testo di Porfirio , un allievo di Plotino , che in un ” Commento alla logica di Aristotele ” dice che a riguardo della questione degli universali , se esistano o meno , e se abbiano esistenza propria o no , tratterà in seguito , ma in realtà non ne parla più . Da qui scaturisce la disputa , che altro non é che un tentativo dei medioevali di affrontare la tematica lanciata da Porfirio : le posizioni di fronte alla domanda ” gli universali esistono ? ” sono essenzialmente due ; vi é una posizione NOMINALISTA , che vuole che gli universali altro non siano che ” flatus vocis ” , soffi di voci : esistono solo come vibrazioni sonore . Vi é poi una posizione REALISTA che , sulla scia di Platone e Aristotele , ammette l’ esistenza degli universali ; tuttavia vi sono delle varianti : 1 ) Vi é chi sostiene che esistano ANTE REM , ossia prima dell’ esistenza stessa della cosa in questione , come aveva sostenuto Platone . 2 )Vi sarà chi sosterrà che esistano IN RE , nella cosa stessa , come aveva detto Aristotele . 3 ) Vi sarà chi dirà che esistono POST REM , ossia nella misura in cui esistono nella mente , come concetti : per esempio , guardando ad una folla estraggo il concetto di ” uomo ” . Queste tre diverse concezioni dell’ universale non si escludono a vicenda : l’ ordine in cui le abbiamo poste implica che se ammettiamo la prima , allora ammettiamo anche le altre due , ma non viceversa . In un certo senso viene ripreso Plotino e la sua ipostatizzazione della realtà : nel nous c’ erano le idee platoniche , nell’ anima le forme aristoteliche : questo testimonia che l’ esistenza dell’ universale ante rem e in re non contrasta ed é compatibile : la forma era allo stesso tempo trascendente e immanente . Da notare che l’ espressione “universali ante rem ” va depurata dal significato platonico vero e proprio : per i cristiani le idee esistono nella misura in cui son pensate da Dio : per Platone le idee erano autonome rispetto a Dio ( al Demiurgo ) , per i neoplatonici esistono e vengono interiorizzate e diventano l’ oggetto interno alla mente divina , per i cristiani esistono nella misura in cui sono pensate da Dio ; le idee esistono ” ab aeterno ” in Dio e dato che tutto deriva da Dio , allora tutto é presente come idea nella mente di Dio e quindi il mondo delle idee di Platone si identifica con la seconda persona della Trinità , la sapienza : Dio ha quindi un pensiero interno , ossia le idee . La differenza tra il pensiero di Dio e quello dell’ uomo é che l’ uomo pensando può solo riconoscere le verità , Dio invece pensando ad una verità la fonda : la verità che 2 + 2 = 4 é autonoma e sarebbe così anche se io non la pensassi : é tale perchè pensata dalla mente divina : Platone stesso diceva che l’ uomo le verità ( quando proprio gli va bene ) può conoscerle ma non fondarle ; però per lui lo stesso era per Dio : il Demiurgo le verità non le fondava , si limitava a ” copiarle ” e una cosa era santa non perchè piaceva a Dio , ma piaceva a Dio perchè era santa . Quindi Dio crea il mondo prendendo se stesso come modello , o , meglio , l’ apparato ideale insito nella sua natura : e così le idee ( o universali che dir si voglia ) ante rem passano in re con la creazione . Dio le idee le possiede ab aeterno , ciò significa che l’ idea di uomo , per esempio , l’ ha sempre avuta ( universale ante rem ) e quando crea l’ uomo la fa passare in re . Se ammettiamo l’ ante rem , oltre all’ in re , allora sarà anche compatibile il post rem : é un processo di astrazione che avviene nel nostro cervello , ossia da casi particolari si astrae mentalmente l’ universale . Se però ammetto solo il post rem , allora non sarà più necessario ammettere l’ ante rem : infatti dirò che gli universali esistono solo come processo umano di astrazione , e quindi nè l’ ante rem platonico nè l’ in re aristotelico potrà esistere . Naturalmente vi furono anche posizioni radicali di nominalismo : il concettualismo , che ammetteva in qualche modo , pur non riconoscendo valida l’ ante rem e l’ in re , l’ esistenza degli universali . Il vero e proprio nominalismo , però , tendeva a volere gli universali come ” flatus vocis ” , espressione coniata dal primo vero nominalista , Roscellino : l’ universale é solo una vibrazione sonora ed esiste solo nella parola che esprimo ( ” uomo ” , cavallo ” … ) . Di Roscellino non possediamo scritti perchè venne condannato dalla Chiesa : pare infatti essere stato accusato di triteismo , ossia di spezzare la Trinità in 3 divinità , ricadendo così nel politeismo : era la conclusione necessaria alla quale lo portavano le sue idee , in quanto la dottrina trinitaria implica una natura e tre persone , ma se si é nominalisti non si può ammettere che tre persone siano presenti in una natura : per i nominalisti l’ unica cosa esistente sono i casi singoli , gli individui singoli : non vi é alcuna idea o forma di uomo : una cosa non può partecipare di tre cose ( nel caso della Trinità ) . Queste sono questioni sia logiche sia metafisiche ; Tommaso é il maggior filosofo di ispirazione aristotelica del Medioevo e più di ogni altro rese l’ aristotelismo adatto al cristianesimo : prima di lui ci si era accontentati della versione averroistica o si rendevano in qualche modo compatibili i punti aristotelici meno adatti al cristianesimo . Questo fino ad Alberto Magno ; Tommaso , invece , operò una vera e propria riforma dell’ aristotelismo nel suo nucleo in modo tale da rendere effettivamente compatibile al cristianesimo l’ intero sistema aristotelico . E’ risaputo che in Aristotele siano presenti una sfilza di dualismi come quello potenza-atto , materia-forma , essenza ( ciò che una cosa é ) – esistenza ( il fatto di esistere ) ; potenza-atto corrisponde a materia-forma ( la materia é la potenza e la forma é l’ atto ) , ma essenza ed esistenza in Aristotele stanno entrambi dalla parte dell’ atto ( la madre dà la materia , il padre la forma e un uomo in potenza diventa uomo in atto quando ha sua essenza ed esistenza ) . Tommaso ammette sì il dualismo potenza-atto : però lui mette dalla parte della potenza sia la materia sia la forma , che danno l’ essenza ; dalla parte dell’ atto lui mette l’ esistenza : Aristotele era convinto che la materia fungesse da ” principium individuationis ” : noi siamo diversi l’ uno dall’ altro per via della materia ; se non ci fosse materia saremmo tutti uguali , o , meglio , saremmo uno solo : non a caso l’ unico essere privo di materia che Aristotele ammetta é Dio , che é uno solo , puramente formale . Per Tommaso la materia , invece , é QUANTITATE SIGNATA , ossia é quantitativamente determinata : non é la materia che ci distingue , ma quella determinata quantità di materia che contraddistingue ciascuno di noi : é l’ unica forma uomo che si cala in diversi quantitativi di materia . L’ introduzione di questa concezione permette a Tommaso di affermare che per gli esseri materiali l’ essenza non é data solo dalla forma , ma anche dalla materia : d’ altronde se parlando di ” uomo ” escludiamo la materia non stiamo più parlando di un uomo , ma di un essere senza materia , un angelo . Materia + forma = essenza e vanno collocate tutte e 3 dalla parte della potenza perchè l’ essenza in quanto tale é solo potenza : l’ essenza dell’ uomo é l’ essenza dell’ uomo così come esiste nella mente di Dio : l’ uomo é esistito prima ancora di essere creato , come essenza insita nella mente di Dio , ma solo in modo potenziale : Adamo non c’era , o meglio , c’ era come idea nella mente di Dio ; per il passaggio all’ atto é necessario che Dio decida di creare il mondo : all’ essenza ( materia + forma ) , Dio aggiunge l’ esistenza e quindi la materia ” quantitate signata ” . E’ la modificazione che consente a Tommaso di rendere l’ aristotelismo compatibile al cristianesimo : la concezione aristotelica , di per sè , non potrebbe rendere ragione dell’ atto creatore del mondo : tutto infatti per Aristotele ha in sè la ragione della sua esistenza . Ogni cosa che esista effettivamente ha in sè essenza ed esistenza . Cartesio quando cercherà di definire la sostanza dirà che essa é ciò ” che non ha bisogno di nient’ altro fuori di sè ” : così come per Aristotele , anche per Cartesio sostanza é tutto ciò che esiste da sè . Aristotele divideva tra sostanze , dotate di esistenza autonoma , ed accidenti , cose che per esistere hanno bisogno che esista la sostanza : essi hanno esistenza ” parassitaria ” : il giallo per esistere ha bisogno di una sostanza , per esempio un libro : di per sè il giallo non esisterebbe , esiste solo insieme all’ esistenza della sostanza . In una concezione cristiana , a rigore , solo Dio é sostanza , perchè tutto per esistere ha bisogno di essere creato da Dio ; sostanza per Aristotele era ciò che aveva essenza ed esistenza : é la forma che ad un cavallo lo fa essere e lo fa essere cavallo . Solo Dio ha identificazione tra essenza ed esistenza ; Tommaso correggerà la frase ” sostanza é tutto ciò che per esistere non ha bisogno di nulla all’ infuori di sè ” facendola diventare ” sostanza é tutto ciò che per esistere non ha bisogno di null’ altro , se non di Dio . L’ uomo é essenza nella misura in cui é pensato da Dio ab aeterno , é esistenza nella misura in cui Dio vuole crearlo : pare quindi che non ci sia differenza tra uomo in potenza ( pensato da Dio ) e uomo in atto ( creato da Dio ) : invece c’é perchè Tommaso spiega che é vero che Dio poteva decidere di non creare l’ uomo , ma non poteva decidere di non pensarlo , perchè il pensare é connaturato all’ essenza stessa di Dio : Dio può tutto , ma non può non essere Dio : dalla volontà di Dio dipende l’ aver creato il mondo , cosa che volendo avrebbe potuto non fare , ma non il pensarlo : fa infatti parte della sua natura . E così le verità che noi possiamo solo conoscere , lui le fonda col suo pensiero : tuttavia Dio non decide che 2 + 2 = 4 , ma che 2 + 2 = 4 dipende dall’ essere pensata da Dio : la verità dipende dall’ essere pensata da Dio . Per Tommaso l’ onnipotenza divina é limitata dalla natura stessa di Dio . Diversa é la concezione dell’ onnipotenza divina di Ockham : lui é francescano e il francescanesimo é un ordine più mistico che non intellettuale : scarso é l’ interesse per la speculazione teologica , forte é invece l’ amore per Dio e la mistica . Chiaramente questa concezione ha portato i francescani ad una diversa idea dell’ onnipotenza : i domenicani , nella loro visione intellettuale , identificavano di fatto il mondo delle idee con la seconda persona della Trinità , la Sapienza : l’ esistenza del mondo per loro dipende dall’ essenza divina , l’ essenza del mondo dipende invece dalla sapienza divina . Per loro l’ onnipotenza era limitata : Dio non può scegliere qualsiasi cosa : io so che 2 + 2 = 4 , per Dio 2 + 2 = 4 perchè lo pensa lui : ma non é che decida che sia così , é limitato dal suo pensiero stesso . Per i francescani , invece , Dio ha onnipotenza totale : tutto dipende da Dio , sia l’ essenza sia l’ esistenza del mondo ; tra quelli che la pensano così vi é appunto Ockham : per loro ciò che é santo lo é perchè piace a Dio ; Ockham diceva , riprendendo il primo comandamento che dice di amare Dio , ” se Dio avesse decretato che fosse meritevole odiare Dio , allora sarebbe giusto odiarlo ” : questa é la cosiddetta prospettiva voluntarista : Dio ha stabilito ogni cosa : se avesse stabilito che 2 + 2 = 5 , allora sarebbe così . Dio può scegliere ciò che vuole , é talmente onnipotente da poter cambiare l’ essenza delle cose . Questo discorso si riconnette anche con il radicale nominalismo di Ockham : la volontà di Dio é addirittura più potente dell’ intelletto divino : in Ockham si trovano 3 posizioni che in qualche modo si riconnettono tra loro : a ) nominalismo , ossia il negare l’ esistenza degli universali ; b ) separatismo , ossia l’ inconciliabilità tra fede e ragione ; c ) voluntarismo , ossia la prospettiva secondo la quale Dio può tutto e ha stabilito tutto secondo il suo volere . Per quel che riguarda gli universali Ockham nega totalmente la loro esistenza : non esistono nè in re , nè post rem , nè ante rem : per lui gli universali sono una inutile moltiplicazione della realtà : questo é un problema già affrontato da Platone nel Parmenide ed era una delle accuse mossegli da Aristotele : tuttavia anche le idee in re di Aristotele sono per Ockham una inutile moltiplicazione della realtà : per Ockham bisogna evitare tutto ciò che é inutile e questa idea é sintetizzata nel cosiddetto ” rasoio di Ockham ” , così chiamato perchè con esso si cerca di tagliare via il superfluo : ” frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora ” : quando si può spiegare una cosa con poco , perchè dilungarsi ? Nel Medioevo , poi , ogni minima cosa la si attribuiva ai diavoli o agli angeli , a seconda che fosse positiva o negativa . Chiaramente il ” rasoio ” Ockham lo applica pure agli universali : se posso spiegare qualcosa con pochi elementi , perchè introdurne di superflui ? Ma come si può fare a meno degli universali per spiegare la realtà ? Pare assai difficile , ma Ockham ci prova , grazie all’ introduzione di due concetti : 1 ) intentio e 2 ) suppositio La intentio é la caratteristica propria dei segni di possedere un significato : gli universali non ci sono , ci sono solo realtà individuali : la parola ” uomo ” é una realtà individuale , che , scritta , altro non é che un insieme di macchie di inchiostro e si riferisce alla parola detta : se la si legge suona nell’ aria ” uomo ” : é una realtà individuale che vibra nell’ aria e si riferisce ad un concetto , quello di uomo che io ho nella testa : non é un universale , però si riferisce agli uomini : il concetto uomo , di per sè individuale , si può riferire a più persone : non esistono universali , ma funzioni universali con la caratteristica di potersi riferire e tendere ad altre : la parola scritta ” uomo ” non si riferisce all’ idea di uomo ( che non esiste ) , ma alla parola vibrante nell’ aria : dopodichè la parola vibrante nell’ aria si riferisce a tanti uomini contemporaneamente : ma tuttavia non é un universale . Ma come possono esistere le funzioni universali se gli universali non esistono ? Infatti si passa da una macchia di inchiostro ad una parola e poi a più cose : come fanno a richiamarsi tra loro ? C’ é la suppositio ( dal latino subpono = metto al posto di ) : i segni sono ciò che può stare al posto di qualcos’ altro ; dire ” Socrate é uomo ” per Platone e Aristotele significava che Socrate partecipava dell’ idea di uomo per l’ uno , e che la forma uomo era in lui per l’ altro : una cosa individuale partecipava di una cosa universale . Per Ockham vuol dire che la parola ” Socrate ” sta al posto di quella particolare cosa che é Socrate in carne e ossa : parlando o scrivendo sostituiamo le realtà di cui parliamo con parole o macchie di inchiostro . Anche per la parola ” uomo ” é lo stesso : la si usa per sostituire gli uomini in carne e ossa , ossia Socrate più altri : ciò significa semplicemente che esiste una cosa per la quale possono ugualmente stare sia la parola ” Socrate ” sia la parola ” uomo ” ; alcune cose stanno al posto di altre quando sono un segno o naturale o artificiale di quelle cose ; si parla di segni artificiali quando , ad esempio , vediamo un cavallo ed esso ci lascia un ” segno ” nella nostra testa e questo segno non sarà solo più segno di quel determinato cavallo ( segno naturale ) , ma anche di tutte le cose simili ( gli altri cavalli ) . E’ una questione sia logica ( in quanto si occupa del significato ) sia ontologica ( gli universali non esistono ) che porta a delle conseguenze : dire che esistono solo i casi particolari significa di fatto far venir meno la distinzione essenza-esistenza ; l’ idea generale del Medioevo era che nella mente di Dio vi fosse ab aeterno l’ apparato ideale e che Dio ad un certo momento decidesse di creare il mondo con queste idee insite nella sua mente : era sì Dio a decidere se creare o meno il mondo , ma tuttavia non poteva decidere se pensarlo o meno : l’ apparato ideale nella sua mente lo vincolava ( Dio può tutto , ma non può non essere Dio ) ; per Ockham , invece , gli universali ( o idee che dir si voglia ) non esistono e quindi Dio non ha l’ apparato ideale nella sua mente che lo vincola : creando il mondo , crea essenza ed esistenza : non é che crei Adamo seguendo l’ idea di uomo ( che per Ockham non esiste ) : Dio crea dal nulla Adamo e gli dà simultaneamente esistenza ed essenza . Il nominalismo si lega radicalmente al volontarismo : implica una onnipotenza totale , dove Dio non é vincolato neanche più dall’ apparato ideale della sua mente e può davvero tutto : tutto dipende esclusivamente dalla sua volontà . E’ vero che in natura ci sono delle forme di regolarità ( le leggi fisiche ) ; queste leggi potrebbero essere pensate come essenze della realtà e si potrebbe dire che non é Dio a decidere che vadano così : per esempio , ogni corpo tende a cadere verso il basso , e quindi anche una penna cadrà verso il basso . Ockham era pienamente cosciente di ciò ma tuttavia arrivava a dire : ” é vero che ogni corpo cade verso il basso , ma se Dio volesse non sarebbe così ” : Dio può cambiare le regole a suo piacimento perchè non ha vincoli ; quella che noi chiamiamo ” regolarità naturale ” non é però tale perchè presente nella mente di Dio come idea , ossia come essenza di Dio . Ockham arriverà a distinguere il modo di operare divino in potentia absoluta e potentia ordinata : Ockham é consapevole che esistano forme di regolarità in natura , ma é convinto che il fatto che esistano non comporti che esse debbano per forza esistere : se Dio volesse cambiare le regole del gioco potrebbe farlo a suo piacimento : potrebbe benissimo non far cadere in basso gli oggetti , ma farli cadere obliquamente . In altre parole , se una penna cade a terra é così perchè Dio ha deciso che sia così , che ci sia un ordine : tuttavia non é vincolato da quest’ ordine . Quindi é vero che per potenza ordinata ci sono delle leggi fisiche , ma tuttavia per potenza assoluta Dio può stravologerle ( pensiamo ai miracoli ) . Una concezione simile a quella teologica di Ockham sarà quella politica del 1600 , il secolo dell’ assolutismo : ci sarà chi dirà che esistono leggi , ma che esistono solo perchè il sovrano l’ ha decretato . Nel Medioevo invece , per quel che concerne la politica , il sovrano era vincolato , per esempio , dalla consuetudine . Tutto questo ha una conseguenza ancora più importante che porterà Ockham a concepire la filosofia e la religione come inconciliabili : ciò che é necessario é prevedibile , ciò che é volontario ( ossia arbitrario ) non é prevedibile : per esempio , l’ atteggiamento di un cane affamato davanti al cibo é prevedibile , quello di un uomo no , perchè é dotato di libero arbitrio : può decidere se mangiare o trattenersi , e quindi il suo atteggiamento non sarà prevedibile . Se ammettiamo le essenze ( le idee ) divine che da Dio non dipendono e che sono necessarie é un conto , ma se dico che esse non ci sono allora sarà impossibile effettuare ragionamenti che seguano le strutture della realtà : prendiamo il caso della dimostrazione geometrica dove i vari passaggi hanno legami tra loro : da una verità A passo ad un’ altra verità B , poi a una C e così via : si tratta di collegamenti necessari che non dipendono da Dio . Se però , ad esempio , qualcuno ( per esempio Dio o il triangolo stesso ) potesse decidere che la somma degli angoli interni di un triangolo vale 37 gradi , ossia se dipendesse dalla volontà di qualcuno , allora non avrebbe più senso e sarebbe impossibile effettuare i passaggi dimostrativi . Lo stesso vale per quel che riguarda Dio secondo Ockham : siccome le essenze ( le idee ) non ci sono , allora non si può ragionare sulle strutture della realtà divina : quindi le complesse catene di ragionamenti di Tommaso sono agli occhi di Ockham assurde e inutili . L’ esistenza di Dio é indimostrabile . Finchè ragiono sulle regolarità in natura che dipendono dalla potenza ordinata allora io posso ragionare e risalire le varie ” catene ” di ragionamenti : verità A poi B e poi C ; ma quando entro nel campo delle realtà soprannaturali allora entro nel campo di Dio e non posso ipotizzare di argomentare ragionando perchè non esistono concatenazioni ( da una verità A a una B e così via ) ; sostenendo il volontarismo di Dio é come se spezzassi l’ ipotetica ” scala ” delle dimostrazioni che mi permettono di dimostrare con la ragione perchè il rapporto tra Dio e la natura non é più necessario ( tra Dio e le idee ) , ma é un rapporto volontario ( tra Dio e Dio ) . Se ammetto le idee nella mente di Dio , come Tommaso , posso dimostrare razionalmente l’ esistenza di Dio e posso risalire la ” scala ” delle verità , ma se nego gli universali , come Ockham , allora ciò non é più possibile perchè Dio agisce solo secondo la sua volontà . Nella matematica , ad esempio , i pioli della scala argomentativa sono fortissimi perchè tutto é regolato , ma più c’ é arbitrio e meno si possono usare i pioli . Secondo Ockham più ci si avvicina a Dio e più ci si allontana dalla realtà : ammettendo il nominalismo elimino l’ essenza e la scala non può più funzionare in ambito divino : così allora Ockham arriva a spezzare la scolastica , che altro non era che tentare di dimostrare le realtà divine con la ragione e con la filosofia . La filosofia diventa indipendente dalla religione : la fede allora si rafforza perchè é la sola che può portare a Dio ( se infatti l’ esistenza di Dio fosse dimostrabile razionalmente nessuno avrebbe più fede ) . La fede arriva a darmi la ” certezza di cose non viste ” , come diceva san Paolo .
BOEZIO

INTRODUZIONE AL PENSIERO
Suo padre fu Flavio Narsete Manlio Boezio, due volte prefetto del pretorio d’Italia, prefetto di Roma e console nel 487, mentre la madre apparteneva alla nobile e antichissima gens Anicia. Alla morte del padre, avvenuta intorno al 490, fu affidato a Quinto Aurelio Memmio Simmaco, nobile e letterato romano, la figlia del quale, Rusticiana, sposerà intorno al 495 avendone due figli. Nel 493 Teodorico, re degli Ostrogoti, vince in battaglia e uccide Odoacre, re degli Eruli, stabilendo in Italia il proprio regno, confermando Ravenna come capitale, ma risiedendo anche a Pavia e a Verona. Boezio studiò alla scuola di Atene, retta dallo scolarca Isidoro, dove si insegnavano soprattutto Aristotele e Platone insieme con le quattro scienze fondamentali per la comprensione della filosofia platonica, l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica; qui conobbe forse il giovane e futuro grande commentatore di Aristotele, Simplicio, che indicò come nella scuola si cercasse un accordo tra i due maggiori filosofi dell’antichità, studiando ogni singola frase delle loro opere e discutendo le opinioni dei commentatori, partendo da Aristotele, il maggior studioso della natura, per giungere a Platone: «Aristotele procede dalle cose fisiche» – scrive Simplicio – «verso quelle che stanno al di sopra della natura; considera queste in base alla relazione che hanno con quelle, mentre Platone considera le cose naturali in quanto partecipi di quelle che stanno al di sopra della natura». S’iniziava con lo studio della logica di Aristotele, preceduta dall’introduzione, l’ Isagoge, di Porfirio; è il piano che Boezio seguirà nel compito che un giorno vorrà assumersi di tradurre in latino, commentare e accordare i due pensatori greci. Intorno al 502 si fa risalire la sua attività letteraria e filosofica: scrive i trattati del quadrivio, le quattro scienze fondamentali del tempo, il De institutione arithmetica, il De institutione musicae e i perduti De institutione geometrica e De institutione astronomica. Qualche anno dopo traduce dal greco in latino e commenta l’Isagoge di Porfirio, un’introduzione alle Categorie di Aristotele, che avrà un’enorme diffusione nei secoli a venire. La fama così ottenuta gli procura nel 510 la nomina di consul sine collega dalla corte imperiale di Costantinopoli, carica biennale che gli dà diritto a un seggio permanente nel Senato romano. Da questi anni fino al 520 traduce e commenta le Categorie e il De interpretatione di Aristotele, scrive il trattato teologico Contra Eutychen et Nestorium, il perduto commento ai Primi Analitici di Aristotele, un De syllogismis categoricis, un De divisione, gli Analytica posteriora, un De hypotheticis syllogismis, la traduzione, perduta, dei Topica di Aristotele e un commento ai Topica di Cicerone. Partecipa ai dibattiti teologici del tempo: intorno al 520 compone il De Trinitate, dedicato al suocero Simmaco, l’ Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur, il Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint, cum non sint substantialia sint e, secondo alcuni, il De fide catholica. L’interesse di Boezio e di molta parte del patriziato romano per i problemi teologici che avevano il loro centro soprattutto in Oriente, con i dibattiti sull’arianesimo, mettono in allarme Teodorico, che sospetta un’intelligenza politica della classe senatoria romana con l’Impero, la cui ostilità verso i Goti ariani era sempre stata appena malcelata. Appena terminati i De sophisticis elenchis, perduti, e i De differentiis topicis, Boezio è chiamato alla corte di Teodorico, per discutere della non facile convivenza fra gli elementi gotici e italici della popolazione. Nel 522 è magister officiorum – i suoi due figli sono nominati consoli – nel 523, alla morte di papa Ormisda, succede al papato Giovanni I. Il magistrato Cipriano, a Pavia, in seguito al sequestro di lettere dirette alla corte di Bisanzio, accusa il nobile romano Albino di complotto ai danni del regno di Teodorico. Boezio difende Albino, esponendo se stesso e tutto il Senato nella difesa del collega. Portate nuove accuse fondate su lettere, forse falsificate, di Boezio, nelle quali egli avrebbe sostenuto la necessità di “restaurare la libertà di Roma”, viene sostituito nella sua carica da Cassiodoro e, nel settembre 524, incarcerato a Pavia con l’accusa di praticare arti magiche; qui inizia la composizione della sua opera più nota, la De consolatione philosophiae. Egli viene giudicato, a Roma, da un collegio di cinque senatori, estratti a sorte, presieduto dal prefetto Eusebio. Questi, nell’estate del 525, notifica la sentenza di condanna a morte di Boezio, che viene ratificata da Teodorico ed eseguita presso Pavia, nell’ ager Calventianus, una località che non si è potuta identificare con certezza. L’intento di Boezio fu soprattutto quello di tradurre Platone e Aristotele, forse allo scopo di confermare il loro accordo di fondo, secondo un’impostazione propria dei Neoplatonici. Il progetto però rimase incompiuto: a noi sono pervenute le traduzioni delle Categorie, del De interpretatione, dei Topici e delle Confutazioni sofistiche di Aristotele, mentre é andata perduta quella degli Analitici secondi. Boezio fu dunque il più grande traduttore di Aristotele del mondo medievale in Occidente. Egli tradusse, inoltre, l’Isagoge di Porfirio alle Categorie, su cui compose due commentari, uno più elementare e uno più avanzato; scrisse commenti al De interpretatione e alle Categorie di Aristotele e uno ai Topici diCicerone, e compose anche propri trattati di logica: Sulla divisione, Sulle differenze topiche , due scritti Sui sillogismi categorici e uno Sui sillogismi ipotetici. La traduzione di Boezio – che seguono parola per parola l’originale – trasmettono le dottrine logiche degli antichi, sulle quali si baserà la cultura medioevale sino all’undicesimo secolo. Nei commenti all’Isagoge di Porfirio, Boezio affronta il problema degli universali, che sarà più ampiamente dibattuto anche nei secoli successivi (sarà il tema portante dell’età medievale). In quest’opera Porfirio riportava varie opinioni sulla natura dei generi e delle specie, ma senza assumere una posizione personale. La questione é se i generi e le specie, per esempio “animale” o “uomo” , sussistano indipendentemente dai singoli animali o dai singoli uomini (come credeva Platone) oppure esistano solo in questi (come credeva Aristotele) oppure siano entità che hanno la loro esistenza soltanto nel pensiero. Boezio, pur riconoscendo che la questione é assai difficile, propende per una soluzione che egli considera propria di Aristotele e differente invece da quella di Platone. Egli afferma che universale é ciò che é comune a molte cose, ma poichè una cosa realmente esistente non può essere comune a molte cose perchè non può suddividersi in pezzi tra esse, gli universali non possono esistere come sostanze autonome. Essi, allora, esistono come pensieri, ma come pensieri che hanno la loro base in oggetti che esistono nella realtà, poichè se così non fosse, gli universali non avrebbero alcun contenuto nè riferimento alla realtà. Come aveva insegnato Aristotele, l’intelletto partendo dagli oggetti sensibili, ne astrae la forma o specie: vedo tanti cavalli in carne ed ossa e, per un’astrazione operata dal mio intelletto, ne ricavo l’universale di cavallo. Specie (per esempio “uomo”) non é altro che la somiglianza tra più cose (in questo caso : uomini) colte dall’intelletto, mentre genere ( per esempio : “animale” ) é la somiglianza tra più specie. Generi e specie sussistono nelle cose in modo percepibile, ma sono anche pensieri che sussistono in sè. Nel commento alle Categorie, Boezio rintraccia invece la base degli universali (generi e specie), più che nelle somiglianze tra le cose, nelle collezioni di individui simili. Armato di questi strumenti logici, egli interviene, forse a partire dal 520, in controversie teologiche sulla natura di Cristo e sulla Trinità scrivendo 5 Opuscoli Sacri, tra i quali Sulla Trinità – sulla linea di Agostino. In essi egli sostiene platonicamente che le specie sono le idee eterne esistenti nella mente di Dio e modelli delle cose; egli distingue inoltre tra eternità, che appartiene esclusivamente a Dio, e perpetuità, che é propria del mondo creato nella sua durata ininterrotta. L’ultimo imponente scritto composto da Boezio é la Consolazione della filosofia, in cinque libri. I personaggi che egli mette in scena sono Boezio stesso e la personificazione della Filosofia che lo visita in cella: il suo modello é il Critone platonico, dove le leggi – con una celebre prosopopea – appaiono in sogno a Socrate nel carcere e colloquiano con lui, inducendolo a non evadere, perché così facendo commetterebbe ingiustizia non verso i suoi calunniatori, ma verso la poliV alla quale deve ogni cosa. Dopo aver sottolineato la necessità di disprezzare la sorte, la Filosofia dimostra che solo Dio é il Sommo Bene. Secondo Boezio il bene perfetto, se é possibile, deve esistere nella realtà: ma “non si può concepire nulla migliore di Dio”, dunque Dio esiste . E’ questo un embrione di ragionamento, già presente in Seneca, che sarà ripreso e sviluppato da Anselmo nella sua formulazione della “prova ontologica” dell’esistenza di Dio. Gli ultimi due libri dell’opera affrontano il problema del male, risolto alla maniera agostiniana, e quello del rapporto tra prescienza divina e libero arbitrio umano . Secondo Boezio, la conoscenza divina é diversa da quella umana, perchè é fuori dal tempo. Infatti la conoscenza che Dio ha del futuro non corrisponde a quella che ne ha l’uomo, essa é piuttosto avvicinabile a quella che l’uomo ha del presente: ciò che per noi è futuro, per Dio è presente. Agli uomini, infatti, il futuro appare incerto, ma ciò non é possibile per Dio; egli dunque conosce pienamente il futuro, ma ciò non significa che la sua conoscenza causi il futuro. Ogni evento é l’effetto di una causa, e Dio, conoscendo le cause, conosce simultaneamente anche i loro effetti, e poichè la volontà umana fa parte delle cause che danno luogo a eventi, Dio conosce anche quale é la volontà dei singoli, benchè il fatto che egli la conosca non significhi che egli annulli la libertà del volere: a tal proposito Tommaso si avvarrà di un esempio particolarmente significativo; come quando vediamo un vascello e sappiamo già quale sarà la sua rotta, ma non per questo possiamo influenzarla, così Dio sa già come ci comporteremo ma non per questo limita la nostra libertà. Gli interpreti moderni sono stati colpiti dal fatto che nella Consolazione della filosofia manchino riferimenti espliciti al cristianesimo, anche se allusioni al testo biblico non sono assenti, ma va rilevato che in linea di principio non c’é incompatibilità tra il cristianesimo e le dottrine neoplatoniche, che pervadono il suo scritto. Inoltre, con Boezio la filosofia in lingua latina sembra ripercorrere un itinerario di allontanamento dalla scena politica, che già Cicerone e Seneca avevano conosciuto. Nel mondo latino la filosofia riconferma così la sua vocazione terapeutica e consolatoria (e quindi pratica) nei momenti drammatici della vita, ma l’eredità più rilevante di Boezio consiste nella creazione di un vocabolario latino della logica e della riflessione teologica e nell’uso di una tecnica di risoluzione delle questioni che saranno determinanti per l’età successiva.
DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE
Quando Boezio venne da Teodorico fatto imprigionare e condannato alla pena capitale nel 524, scrisse un’opera in cinque libri, mista di versi e prosa, che è rimasta pietra miliare della filosofia medievale: De consolatione philophiae. Quest’opera godette di una fortuna strepitosa, non solo in età medievale (Dante si formò filosoficamente su di essa), ma anche in epoca moderna: quando Shakespeare – in Romeo e Giulietta – proclama “Adversity’s sweet milk, philosophy”, nelle sue parole sentiamo echeggiare la lezione boeziana, della filosofia come viatico e come cura per far fronte alle avversità che si abbattono imperscrutabilmente su di noi. Riportiamo qui un breve riassunto del De consolatione philosophiae:
-LIBRO I: Non appena Boezio riconosce la donna, apparsagli, come la “nutrice” compagna della sua giovinezza, ella cerca subito di allietarlo ricordandogli le ingiustizie che tanti pensatori hanno dovuto subire; poi lo invita a sfogare il proprio dolore affinché lei possa curarlo e indicargli la giusta via. Boezio, perciò, mette a nudo tutta la sua infelicità come conseguenza della disastrosa condizione umana in contrasto con l’ordinato equilibrio del cielo. Perciò la Filosofia intravede un vuoto attraverso il quale si è insinuato nell’animo di Boezio il male del turbamento, in quanto egli si è dimenticato quale sia il fine delle cose e da quali strumenti il mondo sia retto e, per di più, giudica potenti e fortunati gli uomini malvagi.
-LIBRO II: Ha, quindi, inizio l’opera benefica della Filosofia con l’aiuto della Retorica e della Musica. Ella esorta l’infelice a diffidare dei favori della fortuna, perché, in quanto instabile, non può portare alla realizzazione della felicità: “…in che modo, infatti, con la sua presenza, può rendere felici gli uomini una condizione fortunata la cui assenza non li può rendere felici?” (I, 5°). Boezio è perciò concorde che sia più vantaggiosa una sorte avversa, che rende consapevoli, piuttosto che una sorte prospera, che fornisce solo fallaci illusioni.
-LIBRO III: La Filosofia annuncia a Boezio che è giunto il momento di parlare con estrema chiarezza all’animo di lui, che ormai è ben disposto a ricevere i suoi più importanti precetti: quelli che lo condurranno alla vera felicità, definita come lo stato di perfezione conseguente alla presenza di tutti i beni. La Filosofia si accinge quindi a definire quali siano i caratteri della felicità umana; ogni uomo vede la felicità in quella condizione a cui egli aspira al di sopra di tutte le altre (ricchezze, onori, potere, gloria, piaceri del corpo). Tramite un vasto ragionamento, la Filosofia riesce a far capire a Boezio che da nessuna di queste cose deriva la felicità e che dunque sono soltanto delle immagini illusorie di essa. Ne viene dunque che, se tutto ciò che è un bene terreno non è un bene vero, il sommo bene si identificherà necessariamente con Dio, a cui tutti dovranno aspirare per essere davvero felici.
-LIBRO IV: Boezio si pone quindi una logica domanda, che da sempre pone l’essere umano nell’incertezza: da dove viene, dunque, il male che attanaglia il mondo? Con quale criterio è fatta la ripartizione dei beni, che sembrano andare più verso i malvagi che verso i buoni? La Filosofia lo conduce alla ragione portandolo a riconoscere che i beni dei cattivi non sono veri beni e che le infelicità dei buoni sono utili per la loro salvezza.
-LIBRO V: I due si avviano ad un altro problema; si tratta stavolta della questione sul rapporto tra libero arbitrio e prescienza divina.
Nel De consolatione philophiae Boezio cercava nella filosofia una via di consolazione alle proprie disgrazie: in essa, egli immagina di ricevere, durante la prigionia, la visita di una donna che si rivela essere la Filosofia stessa, venuta a consolarlo del suo triste stato e a fornirgliene una spiegazione teleologica. La Filosofia inizia col ricordare a Boezio che ciò che egli sta vivendo lo vive proprio in quanto filosofo: è, infatti, tipica dei veri discepoli della filosofia la tendenza a dispiacere ai perversi. Ciò è dimostrato anche dal fatto che situazioni più o meno analoghe sono state vissute da uomini altrettanto illustri e tra questi la Filosofia ricorda Socrate e lo stesso Seneca, due grandi martiri della filosofia. Proprio in virtù di quanto asserito dalla Filosofia, Boezio si chiede come sia possibile che il mondo premi gli ingiusti mentre la Fortuna si accanisca contro un uomo come lui che ha sempre difeso i diritti dei deboli. A questa angosciata domanda, che chiude il libro I, la Filosofia risponde dicendo che Boezio non deve temere, perché non alla fortuna è affidato il mondo, ma alla divina ragione. Del resto (e ciò è l’argomento del II libro), la felicità non è da ricercarsi nei beni materiali: questi ultimi, infatti, sono tali che per procurarseli l’uomo deve inevitabilmente ricorrere a soluzioni aberranti, stravolgendo il valore delle cose e finendo, così, per uccidere proprio ciò in cui crede. Infatti, l’uomo che vuole superare gli altri in onori, dovrà necessariamente disonorarsi umiliandosi servilmente per ottenere gli onori cui aspira; allo stesso modo, chi cerca la ricchezza dovrà sottrarla a chi la possiede; e ancora, se si vuole una vita all’insegna dei piaceri, si finisce col suscitare ripugnanza. Eppure, la presenza di beni imperfetti implica automaticamente l’idea della perfezione cui i beni imperfetti partecipano. Dante stesso – che nel Convito chiama Boezio suo consolatore e dottore – si ricorderà di queste riflessioni boeziane sulla caducità dei beni terreni, quando nel Paradiso (X, 124-129) scriverà – alludendo a Boezio stesso, che l’ha iniziato alla filosofia – :
Per vedere ogni ben dentro vi gode
L’anima santa, che ‘l mondo fallace
Fa manifesto a chi di lei ben ode.
Lo corpo, ond’ella fu cacciata, giace
Giuso in Cieldauro; ed essa da martìro
E da esiglio venne a questa pace.
Ora, i beni materiali di per sé non sono un male – come già diceva Plotino -, in quanto creati da Dio, ma tali diventano se ci distolgono dai veri beni, quelli di natura spirituale: finchè restiamo all’infimo livello della materialità, vediamo i beni materiali come i supremi; ma non appena ci innalziamo a quelli spirituali, i beni materiali ci appaiono insignificanti e minuti, proprio come quando – per riprendere l’immagine che userà Petrarca nella sua ascesa al monte Ventoso – saliamo in cima ad un monte vediamo piccolissimo ciò che sta sotto e che, prima di salire, ci pareva enorme. La Filosofia conclude quindi che la felicità è Dio stesso, inteso come sommo bene. Fin qui, i primi tre libri; nel libro IV, però, viene sollevata l’inevitabile obiezione: se il mondo è governato da Dio e se Dio è il sommo bene, come mai esiste il male? Si Deus est, unde malum? Così si interroga lo stesso Agostino, e la tematica verrà lasciata in eredità ai pensatori successivi, fino ai giorni nostri (ma, del resto, si Deus non est, unde bonum?). A questa legittima domanda, la Filosofia risponde che ciò che governa tutto è la Provvidenza, ossia la volontà divina stessa, la quale però si serve del Fato, cioè la contingenza relativa alle cose mutevoli. Gli uomini, che non conoscono questo stato di cose, non operano la necessaria distinzione tra fato e provvidenza, sì che il verificarsi del male nel mondo appare ad essi incomprensibile, tanto più quando a farne le spese sono i virtuosi (pensiamo a Socrate e a Seneca). Ma una provvidenza che governa il mondo non annulla la libertà dell’uomo? Boezio utilizza il V libro per dare risposta a questo arduo problema: ciò che governa il mondo è provvidenza, non previdenza; le azioni passate, presenti e future sono in Dio tutte presenti: “se tu volessi valutare esattamente la previsione con cui egli riconosce tutte le cose, dovresti giustamente ritenere che si tratti non di prescienza di cose proiettate nel futuro, ma di conoscenza di un presente che non viene mai meno. Onde si chiama, non previdenza, ma provvidenza” (De consolatione philosophiae, V). Ciò che rappresenta per l’uomo un evento futuro, in Dio è sempre presente “… per cui quelli [gli eventi] che dipendono dal libero arbitrio sono presenti nella loro contingenza” (Giovanni Reale). Dio vede sì cosa noi faremo in futuro, ma non per questo la nostra libertà viene meno, giacchè ciò che per Lui è presente attuato, per noi è futuro e, pertanto, possibile, non necessario.
GIOVANNI SCOTO ERIUGENA
INTRODUZIONE
Giovanni Scoto, detto Eriugena, ossia originario dell’ Irlanda – nato all’ inizio del nono secolo – godeva della protezione di Carlo il Calvo e insegnava in una scuola di palazzo nel nord della Francia. Rispondendo alla richiesta di Incmaro, che era ostile alla teoria della doppia predestinazione formulata da Gotescalco, Scoto scrisse un’opera intitolata Sulla predestinazione, nella quale avvertiva la necessità di comprendere che cosa si può e che cosa non si può dire di Dio; innanzi tutto, rispetto a Dio, il linguaggio umano si rivela inadeguato, é pertanto fuorviante parlare di pre-destinazione e di pre-scienza a proposito di Dio, perchè Dio non esiste nel tempo, bensì esiste nell’eternità , nella quale non c’é un prima e un dopo. L’anteriorità della prescienza di Dio significa solo che egli nell’eternità ha priorità rispetto alle sue creazioni; in tal senso la prescienza di Dio fa parte della sostanza divina, che é unitaria, non é un momento o una fase di tale sostanza. Inoltre, é assurdo dire che Dio predestina alcuni uomini alla dannazione, ossia ad un male. Scoto riprende a tal proposito da Agostino la tesi che il male é non essere e quindi non ha senso parlare di una predestinazione a ciò che non é . La posizione di Scoto appare , su questo punto , agli antipodi di quella avanzata da Fredegiso da Tours, morto verso l’ 834. Questi in un’epistola, Sul nulla e sulle tenebre, si era posto il problema se il nulla sia qualcosa. Partendo dalle premesse che ogni nome determinato significa qualcosa che é e che anche il termine “nulla” é un nome determinato, egli aveva tratto la conclusione che anche il termine “nulla” significa qualcosa che é: dunque anche il nulla, come le tenebre, é qualcosa. Come risulta dalla Genesi, Dio stesso, nell’atto della creazione, parla di nulla e di tenebre , perciò a questi nomi deve corrispondere qualcosa di reale . Per Scoto, invece, le nozioni di non essere e di male indicano soltanto una mancanza di essere e quindi egli ritiene che non si possa attribuire una qualche consistenza ontologica ad essi. Due sono i mali: il peccato e la punizione di esso, ma nessuno dei due é predestinato da Dio, poichè essi provengono soltanto dalla volontà umana; infatti é l’uomo che abusa della propria volontà, che di per sè é bene. La punizione non é altro che mancanza e pertanto non é pensata dalla mente divina, che pensa solo a ciò che é ed é bene, essa non consiste che nell’essere nella condizione di peccato, cioè di deficienza, sicchè solo metaforicamente si parla delle pene dell’inferno : l’inferno non é un luogo reale, é nell’interno del peccatore stesso. Scoto, tuttavia, non riprende da Agostino la tesi che la vera libertà consiste solamente nel volere il bene : se Dio avesse dato all’uomo solo la capacità di volere il bene, l’uomo non sarebbe propriamente libero. Il libero arbitrio, consiste infatti nella capacità di orientarsi verso il bene o verso il male; se l’uomo non fosse libero in questo senso, non si potrebbe parlare di giustizia divina. La giustizia consiste infatti nell’attribuire a ciascuno ciò che gli compete secondo i suoi meriti, e il merito é determinato dall’obbedienza ai comandi di Dio, la quale dunque deve essere liberamente prestata. Le tesi sostenute da Scoto apparvero pericolose a Incmaro, che , per evitare di essere coinvolto , disse che lo scritto era una falsificazione; esso fu però ugualmente condannato nei concili di Valence (855) e di Langres (859). Tuttavia Scoto non interruppe la sua attività presso la corte di Carlo il Calvo, anche se non si ha più notizia di lui dopo la morte del re avvenuta nell’ 877. Nell’ 827 il figlio di Carlo Magno, Ludovico Pio, aveva ricevuto in dono dall’imperatore di Bisanzio, Michele, una copia degli scritti attribuiti a Dionigi l’Areopagita, i quali venivano tradotti in latino. Verso l’ 858 Scoto, che conosce il greco, li ritraduce su incarico di Carlo il Calvo; successivamente egli traduce anche uno scritto di Massimo il Confessore oltre a La creazione dell’uomo di Gregorio di Nissa , e scrive un’Omelia al prologo del Vangelo di Giovanni. Ispirato da questi lavori, egli matura la sua opera fondamentale, intitolata Peri fusewn (Periphyseon), ossia Sulle nature, conosciuta anche come La divisione della natura; essa ha la forma di un dialogo tra maestro ed allievo ed é composta di 5 libri. Il compito fondamentale che anche Scoto si pone é la comprensione della Scrittura (in particolare del libro della Genesi) , che , contenendo la parola di Dio, costituisce l’auctoritas; ma ad essa Scoto affianca anche le auctoritates dei Padri della Chiesa: quando queste sono in disaccordo, é la ragione che opta per la soluzione migliore. Tra la vera ragione e la vera autorità non può esserci alcun contrasto, perchè entrambe provengono da un’unica sorgente , la sapienza divina. Alla base dell’autorità, tuttavia, c’é la ragione: infatti mentre l’autorità ha bisogno della conferma e del sostegno della ragione, la ragione non ha bisogno di quello dell’autorità. La ricerca razionale é dunque pienamente giustificata, in quanto le verità alle quali essa conduce non possono che coincidere con le verità della religione. La divisione a cui allude il titolo dell’opera di Scoto é la procedura della dialettica, di cui aveva parlato Platone, consistente nell’articolazione di una nozione generale nelle sue specie o parti . La nozione che Scoto sottopone a divisione é quella di natura, comprensiva di tutto ciò che é e non é (quest’ultimo inteso, alla maniera platonica, come negazione e alterità rispetto a ciò che é, non come una sostanza vera e propria). La natura universale si articola in quattro nature, che rappresentano il procedere delle creature da Dio e il loro ritorno a Dio . La prima natura non é creata e crea: questa prerogativa é propria di Dio, che non é creato da nulla e non dipende da una causa o un principio superiore. A proposito di Dio, Scoto riprende gli insegnamenti della teologia negativa di Pseudo-Dionigi: Dio é al di là di tutto ciò che l’intelletto può comprendere. Egli é anche oltre l’essere, ma il suo non essere non é interpretabile come privazione, ma indica piuttosto la sua superiorità, il suo non essere nessuna delle creature finite e delle loro proprietà: è nihil per excellentiam. In questo senso, si può anche dire che Dio é super-essenza. I nomi sono solo metafore, quando sono applicati a Dio, e ciò che la ragione può fare é appunto dimostrare che nulla si può propriamente affermare di Dio. Ma poichè Dio, in quanto crea, é in tutte le creature, può essere conosciuto nelle sue creature: questa manifestazione di Dio nelle cose é la teofania. La tesi secondo cui Dio é nelle creature attirerà su Scoto l’accusa di panteismo, ma in realtà egli ha sempre accompagnato quest’affermazione con il riconoscimento che Dio é anche al di sopra di tutte le creature. La seconda natura è creata e crea. Il primo momento della “processione” delle cose create da Dio é rappresentato dal mondo intelligibile. Esso é costituito dalle cause primordiali di tutte le cose, le quali sono nel Logos e quindi sono coeterne a Dio. Esse sono quelle che la tradizione platonica chiamava idee, modelli o archetipi delle cose. A differenza dei platonici, tuttavia, Scoto non ricorre alla nozione di anima del mondo, nè interpreta antropomorficamente il processo della creazione. In Dio conoscere e fare coincidono, cosicchè la creazione é un atto che scaturisce necessariamente da Dio. Per questo la prima natura creata é costituita dalle idee universali e non dagli esseri empirici accidentali, suscettibili di generazione e corruzione; dalle idee procedono poi , articolandosi, i generi e le specie. Generi e specie sono dunque le realtà autentiche , mentre le cose individuali posseggono realtà solamente in quanto partecipano dei generi e delle specie: così, per esempio, la vera realtà di Socrate é data dal suo essere uomo, più che dalle particolarità strettamente individuali e accidentali che lo riguardano. Il grado di realtà aumenta in proporzione all’universalità, sicchè le vere sostanze, più che gli individui, sono i generi e le specie di cui gli individui partecipano e da cui dipende il loro essere. I primi momenti della teofania sono pertanto le idee o forme primordiali di tutte le cose, che vengono articolandosi in generi e specie. La terza natura é creata e non crea. Essa é il mondo sensibile, che procede dalle forme o cause primordiali, che ne costituiscono insieme il modello e la struttura. E’ il mondo nella sua molteplicità, dispersione e caducità. Infatti, il passaggio dal mondo intelligibile a quello sensibile é frutto del peccato dell’uomo. Adamo, se non avesse peccato, sarebbe rimasto nel mondo puramente intelligibile, senza assumere la corporeità: tra la natura angelica e quella umana ci sarebbe stata identità. E’ l’anima umana dunque ad essere responsabile di tutto ciò che esiste al di sotto del mondo intelligibile, a partire dal proprio corpo mortale. Come si é visto, le cose individuali hanno il loro vero essere nelle nozioni universali di cui esse sono solo un’esemplificazione. Ma queste nozioni universali sono presenti anche nell’intelletto umano: é dunque dall’intelletto che procedono le vere sostanze delle cose . Ciò significa che nel processo della teofania l’uomo occupa una posizione intermedia tra l’intellegibile e il sensibile, in virtù rispettivamente del suo intelletto e del corpo . Propriamente il corpo é dell’uomo, non é l’uomo. Nonostante il peccato, l’anima umana, in quanto immagine di Dio, rimane incorruttibile. E’ dunque ritornando nell’uomo, cioè nel suo intelletto, che tutto si avvia lungo la strada del ritorno a Dio. Dio infatti, oltre che principio, é anche fine di tutte le cose. Il ritorno a Dio inizia già dal mondo sensibile: il corpo si decompone nei quattro elementi e con la resurrezione si spiritualizza , lo spirito torna alle cause primordiali che sono nel Logos e tutto torna allo stato originario che l’uomo, peccando, aveva perduto. Il punto terminale é diventare uno con Dio, adunatio o deificatio. Ma, a differenza di quanto pensavano i neoplatonici antichi, ciò non comporta la perdita dell’individualità delle differenti nature; nè il “diventare Dio” elimina la trascendenza di Dio stesso. La quarta natura non è creata e non crea: essa è il fine, il punto di arrivo di questo processo ; essa viene a coincidere con la prima natura, cosicchè il cerchio si chiude. La contemplazione é un momento importante in questo processo di ritorno a Dio, ma la conoscenza razionale non é per Scoto il fine della vita intellettiva, poichè non é in grado di cogliere Dio, che resta imperscrutabile per essa. Di qui l’esaltazione del non sapere e dell’ignoranza, come momenti essenziali dell’ascesa a Dio “si conosce meglio non sapendo”, afferma Scoto. Per questo aspetto il ritorno é mistico, comporta un andare oltre la razionalità , come avevano sostenuto i neoplatonici. Ma il ritorno é anche un processo dell’intero universo: attraverso e con l’uomo, tutte le cose si salvano e tornano a Dio. Il presupposto di ciò é la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo: nell’uomo si compendia e raccoglie l’intero universo creato. Per tornare a Dio non basta la volontà dell’individuo, occorre il Logos mediatore, che, incarnandosi nello spazio e nel tempo, e assumendo veste umana, in quanto Dio fatto uomo riporta nella sua condizione ideale la realtà umana decaduta a causa del peccato originale. Anche l’Incarnazione assume dunque un significato cosmico. In tal modo Scoto Eriugena intreccia, in un equilibrio sempre pericolante, il modello neoplatonico , eterno e atemporale, della processione e del ritorno a Dio con il racconto biblico della creazione, del peccato, della redenzione e della resurrezione finale, che si svolgono nel tempo.
PASSI DALLE OPERE
De divisione Naturae, I
1 Maestro: Su questa questione non so chi potrebbe parlare in breve o con chiarezza; infatti, o si deve tacere […] o ci si deve affidare alla semplicità della fede ortodossa, dal momento che si tratta di una questione che supera ogni intelletto, cosí come è stato scritto “solo tu che hai l’immortalità abiti la luce inaccessibile”. Se qualcuno comincia a discutere su questi argomenti, necessariamente, in molti modi e con molte argomentazioni, persuaderà nella maniera piú giusta che si devono usare le due principali parti della teologia: quella affermativa, che i Greci chiamano kataphatiké, e quella negativa, che chiamano apophatiké. Sola la negativa nega che la divina essenza o sostanza sia qualcuna delle cose che sono, che possono essere dette o capite. L’altra invece predica dell’essenza divina tutte le cose che sono, quindi si dice affermativa, non tanto perché dichiara che essa [la sostanza divina] sia qualcuna delle cose che sono, ma perché sostiene che tutte le cose che derivano da quella essenza possono essere dette di essa. Razionalmente, infatti, si può capire che gli effetti significano la causa. Dice infatti che ci sono Verità, Bontà, Essenza, Luce, Giustizia, Sole, Stella, Soffio, Acqua, Leone, Città, Verme e tutte le cose innumerabili. E non solo insegna che l’essenza divina è quelle cose conformi alla natura divina, ma anche quelle ad essa contrarie, quando dice che Dio si inebria ed è folle e stolto. Ma non vogliamo ora discutere di queste cose; su tali argomenti, infatti, Dionigi l’Areopagita ha scritto la Teologia simbolica. Torniamo pertanto a ciò che hai chiesto, cioè se di Dio si possono predicare propriamente tutte le categorie, o solo alcune di esse.
2 Discepolo: Certamente bisogna tornarvi, ma prima penso che bisogna considerare perché i predetti nomi, cioè essenza, bontà, verità, giustizia, sapienza, e gli altri di questo genere, che sembrano non solo divini, ma anzi divinissimi e tali da non significare nient’altro all’infuori dell’essenza o sostanza divina, diventino metaforici, cioè traslati dalla creatura al Creatore, secondo quello che dice il predetto santissimo padre e teologo. Non lo avrà detto, infatti, senza una mistica e segreta ragione.
3 M.: […] Vorrei che tu mi dicessi se puoi pensare qualcosa di opposto o di necessariamente connesso [cointellectum] con Dio. Dico opposto o per privazione, o per contrarietà, o per relazione, o per assenza; intendo poi per connesso necessariamente qualcosa che si pensi essere insieme eternamente con lui, pur senza essere della sua stessa essenza.
4 D.: […] Non oserei affermare né che qualcosa gli sia opposto, né che essendo necessariamente con lui sia eteroúsion, ossia diverso per essenza da lui. Infatti gli opposti per relazione sono sempre opposti, dal momento che insieme hanno inizio e insieme cessano di esistere, perché sono della medesima natura, come il semplice e il doppio, i due terzi e i tre mezzi; cosí gli opposti per negazione, come è e non è; o per privazione, come morte e vita; o per contrarietà, come vigore e debolezza. Ma queste opposizioni si attribuiscono correttamente alle cose sensibili o intelligibili, e perciò non sono in Dio. Infatti le cose che si oppongono fra loro non possono essere in Dio, poiché se fossero eterne non potrebbero opporsi. L’eternità, infatti, è simile a se stessa e sussiste tutta per tutto, semplice, una e indivisibile. Il principio e il fine di tutte le cose è uno, in nulla discordante da sé. Per la stessa ragione non so chi oserebbe affermare che è coeterna a Dio una cosa che non è della sua stessa essenza. Infatti, se si potesse pensare questo si potrebbe concludere che il principio di tutte le cose non è uno, ma due o piú, differenti fra loro. Il che è rifiutato dalla vera ragione, perché giustamente tutte le cose derivano da un principio e nessuna da due o piú.
M.: Ragioni bene, mi sembra. Se dunque i predetti nomi divini hanno altri nomi a sé opposti, necessariamente si oppongono anche le realtà che essi propriamente significano e perciò non possono predicarsi propriamente di Dio a cui nulla è opposto e al quale nulla di diverso è coeterno. La vera ragione, infatti, non ha ancora trovato un nome, fra quelli ricordati o fra altri simili, del quale non esista un nome opposto o nel medesimo genere o fuori. E ciò che è vero dei nomi è necessariamente vero della realtà da essi significata. Per esempio, Dio si dice “essenza”, ma non è propriamente quella essenza a cui si oppone il “nulla”, Dio, dunque è yperoúsios, cioè sovraessenziale. Cosí si dice bontà, ma non è propriamente bontà, poiché a questa si oppone la malizia; è dunque yperagathós, piú che buono, e yperagathótes, cioè piú che bontà. […]
5 M.: [Pertanto non c’è contraddizione fra la teologia affermativa e quella negativa] […] Per esempio, la teologia affermativa dice: Dio è verità; la teologia negativa dice: non è verità. Qui sembra che ci sia una forma di contraddizione, ma quando si guarda meglio si vede che non c’è contraddizione. Infatti, quella che dice “Dio è verità” non afferma che la sostanza divina sia propriamente verità, ma che essa può essere chiamata cosí per una metafora dalla creatura al Creatore: veste infatti con tali vocaboli l’essenza divina nuda e scevra di ogni propria significazione. E quella che dice “non è verità”, non nega che sia verità, ma che sia e si possa chiamare propriamente verità. La teologia negativa sa di spogliare la divinità di tutti quei significati dei quali l’affermativa la riveste. Una, infatti, dice, per esempio, “è sapienza”, rivestendola di questo attributo; l’altra dice “non è sapienza”, e di questo attributo la spoglia. Una dunque dice: la divinità non si può chiamare cosí; ma non dice: la divinità è propriamente questo; l’altra dice: non è cosí, sebbene si possa chiamare cosí.
6 D.: Vedo chiaramente queste cose e mi è chiaro piú della luce che le cose che finora mi parevano opposte ora si accordano e non dissentono fra loro, quando si considerano in Dio.
[…]
7 M.: […] Non dobbiamo forse considerare nel medesimo modo il valore di tutte le parole che la Sacra Scrittura predica della Natura divina, ritenendo cosí che esse non significano altro che la semplice, immutabile, essenza e sovraessenza, incomprensibile da ogni intelligenza? Per esempio, quando sentiamo dire che Dio vuole e ama e vede e ode e altre espressioni che si possono predicare di lui, dobbiamo pensare che con queste espressioni a noi naturali si vuole rivolgere la nostra mente alla sua ineffabile essenza e virtú, affinché la vera e pia religione cristiana non taccia del Creatore a tal punto da non dire nulla, per istruire l’animo dei semplici e per combattere le astuzie degli eretici, che sempre insidiano la verità e si sforzano di toglierla dall’animo degli altri e desiderano ingannare coloro che sono meno eruditi. Quelle espressioni fanno capire che in Dio non sono distinti essere, volere, amare, vedere, e altre cose simili, ma che in lui significano la stessa cosa.
8 D.: Precisamente. Dove infatti è la vera ed eterna semplicità è impossibile che vi sia il molteplice e il diverso.
ROSCELLINO
La vita
Roscellino di Compiégne (1050- ca. 1125) monaco filosofo e teologo francese, nacque a Compiégne (a nord est di Parigi) nel 1050 e fu attivo dal 1087 come maestro della scuola Scolastica a Compiégne, Loches e a Tours.
Ebbe contatti con Sant’Anselmo (1033-1109) e Lanfranco di Canterbury (1005-1089), l’oppositore delle teorie di Berengario di Tours, ed ebbe molti allievi, tra i quali si distinse Pietro Abelardo, successivamente suo accanito contestatore.
Al concilio di Soissons del 1093, Roscellino fu accusato di triteismo, ma abiurò sotto la minaccia della scomunica. Successivamente viaggiò in Inghilterra, Italia e Francia, dove fu addirittura bastonato dai canonici della scuola di San Martino di Tours per una diatriba teologica. Così almeno raccontò Abelardo, che lo dipinse, non certo in maniera lusinghiera, come un uomo arrogante ed intemperante.
Morì verso il 1125.
Il pensiero
Roscellino contribuì all’elaborazione della dottrina del nominalismo nel trattato De generibus et speciebus, attribuitogli da alcuni esperti, poiché nulla di sicuramente suo ci è giunto. Si è conservata soltanto una sua lettera indirizzata al suo allievo Abelardo. La ricostruzione del suo pensiero è ricostruibile solo attraverso le critiche che ad esso mossero i suoi avversari (Abelardo e Anselmo da Aosta), tenendo presente che – come sempre accade – chi critica un pensiero tende a strumentalizzarlo, a distorcelo, a semplificarlo per renderlo meglio attaccabile.
Nello scritto De generibus et speciebus, Roscellino avrebbe sostenuto che solo le singole essenze esistevano, mentre i generi e le specie erano concetti universali, noti come semplicemente “universali”.
Per Roscellino, gli universali non esistevano nella realtà, come invece le essenze, ma erano solo segni convenzionali o parole (voces) o nomi. La loro unica funzione era di muovere l’aria quando venivano pronunciati: essi, secondo la celeberrima tesi di Roscellino, non sono che flatus vocis, ossia “soffi di voce” privi di esistenza autonoma. Infatti – come abbiamo testè visto – soltanto gli individui sono reali, mentre gli universali, o concetti generali, sono semplicemente nomi, puri suoni che vibrano nell’aria.
Lungi dall’esistere ante rem (alla maniera platonica) o in re (alla maniera aristotelica), gli universali (“uomo”, “cavallo”, ecc) esistono solo post rem, ossia a monte delle singole realtà individuali: gli universali, infatti, sono solo vibrazioni sonore ed hanno esistenza solo nelle parole che essi esprimono (la parola “uomo”, la parola “cavallo”, ecc). Non vi è un concetto di “uomo” dato come idea stante prima rispetto alla realtà (come credeva Platone), né vi è un concetto di “uomo” calato nei singoli uomini effettivamente esistenti (come credeva Aristotele). Esistono soltanto soffi di voce che derivano dalle singole realtà empiriche considerate complessivamente: “nihil est praeter individuum”. Questo è il nocciolo concettuale del “nominalismo” di Roscellino.
Contro questa concezione si schierarono i realisti, capeggiati da Sant’Anselmo, che facevano corrispondere gli universali a idee nella mente di Dio, da cui l’impianto ontologico di Anselmo, contestato dal monaco Gaunilone.
Ma Roscellino venne anche accusato di togliere ogni distinzione fra le tre Persone della Trinità: seguendo infatti il suo ragionamento fino alle estreme conseguenze a cui esso portava, era impossibile affermare l’esistenza di una essenza divina in tre persone, quindi dovevano esistere tre divinità separate. Per un nominalista coerente quale Roscellino non possono infatti che esistere i casi individuali (questo uomo qui, questo cavallo qui, ecc), senza dover postulare l’universale “uomo” o “cavallo”: sicché non è ammissibile che una cosa partecipi di tre idee distinte. Sicché, applicando questa teoria alla dottrina cristiana della Trinità, egli asserì che la Trinità deve essere costituita di tre distinte persone divine, e che l’unità tradizionalmente ascrittale è essenzialmente verbale, o nominale: in questo modo, egli faceva del Cristianesimo una sorta di politeismo avente ben tre divinità distinte.
Per questo motivo Roscellino, come si è detto, fu accusato di triteismo al concilio di Soissons e fu costretto ad abiurare.
Per sfuggire alla persecuzione che si abbattè su di lui e sulle sue teorie, giudicate eretiche, si rifugiò in Inghilterra, ma le sue teorie lo portarono nuovamente al contrasto, questa volta con Anselmo da Aosta, allora arcivescovo di Canterbury. Roscellino fece infine ritorno a Roma per riconciliarsi con la Chiesa.
Nella sua ferrea contrapposizione al realismo, il nominalismo estremo di Roscellino aprì la via alla filosofia moderna, incentrata nella conoscenza scientifica della natura e dell’uomo, prescindendo da ogni condizionamento metafisico.
ANSELMO DA AOSTA
INTRODUZIONE AL PENSIERO
Difensore di una ricerca tenente conto della fede, ma non per questo sbarazzantesi della ragione, Anselmo (nato ad Aosta nel 1033) entrò nell’abbazia benedettina di Bec in Normandia , dove era abate Lanfranco di Pavia , e nel 1066 divenne monaco . Successe poi a Lanfranco dapprima nella carica di abate , nel 1078 , e , nel 1093 , in quella di arcivescovo di Canterbury . Qui si trovò a dover difendere le prerogative e l’ autonomia della Chiesa contro i sovrani normanni d’ Inghilterra , sino alla sua morte avvenuta nel 1109 . Verso il 1076 compose il Monologio , cioè soliloquio , da lui considerato “un esempio di meditazione” sulle ragioni della fede . Nei due anni successivi scrisse il Proslogio , cioè colloquio , intitolato anche (con espressione agostiniana) “Fides quaerens intellectum” (la fede alla ricerca di intendimento): è importante il fatto che Anselmo parli di intelletto e non di ragione, poiché il primo è uno strumento intuitivo, mentre la seconda è, piuttosto, un’arma discorsiva. Dopo che il monaco dell’ abbazia di Marmoutier , Gaunilone , intervenne nella discussione sul problema dell’ esistenza di Dio , affrontato da Anselmo nel Proslogio , con un “Libro in difesa dell’insipiente”, Anselmo compose un “Libro apologetico contro Gaunilone”. Altri scritti di epoca probabilmente successiva sono : “Sulla verità”, “Sulla libertà di arbitrio”, “Sul grammatico”, “Sulla concordia della scienza e della predestinazione”. Verso la fine della sua vita Anselmo compose il “Perchè Dio si é fatto uomo”. Anselmo è uno dei pochi pensatori dell’età medioevale che lasci note personali alle proprie opere, alle quali era legato da un attaccamento quasi museale (addirittura suddivide egli stesso i suoi scritti in capitoli). E’ originario di Aosta, ma ben presto si spinge fino in Borgogna, dove riceve notizie dell’abate del Bec (piccolo paese nell’attuale Normandia), Lanfranco di Pavia (anch’egli italiano), e decide di trasferirsi colà. Improvvisamente Lanfranco è richiamato da Guglielmo il conquistatore, che lo vuole vescovo di Canterbury: sarà Anselmo a prendere il suo posto una volta che Lanfranco morirà, rivelando però (a differenza di Lanfranco) una personalità schiva e avversa ai compromessi e, in forza di ciò, entrerà in conflitto col re d’Inghilterra, che arriverà ad esiliarlo (il papa interverrà in merito solo tiepidamente). L’intera produzione anselmiana risale tuttavia al suo soggiorno nel Bec, quando il filosofo aostano era immerso nella quiete del monastero. Gli interessi di Anselmo orbitano soprattutto (ma non solo) intorno alla questione dell’esistenza di Dio, ch’egli prova a dimostrare percorrendo due diverse vie: la prima – intrapresa nel Monologion – è quella che sarà detta “a posteriori”, poiché parte dagli effetti, ossia dagli enti che popolano il mondo sensibile e cadono continuamente sotto i nostri sensi, per risalire a ciò che li ha causati (Dio). Nel Proslogion, invece, egli imbocca una strada alternativa, radicalmente nuova rispetto a tutta la tradizione occidentale: si tratta della celebre “prova ontologica”, con la quale Anselmo dimostra l’esistenza di Dio lavorando esclusivamente sul concetto stesso di Dio. Pur dichiarando egli di partire da null’altro all’infuori della ragione, il punto di partenza di Anselmo é la fede nella verità rivelata da Dio e contenuta nelle Sacre Scritture: ad esse, che costituiscono l’auctoritas per eccellenza, si affiancano gli insegnamenti dei Padri della Chiesa. Il programma di Anselmo é compendiabile nel detto credo ut intelligam (“credo per comprendere”), il suo intento é di approfondire le ragioni (intelligere) che sono presenti nei contenuti della fede , nella misura in cui ciò é possibile nella condizione terrena . La comprensione , però , non é veramente possibile se non si ha la fede ; ragione e fede non sono dunque due ambiti separati o addirittura contrastanti , nè esiste una distinzione fra teologia e filosofia . Nel Monologio , Anselmo dice di scrivere su richiesta dei suoi confratelli quanto egli aveva esposto oralmente sull’ esistenza di Dio , allo scopo di offrirlo come esempio alla loro meditazione . Egli non intende però avvalersi di un procedimento che faccia ricorso all’ autorità delle Scritture e dei Padri ; vuole invece convincere mediante argomenti razionali , accessibili a tutti . O meglio , egli intende mostrare come può arrivare a Dio anche chi ancora ignora , o perchè non ascolta la parola di Dio o perchè non crede. Scrive dunque un monologo , fatto di argomenti cogenti , come preliminare alla meditazione . L’ obiettivo del Monologio é , infatti , quello di mostrare che esiste una natura somma , più alta di tutte le cose esistenti , eternamente beata e autosufficiente , la quale dà l’ essere a tutte le altre cose , rendendole buone in virtù della propria bontà . A tale scopo , Anselmo ricorre ad alcune argomentazioni , che hanno in comune il fatto dalla considerazione delle cose del mondo . Questo tipo di dimostrazioni saranno poi dette ” a posteriori ” , in quanto procedono dagli effetti che vengono dopo ( le cose sensibili create ) per risalire alla loro causa ( Dio ) . Il nocciolo di esse é che il mondo sensibile costituisce un ordine gerarchico di beni e di perfezioni , ma questi beni e perfezioni sono tali in virtù di un bene e di una perfezione , che non dipende a sua volta da altro : esso é il sommo bene e la somma perfezione . Il presupposto di questi ragionamenti é platonico: tutte le cose buone sono tali in quanto partecipano del bene e a causa del bene . Con la ragione si é dunque arrivati a dimostrare che esiste una natura superiore a tutte le altre , la quale non ha nulla sopra di sé : questa natura somma ha nome ” Dio ” . Si é così propriamente dimostrato non tanto che Dio esiste , quanto che esiste una natura somma , alla quale si può dare il nome ” Dio ” . La nozione di Dio non é il punto di partenza , ma il punto di arrivo : é il predicato che , a conclusione , viene attribuito al soggetto , che é la natura somma o sommo bene , per dirla alla Platone. Nel Proslogio Anselmo si chiede se sia possibile trovare un unico argomento , capace di dimostrare da solo che Dio esiste ed é il Sommo Bene . Diversamente dal Monologio , ora Dio é all’ inizio dell’ indagine il cui punto di partenza é la nozione di Dio che si ha grazie alla fede . L’ obiettivo diventa ora propriamente ” comprendere ciò che Dio crede ” , ossia fides quarens intellectum . Il discorso assume la forma di un dialogo con lo stolto ( insipiens ) , di cui si parla in uno dei Salmi e che in cuor suo dice che Dio non esiste . Insipiente qui significa stolto in quanto nega l’ esistenza di Dio , non in quanto non intende la parole o non coglie il significato delle definizioni o la cogenza di un’ argomentazione . Ma prima di procedere nel colloquio con l’ insipiente , Anselmo assume un punto di partenza di chiara impronta agostiniana: la preghiera a Dio per ottenere il suo aiuto e la sua illuminazione e poter comprendere che egli esiste . E’ la fede infatti che fa credere che Dio , a cui Anselmo rivolge la sua preghiera , é ” qualcosa di cui non si può pensare nulla di maggiore ” . Anche l’ insipiente , che dice dentro di sè che Dio non esiste , comprende ciò che sente , ossia questa definizione o questo appellativo di Dio ; e ciò che egli intende é nel suo intelletto , anche se egli comprende che esiste anche nella realtà . Anche l’ insipiente dunque é convinto che almeno nell’ intelletto esiste il concetto di qualcosa di cui non si può pensare nulla di maggiore . Ma ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore non può esistere solo nell’ intelletto . Prende di qui avvio la confutazione dell’ insipiente , ossia quella che sarà detta in seguito prova ontologica dell’ esistenza di Dio (e che sarà smontata in età illuministica da Kant, per poi essere ripresa come valida da Hegel). La sua caratteristica é di partire non dalla considerazione delle cose del mondo , bensì dalla sola nozione di Dio ; in questo senso sarà anche detta a priori . Essa procede per via indiretta , ossia assumendo per vera la tesi dell’ avversario . Ammettiamo , come fa l’ insipiente , che ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore esista solo nell’ intelletto . Sempre rimanendo all’ interno dell’ intelletto , é possibile pensare che ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore esista anche nella realtà , oltre che nell’ intelletto , e che pertanto esso , esistendo anche nella realtà , sia maggiore di ciò che esiste solamente nell’ intelletto . Ma é contraddittorio che di una stessa cosa si possa pensare qualcosa di maggiore e , al tempo stesso , nulla di maggiore : tale é appunto la nozione dell’ insipiente che ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore esiste solo nell’ intelletto ; di essa infatti si é potuto pensare qualcosa di maggiore . Se non si vuole cadere in questa contraddizione , occorre allora riconoscere che ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore esiste , oltre che nell’ intelletto , anche nella realtà . La dimostrazione di Anselmo assume implicitamente , senza dimostrarle , alcune premesse come evidenti di per sè . In primo luogo , assume che l’ insipiente che nega l’ esistenza di Dio sia in grado di comprendere la nozione di qualcosa di cui non si può pensare nulla di maggiore ; altra assunzione é che ciò che si comprende esiste nell’ intelletto ; e infine che ciò che esiste nell’ intelletto e nella realtà é maggiore di ciò che esiste solo nell’ intelletto . In una certa misura , quest’ ultima assunzione si collega alla dottrina dei gradi di perfezione , già utilizzata nel Monologio . La prova di Anselmo sarà sovente discussa , accettata o criticata nella storia della filosofia , ma il primo a tentare di confutarla fu il monaco Gaunilone nel suo Libro in difesa dell’ insipiente . Secondo Gaunilone non é detto che l’ insipiente , per il solo fatto di udire la parola di Dio , ne abbia anche la nozione o ne comprenda il significato : infatti per intendere il significato di una parola o di una definizione occorre aver percepito l’ oggetto indicato da esse , ma questo non é il caso della parola di Dio , visto che l’ insipiente non ha avuto l’ esperienza diretta di Dio . Per lui la parola di Dio potrebbe essere solo un suono . Inoltre , é possibile avere nell’ intelletto una nozione , per esempio quella di isola , e attribuire ad essa ogni perfezione , ma ciò non autorizza a concludere che perciò quest’ isola esiste anche nella realtà . A ciò Anselmo risponde che non si deve confondere il concetto di ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore con il concetto di ciò che é maggiore di altro . Di quest’ ultima tipo é il concetto di isola perfettissima : essa é tale rispetto a tutte le altre isole , ma non é ciò di cui non é possibile pensare nulla di maggiore . Il confronto con Gaunilone consente di chiarire la prospettiva di Anselmo . Per Gaunilone l’ ascolto della parola non dà luogo nell’ intelletto ad un concetto corrispondente a ciò che si é udito : chi dice che ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore sia l’ idea di Dio ? Inoltre dall’ esistenza di una nozione nell’ intelletto non si può inferire l’ esistenza di ciò che é indicato da essa . Nel discorso di Gaunilone s’ interrompe il legame di continuità tra parola , concetto e realtà ; egli pertanto isola l’ argomentazione di Anselmo dal contesto nel quale é inserita . L’ insipiente di cui parla Gaunilone si arresta alla parola ” Dio ” e non comprende che cosa essa significhi e , dunque , nega l’ esistenza di Dio : é fuori dalla sua prospettiva la considerazione della parola come rivelazione divina . Anselmo , infatti , controbatte : come fai tu , un cristiano , a obiettare ciò ? Anche lo stolto che dice che Dio non esiste , deve dare un senso alla parola Dio . Infatti si usano parole , secondo Anselmo , solo se hanno un significato ; in caso contrario l’ insipiente non dice nulla . Nello scritto Sulla verità , Anselmo interpreta la verità come corrispondenza ( rectitudo ) tra le proposizioni e lo stato delle cose che esse enunciano . La proposizione che dice le cose come sono manifesta la verità , cioè la conformità con le cose che essa dice , ma , come dice Anselmo in un altro scritto , Sul grammatico , ” le cose stanno come le ha pensate e dette , in principio , il Logos , nella somma verità ” . A fondamento della conoscenza e del linguaggio umana vi é dunque la parola creatrice di Dio . Dio é verità assoluta , fondamento di ogni verità . Dire la verità da parte dell’ uomo é quindi al tempo stesso conformarsi alla parola di Dio e dire le cose come devono essere dette . Nell’ impostazione di Anselmo conoscenza , atteggiamento morale e fede si saldano inscindibilmente . La fede consiste così nell’ aderire con amore alla parola di Dio . Nella mente umana , come già aveva indicato Agostino, si manifesta un’ immagine della Trinità . Credere in Dio comporta un coinvolgimento non solo dell’ intelligenza , ma anche dell’ amore e della volontà , che spingono alla ricerca della visione diretta di Dio , ma al tempo stesso si avverte che Dio é inattingibile e che solo per iniziativa di Dio stesso se ne può avere una qualche visione parziale . Anselmo é convinto che i più alti misteri della fede sono incomprensibili , ma ciò suscita un impegno ancor maggiore da parte della ragione . Il cristiano sa per fede che Dio si é incarnato , ma deve anche cercare una risposta alla domanda , che fa da titolo a un altro suo scritto : Perchè Dio si é fatto uomo ? La spiegazione di Anselmo é che Dio ha creato l’ uomo allo scopo di consentirgli di essere beato , ma il peccato originale ha prodotto una colpa nei confronti di Dio , per riparare la quale non basta l’ obbedienza prestata a Dio stesso . Sembrerebbe , dunque , che il peccato abbia annullato lo scopo perseguito da Dio nel creare l’ uomo , ma ciò sarebbe assurdo , perchè qualsiasi scopo perseguito da Dio non può non realizzarsi Occorre allora che la grave colpa commessa nei confronti di Dio riceva una riparazione adeguata ad essa , e questa può essere data solamente da un Dio che é anche uomo e sconta la pena del peccato originale . In tal modo Anselmo mostra che l’ Incarnazione presenta una sua razionalità , é cioè spiegabile mediante ragione . Sullo sfondo di questa argomentazione e , in generale , della concezione di Dio di Anselmo , si é anche ravvisata l’ immagine di un sovrano feudale , che comanda ai suoi vassalli e a tutti richiede il servizio e le riparazioni dovute . Ma si tratta anche di un Dio che non impone una costrizione alla libertà umana . Questo tema é affrontato da Anselmo in 2 opere , Sulla libertà di arbitrio e Sulla concordia della prescienza e della predestinazione nonchè della grazia di Dio con il libero arbitrio , quest’ ultima composta nel 1109 . In entrambe , come in generale nell’intera produzione di Anselmo , é evidente l’ influenza della riflessione di Agostino, anche se ne sono smussate alcune punte pessimistiche . Secondo Anselmo , la libertà , per essere tale , non può essere costretta nè da necessità esterne nè da una necessità interna , come per esempio l’ istinto . Tuttavia la libertà non é possibilità di scelta tra peccato e non peccato , perchè , se così fosse , nè Dio nè gli angeli sarebbero liberi , dal momento che essi non possono peccare . In realtà la capacità di peccare diminuisce la libertà , che consiste invece nella capacità di conservare la ” rettitudine della volontà ” . Questa é volere ciò che Dio vuole che si voglia e può essere persa solo per un atto della volontà umana . Solo la grazia divina quindi può restituire all’ uomo la rettitudine della volontà , e la libertà diventa allora capacità di conservare questa rettitudine , quando essa é ridata all’ uomo da Dio . La libertà umana non é limitata neppure dalla prescienza e dalla predestinazione divina : Dio prevede tutte le azioni future , ma le prevede libere . Così anche nella predestinazione degli eletti alla salvezza Dio non impone alcuna necessità : sono salvati quelli di cui Dio conosce anticipatamente la rettitudine della volontà . Testimonianza della grande fortuna che arrise ad Anselmo è il fatto che Dante lo collochi nel “Paradiso” (Paradiso, XIII, 130-138):
Illuminato ed Agositin son quici,
Che fur de’primi scalzi poverelli,
Che nel capestro a Dio si fêro amici.
Ugo da Sanvittore è qui con elli,
E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano,
Lo qual giù luce in dodici libelli;
Natan Profeta, e’l metropolitano
Crisostomo ed Anselmo e quel Donato,
Ch’alla prim’arte degnò por la mano.
MONOLOGION
Nel proemio del Monologion scrive Anselmo: “alcuni confratelli mi pregarono ripetutamente di scrivere per loro come esempio di meditazione le cose che avevo loro esposto circa Dio con linguaggio ordinario”. L’opera è dunque una rielaborazione di discorsi tenuti da Anselmo coi suoi confratelli del monastero e, leggendola, si nota come egli non lasci alcuna questione in sospeso, ma risponda a tutte le possibili obiezioni degli interlocutori. Egli si propone di non ricorrere all’ausilio delle attestazioni della rivelazione, ma di limitarsi all’uso della ragione, arrivando in tal senso a trovare in essa una luce in grado di rischiarare gli atti di fede e le Verità rivelate, “e tutto ciò con stile piano e argomenti accessibili a tutti”, senza trascurare anche le più semplici e sciocche obiezioni. Come Anselmo stesso racconta nel proemio, in un primo momento rifiutò di comporre l’opera, nonostante le assillanti richieste dei suoi confratelli, adducendo anche futili scuse (quali quella di non essere all’altezza del lavoro), ma alla fine, seppur controvoglia per via della difficoltà dell’argomento e – a suo dire – della debolezza del suo ingegno, accetta l’impresa, convinto che lo scritto sarebbe circolato esclusivamente all’interno del monastero, senza prevedere che in realtà ben preso si sarebbe diffuso per l’intera Europa, con un successo editoriale straordinario (addirittura c’era gente che lo imparava a memoria). Rileggendo lo scritto, Anselmo nota l’impressionante vicinanza del suo pensiero con quello di Agostino, e quando Lanfranco lo accusa per via epistolare di aver fatto troppo affidamento sulla ragione, egli ribatte che si è limitato a reinterpretare il “De Trinitate” agostiniano in chiave razionale, arrivando con l’uso della ragione alle stesse Verità attestate dalla Rivelazione; in particolare, egli noterà come la Trinità, da lui intesa nello scritto come “tre sostanze” (e non “tre persone”, secondo la Rivelazione), è concepita in piena sintonia con gli insegnamenti dei Padri greci, ad avviso dei quali sostanza è effettivamente sinonimo di persona (viene così scongiurato ogni possibile equivoco). Come abbiamo detto, nel “Monologion” ci imbattiamo in una dimostrazione “a posteriori” dell’esistenza di Dio, un’argomentazione che si articola in tre punti ben distinti: il punto di partenza da cui Anselmo muove è il mondo sensibile, nella sua datità e nella sua inevitabile inspiegabilità; l’unica strategia per render conto di esso è far riferimento ad un ente (Dio appunto) che, con una creazione “ex nihilo”, l’abbia creato; anche se il termine “ex nihilo” desta non pochi problemi, sui quali Anselmo si sofferma minuziosamente, nel tentativo di dissiparli. Dopo questo avvio, egli giunge, a poco a poco, a parlare della Trinità e così, dopo aver seguito i sentieri tracciati dalla ragione, può finalmente dare libero sfogo alla sua fede. Nel capitolo I dell’opera egli scrive – in toni fortemente platonico/agostiniani -, a conclusione del suo argomentare: “vi è un ente ottimo e massimo e più alto di tutto quel che esiste”. Il punto d’arrivo della prima delle tre prove dispiegate è dunque la dimostrazione dell’esistenza di un ente ottimo e massimo, partendo dalla nozione stessa di bontà, insita nelle nostre menti. Facciamo esperienza di tale nozione – nota Anselmo – nella misura in cui, nella vita di tutti i giorni, abbiamo a che fare con cose buone, sicchè riscontriamo tale concetto nelle entità empiriche. Come si può spiegare l’esistenza di quelle cose buone a cui tutti, per natura, tendiamo? Non si dovrà forse ammettere l’esistenza di qualcosa in virtù di cui esse sono buone? Come è facile capire, il procedere anselmiano è assolutamente razionale, a tal punto che anche chi ignora l’esistenza di Dio può arrivare a comprenderla avvalendosi della sola ragione, e se non riesce a capirlo, ciò significa che non è un uomo, ma una bestia sprovvista di ragione. Anselmo, per sua stessa ammissione, sostiene di non poter dimostrare la necessità di Dio (e in merito al concetto di “necessità” egli aveva letto alcuni scritti logici di Aristotele), ma si accontenta che ciò abbia una probabilità, ovvero che sia ragionevole ritenere che Dio esista. Tuttavia, egli muove obiezioni e critiche alla sua stessa argomentazione: preso atto dell’esistenza di “cose” buone, ne deriva che dovrà sussistere un’entità in forza della quale tali cose sono, appunto, buone; ma che cosa mi vieta di pensare che non si tratti di un’entità, ma di una pluralità di entità? Chi mi vieta di pensare che a render buone le cose sia non un ente unico, ma più enti, dei quali qualcuno rende buone certe cose, qualcun altro ne rende buone altre? Tuttavia – risponde Anselmo – quando istituiamo una gerarchia, è chiaro che lo facciamo sempre in base ad un’unica pietra di paragone, ovvero facendo riferimento ad una sola realtà in base alla quale diciamo che le cose sono giuste, buone, belle: ad esempio, le cose giuste sono dette tali in base ad un unico metro di misura, la giustizia. Facendo ricorso al linguaggio ordinario (proprio come era solito fare Agostino), Anselmo arriva significativamente a chiedersi: perché diciamo che un cavallo è buono quando è forte e veloce (ossia quando ci è utile), ma non diciamo altrettanto di un ladro forte e veloce? Quel qualcosa è buono intrinsecamente o solo per l’utilità che noi ne traiamo? Il pensatore di Aosta risponde che le cose sono buone poiché sussiste un’entità che le rende tali, ed è anzi facendo costante riferimento a tale entità che predichiamo la bontà di quelle cose. Similmente, Tommaso d’Aquino, con la sua quarta prova argomentativa in favore di Dio (una prova di sapore platonico/avicenniano), dirà che se c’è una scala di valori, allora dovrà esserci il minimo e il massimo di tale scala, il che implica l’esistenza di Dio come vertice della gerarchia. Ma, in fin dei conti, la prova può essere in questo modo se non distrutta, almeno fatta scricchiolare: se c’è una gradualità, allora c’è un’unità di misura, ma non necessariamente un massimo e un minimo. Dopo aver trattato nel capitolo II lo stesso argomento del capitolo I come corollario, nelle due parti successive Anselmo parla della “natura”, intesa non aristotelicamente, ma nel mero significato di “essenza”. Se esiste una natura – argomenta Anselmo -, allora dovrà per forza sussistere un ente incausato da cui essa deriva: “tutto ciò che è, esiste in virtù di un unico ente”; le cose, infatti, o esistono in forza di qualcosa o in forza del nulla, il che però è evidentemente assurdo e contraddittorio. Ne consegue, allora, che le cose derivano da qualcosa (e non dal nulla): ma questo qualcosa è un ente singolo o, piuttosto, una molteplicità di enti? Nel caso in cui fosse un ente molteplice, occorrerebbe spiegare se ciascuno di tali enti sussista autonomamente o invece se alcuni siano causati da altri; ma in questo secondo caso, essendo alcuni enti causati da altri, si ritornerebbe al punto di partenza, a dover ammettere un ente da cui tutti gli altri derivano. Se invece ciascun ente esiste indipendentemente dagli altri, ciò avviene necessariamente grazie ad una forza che lo consenta. Ma tale forza, allora, sarà la stessa in tutti gli enti, e dunque sarà essa il principio unico da cui tutto deriva. In ogni caso, pertanto, si è condannati allo scacco: l’ente da cui la natura deriva è unitario, e corrisponde a Dio. Sarebbe inutile, in questa prospettiva, tentare di spiegare le cose ipotizzando una loro azione reciproca e circolare, così come invece può spiegarsi il rapporto tra servo e padrone: al contrario, poiché esiste un ente che fa sì che esistano tutte le altre cose nella loro indefinita molteplicità (e tale ente è Dio), esso sussiste autonomamente, senza però essere “causa sui”, perché altrimenti – nota Anselmo con straordinaria acutezza – in Dio vi sarebbe distinzione interna tra causa ed effetto, cosicchè ci si troverebbe assurdamente costretti ad ammettere la molteplicità di Dio. La terza prova addotta da Anselmo in difesa dell’esistenza di Dio poggia sui valori delle cose: se osserviamo la natura, ci accorgiamo facilmente di come essa sia popolata da cose non equiparabili, ma poste su piani differenti; così il cavallo è superiore rispetto alla pietra, e l’uomo lo è rispetto al cavallo, e così via. Chi non si accorgesse di ciò, sostiene Anselmo, sarebbe indegno di esser detto uomo, poiché rivelerebbe una totale assenza della ragione, che è appunto – aristotelicamente – ciò che qualifica la nostra essenza di esseri umani. Ora, ammettendo tale scala di valori (in base alla quale l’uomo sta sopra il cavallo, il quale a sua volta sta sopra la pietra), si andrebbe avanti all’infinito se non si ammettesse come vertice una natura eccelsa, a cui nulla sia superiore: ma una tale natura potrebbe essere unitaria o molteplice, e per dimostrare la sua unitarietà Anselmo fa ricorso alle argomentazioni dispiegate in precedenza. Tale natura eccelsa e unitaria corrisponde a Dio. Ed è importante notare come Anselmo, profondamente “realista” nelle sue convinzioni logiche (pensiamo alla disputa medioevale sui nomi), arriverà a dire che perfino lo stolto che nega l’esistenza di Dio deve necessariamente avere nella sua mente l’idea di Dio, e alle idee corrisponde sempre (o quasi) qualcosa di reale. Ritorna, in questo senso, la centralità dell’intelletto, di quella luce soffusa che ci fa riconoscere la Verità.
PROSLOGION
In quest’opera, Anselmo parte dalla pura concettualità per risalire all’esistenza: muovendo dalla mera nozione di Dio che ciascuno di noi ha nella sua mente, egli mostra come a ciò debba necessariamente corrispondere qualcosa di reale. Del resto, l’esigenza di dimostrare in modo certo e innovativo l’esistenza di Dio era per Anselmo diventata una vera ossessione che non gli dava pace e che non gli permetteva di pensare più a null’altro. Stando a quanto racconta il suo biografo, dopo un lungo arrovellarsi Anselmo ebbe finalmente – nel cuore della notte – un’illuminazione divina che gli fece balzare alla mente quella che dai suoi successori (parecchi secoli dopo) sarà detta “prova ontologica dell’esistenza di Dio”; ed è in seguito a tale illuminazione divina che egli decise di impugnare la penna e di comporre il “Proslogion”, nel cui proemio rivela che già parecchio tempo addietro “cominciai a chiedermi se non si potesse trovare un unico argomento possibile” per dimostrare che Dio è, e che di conseguenza è buono e dotato di tutte le altre qualità che gli sono proprie. A differenza che nel “Monologion” (dove il punto di partenza era la ragione indagatrice sul mondo empirico), ora Anselmo parte dalla fede e dalle sue verità, e si propone di “capire ciò che crede”; dal punto di vista della fede, egli non ha alcun dubbio, giacchè le verità di cui essa è portavoce sono indubitabili; si tratta, però, di impiegare l’intelletto per arrivare ad una comprensione razionale di tali verità, ed è per questo che Anselmo parla esplicitamente – sulle orme di Agostino – di “fides quaerens intellectum”, quasi convinto che, una volta risolto il problema dell’esistenza di Dio, ne derivino a cascata tutte le altre verità. Se il “Monologion” era un soliloquio, ovvero un dialogo con se stesso, alla maniera agostiniana dei “Soliloqui”, il “Proslogion” si configura invece come “colloquio” con Dio e con la propria anima, quasi come se Anselmo avesse avuto un’esperienza mistica (ed è questa la lettura che del “Proslogion” diede Karl Barth). Nei “Soliloqui” Agostino si rivolgeva alla propria anima, confidandole di voler conoscere lei e Dio stesso: Anselmo, invece, parte da una considerazione sull’affanno della situazione umana, immersa in una incessante corsa e nelle prime pagine dell’opera scrive: “orsù, omiciattolo, fuggi per un poco dalle tue occupazioni […], dedicati per un poco a Dio e riposati in Lui”. Pur muovendo dalla constatazione dell’affannosità della vita umana, Anselmo non si abbandona a quel “contemptus mundi” (il “disprezzo del mondo”) che invece ritroviamo in molti altri Medievali. La prova ontologica viene sviluppata a partire dal libro II, il cui titolo suona “Dio esiste veramente”: il punto di partenza è – come abbiamo detto – il contenuto della fede, ed in particolare la definizione – a tutti evidente – che essa fornisce di Dio come “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” (“id, quo maius cogitari nequit”). Perfino lo stolto di cui parla la Bibbia dice sì in cuor suo che Dio non esiste, ma ne condivide la definizione con il credente: anche per lui Dio è “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”. Si può dunque dire che il concetto di Dio è presente nel suo intelletto, anche se egli è convinto che quel qualcosa non esista nella realtà. Si tratterà dunque – nota Anselmo – di passare dall’esistenza mentale (concettuosa) a quella reale: e per meglio compiere questo salto, il pensatore di Aosta ricorre all’esempio del pittore che, ancor prima di iniziare il quadro, ce l’ha già impresso nella propria mente (il monaco benedettino Gaunilone tuonerà contro Anselmo notando come siano fuori luoghi questi esempi: come possiamo accostare Dio ad un quadro? E poi: un quadro cade sotto i nostri sensi, mentre di Dio non possiamo mai fare esperienza). Anche lo stolto dovrà convincersi che nella sua mente è presente la nozione di Dio come “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: ma Dio non può esistere esclusivamente come nozione, altrimenti sarebbe possibile pensare un’altra cosa “di cui nulla si può pensare di maggiore” ma che – a differenza di Dio come lo intende l’insipiente – esiste effettivamente nella realtà: in tal caso, questa cosa (che esiste oltre ad essere “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”) sarebbe maggiore rispetto a Dio (che esiste solo come nozione), e dunque si potrebbe pensare qualcosa di maggiore rispetto a “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: il che è naturalmente contraddittorio. Infatti, ritenere che “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” non esista nella realtà significa privarlo di quel sommo grado dell’essere che è l’esistenza, ovvero vuol dire che non può essere “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”, infatti, per essere davvero tale, deve avere, oltrechè ad un’essenza, anche l’esistenza. In età illuministica, Kant (fiero sostenitore dell’indimostrabilità dell’esistenza di Dio) dirà che non si può in alcun caso far derivare l’esistenza dall’essenza, adducendo l’esempio dei cento talleri pensati e dei cento talleri esistenti: Hegel biasimerà Kant rinfacciandogli che il suo è un ragionare barbarico, poiché non si può accostare Dio a cento talleri. Questa vivace diatriba sorta in età moderna intorno alla validità della prova ontologica, ai tempi di Anselmo era pressochè assente. Anzi, dopo che egli ebbe composto il “Proslogion” calò il silenzio nella cultura a lui contemporanea: solo nel XIII secolo a.C. si comincerà a discutere sulla prova ontologica; il caso del monaco Gaunilone, che non appena esce il “Proslogion”, lo attacca duramente, è un caso più unico che raro. Nel capitolo III del suo scritto, Anselmo chiarisce ulteriormente – ma senza apportare in realtà grandi innovazioni – perché Dio non possa non esistere, mentre nel IV spiega perché l’insipiente ha potuto credere che Dio non esistesse: qualunque cosa noi pronunciamo dentro di noi è pensiero, ma (stando agli insegnamenti del “De magistro” di Agostino) possiamo fermarci al puro segno (alla parola cui non corrisponde nulla di reale) o invece spingerci alla parola significante qualche cosa (così il termine “sedia” è un “signum” che significa qualche cosa di reale), con la conseguenza che secondo la prima modalità (che è propria dell’insipiente) si può dire che Dio non esista, ma attenendosi alla seconda ciò non è possibile. Alla prova ontologica anselmiana resteranno fedeli (oltre a Hegel) Bonaventura, Cartesio, Leibniz e – pare – perfino Bertrand Russell, il quale – uscito per comprare del tabacco – si arrovellava sull’argomento anselmiano fino a che, bloccatosi al centro della strada, non arrivò all’illuminazione che era una prova valida. Ma una lunga tradizione che parte da Gaunilone e giunge sino a Kant nega la validità della prova anselmiana: in particolare Gaunilone scrive un celebre “Liber pro insipiente” in cui si schiera al fianco dell’insipiente e contro Anselmo; in realtà il monaco benedettino ha una certa tendenza a strumentalizzare il pensiero anselmiano, come quando riferisce che, secondo Anselmo, qualsiasi cosa reale è maggiore di Dio come semplice concetto. Gaunilone (che è cristiano, e dunque saldamente convinto che Dio esista: critica la prova anselmiana, non l’esistenza di Dio in quanto tale) obietta al suo rivale che se ogni cosa pensata ha una sua corrispondenza nel reale, allora anche la chimera o il cavallo alato dovranno trovarvi posto. Se poi Dio è così evidente come Anselmo lo predica, che necessità c’era di costruire quel laborioso edificio che è la prova ontologica? Ma non solo: l’equazione anselmiana secondo cui il pensato è esistente deve essere argomentata, cosa che Anselmo non si preoccupa affatto di fare, ma dà per scontata. Ancora: come si può proclamare con tanta certezza che esista nella realtà quella cosa pensata che è Dio se non se ne è mai avuta esperienza? Oltre a queste riflessioni – nel loro insieme piuttosto acute – Gaunilone ne fa una che si rivela il suo grande passo falso, a tal punto che Anselmo – quando gli risponderà – farà leva quasi esclusivamente su di essa: se “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” deve per forza esistere, allora anche l’isola perfetta – e così il perfetto per ogni categoria (il cavallo perfetto, l’uomo perfetto, ecc) – dovrà necessariamente esistere. Anselmo compone un libro di risposta alle critiche gauniloniane (“Liber apologeticus”), in cui, giustamente, critica duramente il suo avversario per aver paragonato Dio ad un’isola. E, poiché si tratta di rispondere al cattolico Gaunilone e non all’insipiente ateo, Anselmo fa costante riferimento all’idea di Dio (e alle sue conseguenze) derivata dalla fede: dicendo che non vale l’argomentazione secondo cui “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” deve per forza esistere, si va contro la fede, il che è inammissibile. A Parigi, nel XIII secolo, fiorisce un dinamico dibattito intorno alla prova anselmiana: Alessandro di Hales non esita a condividerla, e pure Tommaso d’Aquino ne fa esplicita menzione, pur senza citare Anselmo. L’Aquinate, ne “La somma teologica”, sviluppa la sua analisi in tre punti essenziali: a) come nota Damasceno, “omnibus cognitio existendi Deum naturaliter est inserta” (“la conoscenza dell’esistenza di Dio è in tutti naturalmente insita”); b) inteso che cosa significa Dio, si capisce all’istante ch’Egli esiste, perché, essendo “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” (e qui vi è un’eco anselmiana), deve esistere sia come concetto sia come ente reale; c) è evidente che la verità esista, poiché anche chi la nega incappa in una Verità (la verità che non ci sono verità): ma la verità esiste solo se c’è una Verità, e tale è Dio secondo i Testi Sacri.
Alcuni brani tratti dal “Proslogion”:
a) Necessità di una purificazione interiore e di un forte impegno personale (Proslogion, 1)
Orsú, omuncolo, fuggi per un poco le tue preoccupazioni, sottraiti un poco ai tuoi tumultuosi pensieri. Liberati ora dalle pesanti cure, e lascia da parte le tue laboriose distrazioni. Dedicati un pochino a Dio e riposati in Lui. “Entra nella stanza” del tuo spirito, cacciane fuori tutto all’infuori di Dio e di ciò che ti aiuta a cercarlo, e, “dopo aver chiuso l’uscio”, cerca Lui. Di’ ora, o mio cuore, tutto intero, di’ a Dio: “Io cerco il tuo volto, ricerco il tuo volto, o Signore” (Ps., 26, 8).
b) Credo ut intelligam (Proslogion, 1)
Riconosco, o Signore, e te ne ringrazio, che hai creato in me questa tua immagine, affinché, memore, ti pensi e ti ami. Ma l’immagine è cosí cancellata dall’attrito dei vizi, è cosí offuscata dal fumo dei peccati, che non può fare ciò che dovrebbe, se tu non la rinnovi e la riformi. Non tento, o Signore, di penetrare la tua profondità poiché in nessun modo posso metterle a pari il mio intelletto; ma desidero comprendere in qualche modo la tua verità, che il mio cuore crede ed ama. Non cerco infatti di comprendere per credere, ma credo per comprendere. Poiché credo anche questo: che “se non avrò creduto non potrò comprendere” (Is., 7, 9).
c) La prova ontologica (Proslogion, 2-3)
L’argomento a priori: l’idea di ciò di cui non si può pensare nulla di piú grande, presente nella mente dell’uomo, comporta la necessità logica dell’esistenza di un Essere che corrisponda a questa idea.
1 Ora crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi piú grande. O che forse non esiste una tale natura, poiché “lo stolto disse in cuor suo: Dio non esiste”? (Ps., 13, 1 e 52, 1). Ma certo, quel medesimo stolto, quando sente ciò che io dico, e cioè la frase “qualcosa di cui nulla può pensarsi piú grande”, capisce quello che ode; e ciò che egli capisce è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. Altro infatti è che una cosa sia nell’intelletto, altro intendere che la cosa sia. Infatti, quando il pittore si rappresenta ciò che dovrà dipingere, ha nell’intelletto l’opera sua, ma non intende ancora che esista quell’opera che egli non ha ancor fatto. Quando invece l’ha già dipinta, non solo l’ha nell’intelletto, ma intende che l’opera fatta esiste. Anche lo stolto, dunque, deve convincersi che vi è almeno nell’intelletto una cosa della quale nulla può pensarsi piú grande, poiché egli capisce questa frase quando la ode, e tutto ciò che si capisce è nell’intelletto.
2 Ma, certamente, ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere solo nell’intelletto. Infatti, se esistesse solo nell’intelletto, si potrebbe pensare che esistesse anche nella realtà, e questo sarebbe piú grande. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste solo nell’intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Il che è contraddittorio. Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore e nell’intelletto e nella realtà.
3 E questo ente esiste in modo cosí vero che non può neppure essere pensato non esistente. Infatti si può pensare che esista qualche cosa che non può essere pensato non esistente; e questo è maggiore di ciò che può essere pensato non esistente. Perciò, se ciò di cui non si può pensare il maggiore può essere pensato non esistente, esso non sarà piú ciò di cui non si può pensare il maggiore, il che è contraddittorio. Dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste in modo cosí vero, che non può neppure essere pensato non esistente.
4 E questo sei tu, o Signore Dio nostro.
GERBERTO
Una eccezione rispetto alla vita ascetica che andava affermandosi nel 900 grazie alla fondazione dell’ abbazia benedettina di Cluny , é la figura di Gerberto , nella quale si compendiano le esperienze del monastero , della scuola episcopale e della corte . Egli , infatti , é monaco a Aurillac , ma tra il 937 e il 982 é altresì maestro alla scuola episcopale di Reims e v’ insegna la logica sui testi allora noti di Aristotele e di Boezio . Soggiorna anche alla corte di Ottone terzo , nella quale é ambientata una disputa a cui egli avrebbe partecipato , descritta nel suo Sul razionale e sull’ uso della ragione . Il problema che la anima é se sia corretta la proposizione ” l’ animale razionale usa la ragione ” . Di primo acchito essa sembrerebbe errata , perchè , contrariamente all’ insegnamento della logica aristotelica , contiene un predicato meno esteso del soggetto , mentre dovrebbe essere l’ inverso , poichè il fatto di essere animali razionali comporta l’ esercizio in atto della ragione , da quello dell’ uomo , per il quale il fatto di essere razionale comporta la possibilità di usare la ragione , ma non necessariamente l’ uso in atto di essa : mentre chi ha la ragione in potenza non necessariamente la usa in atto chi la usa in atto necessariamente deve anche averla in potenza . Ciò significa che l’ uso in atto della ragione é più esteso della pura e semplice potenza , quindi , esso entra correttamente come predicato nella proposizione ” l’ animale razionale usa la ragione ” . In tal modo , Gerberto mostra di saper maneggiare non solo gli strumenti della logica aristotelica , ma anche la distinzione tra potenza e atto . i suoi interessi poi si estendono anche alle arti del quadrivio . Verso la fine del 960 egli compie un viaggio in Catalogna , dove entra in contatto con la cultura araba e acquisisce conoscenze matematiche e astronomiche che egli esporrà in scritti e che lo faranno sovente considerare un mago . Successivamente diventa abate di Bobbio , nel 991 arcivescovo di Reims e poi di Ravenna e , infine , nel 999 , viene eletto papa col nome di Silvestro secondo . Muore poco dopo il 1003 .
PIETRO ABELARDO
VITA E OPERE
La vita di Abelardo compendia emblematicamente i mutamenti e le irrequietezze dell’età nuova, in bilico tra il monastero e la scuola. Egli stesso ne ha svolto il racconto nella Storia delle mie sventure (Historia calamitatum mearum), seguita da una serie di lettere scambiate tra lui e l’amata Eloisa, nonchè da una regola destinata al monastero di Paracleto. Si tratta di una ricostruzione letteraria a distanza dai fatti, nella quale Abelardo presenta se stesso come vittima di invidie e complotti e la propria vicenda – sulle orme di Agostino -, come un itinerario dal peccato alla salvezza. Ma essa informa anche su alcuni fatti fondamentali della sua vita: Abelardo nasce nel 1079 a Pallet – a sud est di Nantes – nella Bretagna; figlio di un cavaliere, rinuncia ai beni e alla carriera delle armi per dedicarsi agli studi dapprima a Loches (nella zona della Loira), dove insegna Roscellino (l’iniziatore del cosiddetto “nominalismo”) e poi a Parigi, dove fioriscono gli studi di dialettica. Qui segue le lezioni di Guglielmo di Champeux, ma ardisce criticarne le tesi sugli universali (Guglielmo sarà costretto a rivedere le proprie posizioni), cosicchè é costretto a trasferirsi prima a Melun, e poi a Corbeil, dove insegna a sua volta, riscuotendo grande successo e ottenendo una fama di grande dialettico. Dopo aver trascorsoqualche anno in Bretagna, torna a Parigi e ascolta nuovamente Guglielmo, divenuto canonico di San Vittore, ma nascono nuovi contrasti ; Guglielmo si ritira nell’abbazia di San Vittore e nel 1113 diventa vescovo di Chalons, mentre Abelardo tiene scuola a Parigi, sulla riva sinistra della Senna – a Sainte-Genevieve – allora situata fuori dalle mura della città. Dopo un altro viaggio in Bretagna, nel 1113 si reca a Laon, per studiare scienza sacra con Anselmo di Laon, ma nello stesso anno torna a Parigi, alla scuola episcopale nel chiostro di Notre-Dame, per insegnarvi non solo dialettica, ma anche teologia. In questo periodo – col denaro degli allievi – egli può vivere libero dal controllo delle superiori autorità ecclesiastiche. Qui avviene il suo incontro con Eloisa , nipote di un canonico di Notre-Dame, Fulberto: è amore a prima vista, Abelardo – convinto di essere bello e colto a sufficienza per far colpo sulla ragazza, che primeggia a sua volta per bellezza e cultura- fa di tutto per poter diventare suo precettore, e ci riesce. L’amore nasce improvviso verso la fine del 1115 o gli inizi del 1116 ; quando Fulberto li scopre, Eloisa é già incinta. Abelardo la porta in Bretagna presso la sua famiglia e qui – verso la fine del 1116 – Eloisa partorisce un figlio, al quale é dato il nome di Astrolabio (“rapitore delle stelle”). Tornati a Parigi, Eloisa e Abelardo si sposano in segreto, ma Fulberto divulga la notizia: la coppia smentisce e si separa, Eloisa si ritira ad Argenteuil, dove poi si farà monaca: Abelardo la ripudia come moglie perché teme di perdere i suoi privilegi. Fulberto e i parenti, adirati dalla volontà di Abelardo di liberarsi di Eloisa, si vendicano e lo fanno evirare da sicari nel cuore della notte. Verso la fine del 1117 o l’inizio del 1118 anche Abelardo prende l’abito monastico, ma continua a insegnare logica e teologia in una scuola aperta nella Champagne. Attaccato dai maestri della scuola episcopale di Reims per le tesi sulla Trinità sostenute nel suo scritto Teologia del Sommo Bene, é citato nel 1121 al Concilio di Soissons, dove l’arcivescovo e il legato pontificio lo condannano a bruciare il libro e a rinchiudersi in monastero a Soissons: a tal punto era temuto per il suo talento retorico, che gli vietarono di parlare in processo, nel timore che egli convincesse delle sue tesi la “platea”, e così fu costretto a rispondere semplicemente con dei “sì” o con dei “no”. Successivamente, il legato lo autorizza a rientrare nell’abbazia di Saint-Denis, ma qui insorgono nuovi contrasti con l’abate, che vuole accusarlo davanti al re. Abelardo fugge a Provins, ma una donazione gli permette di stabilirsi eremita con un discepolo a Quincey, dove fonda un oratorio, denominato il Paracleto, ossia lo Spirito Santo, e anche qui vi apre una scuola, sovvenzionata dagli allievi. Tra il 1125 e il 1128 lascia il Paracleto per diventare abate di Saint-Gildas nella diocesi di Vannes in Bretagna: qui trova monaci ignoranti, rozzi e viziosi, che cercano di farlo assassinare . Riprende contatti con Eloisa, ora badessa di Argenteuil, invitandola a stabilirsi con le monache al Paracleto, dove Abelardo periodicamente compie visite e pronuncia prediche. A questo punto terminano i fatti raccontati da Abelardo stesso, ma sappiamo che nel 1136 egli tiene nuovamente una libera scuola di dialettica e teologia a Parigi, ove ha tra i suoi discepoli anche Arnaldo da Brescia e Giovanni di Salisbury. Scoppia in questi anni l’ostilità di Guglielmo di Saint-Thierry e di Bernardo di Chiaravalle nei confronti delle sue dottrine: nel 1140 Bernardo ottiene dal concilio di Sens la sua condanna – ratificata dal papa – , Abelardo allora si ritira presso Pietro il Venerabile nell’abbazia di Cluny, in Borgogna, dove muore nel 1142.
IL PENSIERO
San Bernardo da Chiaravalle – fiero sostenitore delle Crociate e della “militia Christi”- definì Abelardo un combattente sin dall’infanzia e in una sua lettera a Eloisa , Abelardo stesso confessa : “la logica mi ha reso odioso al mondo … ma io non voglio essere filosofo in modo da oppormi a Paolo, nè essere un Aristotele in modo da separarmi da Cristo”. In una sostanziale adesione al messaggio cristiano, Abelardo non ebbe tuttavia mai dubbi sulle sue capacità intellettuali e argomentative: si definiva addirittura “il più grande filosofo del mondo”, superiore a Platone e ad Aristotele. Il suo insegnamento e i suoi primi scritti riguardano la logica: l’ordine che egli segue é quello della “logica vetus”, iniziando con la lettura dell’Introduzione di Porfirio alle Categorie di Aristotele. Abelardo compone glosse a questo scritto (le Glossae super Porphyrium), forse raccolte dai suoi uditori e poi riviste da lui stesso, poi una Logica per i principianti, e una Logica nostrum, e successivamente una Dialettica. In seguito, egli estende l’uso della dialettica anche all’esame di questioni teologiche e a partire dal 1118 compone, oltre alla Dialettica, la Teologia del Sommo Bene, la Teologia cristiana e il Sic et non. Abelardo scrisse anche glosse alla Lettera ai Romani di S. Paolo, sermoni, inni religiosi e probabilmente anche poesie d’amore . Tra i suoi ultimi scritti sono il Conosci te stesso (Scito te ipsum) o Etica, e , incompiuto , il Dialogo tra un giudeo, un filosofo e un cristiano. Gli interessi iniziali di Abelardo sono soprattutto per la logica o dialettica, che egli intende come arte di distinguere la verità o la falsità del discorso. I discorsi sono fatti di termini, si tratterà allora di investigare l’uso e il significato dei termini: questo orientamento rimarrà caratteristico di tutto l’itinerario d’indagine di Abelardo. Tra i termini sono soprattutto i termini universali, ossia i generi e la specie, come “animale” “uomo”, “cavallo” e così via, a sollevare un greve problema. La tradizione del platonismo cristiano aveva identificato questi termini con le idee o le ferme presenti nella mente di Dio, le quali costituiscono i modelli archetipi delle cose create da Dio; quindi essi rappresentano anche la sostanza delle singole cose create, ciò che ciascuna di esse propriamente è. Per esempio, la sostanza dell’individuo Socrate è quella di essere un animale razionale: sono il genere (animale) e la specie (uomo) ai quali Socrate appartiene che determinano che cosa Socrate propriamente è. Questa soluzione del cosiddetto problema degli “universali” (così caro ai Medievali) sarà detta in età moderna “realismo”, in quanto per essa l’universale è una realtà vera e propria, esistente autonomamente (alla pari delle idee platoniche). Ma all’inizio del XII secolo emergono nuove prospettive nell’affrontare questo problema, in particolare esse considerano l’universale non tanto dal punto di vista di Dio, quanto dal punto di vista dell’uomo che parla e pensa. Che cosa sono i termini universali, di cui i discorsi sono costellati? Uno dei primi maestri di Abelardo è Roscellino di Compiègne, nato verso il 1050 e morto verso il 1120. Di Roscellino è conservata soltanto una lettera ad Abelardo, ma il contenuto delle sue dottrine è ricavabile da quanto ne dicono i suoi avversari, Anselmo di Aosta e appunto Abelardo. Secondo Anselmo, Roscellino rientra tra quei dialettici, che ritengono che gli universali non siano altro che emissioni di voce (flatus vocis); alla base di questa concezione ci sarebbe l’assunzione che realtà vere e proprie sono soltanto quelle individuali e che i termini universali sono soltanto parole, suoni fisici, sensibili, i quali non si riferiscono a presunte entità universali: tale dottrina sarà denominata in età moderna nominalismo estremo. Essa mostrava la sua pericolosità non appena veniva applicata ad un problema teologico come quello della Trinità; Anselmo infatti accusa Roscellino di prevenire, mediante le sue premesse nominalistiche, a una sorta di triteismo, ossia a concepire le tre persone della della Trinità come tre individui distinti, poichè l’unità della Trinità non sarebbe per lui un’unità di sostanza, ma soltanto di somiglianza o uguaglianza. Nel 1092 questa dottrina trinitaria è condannata dal Concilio di Reims come eretica. L’altro maestro con cui Abelardo inizialmente studia è Guglielmo di Champeaux (1070-1121 circa). In una prima fase, questi è sostenitore di una forma di realismo: gli universali, ossia i generi e le specie, sono entità reali esistenti in sè. Una specie è una sostanza unica, che è presente essenzialmente, non accidentalmente, in tutti gli individui che ne partecipano; gli individui differiscono, dunque, tra loro soltanto per accidente. Così la specie uomo é presente in tutti gli individui, quali Socrate, Platone e così via, che sono appunto detto uomini. Le differenze tra gli individui rientranti nella stessa specie sono date esclusivamente da proprietà accidentali, variabili e casuali (per esempio, statura, colore dei capelli, professione e così via). A questa posizione Abelardo mosse l’obiezione che essa conduceva a ritenere inessenziali le differenze tra specie e tra individui (e Guglielmo cambiò allora idea). La concezione di Guglielmo comporta, infatti, che il genere animale sia presenta in tutti gli animali, sia privi sia dotati di ragione; di conseguenza l’essere o no dotati di ragione non costituisce una differenza sostanziale. Ma allora vi sono due possibilità: o nella stessa sostanza (animale) ci saranno proprietà contrarie (razionalità e irrazionalità) oppure queste proprietà, trovandosi in un’unica sostanza, non saranno più contrarie. La prima alternativa é assurda, perchè i contrari non possono coesistere in una stessa sostanza: come non si può contemporaneamente bianchi e neri, così non si può essere insieme razionali e irrazionali; ma é assurda anche la seconda alternativa, perchè possedere la ragione é il contrario di non possedere la ragione. Se la sostanza dell’uomo e del cavallo è, parimenti, l’essere animale, dobbiamo forse dire che la razionalità è un accidente? Forse in seguito a queste critiche di Abelardo, Guglielmo corresse la propria teoria, sostenendo che gli universali sono presenti negli individui non essenzialmente, ma in maniera “indifferenziata”. Per esempio, Socrate e Platone sono entrambi uomini, in quanto in ciascuno di essi é presente l’universale, la specie uomo, ma questa é presente in essi non essenzialmente, bensì indifferentemente: Guglielmo intende dire che ciò rispetto a cui Socrate é un uomo non é differente da ciò rispetto a cui Platone é un uomo. Abelardo riprende la definizione aristotelica di universale come ciò che può essere predicato di molte cose: di Socrate si può dire che é uomo, ma questo si può dire anche di Platone o di Aristotele. Se é così, l’universale non é nè una realtà a sè stante, nè un puro suono: Abelardo respinge in tal modo sia il realismo, sia il nominalismo estremo. L’universale non può essere una res, una cosa, poichè una res é un’entità individuale autosussistente e in quanto tale non può essere predicata di un’altra. Non si può dire di una cosa individuale, per esempio Socrate , che é un’altra cosa individuale, per esempio Platone, proprio perchè – secondo Abelardo – una res non può essere predicata di un’altra res: viene così smentita la possibilità che gli universali siano entità a se stanti. Ma se l’universale non é una res, ciò non vuol dire che esso sia un puro suono, perchè anche un suono, per esempio il suono “Platone”, é un’entità individuale e quindi anch’esso non può essere predicato di altro. La soluzione di Abelardo (non assimilabile né al realismo né al nominalismo) consiste nel dire che l’universale é sermo, ossia parola, ma parola intesa non come semplice insieme di suoni fisici, bensì dotata di significato, ossia riferentesi a qualcosa. Il problema degli universali diventa allora il problema di che cosa e come significhino questi termini universali e le proposizioni che essi contribuiscono a costituire. Il testo a cui Abelardo si richiama per elaborare la sua teoria del significato é il De interpretatione di Aristotele. L’immaginazione, che Aristotele aveva chiamato fantasia, forma immagini di ciò che non é più presente ai sensi, ma anche di cose irreali che non sono mai state presenti ai sensi (per esempio, di mostri). Inoltre, é possibile formarsi immagini di entità particolari, per esempio di Platone, ma anche di corporeità o di razionalità o di uomo in generale. In quest’ultimo caso, si tratta dell’immagine comune e confusa di tutti gli uomini, di ciò che essi hanno di simile, senza che sia proprio di uno o qualcuno soltanto di essi. Di per sè, le immagini non sono sostanze: esse sono usate come segni per riferirsi ad altre cose: infatti quando si sente la parola “uomo” sorge nell’animo – secondo Abelardo – qualcosa che si riferisce agli uomini individuali presi in comune e non ad uno di loro con precisione. Tale posizione sarà in seguito denominata concettualismo. Mediante termini dotati di significato, si possono formare proposizioni dotate di significato, per esempio , la proposizione “Platone é uomo”. In tal caso, si considerano le due immagini – Platone e uomo – e mediante esse l’intelletto giunge a comprendere la verità di questa proposizione. Ma le proposizioni non sono come i nomi propri (per esempio, il nome di persona Platone), che si riferiscono semplicemente e direttamente a cose. Chiariamo questo punto con un esempio: la proposizione “se x é un uomo, x é un animale” é vera anche nel caso che ogni forma di vita sia distrutta nel mondo. Ossia, come si è detto, “ciò che la proposizione asserisce può sussistere anche quando non sussistono più gli oggetti denotati”: se anche sparissero improvvisamente dal mondo tutte le rose, il termine “rosa” continuerebbe ad avere il suo significato. In altre parole, le proposizioni non significano cose, ma relazioni tra cose, il modo in cui le cose sono tra loro collegate; è in riferimento ad esse che si può dire se una proposizione è vera o falsa. Il verbo “essere” usato come copula (“il sole è splendente”) non indica che una qualità appartiene o inerisce a un soggetto, ma che due termini sono correlati tra loro in un determinato modo. Questa analisi della proposizione può essere utilizzata per chiarire il modo in cui i termini universali significano qualcosa o si riferiscono a qualcosa. Infatti , secondo Abelardo, non esiste un’entità uomo, esistono gli uomini: tuttavia gli uomini sono simili nello status (o natura) di essere uomini; questo status però non é una cosa, ma non é neppure nulla: é il modo in cui le cose sono. E’ questo status che fa sì che noi possiamo usare la parola uomo per descrivere tutti gli uomini. Nel comprendere i termini universali e le proposizioni contenenti termini universali, l’intelletto umano é aiutato dall’immaginazione, che forma immagini di ciò che é comune e delle relazioni tra le cose menzionate nella proposizione. Ad esso, tuttavia, compete il compito di giudicare la verità o la falsità delle proposizioni; in tal senso, la logica, (o dialettica) é appunto la disciplina che discrimina tra vero e falso. Scrive Abelardo sulla questione degli universali nelle Glosse su Porfirio:
“Viste le ragioni per le quali le cose né singolarmente né collettivamente prese si posson dire universali, in quanto l’universale si predica di molti, resta che attribuiamo l’universalità solo alle parole.
Come dunque certi nomi son detti dai grammatici appellativi, e certi altri propri, cosí dai dialettici certe espressioni semplici son dette universali, certe altre particolari, ossia singolari. L’universale è un vocabolo trovato in modo da esser capace di essere predicato singolarmente di molti, come per esempio il nome uomo è unibile ai nomi particolari degli uomini, per la natura dei soggetti reali ai quali è imposto. Il singolare, invece, è quello che è predicabile di uno solo, come per esempio Socrate, quando è preso come nome di un uomo solo. Se infatti lo si assume equivocamente, non si ha piú una parola sola, ma molte per il significato, poiché, secondo Prisciano, molti nomi possono essere impliciti in un’unica espressione verbale. Quando si descrive l’universale come ciò che si predica di molti, quel ciò che non solo indica la semplicità dell’espressione per distinguerlo dai discorsi composti, ma anche l’unità del significato, per distinguerlo dai termini equivoci”.
Della concezione abelardiana si ricorderà lo stesso Umberto Eco, in Il nome della rosa, quando – in chiusura del suo capolavoro – scriverà: “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”. Abelardo passa successivamente ad affrontare questioni teologiche, quando ha ormai elaborato questo ricco bagaglio di analisi logiche: ritiene che, finchè la ragione è nascosta, è necessario ricorrere all’autorità; ma in ciò che può essere discusso dalla ragione, tale ricorso non è più necessario. Sulle cose divine la ragione da sola è insufficiente, può pervenire soltanto a soluzioni verosimili, non contrarie alla fede. Ciò non significa che sulle cose della fede non si debba discutere: anche per credere occorre intendere (come già diceva Anselmo) ciò che si crede e rendersi conto che i contenuti della fede non danno luogo a proposizioni contraddittorie. Inoltre, per controbattere coloro che fanno un cattivo uso della dialettica anche in ambito teologico, occorre, comunque, saper usare la dialettica. Abelardo afferma nella Dialettica: “Ogni scienza è buona, anche quella che tratta del male”. Il ricorso alla ragione è tanto più importante in quanto non di rado i Padri della Chiesa paiono enunciare opinioni contrastanti sulle stesse verità della fede: Abelardo è tra i primi a formulare una serie di criteri per valutare ed eventualmente appianare tali divergenze. Ciò avviene in una delle opere più emblematiche dal punto di vista del metodo, il Sic et non, letteralmente il “sì e no”. E’ uno scritto a carattere didattico, che intende addestrare i giovani teologi alla ricerca della verità: si parte da un problema, si elencano le soluzioni non di rado contrastanti, almeno apparentemente, date ad essa da parte dei Padri della Chiesa, desumendole dai loro scritti, e infine si tenta d’individuare dove stia la verità. Nel Sic et non, Abelardo affronta circa 150 problemi teologici, raggruppati per temi. Per dissolvere o ridurre le apparenti contraddizioni nelle soluzioni proposte dalla tradizione, Abelardo enuncia alcune regole: in primo luogo, si tratta di accertare se certe espressioni non sono poi smentite dagli stessi autori oppure se riferiscono opinioni altrui, inoltre, occorre soprattutto tener conto del fatto che le medesime parole sono sovente usate da autori diversi con significati diversi, perché ogni autore ha un suo specifico modo di parlare e di scrivere. Tenendo conto di ciò, “si troverà per lo più facile la soluzione delle controversie”, tuttavia, in casi di contrasto insanabile occorrerà dare la preferenza alle tesi che hanno maggiori argomenti a loro favore. In tal modo, Abelardo rivendica libertà di giudizio anche nei confronti delle opere dei Padri, le quali non devono essere lette con l’obbligo di credere. Ciò conduce Abelardo a rivalutare i contributi dei filosofi pagani: anch’essi già prima di Cristo hanno scoperto alcune verità; la rivalutazione della filosofia antica e la formidabile padronanza dialettica varranno ad Abelardo il soprannome di “Peripatetico palatino”. In questo modo, egli si riallaccia ad una impostazione tipica della prima riflessione filosofica cristiana. Gli stessi filosofi pagani hanno in qualche modo riconosciuto la Trinità, quando hanno parlato di Dio, dell’Intelletto divino e dell’Anima del mondo, che Abelardo avvicina allo Spirito Santo: negli ultimi anni del suo soggiorno a Cluny, Abelardo scrive il Dialogo tra un giudeo, un filosofo e un cristiano, rimasto incompiuto. L’Abate di Cluny, Pietro il Venerabile, era un fautore del dialogo con l’Islam e questo scopo egli aveva anche fatto tradurre in Spagna il Corano in latino. I tre personaggi dell’opera di Abelardo credono tutti in un Dio unico, ma due hanno leggi scritte, mentre il filosofo si accontenta della sola legge naturale . Dapprima dialogano il giudeo e il filosofo, che non può accettare una religione fondata esclusivamente sulla Scrittura, poi dialogano il filosofo e il cristiano, che mostra il carattere ragionevole della fede. Non é irrilevante il fatto che, proprio in riferimento al soggiorno di Abelardo a Cluny, con Pietro il Venerabile, il filosofo del dialogo sia nato in un paese dell’Islam. L’opera si apre con una rapida introduzione in cui a parlare è Abelardo stesso, che così racconta: “in una visione notturna, vidi tre uomini che arrivavano per sentieri diversi” – chiara allusione alle tre differenti prospettive di cui essi son portavoce. Tutti e tre adorano sì lo stesso Dio, ma in maniere assai diverse: il filosofo è illuminato dalla sola legge naturale, gli altri due dal Libro. Si recano da Abelardo per chiedergli di essere giudice di un confronto che li vede contrapposti: si tratta di un confronto tra i tre diversi tipi di religione. Abelardo, sbalordito, domanda perché abbiano scelto proprio lui come giudice e il filosofo gli rivela che è stato lui a prender tale decisione, poiché muove alla ricerca della verità sotto la sola guida della ragione, evitando le opinioni. Il filosofo, inoltre, sostiene (e in ciò leggiamo il pensiero dello stesso Abelardo) che il vero obiettivo della filosofia (e di ogni altra disciplina) è la morale, ossia lo studio del sommo bene e del sommo male; il filosofo dichiara apertamente di volersi confrontare col cristiano e col giudeo per esaminare quale tra le due religioni sia più vicina alla ragione e, dunque, da seguire, ma giunge ben presto alla conclusione che “i giudei sono stolti, i cristiani pazzi”. Poiché i tre, da soli, non riuscivano a concludere la loro discussione, si sono rivolti ad Abelardo, che ben conosce la filosofia e la religione (è un evidente auto-elogio del pensatore, che per bocca del filosofo del dialogo è detto il migliore, autore di opere eccelse, anche se “l’invidia non potè sopportare”). Abelardo, sinceramente onorato che la scelta sia ricaduta su di lui, ammonisce preliminarmente il filosofo, mettendolo in guardia: a differenza dei suoi due interlocutori – che possono usare contro di lui una sola “spada” -, egli può attaccarli con due “spade”, ossia criticandoli sia per quel che riguarda la ragione sia per quel che riguarda la loro fede: la sua armatura filosofica è, dunque, superiore in partenza. A tal punto, il filosofo spiega che spetta a lui porre la prima domanda, poiché la legge naturale (della quale egli si nutre) viene prima rispetto alla religione: egli chiede allora, rivolgendo una domanda che tange parimenti i suoi interlocutori, se essi si siano accostati alla fede perché indotti dalla religione o perchè spinti dalle tradizioni familiari e, quindi, dalle opinioni. Nel primo caso, la scelta sarebbe legittima; ma nel secondo da ripudiare: e al filosofo pare proprio che si opti per la fede esclusivamente per motivi familiari, e adduce come prova del suo asserto il fatto che, quando si sposano due individui di fedi diverse, capita sempre che uno dei due si converta alla fede dell’altro coniuge. Orazio stesso diceva che “la giara ricorderà a lungo l’odore di ciò di cui è stata riempita”. Il filosofo mette dunque in luce la necessità di cercare criticamente il senso delle proprie scelte, e Abelardo condivide pienamente tale prospettiva, lui che arriva – anselmianamente – alla fede senza respingere la ragione.
Le tre opere fondamentali di teologia di Abelardo riguardano soprattutto il problema della Trinità. Egli non pretende di dire la verità sulla Trinità, in quanto la ragione umana non é in grado di cogliere pienamente i misteri divini, tuttavia con l’ ausilio di analogie – come aveva già fatto Agostino -, è a suo avviso possibile raggiungere almeno il verosimile. Abelardo ritiene che la distinzione fra le tre persone divine poggi sulla distinzione fra gli attributi divini e, precisamente, con il nome del Padre si indica la potenza, con quello del Figlio la sapienza e con quello dello Spirito Santo la carità. Ma poiché tali attributi in Dio costituiscono un’unità, i rapporti tra le persone divine possono essere spiegati in termini di derivazione di una dall’altra: il Padre genera il Figlio, che è della stessa sostanza del Padre, in quanto la sapienza non è che quella particolare forma della potenza divina per cui essa non può essere ingannata, invece, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, perchè la carità senza potenza sarebbe inefficace e senza la sapienza procederebbe a caso e non condurrebbe al meglio. Però in tal modo lo Spirito Santo non risulta essere della stessa sostanza del Padre e del Figlio: fu questo un punto che suscitò gli attacchi contro Abelardo, in particolare san Bernardo ritenne che esso conducesse a negare qualsiasi potenza dello Spirito Santo. Un esempio di applicazione della dialettica a una questione teologica è dato anche dalla discussione di Abelardo del problema dei cosiddetti futuri contingenti. Secondo Abelardo, l’azione di Dio, che è onnipotente, è necessaria: Dio non può fare altro che ciò che fa, ossia il bene; infatti, Dio fa ciò che vuole, ma ciò che egli vuole, in perfetta libertà, senza essere costretto da nulla, è il bene. Ora, Dio prevede tutto, anche gli eventi futuri. Ciò significa che egli determina il loro necessario verificarsi? Oppure gli eventi futuri continuano a essere contingenti, ossia non necessari? Per l’uomo gli eventi futuri sono indeterminanti; egli non può sapere anticipatamente se le proposizioni che riguardano questi eventi sono vere o false, mentre Dio non può conoscere se esse sono vere o false, e tuttavia Dio prevede gli eventi futuri come contingenti. A ciò si potrebbe obiettare: è possibile che le cose avvengano diversamente da come Dio ha previsto, altrimenti esse non sarebbero più contingenti, ma in tal caso si avrebbe come conseguenza che Dio si può ingannare nella sua previsione. La risposta di Abelardo è che sono possibili due interpretazioni: o qualcosa che Dio ha previsto ha la possibilità di avvenire diversamente oppure è possibile che qualcosa avverrà diversamente da come Dio ha previsto, ma poichè non è possibile che Dio si sbagli, la sola possibilità che qualcosa si verifichi diversamente si riferisce dunque non al prevedere di Dio, ma a ciò che è previsto. Nell’ultimo periodo della sua attività, Abelardo apre un nuovo territorio alla sua riflessione: l’ etica, alla quale dedica un’opera intitolata appunto Conosci te stesso o Etica, riprendendo nel titolo l’enigmatico motto inciso sul tempio di Apollo a Delfi (gnwqi sauton). L’ antica formula “conosci te stesso” dell’oracolo delfico, ripresa da Socrate, è usata da Abelardo per indicare all’uomo la conoscenza della propria miseria, dovuta al peccato, ma allo stesso tempo, la propria somiglianza con Dio. Abelardo distingue tra vizio e peccato: infatti, il vizio è un’inclinazione naturale al peccato, ma di per se non è peccato. Con questa affermazione, Abelardo si oppone alle forme di ascetismo, che considerano forme del peccato quelle che sono invece inclinazioni proprie della natura umana; in tal senso, contro l’ultimo Agostino, Abelardo rivendica la naturalità dell’inclinazione al piacere sessuale, che non potrà mai essere estirpata dall’uomo. Proprio in quanto naturali, le inclinazioni sono ineliminabili, possono soltanto essere contrastate; peccato è invece il consenso dato a queste inclinazioni: esso è un atto di disprezzo nei confronti di Dio, un non fare ciò che egli vuole o un non tralasciare ciò che egli vieta. In sostanza, finchè penso di commettere il male sono nell’ambito del vizio; quando invece lo compio realmente, sono nell’ambito del peccato. L’azione che eventualmente deriva dall’atto di consenso dato ad una cattiva inclinazione non aggiunge nulla al peccato stesso. Nel caso in cui il consenso interiore dato dall’inclinazione cattiva, per esempio, di uccidere un rivale, non si traduca nell’azione corrispondente, il peccato continua sempre a sussistere in tutta la sua gravità; né, d’altra parte, un’azione cattiva è di per se peccato se manca il consenso ad essa. Per esempio, colui che per sfuggire a un aggressore, per caso lo uccide, compie un’azione cattiva, ma non commette peccato, che è il vero male dell’anima. Così, una stessa azione commessa dallo stesso uomo in momenti diversi può essere buona o cattiva, a seconda dell’ intenzione dell’ anima. Su questa base, Abelardo giunge addirittura ad avanzare l’ ipotesi che gli stessi persecutori di Cristo e dei martiri non abbiano peccato, in quanto non hanno agito per disprezzo di Dio. L’ ignoranza non è peccato, ne lo è l’ essere infedeli, anche se questa condizione impedisce di essere salvati. D’ altra parte, lo stesso peccato originale, in quanto contrassegna i successori di Adamo senza che ci sia da parte loro consenso, non può essere considerato propriamente peccato: esso è piuttosto la pena di un peccato. Tutte queste proposizioni saranno condannate nel Concilio di Sens, ma, in realtà, con esse Abelardo si opponeva al formalismo e al legalismo ecclesiastico. Non è l’agire esteriore, ma l’ intenzione che qualifica ciò che è bene o male; l’atto è buono o cattivo soltanto in virtù dell’ intenzione che lo determina. Di qui, l’ importanza della contrizione rispetto all’ assoluzioneper il peccato commesso: la prima riguarda l’ interiorità, la seconda è una liberazione puramente esteriore e e formale. Un’ analoga protesta contro il formalismo e la corruzione ecclesiastica animava all’ epoca i movimenti religiosi popolari. Non è un caso che la scuola di Abelardo fosse frequentata anche da Arnaldo da Brescia, che non molto tempo dopo la morte di Abelardo lottò contro il potere temporale dei papi, instaurando in Roma un libero comune. Abelardo, tuttavia, riconosce che in terra è giusto che gli uomini siano puniti o ricompensati in base alle loro azioni: solo Dio, infatti, e non l’ uomo, è in grado di giudicare le intenzioni.
GUGLIELMO DI CONCHES
Nacque a Conches, in Normandia. La sua attività d’insegnamento andò dal 1120 a sicuramente tutto il 1154, anno da cui non si fa più menzione di lui nei documenti. Attorno al 1122 egli divenne tutore e precettore del giovane Enrico II Plantageneto, ma è possibile che abbia insegnato anche a Chartres prima di quell’anno. Giudicate come pericolose le sue idee da parte di un amico, che ne condannava il realismo per come le applicava alla teologia, Guglielmo cominciò gli studi delle filosofie islamiche e della fisica. La data, la causa e il luogo della sua morte non sono note. Guglielmo pose particolare attenzione alla cosmologia e alla psicologia. Come studente di Bernardo di Chartres, nei suoi scritti emergono i tratti di ciò che oggi definiremmo umanesimo, col chiaro riferimento al realismo platonico, e a un gusto per le scienze naturali che lo dividono nettamente dai seguaci della Scuola di Chartres. Egli fu il primo di una lunga serie di filosofi cristani medievali a trarre beneficio dagli studi di fisica e fisiologia eseguiti nelle regioni occupate dagli Arabi, e le cui traduzioni erano diffuse in Europa da Costantino l’Africano. Guglielmo di Saint-Thierry, che aveva incoraggiato Bernardo di Chiaravalle a perseguire Pietro Abelardo, in un’altra lettera a Bernardo attaccò il De philosophia mundi di Guglielmo di Conches per la sua visione modalista della Trinità. Nel suo Dramagticon, in seguito, Guglielmo rivide alcune delle sue posizioni più controverse. Guglielmo di Conches aveva infatti descritto l’uomo e la creazione secondo i principi della philosophia naturalis, ovvero fisicamente: indirettamente, l’autore negava dunque il valore della Bibbia, annullando ciò che di sacro vi era nella Genesi e nella creazione di Adamo ed Eva, che nella Scolastica indicava una prefigurazione dell’unione di Cristo con la Chiesa. Si traduceva così la teologia in mera fisica, giungendo a conclusioni naturalistiche e panteistiche (l’identificazione dello Spirito Santo come anima del mondo) del tutto inaccettabili per l’epoca. La paternità dei lavori di Guglielmo di Conches è stata ampiamente discussa per tutte le opere che gli sono state attribuite. Sembra possibile che sia l’autore dell’enciclopedico De philosophia mundi (o più semplicemente Philosophia) e del dialogo a essa relativo, il Dragmaticon, oltre a una serie di glosse sul Timeo di Platone, sulla De consolatione philosophiae di Boezio, sulle Istitutiones Grammaticae di Prisciano e sui Commentarii de Somnio Scipionis di Macrobio. Probabilmente fu anche autore di un trattato intitolato Magna de naturis philosophia, oggi perduto. Un’opera di etica, la Moralium dogma philosophorum, gli fu attribuita negli anni venti, ma molti storici della filosofia oggi rigettano l’ipotesi. Il “De philosophia mundi” si divide in quattro libri, a coprire una serie di conoscenze di fisica, astronomia, geografia, meteorologia e medicina. Guglielmo spiega che il mondo è composto di elementi (elementa), che definisce l«a più semplice e minima parte di ogni corpo, semplice in qualità e minima in quantità»[1]. Egli li identifica coi quattro elementi fondamentali (fuoco, aria, acqua, terra), ma, seguendo le idee di Costantino l’Africano, non per come esse vengono normalmente percepite – poiché esse in questo modo non sono né semplici né minime, essendo sempre presente per esempio nel terreno qualcosa di caldo, qualcosa di freddo, qualcosa di asciutto e qualcosa di umido allo stesso tempo -, bensì per come vengono afferrate e intese dalla ragione. Gli elementi puri non possono così essere percepiti, ma devono essere capiti attraverso una divisione astratta dei corpi fisici[2]. Ognuno di questi elementi di base ha in sé due caratteristiche: la terra è fredda e asciutta, l’acqua è fredda e umida, l’aria è calda e umida e il fuoco è caldo e asciutto. Gli elementi percepibili, chiamati “elementata”[3], sono composti soprattutto di elementi puri, ma non interamente. La discussione sulla meteorologia include una descrizione dell’aria, che diventa meno densa e più fredda al salire dell’altitudine, e Guglielmo cerca di spiegare la circolazione dell’aria in connessione con la circolazione degli oceani. La discussione sulla medicina si occupa soprattutto della procreazione e del parto. Questo lavoro influenzò Jean de Meung, autore della seconda parte del Roman de la Rose.
PAOLO DA VENEZIA
A cura di Enrico Gori
Paolo da Venezia fu uno dei massimi pensatori italiani del suo tempo ed uno delle figure di spicco nel panorama della Logica medievale. Le sue teorie filosofiche (la cui massima espressione si trova nell’affermazione della priorità ontologica ed epistemologica degli universali su ogni altra cosa) sono il risultato più alto del precedente pensiero realistico iniziato da John Wyclif e seguaci negli ultimi decenni del XIV secolo. Paolo sviluppò tale modo di pensare e riprese le critiche di Burley sul nominalismo. Le convinzioni metafisiche alla base della sua filosofia sono un’originale revisione delle principali tesi scotiste (univocità dell’essere; esistenza degli universali fuori dalla mente, che sono allo stesso tempo uguali e diversi dai corrispettivi individuali; identità reale e distinzione formale tra essere ed essenza; la quiddità come principio dell’individuazione; distinzione effettiva tra le dieci categorie aristoteliche), ma Paolo si concentra sui presupposti ontologici e le implicazioni della dottrina. Allo stesso tempo era disposto ad accogliere altri pareri, come dimostrano le influenze di Alberto Magno e Tommaso d’Aquino. Fu avversario quindi dei nominalisti come Ockham, Buridano e Marsilio da Inghen, talvolta contraddicendosi. Ciò contribuisce a rendere la sua opera stimolante ed arricchente da un punto di vista storico ma rende ardua la comprensione delle sue idee in modo organico. Queste riflessioni aiutano a spiegare come mai Paolo fu considerato, erroneamente ma unanimemente, un occamista in logica e metafisica e un averroista in psicologia ed epistemologia.
VITA
Paolo Nicoletto Veneto (Paulus Nicolettus Venetus) nasce a Udine nel 1369. A 14 anni si fece agostiniano nel convento di S. Stefano a Venezia. Studiò a Padova, ma nel 1390 fu inviato a Oxford, dove rimase tre anni. Nel 1405 divenne Dottore delle Arti e Teologia. Insegnò a Padova, Siena (1420-24) e Perugia (1424-28). Nel 1424 fu precettore a Bologna. In varie occasioni ricoprì posti di rilievo all’interno del suo Ordine (Papa Gregorio XII lo nominò Priore Generale degli Agostiniani nel maggio del 1409) e fu ambasciatore della Repubblica di Venezia. Morì nel 1429 a Padova mentre commentava il De anima di Aristotele.
Paolo scrisse molti trattati filosofici e teologici tra cui diversi commenti ad opere di Aristotele (De anima, Fisica, Metafisica, Analitici Secondi, Categorie), all’Isagoge di Porfirio oltre alle seguenti opere: Logica Parva, Logica Magna, Sofisticata Aurea, Summa Philophiae Naturalis e l’Ars Vetus, raccolta dei commenti agli antichi.
LOGICA
I contributi principali di Paolo alla storia della logica medievale riguardano la nozione di distinzione formale e l’analisi dei predicati.
IDENTITA’ E DISTINZIONE
La formulazione della teoria di identità e distinzione è un’estensione delle teorie di Duns Scoto e Wyclif. Il maestro italiano distingue due tipi di identità: materiale (secundum materiam) e formale (secundum formam). L’identità materiale si ha quando la causa materiale è la stessa nel numero (ossia una stessa cosa è chiamata con nomi diversi) o nella specie (quando due oggetti sono fatti della stessa materia). L’identità formale si ha quando la causa formale è la stessa. Ciò accade in due modi: se la forma in questione è forma singolare del composto individuale, allora vi è un solo oggetto conosciuto con diversi nomi; se invece la forma è l’essenza esemplificata dalla forma singolare, allora si hanno due oggetti della stessa specie o genere. Analogamente i tipi di distinzione sono due: materiale e formale. Materiale quando la causa materiale è diversa da quella formale e i due oggetti sono entità separabili. In generale, vi è distinzione formale quando la causa formale è diversa. Ciò accade in due modi: se la causa materiale è diversa, c’è un caso particolare di distinzione materiale. Se la causa materiale è la stessa, allora è necessaria un’ulteriore analisi.
Se la causa materiale è la stessa solo secundum speciem, si parla di distinzione formale impropria; ma se la causa materiale è la stessa nel numero allora è una distinzione formale propria dato che le forme prese in esame hanno diversa definizione ma stesso substrato di esistenza. Dunque sono in realtà la stessa cosa. Ad esempio vi è una differenza formale tra le proprietà del ridere (risibile) e dell’apprendere (disciplinabile) che sono forme connesse esemplificate dallo stesso insieme di sostanze individuali.
La distinzione materiale è un criterio necessario e sufficiente per la differenza effettiva tradizionalmente concepita, laddove c’è distinzione formale se e solo se vi è una sostanza secundum numerum (ad esempio identità materiale in senso stretto) ed una molteplicità di principi formali con descrizioni diverse esemplificate dalla sostanza. Perciò Paolo inverte i termini della questione in relazione agli studi precedenti: Duns Scoto e Wyclif avevano provato a spiegare, attraverso la distinzione formale, come sia possibile distinguere diversi aspetti interni ad una sostanza individuale (passaggio da uno a molti). Paolo invece tenta di ridurre la molteplicità all’unità (passaggio da molti a uno). Paolo vuole dimostrare il modo in cui entità diverse di un certo tipo ( ad esempio con modalità di esistenza incomplete e dipendenti) possano costituire una, e la stessa, sostanza secundum numerum.
PREDICABILITA’
Il punto di partenza della teoria di Paolo sui predicati è la sua dottrina degli universali. Come Wyclif ed i suoi seguaci Alyngton, Penbygull, Sharpe, Milverley, Whelpdale, Tarteys, il maestro agostiniano dice che:
1) Vi sono universali reali, essenze comuni che si prestano ad essere predicati di
diversi esseri viventi.
2) Gli universali reali e i loro individuali sono in realtà la stessa cosa, la loro distinzione è unicamente formale.
3) Il predicato è prima di tutto una relazione tra entità metafisiche.
Ma l’analisi del predicato di Paolo differisce da quella di Wyclif e seguaci nella divisione tra predicato formale e identico e li spiega diversamente dalle sue fonti. Per definire il predicato identico, è necessario che il soggetto-termine di una preposizione (vera) e la forma indicata dal termine-predicato abbiano in comune almeno un substrato di esistenza. È il caso di preposizioni quali “l’uomo è animale” e l’universale-uomo è bianco (homo in communi est album). Si parla di predicazione formale in due casi:
1) quando la veridicità della proposizione è relativa alla presenza in tutti i substrati di esistenza della forma espressa dal termine soggetto, della forma espressa dal termine-predicato in virtù di un principio formale (esplicato nella proposizione stessa) a sua volta presente in tutti i substrati di esistenza della forma rappresentata dal termine-soggetto. È il caso di proposizioni come “l’uomo è formalmente un animale”.
2) Oppure nel caso in cui il predicato sia un termine di seconda intenzione come “specie o “genere”, come nelle proposizioni come “l’uomo è una specie”, “animale è un genere”.
Come risulta evidente, il predicato identico è definito in extensio, mentre il predicato formale è definito in intensio, dato che il predicato formale implica una relazione modale tra soggetto e predicato: il predicato formale presuppone una connessione necessaria tra soggetto e predicato della proposizione. Per questo motivo, Paolo nega che frasi come “singulare est universale”, che Wyclif e seguaci ritenevano vera, siano vere proposizioni. Secondo Wyclif la frase menzionata è un esempio di predicato per essentiam; per Paolo si tratterebbe di predicato formale. L’individuale qua individuale non è un universale o viceversa, così come una seconda intenzione in intensio non è un’altra seconda intenzione. Paolo riscrive quindi la frase wyclifiana così: “singolare est hoc universale” in cui la presenza di “hoc” cambia il predicato da formale a identico. In questo modo la frase è corretta, poiché significa che una certa entità, singolare in sé, è il substrato di esistenza di un’essenza universale. Così facendo, Paolo costruisce un sistema misto in cui la copula delle frasi filosofiche oggetti del suo studio ha un triplice significato:
1) Identità parziale tra soggetto e predicato in caso di predicato identico.
2) Collegamento necessario tra le forme in caso di predicato formale di primo grado.
3) Il soggetto in sé è necessariamente parte di una data classe di oggetti in cui il predicato-termine è inscritto, e a cui si riferisce in caso di predicato di secondo grado, ossia quando il predicato è un termine di seconda intenzione.
Il mondo, secondo Paolo, consiste in esseri finiti, che esistono al di fuori della mente (case, uomini, carri) e che sono composti da una sostanza prima e un insieme di forme interne all’oggetto e da esso dipendenti. Le forme di sostanza primaria appartengono a 10 categorie dell’essere. Quindi un essere finito non può essere del tutto identificato con la sostanza primaria. Prova ne sia che questa non contiene tutta l’essenza dell’essere finito. La Sostanza è dunque un ordine di predicati categorici. Le Sostanze Primarie non sono semplici predicati, ma oggetti complessi, essendo composte da materia e forma peculiare, forma identica e formalmente distinta dalla natura specifica esemplificata dalla Sostanza. I concetti di forma e materia sono relativi, poiché i loro significati sono tra loro collegati. Essere la forma di qualcosa ed esserne la materia sono relazioni opposte di tre tipi i cui punti sono:
1) I costituenti metafisici della sostanza individuale (come la materia e forma singolare).
La natura specifica o essenza può essere concepita da un duplice punto di vista: in concreto e in abstracto (in altre parole, in extensio e in intensio). La natura specifica in abstracto esprime l’insieme di proprietà essenziali che compongono una forma categorica, senza far riferimento ad individuali, se vi sono, che la esemplificano. In concreto, la natura specifica è la stessa forma concepita come esemplificazione di almeno un’identità. Per esempio. l’umanità è tale in abstracto (humanitas), in concreto è homo. Entrambe sono forme sostanziali sovraordinate a tutto il composto umano, ma mentre “humanitas” è una forma propria (ossia esistenzialmente incompleta e dipendente, l’uomo è un’entità autonoma e indipendente. Perciò differiscono fra loro nello stesso modo in cui un predicato (come P) differisce da una formula (P(x)).
A causa della complessità della composizione metafisica degli esseri finiti, ogni creatura ha quattro livelli di esistenza: reale, temporale, essenziale ed individuale. L’essere reale non è altro che l’intera realtà dell’essere finito. L’essere essenziale è la modalità di essere propria alla natura specifica esemplificata da un dato essere singolare. L’essere temporale è lo stato designato da espressioni infinitive come “essere un uomo” (hominem esse) o “essere bianco” (album esse), ossia l’oggetto dell’atto di giudicare. Infine l’essere individuale è l’esistenza stessa della Sostanza primaria di un essere finito distinta distintamente dall’intera realtà dell’essere finito in quanto tale.
Secondo Paolo, che segue Duns Scoto e Wyclif sull’argomento, l’essere è condiviso essendo la materia modulata dalle categorie secondo le corrispettive essenze. In linea con questa posizione, Paolo non traccia una distinzione definita tra essenza ed essere. Come Duns Scoto e Wyclif, Paolo parla di differenza formale (o differenza razionale) tra essenza ed essere nelle creature, dato che l’essenza e l’essere di una cosa sono una e la stessa identità considerata da due diversi punti di vista, in abstracto e in concreto. Tale analisi identifica l’opposizione tra essere ed essenza con l’opposizione universali-individuali. Come Wyclif, Paolo pensa all’essenza come
forma universale concepita in abstracto, e l’esistenza (in senso stretto) come la modalità dell’essere propria della Sostanza primaria. Quindi, affermando la differenza formale e l’identità reale di essere ed essenza, Paolo ripropone semplicemente la tesi di identità reale e distinzione formale tra universali ed individuali tipica dei Realisti tardomedievali. Di conseguenza, come Burley e Wyclif, Paolo ritiene che un universale formale in actu esista fuori dalla mente solo se se vi è almeno un individuale che lo esemplifica, cosicché le nature comuni non sono propriamente universali senza individuali. Ciò significa che la relazione tra nature comuni e singolari è fissata sull’individuale, dato che l’esemplificazione e l’universalità de actu non sono possibili senza individuazione. Sull’argomento, Paolo concilia efficacemente l’approccio scotista con alcune tesi tomistiche. Paolo dichiara che il principio di individuazione è duplice, immanente e remoto. Il principio immanente è quello la cui presenza implica necessariamente l’esistenza dell’individuale costituito, e la cui assenza implica necessariamente la non-esistenza (o scomparsa) dell’individuale; il principio remoto è solo ciò che è presupposto dal principio individuale, ma la cui presenza ed assenza da sole non sono sufficienti per determinare l’esistenza, o la scomparsa, dell’individuale, poiché continua l’essere dopo la corruzione dell’individuale. La “haeccitas” è il principio immanente di individuazione, laddove forma, materia e quantità sono il principio remoto. La haeccitas ha a sua volta un’origine duplice: deriva da forma e materia insieme nelle sostanze corporee e dall’essenza (quidditas) nelle intelligenze angeliche. Inoltre, secondo Paolo vi è una similarità stretta tra la haeccitas, da lui chiamata differentia individualis, e la differenza specifica. Quest’ultima è ciò che differenzia la specie dal genere, essendo la determinazione di proprietà che, una volta sommata al genere dà la specie. La differenza specifica è realmente identica al genere, dal quale è distinta solo in virtù di un principio formale. Lo stesso accade alla differenza individuale: è ciò che differenzia l’individuale dalla specie; dal punto di vista ontologico, è realmente identico a e formalmente distinto da la specie in sé, ed è in virtù del principio formale se l’individuale è quello che è, qualcosa di particolare, concreto, e perfettamente definito in sé.
Per quanto riguarda l’individuazione angelica, la conseguenza logica che deriva dalle premesse supposte è che è impossibile trovare due angeli che condividano la stessa natura specifica e siano numericamente distinti, dato che solo una haecceitas può derivare da una specie incorporea. Questa soluzione è vicina al significato profondo della posizione scotista e contrasta con quella di Tommaso, sebbene Paolo affermi che le intelligenze angeliche sono diverse specificamente e non numericamente. Per Tommaso gli angeli sono specificamente differenti perché sono incorporei, e senza materia l’individuazione non è possibile. Al contrario Paolo pensa che gli angeli siano individualizzati attraverso la haeccitas, ma senza esserne moltiplicati proprio perché sono incorporei. così vi è solo un angelo per specie. Siccome le nature specifiche degli esseri incorporei non hanno alcun collegamento con la materia, solo un unico principio di individuazione (ratio suppositalis) può derivare da tali specie. Di conseguenza, nessun angelo è numericamente uno in senso stretto (poiché l’essere uno numericamente implica necessariamente la presenza di molteplicità di cose della stessa specie), sebbene, in un senso più ampio ogni angelo sia numericamente uno, dato che due (o più) angeli sono, dopo tutto, “molte cose” ma mai dello stesso tipo
Nella sua ultima opera, il commento all’Ars Vetus, Paolo riepiloga la sua posizione nel modo seguente:
1) L’individuale è il risultato finale di un processo di individuazione il cui punto di partenza è una forma specifica.
2) L’individuazione è ciò che differenzia l’individuale dalla specie.
3) L’individuazione non è altro che la stessa haeccitas.
4) La haeccitas e la forma specifica sono distinte solo formalmente dall’individuale composto.
5) Il principio di individuazione, quando provoca il passaggio dal livello degli universali a quello dei singolari, non svolge il ruolo di forma (o atto) in relazione alla natura specifica, ma il ruolo di materia (o potenza), essendo ciò che la forma specifica struttura.
In questo modo, Paolo tenta di risolvere le aporie della teoria scotista di individuazione. Duns Scoto non aveva detto niente sul problema della relazione tra haeccitas e la materia particolare e la forma che costituiscono l’individuo. Il Mil maestro Francescano aveva taciuto anche riguardo una possibile identificazione della haeccitas con una delle due forme essenziali della sostanza individuale, la forma partis (ad esempio, l’anima individuale) e la forma totius (la natura umana). Paolo identifica il principio di individuazione con l’atto di formazione attraverso cui la natura specifica modella la propria materia. Tale identificazione fu già suggerita dall’opposizione tra i principi immanenti e remoti di individuazione descritti nella Summa philosophiae naturalis. In effetti, tutti i costituenti del composto individuale (materia, forma e quantità) erano stati opposti alla quidditas, che, per questo motivo non poteva essere identificata con questi. Inoltre, e ovvio che:
1) La “nascita” dell’individuale è determinata dall’unione della forma singolare con la propria materia.
2) La “morte” dell’individuale è determinata dalla separazione dalla materia della forma singolare.
3) L’unione della forma singolare con la propria materia è la condizione necessaria e sufficiente per il passaggio dell’essenza specifica dalla sua modalità in abstracto dell’essere sulla modalità in concreto dell’essere.
PSICOLOGIA
Paolo respinge la concezione agoostina della relazione dell’anima con il corpo e segue la dottrina arristotelica dell’anima come forma del corpo. Ma, contro Aristotele e seguendo Tommaso, Paolo dice che, sebbene l’anima sia una forma del corpo, l’anima umana è una forma auto-sussistente e quindi incorruttibile. Comunque, a differenza di Tommaso, Paolo dichiara che, l’anima umana è duplice poiché deriva, nella sua integrità, dalla stretta unione di due principi distinti, quello cogitativo e quello intellettivo. Il primo è la causa dell’istintività, e il secondo della razionalità umana; nessuna può esistere nell’uomo singolarmente, e l’anima cogitativa è potenzialmente correlata all’anima intellettiva.
Come Tommaso, Paolo sostiene la distinzione tra l’anima e le sue facoltà. Ma, in contrasto con l’Aquinate, ritiene che ci sia solo una distinzione formale (ratione et definitione) tra le stesse facoltà. Laddove le facoltà dell’anima cogitativa dipendono dagli organi del corpo per le loro operazioni, le facoltà dell’anima intellettiva , come l’intelletto attivo, l’intelletto passivo e la volontà, sono indipendenti dal corpo, sebbene in stato di unione con esso abbiano bisogno delle sensazioni per esercitare la loro funzione, non essendo possibili gli atti di sensazione senza la partecipazione del corpo. Oltre alla facoltà vegetativa (che regola il nutrimento, la crescita e riproduzione) e le facoltà locomotorie, le facoltà dell’anima cogitativa sono le seguenti: i cinque sensi esteriori, il senso generale (sensus communis), la fantasia (phantasia), la facoltà di valutazione (vis aestimativa) e la memoria. Contro Avicenna, Paolo nega esplicitamente l’esistenza di un quinto senso interno, l’immaginazione, poiché pensa che le sue operazioni siano analoghe a quelle della fantasia. Il senso generale distingue ed assembla le informazioni dei sensi esteriori speciali. La fantasia conserva le specie sensibili apprese dai sensi e li combina. La facoltà di valutazione riconosce quelle proprietà delle cose che non possono essere percepite attraverso i sensi come, ad esempio, che qualcosa è utile ad un certo scopo, o amichevole, od ostile. La memoria è il “magazzino” dove tutte le specie sensibili sono poste, sicché l’anima cogitativa può operare anche in assenza di oggetti sensibili.
Secondo Nardi, 1958, Ruello,1980, e Kuksewicz, 1983, Paolo era un Averroista in psicologia, avendo appoggiato le tesi di unicità e della separazione dell’intelletto passivo per l’intera specie umana. Ma ciò è falso. Al contrario, il punto di vista di Paolo è vicino a Tommaso sulla questione dell’intelletto passivo, e ad Avicenna sull’intelletto attivo. Se le sue affermazioni contenute nella Summa philosophiae Naturalis sono ambigue ed è quindi possibile non coglierne il significato profondo, nei suoi commenti sul De anima e sulla Metafisica Paolo respinge decisamente tutte le tesi di base dell’averroismo. Prima di tutto, Paolo ritiene l’immortalità personale (tesi negata dagli averroisti puri) e, come i seguaci medievali di Avicenna, identifica l’intelletto attivo con l’attività divina di “illuminazione” dell’anima. In secondo luogo Paolo dichiara, contro Averroé, che l’anima intellettiva è forma e atto del corpo. Inoltre afferma che:
1) Le specie intenzionali presenti nei sensi esteriori, in quelli interiori e nell’intelletto sono di 3 tipi diversi.
2) L’individuale è un oggetto dell’intelletto.
3) La stessa specie intelligibile attraverso cui comprendiamo le essenze sostanziali è il mezzo in virtù del quale possiamo capire la struttura peculiare dell’individuale che esemplifica l’essenza.
Queste tesi sono l’esatto opposto delle convinzioni averroiste. Infine, Paolo polemizza apertamente contro l’unicità dell’intelletto passivo, utilizzando argomenti tratti dalle opere tommasiane De unitate intellectus contra Averroistes e la Summa Theologica. Tra questi, i più importanti sono:
1) Se l’anima è la forma del corpo, come afferma Aristotele, è impossibile che l’intelletto passivo è uno per tutti gli uomini, poiché lo stesso principio numerico non può essere forma di molteplicità di sostanze.
2) Se l’intelletto passivo è uno per tutti gli uomini, allora dopo la morte non resta nulla dell’uomo tranne questo intelletto e in questo modo la distribuzione di ricompense e punizioni è risolta.
3) Un unico intelletto potrebbe implicare opinioni contraddittorie, violando così in apparenza il principio di non contraddizione.
Più generalmente Paolo pensa che le tesi averroiste manchino di una base filosofica solida, dato che possono essere ritenute solo dal punto di vista fisico, secondo cui tutto è considerato influenzato o collegato con il movimento, ma tali proposizioni sono assolutamente errate dal punto di vista metafisico, il più vasto di tutti. Da questa posizione, secondo cui l’intelletto passivo deve essere considerato una forma sostanziale, è evidente che comincia nel tempo, ma di certo non vi finisce, e che, come ogni altra forma sostanziale materiale, è moltiplicata secondo la moltiplicazione dei corpi.
GIOVANNI DI SALISBURY
Di origine sassone andò in Francia nel 1136 dove studiò a Parigi e strinse amicizia con Pietro di Celle. Presente al Concilio di Reims, tornò in Inghilterra nel 1150 dove divenne segretario di Theobaldo di Bec a Canterbury e fu da questo mandato frequentemente in missione presso la Santa Sede. Filosofo della Scolastica scrisse molte opere, nel 1159 pubblicò i suoi lavori sull’educazione. Dopo la morte di Theobaldo di Bec nel 1161 divenne segretario di Thomas Becket avendo una parte importante nella lunga disputa tra il primate ed il sovrano Enrico II d’Inghilterra. Dopo l’assassinio di Becket scrisse La vita di Becket. Nel 1176 divenne vescovo di Chartres e partecipò al Concilio Lateranense III. Morì a Chartres il 25 ottobre 1180. L’interesse di Giovanni per la cultura antica emerge già nei titoli delle sue opere principali , ricalcati sul greco , il Metalogico e il Policratico . Il primo , iniziato nella seconda metà del secolo , é una difesa della logica , che a Giovanni pare utile in ogni ambito del sapere . Sulla scorta di Cicerone , Giovanni si dichiara accademico , ritenendo che la conoscenza umana possa accedere solo al probabile , attenendosi a ciò che accade frequentemente , e poichè non si può essere assolutamente certi del futuro , su questa base egli critica le pretese divinatorie dell’ astrologia . Giovanni , tuttavia , non intende cadere in una forma di scetticismo radicale : i sensi , la ragione e la fede possono dare alcune certezze . I sensi rendono indubitabile , per esempio , che il sole riscaldi e il fuoco bruci , la ragione che la metà sia contenuta nel tutto e la fede che Dio esista , sia potente , sapiente e buono . Quest’ ultimo é il principio di ogni religione , mentre la Trinità divina resta incomprensibile , nel suo mistero , per l’ uomo . Il Policratico , composto da Giovanni prima del conflitto tra il re d’ Inghilterra e l’ arcivescovo di Canterbury , Thomas Becket , che sarà poi assassinato nella cattedrale della stessa città , é una delle opere più importanti del pensiero politico medioevale . Sulla questione dei due poteri , quello spirituale della Chiesa e quello temporale del re , Giovanni non abbraccia la teoria della netta distinzione tra essi , elaborata dai sostenitori dell’ impero . Egli tende piuttosto a riconoscere una certa superiorità del potere spirituale , ma lasciando al principe il compito del governo del popolo . Problema centrale , nella riflessione di Giovanni , diventa appunto quello del rapporto tra principe e popolo , alla base del quale vi é la legge di natura , che vale universalmente ed é vincolante per tutti . La nozione di legge di natura é di origine soprattutto stoica e Giovanni la trova esposta , in particolare , negli scritti di Cicerone . Tale legge proviene direttamente da Dio , é l’ immagine della sua volontà e la salvaguardia della sicurezza e dell’ unità del popolo ; il principe invece impersona la totalità dei suoi sudditi e deve pertanto preoccuparsi del loro benessere . Giovanni traccia quindi un ritratto del principe perfetto , che dovrebbe avere un consigliere saggio e sapiente come Aristotele . Per questo aspetto , l’ opera di Giovanni s’ inscrive nella tradizione trattatistica dello speculum principis , mirante a tracciare il quadro delle virtù che devono essere proprie del buon governante . Su questa base , é possibile distinguere nettamente il vero principe dal tiranno , e il criterio decisivo é dato dall’ obbedienza alla legge , che invece il tiranno non rispetta . Dall’ impostazione di Giovanni potrebbe scaturire un atteggiamento ambivalente : da una parte , sembra possibile giustificare l’ accettazione passiva anche di un dominio tirannico , dal momento che la legge proviene direttamento da Dio e sarà dunque Dio a punire il tiranno , ma , dall’ altra , é anche possibile legittimare la resistenza al tiranno e persino il tirannicidio , come fa appunto Giovanni .
GUGLIELMO DI MOERBEKE
A cura di Enrico Gori
Vissuto tra il 1215 circa e il 1286, grande conoscitore della lingua greca, Guglielmo di Moerbeke fu una figura di profondo spessore culturale. Ebbe modo di confrontarsi con le più importanti menti del suo tempo, fu il traduttore di testi medici, filosofici e scientifici dal greco al latino. Le sue traduzioni furono fondamentali, in un’epoca nella quale i traduttori di buona fatta erano rari e, soprattutto, hanno il pregio di essere sopravvissute fino a noi. Nato probabilmente a Moerbeke, presso Geraardsbergen nel Brabante, divenne domenicano, forse nel convento di Lovanio. Studiò a Parigi e a Colonia. Soggiornò in Grecia e viaggiò in Asia Minore. Nel 1260 fu a Nicea e a Tebe, quindi presso la curia pontificia a Viterbo e ad Orvieto ed ebbe l’incarico di penitenziere e cappellano del papa sotto Urbano IV e Clemente IV. Nel 1272, Gregorio X gli affidò legazioni diplomatiche. Partecipò al concilio Laterano IV e nel 1278 venne eletto arcivescovo di Corinto. Fu in contatto con molti scienziati dell’epoca, come Witelo, Enrico Bate, Campano, Rosello di Arezzo, e in particolare collaborò con Tommaso d’Aquino, da cui ebbe l’incarico di redigere o di correggere la traduzione di molte opere aristoteliche, di interesse anche scientifico, quali la Physica, il De generatione animalium, il De partibus animalium, il De coelo et mundo (con il relativo commento di Alessandro di Afrodisia), le Meteore (con il commento di Alessandro). Tradusse anche numerose opere di Archimede, opere di ingegneria (come il De aquarum conductis et ingeniis erigendis di Erone Alessandrino) e opere di medicina (come il De virtutibus alimentorum di Galeno, traduzione conclusa a Viterbo, presso la curia papale, nell’ottobre del 1277). Guglielmo di Moerbeke fu il primo traduttore della Politica di Aristotele. La ragione della richiesta di traduzione avanzata da Tommaso (il quale, a differenza di Guglielmo, non conosceva il greco) era l’utilizzo fuorviante e mistificante che dei testi di Aristotele facevano gli averroisti, autori delle dette traduzioni latine, che, partite dalla Spagna, venivano tradotte in Siriaco e poi in Arabo. Già nel XIV secolo erano testi classici ed accettati, quando Henricus Hervodius ne dichiarò il loro valore imperituro: erano letterali (de verbo in verbo), fedeli allo spirito aristotelico e senza troppa eleganza. A causa di numerose traduzioni di Guglielmo, molti originali greci sono scomparsi, o meglio hanno assunto nuova forma, mescolandosi col pensiero di Guglielmo: ma al tempo stesso, senza di lui parecchie opere sarebbero andate irrimediabilmente perse. Nel Nome della rosa di Umberto Eco, Guglielmo di Baskerville sa che la Poetica di Aristotele che Jorge tiene nascosta è stata tradotta da Guglielmo di Moerbeke. Guglielmo tradusse anche opere di Archimede e di Erone di Alessandria. Particolarmente importante fu la traduzione degli Elementi di teologia di Proco, poiché si trattò di una delle fonti essenziali del neoplatonismo duecentesco. La Biblioteca Vaticana conserva le traduzioni di Archimede con commento di Eutoco, composte nel 1269 a Viterbo. Guglielmo consultò due dei migliori manoscritti greci di Archimede, entrambi andati persi.
BERNARDO
Terzo di sette fratelli, nacque da Tescelino il Sauro, vassallo di Oddone I di Borgogna, e da Aletta, figlia di Bernardo di Montbard, anch’egli vassallo del duca di Borgogna. Studiò solo grammatica e retorica (non tutte le sette arti liberali, dunque) nella scuola dei canonici di Nôtre Dame di Saint-Vorles, presso Châtillon-sur-Seine, dove la famiglia aveva dei possedimenti. Ritornato nel castello paterno di Fontaines, nel 1111, insieme ai cinque fratelli e ad altri parenti e amici, si ritirò nella casa di Châtillon per condurvi una vita di ritiro e di preghiera finché, l’anno seguente, con una trentina di compagni si fece monaco nel convento cistercense di Cîteaux, fondato quindici anni prima da Roberto di Molesmes e allora retto da Stefano Harding. Nel 1115, insieme con dodici compagni, tra i quali erano quattro fratelli, uno zio e un cugino, si trasferì nella proprietà di un parente, nella regione della Champagne, che aveva donato ai monaci un vasto terreno sulle rive del fiume Aube, nella diocesi di Langres perché vi fosse costruito un nuovo convento cistercense: essi chiamarono quella valle Clairvaux, chiara valle. Ottenuta l’approvazione del vescovo Guglielmo di Champeaux e ricevute numerose donazioni, l’abbazia divenne in breve tempo un centro di richiamo oltre che di irradiazione: già dal 1118 monaci di Clairvaux partirono per fondare altrove nuovi conventi, come a Trois-Fontaines, a Fontenay, a Foigny, a Autun, a Laon; si calcola che nell’arco dei primi 40 anni furono sessantotto i conventi fondati da monaci provenienti da Chiaravalle. Nella Lettera 1, spedita verso il 1124 al cugino Roberto, Bernardo mostra di considerare la vita monastica dei benedettini di Cluny, allora all’apogeo del loro sviluppo, come un luogo che negava i valori della povertà, dell’austerità e della santità; egli rifiuta la teoria della regola benedettina della stabilitas – ossia del legame permanente e definitivo che dovrebbe stabilirsi fra monaco e monastero – sostenendo la legittimità del passaggio da un convento cluniacense a uno cistercense, essendovi in quest’ultimo professata una regola più rigorosa e più aderente alla Regola di San Benedetto, pertanto una vita monastica perfetta. La polemica fu da lui ripresa nell’ Apologia all’abate Guglielmo, sollecitata da Guglielmo, abate del monastero di Saint-Thierry, che ebbe una risposta dall’abate di Cluny, Pietro il Venerabile, nella quale l’abate rivendicava la legittimità della discrezione nell’interpretazione della regola benedettina. Nel 1130, alla morte di Onorio II, furono eletti due papi: uno, dalla fazione della famiglia romana dei Frangipane, col nome di Innocenzo II e un altro, appoggiato dalla famiglia dei Pierleoni, con il nome di Anacleto II; Bernardo appoggiò attivamente il primo che, nella storia della Chiesa, per quanto eletto da un minor numero di cardinali, sarà riconosciuto come autentico papa, grazie soprattutto all’appoggio dei maggiori regni europei. Numerosi furono i suoi interventi in questioni che riguardavano i comportamenti di ecclesiastici: accusò di scorrettezza Simone, vescovo di Noyon e di simonia Enrico, vescovo di Verdun; nel 1138 favorì l’elezione a vescovo di Langres del proprio cugino Goffredo della Roche-Vanneau, malgrado l’opposizione di Pietro il Venerabile e, nel 1141, ad arcivescovo di Bourges di Pietro della Châtre, mentre l’anno dopo ottenne la sostituzione di Guglielmo di Fitz-Herbert, vescovo di York, con l’amico cistercense Enrico Murdac, abate di Fountaine. Nel 1119 alcuni cavalieri, sotto la guida di Ugo di Payns, feudatario della Champagne e parente di Bernardo, fondarono un nuovo ordine monastico-militare, l’Ordine dei Cavalieri del Tempio, con sede in Gerusalemme, nella spianata ove sorgeva il Tempio ebraico; lo scopo dell’Ordine, posto sotto l’autorità del patriarca di Gerusalemme, era di vigilare sulle strade percorse dai pellegrini cristiani. L’Ordine ottenne nel concilio di Troyes del 1128 l’approvazione di papa Onorio II e sembra che la sua regola sia stata ispirata da Bernardo, il quale scrisse, verso il 1135, l’Elogio della nuova cavalleria (De laude novae militiae ad Milites Templi). L’interesse di Bernardo per le vicende politiche del suo tempo si manifestò anche in occasione dei conflitti che opposero il conte della Champagne, Tibaldo II, da lui sostenuto, al re Luigi VII di Francia e in occasione della repressione, nel 1140, del neonato Comune di Reims, operata dal suo pupillo cistercense, il vescovo Sansone di Mauvoisin. L’ Apologia contra Bernardum di AbelardoGrande fu la risonanza del conflitto che oppose Bernardo al filosofo Pietro Abelardo. Nel 1140 Guglielmo di Saint-Thierry, cistercense del convento di Signy, scriveva al vescovo di Chartres, Goffredo di Lèves e a Bernardo, denunciando che due opere di Abelardo, il Liber sententiarum e la Theologia scholarium, contenevano, a suo giudizio, affermazioni teologicamente erronee, elencandole in un proprio scritto, la Discussione contro Pietro Abelardo. Bernardo, senza preoccuparsi di leggere i testi, scrisse a papa Innocenzo II la Lettera 190, sostenendo che Abelardo concepiva la fede una semplice opinione; davanti agli studenti parigini pronunciò il sermone de La conversione, attaccando Abelardo e invitandoli ad abbandonare le sue lezioni. Abelardo reagì chiedendo all’arcivescovo di Sens di organizzare un pubblico confronto con Bernardo, da tenersi il 3 giugno 1140, ma questi, temendo l’abilità dialettica del suo controversista, il giorno prima presentò 19 affermazioni chiaramente eretiche, attribuendole ad Abelardo, chiamando i vescovi presenti a condannarle e invitando il giorno dopo lo stesso Abelardo a pronunciarsi in proposito. Al rifiuto di Abelardo, che abbandonò il concilio, seguì la condanna dei vescovi, ribadita il 16 luglio successivo dal papa. Nel 1144 il monaco Evervino di Steinfeld lo informò di un’eresia, di tipo pauperistico, diffusa in quel di Colonia, alla quale rispose con i Sermoni 63, 64, 65 e 66; l’anno successivo accolse l’invito del cardinale di Ostia, Alberico, a combattere un’eresia diffusa nella regione di Tolosa dal monaco Enrico di Losanna, seguace di Pietro di Bruys, critico nei confronti delle gerarchie ecclesiali e propositore di una vita improntata alla povertà e alla penitenza; in questa occasione, Bernardo ritenne necessario recarsi, insieme con il suo segretario Goffredo d’Auxerre a Tolosa. Ottenuta, dopo molti contrasti, una professione di fede, tornò a Chiaravalle e indirizzò una lettera agli abitanti di Tolosa – la Lettera 242 – nella quale esprimeva la sua convinzione che quelle dottrine fossero state definitivamente confutate. Richiesto ancora di pronunciarsi sulle tesi trinitarie del vescovo di Poitiers e maestro di teologia a Parigi, Gilberto Porretano, nel 1148, nuovamente Bernardo tentò di far approvare da vescovi da lui riuniti a parte, una preventiva condanna che il sinodo da tenere il giorno successivo a Reims avrebbe dovuto semplicemente ratificare; questa volta, tuttavia, i vescovi non appoggiarono la sua iniziativa, tanto che Bernardo dovette cercare appoggio da papa Eugenio III. La difesa di Gilberto – che affermò di non aver mai sostenuto le tesi a lui contestate, frutto, a suo dire, di interpretazioni erronee dei suoi studenti – fece cadere ogni accusa. Il 15 febbraio 1145, a Roma, nel convento di san Cesario, sul Palatino, il conclave eleggeva nuovo papa Eugenio III, abate del convento romano dei Ss Vincenzo e Anastasio; il nuovo papa, Bernardo Paganelli, conosceva bene Bernardo, per averlo incontrato nel concilio di Pisa del 1135 e per essersi ordinato cistercense proprio a Chiaravalle nel 1138. Bernardo, felicitandosi per l’elezione, gli ricordava curiosamente che si diceva «che non siete voi a essere papa, ma io e ovunque, chi ha qualche problema si rivolge a me» e che era stato proprio lui, Bernardo, ad «averlo generato per mezzo del Vangelo». Eugenio III incaricò Bernardo di predicare a favore della nuova crociata che si stava preparando, e che avrebbe dovuto essere composta soprattutto da francesi, ma Bernardo riuscì a coinvolgere anche i tedeschi. La crociata fu un completo fallimento che Bernardo giustificò, nel suo trattato La considerazione, con i peccati dei crociati, che Dio aveva messo alla prova. Questo trattato, finito di comporre nel 1152 si occupava anche dei compiti del papato, e Bernardo lo mandò a papa Eugenio che si dibatteva con le difficoltà procurategli dall’opposizione dei repubblicani romani, guidati da Arnaldo da Brescia. Le sue condizioni di salute cominciano a peggiore alla fine del 1152: ha ancora la forza di intraprendere un viaggio fino a Metz, in Lorena, per mettere fine ai disordini che travagliavano quella città. Tornato a Chiaravalle, apprende la notizia della morte di papa Eugenio, avvenuta l’8 luglio 1153 e muore il mese dopo. Rivestito con un abito appartenuto al vescovo Malachia, del quale aveva appena finito di scrivere una biografia, viene sepolto davanti all’altare della sua abbazia. Riguardo il suo pensiero teologico e filosofico, Bernardo esprime sul piano morale un orientamento ispirato, apparentemente, al pessimismo: « […] generati dal peccato, noi peccatori generiamo peccatori; nati corrotti, generiamo dei corrotti; nati schiavi, generiamo degli schiavi. » San Bernardo, dunque, combatte alcune tesi del suo tempo, come la teoria secondo la quale i discendenti di Adamo (cioè noi) non abbiano in sé un «peccato originale» sin dalla nascita, ma solo un «malum poenae», un «male di pena». Bernardo dice anche: « L’uomo è impotente di fronte al peccato. » Ciò, evidentemente non è una giustificazione al peccato stesso, ma una spiegazione della miseria umana che nei nostri peccati si rivela, ma che è originata dal peccato originale che in ciascuno è impresso come un marchio. Dunque, la questione fondamentale è restaurare la natura umana, per riportare l’uomo al suo stato di «figlio di Dio», e dunque «essere eterno» nella beatitudine del Padre. Poiché ognuno porta in sé il peccato originale, però, nessuno può restaurare la propria natura da solo, ma può farlo solamente attraverso la «mediazione» di Cristo, che è «Soter» (cioè «Salvatore»), proprio in quanto per noi è morto, espiando al nostro posto quel peccato originale che nessun altro poteva espiare, essendone sottoposto. Nella sua opera De gradibus humilitatis et superbiae, tuttavia, dice che, per avere la «mediazione» di Cristo, l’uomo deve superare l’«io di carne», deve limitare e poi annullare la superbia e l’amore di sé, attraverso l’umiltà. Contro di sé, dunque, deve porre l’amore di Dio, poiché solo col Suo amore si ottiene anche la Sua vera intelligenza, e solo con esso « […] l’anima passa dal mondo delle ombre e delle apparenze all’intensa luce meridiana della Grazia e della verità. » Nel “De diligendo Deo”, San Bernardo continua la spiegazione di come si possa raggiungere l’amore di Dio, attraverso la via dell’umiltà. La sua dottrina cristiana dell’amore è originale, indipendente dunque da ogni influenza platonica e neoplatonica. Secondo Bernardo esistono quattro gradi sostanziali dell’amore, che presenta come un itinerario, che dal sé esce, cerca Dio, ed infine torna al sé, ma solo per Dio. I gradi sono:
1) L’amore di se stessi per sé: « […] bisogna che il nostro amore cominci dalla carne. Se poi è diretto secondo un giusto ordine, […] sotto l’ispirazione della Grazia, sarà infine perfezionato dallo spirito. Infatti non viene prima lo spirituale, ma ciò che è animale precede ciò che è spirituale. […] Perciò prima l’uomo ama sé stesso per sé […]. Vedendo poi che da solo non può sussistere, comincia a cercare Dio per mezzo della fede, come un essere necessario e Lo ama. »
2) L’amore di Dio per sé: « Nel secondo grado, quindi, ama Dio, ma per sé, non per Lui. Cominciando però a frequentare Dio e ad onorarlo in rapporto alle proprie necessità, viene a conoscerlo a poco a poco con la lettura, con la riflessione, con la preghiera, con l’obbedienza; così gli si avvicina quasi insensibilmente attraverso una certa familiarità e gusta pura quanto sia soave. »
3) L’amore di Dio per Dio: « Dopo aver assaporato questa soavità l’anima passa al terzo grado, amando Dio non per sé, ma per Lui. In questo grado ci si ferma a lungo, anzi, non so se in questa vita sia possibile raggiungere il quarto grado. »
4) L’amore di sé per Dio: « Quello cioè in cui l’uomo ama sé stesso solo per Dio. […] Allora, sarà mirabilmente quasi dimentico di sé, quasi abbandonerà sé stesso per tendere tutto a Dio, tanto da essere uno spirito solo con Lui. Io credo che provasse questo il profeta, quando diceva: “-Entrerò nella potenza del Signore e mi ricorderò solo della Tua giustizia-“. […] » (San Bernardo di Chiaravalle, De diligendo Deo, cap. XV)
Nel De diligendo Deo, dunque, San Bernardo presenta l’amore come una forza finalizzata alla più alta e totale fusione in Dio col Suo Spirito, che, oltre ad essere sorgente d’ogni amore, ne è anche «foce», in quanto il peccato non sta nell’«odiare», ma nel disperdere l’amore di Dio verso il sé (la carne), non offrendolo così a Dio stesso, Amore d’amore.
UGO DI SAN VITTORE
Gli studi e la spiritualità che si instaurano nell’ abbazia di San Vittore a Parigi , fondata dal maestro e avversario di Abelardo , Guglielmo di Champeaux , mostrano come la stessa cultura monastica , innestata in un tessuto urbano , giunga a modificare i suoi contenuti e i suoi caratteri . Allievo di Guglielmo é Ugo di San Vittore , morto nel 1141 , il quale , originario della Sassonia , insegna a San Vittore le arti liberali e la teologia . Egli corregge la tendenza a considerare immediatamente l’ universo un sistema di simboli e a trovare una corrispondenza immediata tra macrocosmo e microcosmo . In una delle sue opere principali , il Didascalico , egli sostiene che se si interpreta allegoricamente il testo sacro a prescindere dalle ” historia ” , ossia dal suo significato letterale , si procede a vuoto . La Scrittura é come una grande ” fabrica spiritualis ” , una struttura nella quale cose e parole hanno significato , anche simbolico , ma all’ interno di una trama storica , dalla quale non possono essere separate . Nello scritto ” Sui Sacramenti della fede cristiana ” Ugo interpreta allegoricamente i misteri della fede , ma ancorandola alla ” historia ” , mira ad eliminare eventuali arbitrarietà dall’ interpretazione . Nel Didascalico Ugo costruisce una sorta di mappa del sapere , che mostra come l’ ambiente di San vittore , inserito in un contesto urbano , fosse ormai attento anche al mondo delle arti . Contrariamente a San Bernardo , Ugo rivaluta il sapere profano in tutti i suoi aspetti : esso é subordinato alla scienza sacra , ma non é in contrasto con essa , bensì é un gradino che conduce ad essa . L’ uomo caduto a causa del peccato originale deve infatti percorrere un cammino che lo guidi al ricupero della conoscenza e della virtù originale , che sono state smarrite . ” Impara tutto , vedrai che poi nulla é superfluo ” , dice Ugo . Su questa base , egli procede ad una articolazione delle forme del sapere non più fondata sulla tradizionale partizione in trivio e quadrivio , o meglio , tale partizione viene riassorbita in un quadro più ampio , che presenta come novità saliente uno spazio anche per la pratica e per le tecniche . La stessa meccanica vi trova posto , anche se l’ idea classica della superiorità della contemplazione , rafforzata dalla concezione cristiana del lavoro come castigo inflitto a causa del peccato originale commesso da Adamo , conduce Ugo a qualificarla con gli aggettivi di ” servile ” e ” adultera ” , nel senso platonico di una inferiorità degli oggetti artificiali rispetto agli originali . Nonostante ciò , la meccanica stessa , inserita nel quadro delle discipline che hanno al loro vertice la teologia , si riveste di nuova dignità , sicchè anche le forme più basse del sapere , che permeano le attività cittadine del commercio e dell’ artigianato , possono contribuire all’ ascesa verso le conoscenze più alte e , quindi , a Dio . In questo senso , la mappa del sapere di Ugo di San Vittore é anche specchio della rinascita del mondo delle città nel XII secolo , tanto più significativo in quanto proveniente da un ambiente monastico . Al di sopra delle vie della ragione , che la natura dà all’ uomo , si collocano , secondo Ugo , le vie della rivelazione , che sono date dalla grazia ; esse hanno luogo o per via di illuminazione interna o attraverso gli insegnamenti della tradizione : la grazia , così , completa la natura . Ma anche la ragione , partendo dalla considerazione delle cose esterne o interne all’ uomo , é in grado di giungere al riconoscimento dell’ esistenza di Dio , della Trinità e della creazione del mondo . Diversamente da Abelardo , Ugo sostiene che Dio avrebbe potuto creare un mondo migliore ; se si nega questa possibilità , si deve ammettere o che il mondo non é privo di alcuna perfezione o che esso non é suscettibile di avere una perfezione maggiore di quella che ha e quindi é imperfetto , ma , nel primo caso , il mondo sarebbe simile a Dio , in quanto entrambi sarebbero o finiti o infiniti , e ciò é assurdo , perchè non é possibile che non ci sia differenza tra ciò che é creato e il creatore ; nel secondo caso , invece , si ha las conferma che il mondo , essendo incapace di una perfezione maggiore , é imperfetto . Di conseguenza , solo Dio é perfetto e il mondo creato non possiede una perfezione assoluta . La creazione , d’ altra parte , é un libero atto della volontà divina , ma mentre la volontà di creare da parte di Dio é eterna , non é eterno ciò che é creato in virtù della volontà divina . Inoltre , Dio non vuole qualcosa in quanto questo qualcosa é buono ( come aveva detto Platone ) , ma questo é buono in quanto voluto da Dio . In particolare , Dio ha creato l’ uomo perchè lo serva , così come ha creato il mondo sensibile perchè sia al servizio dell’ uomo . Il percorso di avvicinamento dell’ uomo a Dio ha il suo momento culminante nella via mistica , che si articola in tre momenti : 1) cogitatio , ossia il pensiero che procede per immagini che gli provengono dai sensi o dalla memoria ; 2) meditatio , il pensiero che ripiegandosi entro di sè cerca di penetrare ciò che é nascosto , 3) contemplatio , cioè la visione compiuta di tutto ciò che é stato esaminato . Il grado supremo é dato dalla contemplazione mistica , che consiste nel trascendere se stessi per unirsi a Dio .
RICCCARDO DI SAN VITTORE
A cura di Claudia Fazio
Continuatore della riflessione sull’esperienza mistica avviata da Ugo di San Vittore, Riccardo di San Vittore fu un teologo nativo della Scozia, del quale non si conoscono con esattezza la città e la data di nascita, che dev’essere comunque collocata intorno al 1100; morto nel 1173 a Parigi, fu commemorato il 10 Marzo nel necrologio dell’abbazia. Fu educato presso il monastero di San Vittore sotto il primo Abate Gilduin (morto nel 1155) e fu discepolo del grande mistico Ugo di San Vittore, di cui adottò ed elaborò i principi ed i metodi. La sua carriera fu rigorosamente monastica, e le sue relazioni con il mondo esterno furono molto limitate. Fu sotto-priore del monastero nel 1159, e successivamente ne divenne priore. Durante il suo compito, in quest’ ultimo incarico, sorsero seri problemi nella comunità di San Vittore a causa della cattiva condotta dell’abate inglese Ervisius, la cui vita irregolare lo portò ad un’ammonizione personale da parte di Alessandro III, e fu, successivamente, chiamato ad appello dal papa presso una commissione di inquisizione sotto l’autorità reale; dopo vari ritardi e resistenze da parte dell’abate, le sue dimissione furono ottenute e si ritirò dal monastero. Una lettera di esortazioni fu inviata dal papa a “Riccardo, il priore” e alla comunità nel 1170. Sembra che Riccardo non prese parte attiva durante queste procedure, ma le condizioni contrastanti dell’ambiente potrebbero aver accelerato il suo desiderio di ritiro interiore alla contemplazione mistica. Le dimissioni di Ervisius arrivarono nel 1172. Nel 1165 San Vittore ricevette la visita di San Tommaso di Canterbury, in ritorno dal suo viaggio da Northampton; Riccardo fu, senza dubbio, uno degli uditori del discorso emanato dall’arcivescovo in quell’occasione. Una lettera ad Alessandro III, che tratta gli affari dell’arcivescovo, firmata da Riccardo, è pubblicata dal Migne. Come il suo maestro Ugo, anche Riccardo potrebbe avere avuto dei rapporti con San Bernardo, ritenuto il Bernardo a cui è indirizzato il trattato De tribus appropriatis personis in Trinitate. La sua fama di teologo si spinse ben oltre i confini dei recinti monastici e copie dei suoi scritti vennero, a gran richiesta, ricercati da altre case religiose. Esclusivamente teologo, come Ugo, sembrava non avere interesse per la filosofia e non prese mai parte alle acute controversie filosofiche di quel tempo, ma, come tutta la scuola di San Vittore, era disposto a servirsi, in teologia, del metodo didattico e costruttivo introdotto da Abelardo. Nonostante ciò, Riccardo osservò il secolare insegnamento con qualche sospetto, ritenendolo inutile come fine in sè e ritenendolo solo motivo di orgoglio a livello mondiale e ricerca introspettiva quando ci si separa dagli argomenti divini. Egli chiama tale insegnamento, nello stile antitetico che caratterizza tutti i suoi scritti, “sapentia insipida et doctrina indocta”; e il professore di tale insegnamento è “captator famae, neglector conscientiae”. Personaggi così dotati, dovrebbero stimolare lo studioso di argomenti sacri a maggiori sforzi per raggiungere più alte sfere. “Quando noi consideriamo quanto i filosofi di questo mondo hanno lavorato, noi dovremmo vergognarci dell’essere inferiori a loro”. Scrive ancora Riccardo: “noi dovremmo cercare sempre di capire tramite la ragione quello che sosteniamo con la fede”.
Le sue opere rientrano nelle tre classi di dogmatica, mistica ed esegetica. Prima di tutto ricordiamo il trattato in sei libri sulla Trinità, con il supplemento sugli attributi delle Tre Persone e il trattato del VerboIncarnato. Ma di maggior interesse è la sua teologia mistica, che è principalmente contenuta nei due libri sulla contemplazione mistica, intitolati rispettivamente Benjamin Minor e Benjamin Major e l’allegorico trattato sul Tabernacolo.
Come abbiamo detto, Riccardo diede nuovo sviluppo alla dottrina mistica di Ugo, con uno schema maggiormente dettagliato in cui vengono descritti anche i passi successivi della contemplazione. Questi sono in tutto sei, suddivisi nei tre che riguardano i poteri dell’anima – l’immaginazione, la ragione e l’intelligenza -ascendendo dalla contemplazione delle cose visibili della creazione fino all’estasi nella quale l’anima è trasportata “oltre se stessa” alla Presenza Divina, attraverso gli ultimi tre passi finali della “Dilatio, sublevatio, alienatio”. Questi i titoli (Benjamin Major e Minor) si riferiscono a Ps. 1xvii, “Benjamin in mentis excessu”. Rachel rappresenta la ragione, Lia rappresenta la carità; il tabernacolo rappresenta lo stato di perfezione nel quale l’anima alloggia presso Dio. In un certo senso, il punto di vista mistico o devozionale predomina nei trattati esegetici; anche l’esposizione critica e dottrinale del testo riceve attenzione. I quattro libri intitolati Tractatus exceptionum e attribuiti a Riccardo trattano tematiche di insegnamento secolare. Otto titoli di opere gli sono attribuiti dal Trithemius e si riferiscono, probabilmente, a frammenti manoscritti di sue opere conosciute. Un Liber Penitentialis è menzionato da Montfaucon come attribuibile a “Ricardus Secundus a Sancto Victore”, e potrebbe, probabilmente, essere identificato con il trattato De protestate solvendi et ligandi sopra menzionato. Null’altro si conosce di un secondo Riccardo di San Vittore. Si dice che esistano altri quindici manoscritti, opere attribuite a Riccardo che non sono apparse in nessuna delle edizioni pubblicate e sono probabilmente false. Otto edizioni di queste opere sono state pubblicate: Venezia, 1506 (incompleta) e 1592; Parigi, 1518 e 1550; Lione, 1534; Cologna, 1621; Rouen, 1650, presso i Canonici di San Vittore; e presso Migne. Oltre a un’opera Sulla trinità e a un manuale di scienze profane, Riccardo compose vari scritti mistici, tra cui sulla preparazione alla contemplazione, sulla grazia della contemplazione e sullo stato interiore dell’uomo. Secondo Riccardo, tre sono le vie attraverso le quali l’uomo perviene alle verità relative alle cose terrene ed eterne: l’esperienza, la ragione e la fede. Egli ravvisa il fondamento dei tre momenti della via mistica, gia descritti da Ugo, in tre facoltà dell’anima umana. E precisamente la cogitatio ha la sua base nell’immaginazione, la meditatio nella ragione e la contemplatio nell’intelligenza, una sorta di vista spirituale che vede le cose invisibili come realmente presenti. Condizioni imprescindibili per la contemplazione, poi, Riccardo distingue sei grandi successivi, che vanno dalla considerazione del mondo sensibile a quella degli attributi di Dio che trascendono la piena comprensione umana, come la Trinità. Questi vari gradi si distinguono anche per una diversa condizione della mente in ciascuno di essi; Riccardo ne distingue tre livelli: la dilatatio, ossia l’espansione e l’acutizzarsi della mente; la sublevatio, ossia il sollevarsi di essi oltre i limiti umani grazie all’illuminazione divina e, infine, l’alienatio, il diventare altro e trasfigurarsi in una condizione non più umana. Qui si ha allora il momento culminante dell’ estasi o uscita della mente da sé (excessus mentis).
PIETRO LOMBARDO
Vita e opere. Pietro Lombardo, nativo di Novara, studiò dapprima a Reims e poi a Parigi, dove si trovava già alla scuola di San Vittore nel 1135 o 1136: ai Vittorini era stato presentato da Bernardo da Chiaravalle. Tuttavia fu forse anche allievo di Abelardo, e divenne poi maestro della scuola cattedrale. Nel 1148 fu uno dei giudici del processo di Reims, in cui furono condannate le tesi teologiche di Gilberto Porretano. Agli anni 1150-52 risale la redazione della sua opera principale, i quattro libri delle Sententiae; scrisse inoltre opere di commento biblico, fra cui un commento alle Lettere di Paolo, e diversi sermoni. Morì nel 1160, poco dopo essere stato eletto vescovo di Parigi. Le Sententiae e lo sviluppo della teologia. L’opera principale di Pietro Lombardo è quella che lo collega alla tradizione dei ‘Sentenziari’: autori di opere teologiche basate sulla raccolta di testi di auctoritates patristiche e alto-medievali, disposti secondo un piano di argomenti definito e utilizzabile nell’insegnamento. Già nel VII sec., con Isidoro di Siviglia, l’ordine degli argomenti utilizzato non era più quello tradizionale che seguiva quello dei libri della Bibbia, ma un ordine di carattere logico (Dio – gli spiriti angelici – l’uomo). Fra XI e XII sec. la raccolta più famosa è quella elaborata alla scuola di Anselmo di Laon (morto nel 1117), di cui fu allievo Abelardo. Testi di autori diversi sono raccolti per risolvere questioni nate dalla lettura del testo biblico. Anselmo, che Abelardo giudicava “fumoso e oscuro”, non utilizzava ancora il metodo dialettico, che invece Abelardo stesso applicò al suo Sic et non. Questa scelta, che comporta una dimensione filosofica in senso proprio, caratterizza anche i Quatuor libri Sententiarum di Pietro Lombardo, che fu per questo attaccato –insieme ad Abelardo, Gilberto Porretano, Pietro di Poitiers- da Gualtiero di San Vittore che bollò le loro ricerche rivolte ad elaborare una teologia razionale (peraltro con modalità diverse), definendoli ‘i quattro labirinti di Francia’. Pietro Lombardo considera necessaria l’utilizzazione della dialettica, metodo di ricerca della verità, laddove il testo sacro presenta problemi interpretativi; e tuttavia la sua raccolta non ha, come quella di Abelardo, l’intento di mettere a confronto opinioni diverse e anche contrastanti, ma piuttosto quella di presentare una tradizione “desiderando toglier di mezzo il contrasto fra autorità”. Le caratteristiche della sua raccolta sono: l’accoglimento della distinzione agostiniana fra dottrine che concernono la realtà (res: i primi tre libri) e dottrine che concernono i segni (signa: il quarto libro); la sistematizzazione degli argomenti di dibattito teologico secondo una quadripartizione che vede come oggetto del primo libro i misteri divini (unità e Trinità, gli attributi di Dio, l’azione ad extra, la prescienza, l’onnipotenza), del secondo la creazione(il fine della creazione, la creazione degli angeli, l’opera dei sei giorni, l’uomo, il peccato e la grazia), del terzo l’incarnazione di Cristo (l’opera della salvezza, le virtù teologali e i doni dello Spirito santo, i comandamenti), del quarto i sacramenti; la codificazione di un linguaggio tecnico, che divenne strumento condiviso dai teologi posteriori. Fra questi spicca un diretto allievo del Lombardo, Pietro di Poitiers, autore a sua volta di una raccolta di Sententiae in cinque libri e cancelliere della cattedrale di Parigi a partire dal 1193, cioè negli anni di formazione dell’università. Nonostante avesse suscitato molti contrasti, nel Concilio Lateranense del 1215 la raccolta di Pietro Lombardo venne approvata ufficialmente; in conseguenza di ciò, divenne il libro di testo su cui si strutturò l’insegnamento nella facoltà teologica delle nascenti università. Gli studenti di teologia dovevano seguire le lezioni sulle Sentenze del Lombardo e poi, come baccellieri, esercitarsi nelle dispute (quaestio) relative, prima di passare allo studio della Sacra Scrittura. Nei commenti alle Sentenze è dunque possibile seguire lo sviluppo della teologia scolastica e anche di molte problematiche filosofiche ed epistemologiche ad esso connesse.
BONAVENTURA
Come se uno cade in un precipizio e vi rimane se un altro non lo aiuta a sollevarsi, così l’anima nostra non avrebbe potuto risollevarsi dalle cose sensibili fino alla contemplazione di se stessa e dell’eterna verità riflessa in essa, se la verità stessa, assumendo la forma umana in Cristo, non si fosse fatta scala di riparazione per la caduta della prima scala di Adamo. Perciò nessuno, per quanto possa essere illuminato dai doni di natura e della scienza acquisita, può rientrare in se stesso per godervi Dio, se non per la mediazione di Cristo, che ha detto: “Io sono la porta; chi passerà attraverso di me si salverà, entrerà e troverà pascoli eterni”.
Giovanni Fidenza , detto Bonaventura (e appellato “doctor seraficus”), nasce verso il 1217 a Bagnoregio presso Viterbo . Nel 1235 si reca a Parigi a studiare forse nella facoltà delle Arti e successivamente, nel 1243 , nella facoltà di teologia. Nel 1235 si reca a Parigi a studiare forse nella facoltà delle Arti e successivamente, nel 1243, nella facoltà di teologia. Probabilmente in quello stesso anno entra tra i Frati Minori. I suoi studi di teologia terminano nel 1253, quando diventa “magister” (cioè “maestro”) di teologia e ottiene la licentia docendi (la “licenza d’insegnare”). Nel 1250 il papa aveva autorizzato il cancelliere dell’Università a conferire tale licenza a religiosi degli ordini mendicanti, sebbene ciò contrastasse con il diritto di cooptare i nuovi maestri rivendicato dalla corporazione universitaria. E proprio nel 1253 scoppia uno sciopero al quale tuttavia i membri degli ordini mendicanti non si associarono. La corporazione universitaria richiese loro un giuramento di obbedienza agli statuti, ma essi rifiutarono e pertanto vennero esclusi dall’insegnamento. Questa esclusione colpì anche Bonaventura, che fu maestro reggente fra il 1253 e il 1257. Nel 1254 i maestri secolari denunciarono a papa Innocenzo IV il libro del francescano Gerardo di Borgo San Donnino Introduzione al Vangelo eterno. In questo testo fra’ Gerardo, rifacendosi al pensiero di Gioacchino da Fiore, annunciava l’avvento di una «nuova età dello Spirito Santo» e di una «Chiesa cattolica puramente spirituale fondata sulla povertà», profezia che si doveva realizzare attorno al 1260. In conseguenza di questo il Papa — poco prima di morire — annullò i privilegi concessi agli ordini mendicanti. Il nuovo pontefice papa Alessandro IV condannò il libro di Gerardo con una bolla nel 1255, prendendo tuttavia posizione a favore degli ordini mendicanti e senza più porre limiti al numero delle cattedre che essi potevano ricoprire. I secolari rifiutarono queste decisioni, venendo così scomunicati, anche per il boicottaggio da loro operato ai danni dei corsi tenuti dai frati mendicanti. Tutto questo nonstante che i primi avessero l’appoggio del clero e dei vescovi, mentre il re di Francia Luigi IX si trovava a sostenere le posizioni dei mendicanti. San Bonaventura in un dipinto di Francisco de ZurbaránNel 1257 Bonaventura venne riconosciuto magister. Nello stesso anno fu eletto Ministro generale dell’Ordine francescano, e rinunciando così alla cattedra. A partire da questa data, preso dagli impegni della nuovo servizio, accantonò gli studi e compì vari viaggi per l’Europa. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l’unità dei Minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale (influenzata dalle idee di Gioacchino da Fiore e incline ad accentuare la povertà del francescanesimo primitivo), sia contro le tendenze mondane insorte in seno all’Ordine. Favorevole a coinvolgere l’Ordine francescano nel ministero pastorale e nella struttura organizzativa della Chiesa, nel Capitolo generale di Narbona del 1260, contribuì a definire le regole che dovevano guidare la vita dei membri dell’Ordine: le Costituzioni dette appunto Narbonensi. A lui, in questo Capitolo, venne affidato l’incarico di redigere una nuova biografia di san Francesco d’Assisi che, intitolata Legenda maior, diventerà la biografia ufficiale nell’Ordine. Infatti il Capitolo generale successivo, del 1263, approvò l’operà composta dal Ministro generale; mentre il Capitolo del 1266, riunito a Parigi, giunse a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla Legenda Maior, probabilmente per proporre all’Ordine una immagine univoca del proprio fondatore, in un momento in cui le diverse interpretazioni fomentavano contrapposizioni e conducevano verso la divisione.[1] Negli ultimi anni della sua vita, Bonaventura intervenne nelle lotte contro l’aristotelismo e nella rinata polemica fra maestri secolari e mendicanti. A Parigi, tra il 1267 e il 1269, tenne una serie di conferenze sulla necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Nel 1270 lascia Parigi per farvi però ritorno nel 1273, quando tiene altre conferenze nelle quali attacca quelli che sono a suo parere gli errori dell’aristotelismo. Nel maggio del 1273, già vescovo di Albano, viene nominato cardinale; l’anno successivo partecipa al Concilio di Lione (in cui favorisce un riavvicinamento fra le Chiesa latina e quella greca), nel corso del quale muore, forse a causa di un avvelenamento, stando almeno a quanto affermò in seguito il suo segretario, Pellegrino da Bologna. Pierre de Tarentasie, futuro papa Innocenzo V, ne celebrò le esequie, e Bonaventura venne inumato nella chiesa francescana di Lione. Nel 1434 la salma venne traslata in una nuova chiesa, dedicata a San Francesco d’Assisi; la tomba venne aperta e la sua testa venne trovata in perfetto stato di conservazione: questo fatto ne facilitò la canonizzazione, che avvenne ad opera del papa francescano Sisto IV il 14 aprile 1482, e la nomina a dottore della Chiesa, compiuta il 14 maggio 1588 da un altro francescano, papa Sisto V. Bonaventura è considerato uno dei pensatori maggiori della tradizione francescana, che anche grazie a lui si avviò a divntare una vera e propria scuola di pensiero, sia dal punto di vista teologico che da quello filosofico. Difese e ripropose la tradizione patristica, in particolare il pensiero e l’impostazione di sant’Agostino. Egli combatté apertamente l’aristotelismo, anche se ne acquisì alcuni concetti, fondamentali per il suo pensiero. Inoltre valorizzò alcune tesi della filosofia arabo-ebraica, in particolare quelle di Avicenna e di Avicebron, ispirate al neoplatonismo. Nelle sue opere ricorre continuamente l’idea del primato della sapienza, come alternativa ad una razionalità filosofica isolata dalle altre facoltà dell’uomo. Egli sostiene, infatti, che: « (…) la scienza filosofica è una via verso altre scienze. Chi si ferma resta immerso nelle tenebre. » Secondo Bonaventura è il Cristo la via a tutte le scienze, sia per la filosofia che per la teologia. Il progetto di Bonaventura è una riduzione (reductio artium)non nel senso di un depotenziamento delle arti liberali, bensì della loro unificazione sotto la luce della verita rivelata, la sola che possa orientarle verso l’obiettivo perfetto a cui tende imperfettamente ogni conoscenza, il vero in sè che è Dio. La distinzione delle nove arti in tre categorie, naturali (fisica, matematica, meccanica), razionali (logica, retorica, grammatica) e morali (politica, monastica, economica) riflette la distinzione di res, signa ed actiones la cui verticalità non è altro che cammino iniziatico per gradi di perfezione verso l’unione mistica. La parzialità delle arti è per B. non altro che il rifrangersi della luce con la quale Dio illunima il mondo: prima del peccato originale Adamo sapeva leggere indirettamente Dio nel Liber Naturae (nel creato), ma la caduta è stata anche perdita di questa capacità. Per aiutare l’uomo nel recupero della contemplazione della somma verità, Dio ha inviato all’uomo il Liber Scripturae, conoscenza supplementare che unifica ed orienta la conoscenza umana, che altrimenti smarrirebbe se stessa nell’autoreferenzialità. Attraverso l’illunimazione della rivelazione, l’intelletto agente è capace di comprendere il riflesso divino delle verità terrene inviate dall’intelletto passivo, quali pallidi riflessi delle verita eterne che Dio perfettamete pensa mediante il Verbo. Ciò rappresenta l’accesso al terzo libro, Liber Vitae, leggibile solo per sintesi collaborativa tra fede e ragione: la perfetta verita, assoluta ed eterna in Dio, non è un dato acquisito, ma una forza la cui dinamica si attua storicamente nella reggenza delle verita con le quali Dio mantiene l’ordine del creato. Lo svelamento di quest’ordine è la lettura del terzo libro che per segni di dignità sempre maggior avvicina l’uomo alla fonte di ogni verità. La primitas divina La primalità di Dio è il sostegno a tutto l’impianto teologico anselmiano. Nella sua prima opera, il Breviloquium, egli definisce i caratteri della teologia affermando che, poiché il suo oggetto è Dio, essa ha il compito di dimostrare che la verità della sacra scittura è da Dio, su Dio, secondo Dio ed ha come fine Dio. l’unita del suo oggette determina come unitaria ed ordinata la teologia perché la sua struttura corrisponde ai caratteri del suo oggetto. Nella sua opera più famosa, l’Itinerarium mentis in Deum (“L’itinerario della mente verso Dio”), Bonaventura spiega che il criterio di valore e la misura della verità si acquisiscono dalla fede, e non dalla ragione (come sostenevano gli averroisti). Da ciò fa conseguire che la filosofia serve a dare aiuto alla ricerca umana di Dio, e può farlo, come diceva sant’Agostino, solo riportando l’uomo alla propria dimensione interiore (cioè l’anima), e, attraverso questa, ricondurlo infine a Dio. Secondo Bonaventura, dunque, il «viaggio» spirituale verso Dio è frutto di una illuminazione divina, che proviene dalla «ragione suprema» di Dio stesso. Per giungere a Dio, quindi, l’uomo deve passare attraverso tre gradi, che, tuttavia, devono essere preceduti dall’intensa ed umile preghiera, poiché: « (…) nessuno può giungere alla beatitudine se non trascende sé stesso, non con il corpo, ma con lo spirito. Ma non possiamo elevarci da noi se non attraverso una virtù superiore. Qualunque siano le disposizioni interiori, queste non hanno alcun potere senza l’aiuto della Grazia divina. Ma questa è concessa solo a coloro che la chiedono (…) con fervida preghiera. È la preghiera il principio e la sorgente della nostra elevazione. (…) Cosí pregando, siamo illuminati nel conoscere i gradi dell’ascesa a Dio. » La “scala” dei 3 gradi dell’ascesa a Dio è simili alla “scala” dei 4 gradi dell’amore di Bernardo di Chiaravalle, anche se non uguale; tali gradi sono:
1) Il grado esteriore: « (…) è necessario che prima consideriamo gli oggetti corporei, temporali e fuori di noi, nei quali è l’orma di Dio, e questo significa incamminarsi per la via di Dio. »
2) Il grado interiore: « È necessario poi rientrare in noi stessi, perché la nostra mente è immagine di Dio, immortale, spirituale e dentro di noi, il che ci conduce nella verità di Dio. »
3) Il grado eterno: « Infine, occorre elevarci a ciò che è eterno, spiritualissimo e sopra di noi, aprendoci al primo principio, e questo dona gioia nella conoscenza di Dio e omaggio alla Sua maestà. »
Inoltre, afferma Bonaventura, in corrispondenza a tali gradi, l’anima ha anche tre diverse direzioni: « (…) L’una si riferisce alle cose esteriori, e si chiama animalità o sensibilità; l’altra ha per oggetto lo spirito, rivolto in sé e a sé; la terza ha per oggetto la mente, che si eleva spiritualmente sopra di sé. Tre indirizzi che devono disporre l’uomo a elevarsi a Dio, perché l’ami con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l’anima (…). » (San Bonaventura da Bagnoregio, Itinerarium mentis in Deum) Dunque, per Bonaventura l’unica conoscenza possibile è quella contemplativa, cioè la via dell’illuminazione, che porta a cogliere le essenze eterne, e ad alcuni permette persino di accostarsi a Dio misticamente. L’illuminazione guida anche l’azione umana, in quanto solo essa determina la «sinderesi», cioè la disposizione pratica al bene. Il mondo, per Bonaventura, è come un libro da cui traspare la Trinità che l’ha creato. Noi possiamo ritrovare la Trinità “extra nos” (cioè “fuori di noi”), “intra nos” (“in noi”) e “super nos” (“sopra di noi”). Infatti, la Trinità si rivela in 3 modi: come “vestigia” (o impronta) di Dio, che si manifesta in ogni essere, animato o inanimato che sia; come “immagine” di Dio, che si trova solo nelle creature dotate d’intelletto, in cui risplendono memoria, intelligenza e volontà; come “similitudine” di Dio, che è qualità propria delle creature giuste e sante, toccate dalla Grazia e animate da fede, speranza e carità; quindi, quest’ultima è ciò che ci rende “figli di Dio”. La Creazione dunque è ordinata secondo una scala gerarchica trinitaria, e la natura non ha sua consistenza, ma si rivela come segno visibile del principio divino che l’ha creata; solo in questo, quindi, trova il suo significato. Bonaventura trae questo principio anche da un passo evangelico, in cui i discepoli di Gesù dissero: « “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!” Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”.Ma egli rispose: “Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”. » (Lc, 19,38-40) Le creature, dunque, sono impronte, immagini, similitudini di Dio, e persino le pietre “gridano” tale loro legame col divino.
GILBERTO PORRETANO
Profondamente legato alla cosiddetta “scuola di Chartres” – di cui fu peraltro il più insigne esponente -, insieme con Teodorico di Chartres, Gugliemo di Conches e Ivo di Chartres, Gilberto di Poitiers (1076-1154), noto anche come “de la Porrée” o “Porretanus” (Porretano), studiò a Poitiers, quindi a Chartres con Bernardo e a Laon. Insegnò a Chartres, ove fu reggente dal 1126 al 1137; nel 1142 divenne vescovo di Poitiers e morì nel 1154. Gilberto scrisse diversi commenti ai Salmi, a s.Paolo e agli opuscoli teologici di Boezio: compose parecchi Commentaria alle opere teologiche di Boezio stesso e un De sex principiis, che però è di dubbia attribuzione. Egli opera una saldatura tra logica, fisica (quale era quella elaborata a Chartres) e teologia, sulle orme di Boezio stesso. Una tecnica da lui impiegata con assiduità è quella della quaestio. Una “questione” consta di una affermazione e della negazione contraddittoria di essa; in tal senso la questione rientra, dunque, nel genere delle contraddizioni, ma non ogni contraddizione, secondo Gilberto, è una quaestio: non si ha una questione vera e propria, per esempio, quando una delle due parti (chi afferma o chi nega) non sembra avere argomenti a favore della verità della propria tesi o quando nessuna delle due parti può averli. Una quaestio, invece si determina quando entrambe le parti sembrano avere argomenti a sostegno della propria tesi: quaestio, dunque, non significa soltanto domanda, essa è, piuttosto una tecnica coscientemente e metodicamente applicata. Spesso la contraddizione può essere sciolta mostrando che uno stesso termine è usato in modo diverso oppure che nel sostenere una tesi si fa ricorso ad argomentazioni di genere diverso; per esempio si cade necessariamente in errore se si pretende di applicare al Creatore argomenti adatti alle creature. Nei suoi commenti a Boezio, Gilberto distingue tra ciò che egli chiama “quod est” (letteralmente “ciò che e”), l’individuo esistente, e il “quo est” (letteralmente “ciò in virtù di cui esso è”), ossia i princìpi dalla cui composizione esso (“ciò che è”) risulta. Questa distinzione si applica ad insiemi concreti, ai loro accidenti e alle loro parti: per esempio, rientrano nel quod est questo uomo, questo braccio, questo bianco e nel quo est umanità, corporeità, bianchezza. Né il quod est, né il quo est possono esistere o essere concepiti isolatamente, ma vanno sempre e comunque integrati; peraltro, la distinzione tra quod est e quo est non corrisponde neppure a quella tra particolare e universale. Anche il quo est infatti è singolare e fonda la singolarità degli individui: la bianchezza di questo cavallo bianco non è la stessa cosa della bianchezza di questo cane bianco, e così via. Tra le due forme intercorre dunque una relazione reciproca, tale per cui la corporeità non è nulla in atto a meno che non sia un corpo singolo e un corpo non è uno se in esso non vi è corporeità. Nella realtà, dunque, essi non possono sussistere separatamente l’un dall’altro. Il che significa che l’essere di ogni cosa sussistente è complesso e può essere analizzato – cioè scomposto concettualmente nelle sue componenti: per esempio, a proposito di un uomo, si tratta della sostanza per cui egli è un uomo, qualsiasi genere e differenza si possano predicare di esso (come avere un corpo e un’anima) e qualsiasi accidente sia presente nella sua interezza o in singole parti di esso. Dio, invece, in quanto è semplice, non è una composizione e pertanto non è propriamente comprensibile da parte dell’uomo: in Lui, infatti, non sono distinguibili un quod est e un quo est, non vi è cioè una sostanza “divinità” per cui Dio è ciò che è. Del resto, si può parlare di “essere” delle cose create solamente per analogia, in quanto la loro esistenza non deriva dalla loro essenza, bensì da Dio: solo di Dio, infatti, si può propriamente asserire che è. Le tesi teologiche di Gilberto, innovative e acute al tempo stesso, non tardarono a destare i sospetti di quel san Bernardo che tanto si accanì contro Abelardo: per tal motivo Gilberto dovette difendere le proprie posizioni nel Concilio di Reims del 1148. Accanto agli spinosi problemi teologici – che troppo spesso finivano per costare cari a chi se ne occupava -, Gilberto Porretano si occupò anche di uno dei problemi più senti e arrovellanti dell’età medioevale: quello degli universali e della loro natura. Gilberto seppe fondere con perizia il problema degli universali, ormai parte integrante della filosofia scolastica, col problema della natura; a fondamento della sua ricerca c’è la dichiarazione di una relativa autonomia della ragione (che precede la fede nello studio della natura) dalla fede (che precede la ragione nel campo della teologia).
“Penso che nella teologia l’indagine debba incominciare dagli stessi fondamenti della fede cattolica. Nelle altre discipline la ragione non segue la fede, ma la fede segue la ragione”. (“In librum de predicatone trium personarum”)
In quanto al problema degli universali, Gilberto, distinguendo l’essere e il sussistere dall’esistere, sostiene che solo gli individui esistono, mentre i generi e le specie sono, ma non esistono.
“Gli universali che l’intelletto astrae dai particolari sono, perché si dice che sono quello per cui i particolari sono un qualche cosa di determinato. Ma i particolari non solo sono ciò che comunque sono per il loro essere, ma esistono anche, perché sono il soggetto degli accidenti che aderiscono agli universali… Sussiste ciò che non ha bisogno degli accidenti per poter essere. Pertanto i generi e le specie sussistono solo, non esistono”. (“In De duabus naturis”, 1374 D)
Ora, se gli universali sono ma non esistono, ciò non significa che, in quanto prodotti del discorso e oggetti dell’intelligenza umana, essi siano un prodotto arbitrario e soggettivo. L’originalità del Porretano è appunto nel chiarire il problema degli universali in termini di filosofia della natura: gli universali, che egli chiama aristotelicamente “forme”, sono appunto le espressioni di un’unica forza naturale, le quali da un lato rendono possibile la generazione di tutti gli individui, dall’altro rendono possibile quelle generalizzazioni concettuali dell’uomo che costituiscono appunto il campo della sua conoscenza.
PIETRO ISPANOO
Pietro Ispano, salito al soglio pontificio con il nome di Giovanni XXI, unica figura di papa ad essere apertamente lodata nel capolavoro dantesco (Paradiso, XII, 135), assomma in sè le istanze di medico e di filosofo, proiettando i propri interessi soprattutto in campo logico. Spesso trascurato dalla critica moderna, Pietro Ispano fu uomo di spicco non solo in campo ecclesiastico, ma soprattutto in campo scientifico essendo l’autore, oltre che di opere logiche, di un trattato medico dall’enorme fortuna: il Thesaurus Pauperum (Il tesoro dei poveri), una raccolta di ricette a capite ad calcem per i mali più diffusi. L’opera fu trascritta in più versioni e tradotta in diverse lingue fino a tutto il XVIII secolo. Pietro Ispano nacque probabilmente a Lisbona tra il 1205 ed il 1215; dopo aver completato i suoi studi a Parigi e forse a Montpellier, nel 1245 circa giunse a Siena dove divenne professore di medicina nello studio locale. La sua carriera culminò con l’elezione al soglio pontificio il 20 settembre 1276, carica che non tenne a lungo: morì infatti otto mesi più tardi a causa delle ferite riportate durante il crollo di una stanza del suo palazzo di Viterbo. Divenuto arcivescovo di Braga nel 1273, fu subito dopo nominato cardinale di Tuscolo da Gregorio X, al quale succedette nel 1276 col nome di Giovanni XXI. Dal punto di vista strettamente medico, la sua cultura ebbe a nutrirsi non solo dei grandi autori del passato – Galeno e Dioscoride ad esempio -, ma anche di quelli più recenti come i Salernitani. I suoi studi furono rivolti soprattutto alla definizione di una professione, quella del medico appunto, che fosse basata oltre che sulla physica nella sua definizione aristotelica – cioè lo studio filosofico della natura umana – , anche sulla pratica. A testimonianza di ciò, basti prendere proprio in considerazione quel Thesaurus Pauperum che i più vorrebbero definire troppo frettolosamente ed ingiustamente come un trattato di terapia popolare ad uso dei meno abbienti, ma che in realtà si risolve essere molto di più: un’opera sì di pratica utilità, ma ad uso di esperti nell’ars medica – basti leggere con attenzione il lungo prologo della versione latina -, attenti quindi ai mutamenti fisici della natura umana, ma attenti anche agli utilizzi di flebotomie e salassi, esperti nell’uso di medicinali semplici e composti e dei loro effetti sul paziente. Un’opera quindi atta ad offrire una risposta pratica ed immediata a problemi di comune diffusione. Pietro Ispano promosse inoltre l’iniziativa del vescovo di Parigi Stefano Tempier, per il controllo dell’ortodossia teologica dei maestri parigini, che culminò il 7 marzo del 1277 con la pubblicazione di un decreto mirante a frenare le tendenze innovative in materia di antropologia teologica e nei rapporti tra cosmologia e teologia. Di grande fortuna e modernità la sua opera di logica e il suo commento al De animalibus di Aristotele. Tra gli scritti di medicina meritano di essere ricordati i Problemata, la Summa medicinae, il Liber de conservanda sanitate. Ma Pietro Ispano apre territori di riflessione anche in campo logico: dopo il ritorno in Occidente del corpus aristotelico – ritorno avvenuto dopo secoli di oblio – grazie al contatto col mondo arabo (che già da tempo aveva eletto Aristotele a suo maestro), il mondo cristiano si mobilitò essenzialmente in due direzioni; da un lato vi fu chi – come Bonaventura – si rivelò nettamente ostile ad Aristotele; dall’altro vi fu chi – come Tommaso – vide in Aristotele il vertice dell’intelligenza umana, ravvisando nell’aristotelismo un sistema così compiuto e capace di render conto del mondo (più precisamente: di questo mondo) da non poter essere semplicisticamente liquidato come vana curiositas; il problema che si parava dinanzi era allora quello di coniugare l’aristotelismo col cristianesimo, epurando però la dottrina di Aristotele dalle fuorvianti interpretazioni date da Averroè. E se a Oxford si diede gran peso ai libri aristotelici sulla filosofia della natura, a Parigi, invece, l’attenzione si concentrò interamente su quelli logici, anche perchè un decreto papale del 1215 proibiva di tenere lezioni sulla Metafisica e sugli scritti di filosofia della natura dello Stagirita. Ben si capisce, allora, perchè Pietro Ispano, attivo a Parigi, si dedichi precipuamente alla logica: la sua opera più significativa in merito sono le Summulae logicales (in 12 libri), elogiate da Dante stesso (che di Pietro Ispano dice: “lo qual giù luce in dodici libelli”, Paradiso XII 135), nelle quali è codificata la pratica didattica di usare, a scopo mnemonico, vocali, parole e versi per designare i tipi di proposizione e di sillogismo di cui aveva trattato Aristotele. Così A indica la proposizione affermativa universale, E l’universale negativa, I la particolare affermativa, O la particolare negativa. Mediante tali vocali sono coniate parole come Barbara, Celarent, Darii, Ferio, etc, le quali descrivono i modi validi delle quattro figure sillogistiche. Così, ad esempio, la parola “Barbara” – caratterizzata dalla presenza di tre A (Barbara) – richiama alla memoria il sillogismo avente come premessa e come conclusione proposizioni universali affermative. L’ultima parte delle Summulae logicales è dedicata allo studio delle proprietà dei termini linguistici, ovvero delle parole intese come segni delle cose. Di qui deriva l’espressione terminismo per designare il nuovo orientamento preso dalle ricerche logiche, la via moderna distinta dalla via antiqua. I termini singolarmente presi godono della proprietà di avere un significato (significatio). Così per esempio il significato del termine “uomo” consiste nel suo indicare e riferirsi a Socrate, a Platone, a Gorgia, e così via. Dalla significatio si distingue la suppositio, che è la proprietà asunta all’interno di una proposizione da un termine, già dotato di significatio, di stare per (in latino supponere pro) l’oggetto che esso indica. Si possono allora distinguere svariati tipi di suppositio: a) si ha la suppositio materialis quando un termine sta per l’espressione stessa, come nella proposizione “uomo è un nome”; b) si ha la suppositio simplex quando un termine è adoperato per l’universale indicato da esso, come nella proposizione “l’uomo è una specie”, dove “uomo” sta per l’uomo in generale, non per qualche individuo in particolare; c) infine si ha la suppositio personalis quando il termine comune sta per gli individui, come per esempio nella proposizione “l’uomo corre”, dove “l’uomo” sta per Socrate, Platone, Gorgia e così via. In questo modo viene sviluppata l’indagine del significato dei termini, che in età moderna sarà battezzata “semantica”. Sviluppando la logica formale e terministica com’era stata impostata da Abelardo, Pietro Ispano esercitò una notevole influenza non solo sugli studiosi latini di logica nel Medioevo (pensiamo a Guglielmo da Ockham), ma anche sui logici bizantini: le sue Summulae logicales furono tradotte infatti in una Sinossi della logica aristotelica, attribuita fino a non molto tempo fa al bizantino Michele Psello.
BERNARDO SILVESTRE
“Deus omnia, omnia ex Deo sunt”.
Bernardo Silvestre di Chartres (1100-1169 circa) fu filosofo di tendenze neo-platoniche, noto soprattutto per aver divulgato le tematiche filosofiche elaborate presso la “Scuola di Chartres”. Poco si sa sul suo conto: è tuttavia certo che tra il 1145 e 1153 abbia composto un’opera intitolata De Mundi Universitate (Sull’universo), dedicata a Teodorico di Chartres con le parole “Terrico veris scientiarum titulus Doctori famosissimo Bernardus Sylvestris opus suum”. Da questa iscrizione si è dedotto che Bernard era probabilmente il pupillo di Teodorico o di qualche altro membro della famosa Scuola di Chartres. Il trattato De Mundi Universitate è diviso dall’autore in due libri, il primo dei quali, Megacosmus, seu Maior Mundus, è un discorso della Natura all’Intelletto e il secondo la risposta dell’Intelletto alla Natura. Lo stile e il metodo della composizione ricordano quelli di Marciano Capella e di Boezio, il contenuto è molto curioso ed è esposto in un misto di poesia e prpsa, con un costante ricorso alle personificazioni (la Natura, l’Intelletto, ecc). L’opera poggia in buona parte su presupposti neo-platonici e neo-pitagorici (tendenze filosofiche, quest’ultime, che sono molto rare nel dodicesimo secolo e praticamente sconosciute fuori dalla Scuola di Chartres). Non è del tutto improbabile che Bernardo, come i panteisti Amaury e Davide di Dinant, che erano suoi contemporanei, fosse influenzato dagli scritti di Scoto Eriugena, a suo tempo accusato di panteismo. La filosofia bernardiana è infatti un tentativo di spiegare l’universo della natura (fisica) descrivendo le emanazioni cosmiche da una Monade originaria. Nella sua opera, Bernardo si propone di seguire le orme platoniche del Timeo (l’unico dialogo platonico – come è noto – dedicato al mondo fisico): il Nous (l’Intelletto contenente le idee, alla maniera plotiniana) impone ordine alla materia informe (da Bernardo chiamata Silva). Tra i tanti personaggi, è anche introdotta l’Anima del mondo (Endelechia), che era centrale nel pensiero platonico. Essa emana dal Nous ed è intermedia fra l’intelletto e la materia; essa è inoltre principio di vita diffuso ovunque nel mondo sensibile, ma permane integra in sè. Dopo aver affrontato quest’esposizione nel Megacosmo, Bernardo passa ad esaminare – nel Microcosmo – la creazione dell’uomo, che si attua in virtù della cooperazione di tre personaggi: a) Natura, b) Urania (principio dell’esistenza celeste), c) Physis (principio dell’esistenza terrena); in questo senso, l’uomo è anfibio tra il celeste e il terreno, vive in terra ma è destinato a mete superiori. Bernardo pare incline ad ammettere l’influenza delle sfere celesti sui caratteri e sui destini umani. Il suo scritto, però, non sviluppa analisi nè argomentazioni, è piuttosto un racconto lussurreggiante di personificazioni e di metafore poetiche e, in forza di ciò, esso appare in sintonia perfetta coi miti platonici, anche se la personificazione della natura diventa un tema tipico della cultura filosofica dell’epoca (pensiamo allo scritto di Alano di Lilla Il pianto della Natura). Non meno pregevoli sono quelle parti del trattato in cui l’autore descrive montagne, fiumi, animali e piante, sebbene lo stile allegorico, poetico dell’ opera molto spesso ne oscuri il significato. Il senso velatamente panteistico della filosofia di Bernardo appare chiaro nell’espressione “Deus omnia, omnia ex Deo sunt”. Riguardo alla teologia tradizionale sembra adottare un atteggiamento scettico: “si theologis fidem praebeas argumentis”. Il suo filosofo preferito è Platone, benché sia chiaro il fatto che egli non abbia letto alcuno dei suoi dialoghi, eccetto – forse – il Timeo. La caratteristica peculiare dello scritto di Bernardo Silvestre risiede nel fatto che il mondo naturale (macrocosmo) e l’uomo (microcosmo) siano studiati – più che nei loro caratteri strutturali – come risultati di una vicenda che si svolge nel tempo e che coinvolge svariati personaggi.
PALAMAS
L’unica uscita dalla strada che non porta da alcuna parte alla quale ci introduce il modo di vita attuale è la rievangelizzazione dell’uomo contemporaneo. È in tal modo che si comprende sempre più il bisogno di ritornare alla spiritualità ortodossa come l’hanno vissuta e insegnata i grandi Padri della nostra Chiesa, uno dei quali è stato San Gregorio Palamas. La pluriforme personalità del Santo Teoforo [portatore di Dio] Gregorio Palamas più viene avvicinata più manifesta la sua luce. Secondo le autentiche descrizioni fornite dal suo biografo, San Filotheos Kokkinos Patriarca di Costantinopoli, San Gregorio Palamas visse nel XIV secolo (1296-1359). Era figlio primogenito di una numerosa e splendida famiglia. Gregorio, dopo eccellenti studi a Costantinopoli, disprezzò la vita mondana e le alte cariche alle quali era condotto dallo stesso Imperatore, Andronico Paleologo, per volgersi all’ascesi e alla perfetta strada dello stato monastico. Oltre a lui, l’intera sua famiglia si volse al monachesimo. Gregorio Palamas emerse come il più grande teologo bizantino del XIV secolo e come uno tra i più importanti di tutti i secoli. Visse in un periodo decisivo e ne contribuì significativamente prendendo una distinta posizione nell’ambito della spiritualità ortodossa. La sua principale attività spirituale è stata quella di difendere i monaci esicasti del Monte Athos dall’accusa del monaco italiano Barlaam. Gli esicasti non presentavano delle novità: rinnovavano nella loro epoca l’antica tradizione della Chiesa sulla quiete spirituale (l’esichìa). La divina esichìa era unita con la preghiera ininterrotta, coè con la preghiera monologica “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me”. A questa preghiera i monaci non assegnavano alcuna forza magica ma, praticandola, evitavano di disperdere la mente nelle realtà del mondo comunicando senza alcuna distrazione, non con la Sostanza di Dio, ma con le sue increate Energie. Tutto ciò ha contribuito a fare in modo che il monaco occidentale Barlaam condannasse gli esicasti come eretici. La difesa degli esicasti fu presa da Gregorio Palamas, sapiente più d’ogni altro della tradizione patristica. Secondo il suo insegnamento, la continuità della tradizione ecclesiastica nella vita liturgica è sempre rimasta ininterrotta. Anche l’insegnamento e la teologia della Chiesa non conoscono interruzione. D’altronde, lo stesso rappresentante di tale continuità della teologia degli esicasti era Gregorio Palamas. Il santo rappresentò e difese i monaci nei tre sinodi tenutisi a Costantinopoli (1311 – 1347 – 1351) i quali affrontarono la questione esicasta. In questi grandi sinodi locali gli esicasti furono riabilitati. Fu constatato che il loro insegnamento seguiva fedelmente l’antica tradizione della Chiesa. In seguito, il Santo fu elevato alla cattedra arcivescovile di Tessalonica. Ovviamente l’esicasmo costituì un eccellente “caso” della spiritualità ortodossa, anche se non è facilmente comprensibile. Infatti, non è mai stato compreso da chi pensava con criteri antropocentrici e scolastici, come l’avversario occidentale di Palamas, Barlaam. San Gregorio Palamas ricapitola l’intera tradizione patristica. Distingue l’irragiungibile Sostanza divina dalle sue raggiungibili Energie, Azioni ed Effetti. Questa distinzione non è nuova: è stata insegnata precedentemente da San Basilio il Grande, dal vescovo Crisostomo, da San Massimo il Confessore e da molti altri grandi Padri della Chiesa. Contrariamente al Dio dei filosofi scolastici, inaccessibile, inaccostabile e punitore degli uomini, San Gregorio Palamas insegna il Dio dei Santi, pieno d’amore per l’uomo che comunica tramite le sue increate Energie. A tal proposito San Gregorio scrive: “Se non esiste questa distinzione tra l’impartecipabile Sostanza divina e le partecipabili sante increate Energie, s’interromperebbe ogni contatto e comunicazione con Lui”. Ovviamente nella vita presente questa capacità di conoscere di Dio, tramite le divine increate Energie, è molto limitata, se paragonata alla conoscenza che avremo nell’altra vita. “Questa limitata conoscenza – scriveva San Gregorio – è identica con il proprio personale impegno e con il grado di perfezione d’ognuno”. La strada della Theognosia o della visione di Dio era vista dal nostro Santo come un continuo esercizio ed impegno di purificazione dall’inquinamento del peccato.
IL PENSIERO
A cura di Giuseppe Girgenti
Siamo abituati a valutare la filosofia e la teologia bizantina in base ad antichissimi pregiudizi per i quali i dotti di Costantinopoli del XIV secolo si preoccupavano di discettare sul sesso degli angeli e su altre questioni “bizantine” mentre i Turchi erano alle porte della città e l’Impero Romano d’Oriente sull’orlo del tracollo. La pubblicazione presso Bompiani delle opere di Gregorio Palamas, tradotto per la prima volta in una lingua occidentale, ci offre uno squarcio prezioso del dibattito che negli anni fra il 1336 e il 1347 animava le Chiese d’Oriente e le Chiese d’Occidente, soprattutto sull’annosa questione del Filioque e cancella in un sol colpo questi pregiudizi. Palamas (1296-1359) è una delle più grandi figure della Chiesa ortodossa, accostato ai grandi Padri greci che ne pensarono e ispirarono la struttura, ovvero Basilio di Cesarea, Giovanni Crisostomo e Gregorio di Nazianzo. Perché questo accostamento, dopo che sono passati molti secoli? Proprio perché l’epoca in cui Palamas visse somiglia a quella protocristiana, tesa alla definizione della dottrina, dunque attraversata da feroci dibattiti; e poi perché, come nei primi secoli della Chiesa latina, lo sfaldarsi dell’Impero creava un grande disordine politico. Insomma un’epoca che, dopo un terremoto, cerca assestamento. Il giovane Gregorio, rampollo di una famiglia senatoria di Costantinopoli, esordisce con delle lezioni, pare di grande successo, su Aristotele. Intanto entra in contatto col controverso movimento esicasta, per cui soltanto tramite precisi metodi di postura e di rilassamento corporale si può raggiungere la reale contemplazione fino all’unione mistica con Dio. Così matura in Gregorio la volontà di farsi monaco e si ritira nel santuario del Monte Athos. Dopo tre anni di eremitaggio, torna nel mondo, a Tessalonica, dove prende i voti, per tornare nel 1335 sul Monte Athos. A Costantinopoli intanto giunge una commissione papale da Roma, per discutere per l’ennesima volta la riunificazione delle due Chiese, dopo il clamoroso fallimento del concilio di Lione nel 1274. L’imperatore bizantino Andronico III incarica Barlaam, un monaco greco nato e vissuto in Italia, di redigere un documento di difesa delle posizioni ortodosse. Barlaam sostiene che né le tesi ortodosse, secondo cui nella Trinità lo Spirito Santo procede solo dal Padre, né quelle occidentali, per cui la processione avviene sia dal Padre sia dal Figlio (come del resto recitiamo nel Credo) possono essere filosoficamente dimostrate: l’Assoluto è inafferrabile e non se ne dà dimostrazione, quindi le dispute in atto sono insensate. Con i Turchi che minacciano i confini dell’Impero Bizantino, l’unificazione fra cattolici e ortodossi non deriva solo da preoccupazioni di carattere dottrinale, ma anche politiche perché garantirebbe la protezione delle potenze occidentali. Intorno a Barlaam si raccoglierà tutta l’ala occidentalizzante del mondo greco-orientale. La risposta dell’ala rigorista sarà invece affidata a Palamas e segnerà l’esordio della sua immensa produzione: a partire dalla tradizione della Scrittura e dai Padri è possibile articolare sillogismi dimostrativi sulle realtà divine; egli difende la processione dello Spirito soltanto dal Padre. Il volume raccoglie questi testi ed è così composto: dopo la ricca introduzione del curatore Ettore Perrella (psicanalista versato in filosofia e teologia) vengono significativamente riprodotte due lettere: una del Patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli, e l’altra del Cardinal Carlo Maria Martini, Arcivescovo emerito di Milano; esse attestano che oggi l’unione delle due Chiese, Cattolica e Ortodossa, ormai è matura e che l’occasione storica della prossima unità politica dell’Europa non può che facilitare questo cammino; del resto anche Giovanni Paolo II ha spesso ricordato che il Cristianesimo europeo respira con due polmoni, l’Oriente e l’Occidente. Seguono i testi di Palamas: nei Discorsi dimostrativi sulla processione dello Spirito Santo c’è il nucleo della disputa teologica trinitaria. Nei Discorsi in difesa dei santi esicasti Palamas respinge la stravagante accusa di onfalopsichia, vale a dire di considerare l’ombelico come sede dell’anima, accusa che Barlaam aveva rivolto ai monaci di Oriente travisando i loro esercizi spirituali uniti anche a metodi corporali di meditazione. Seguono Triadi, Difesa da Barlaam ed Acindino, Atti divini, La partecipazione divina e deificante, Verso la riconciliazione (Dialogo di un ortodosso con un barlaamita), Teofane, Sono Barlaam ed Acindino a dividere davvero in modo errato ed ateo la deità una in due deità di non pari livello. Il volume si conclude con la Vita di Palamas di Filoteo Konkinos. Abbiamo ricordato che Palamas fu studioso di Aristotele; ma la sua teologia fa riferimento piuttosto a Platone e al neoplatonismo: non è un caso che, nel fortunato volume Plato Christianus, E. von Ivanka pone gli scritti dello pseudo-Dionigi Areopagita e quelli di Palamas rispettivamente come punto di partenza e punto di arrivo del platonismo cristiano di lingua greca.
ENRICO DI GAND
Nel novero dei più accaniti nemici della filosofia elaborata da Tommaso d’Aquino va ascritto Enrico di Gand: nato in una data imprecisata, che oscilla tra il 1217 e il 1223, egli fu insegnante di teologia a Parigi a partire dal 1276 e mantenne l’incarico fino alla morte, sopraggiunta nel 1293. Significativamente Enrico fu uno dei teologi che formularono l’elenco delle proposizioni condannate dal vescovo Stefano Tempier nel 1277. Gli scritti principali di Enrico di Gand sono i Quodlibeta e la Summa teologica: quest’ultima è però rimasta incompiuta. Nello sferrare il suo attacco frontale al tomismo, Enrico prende di mira quello che era il caposaldo irrinunciabile della filosofia di Tommaso: la distinzione tra essenza ed esistenza. In rottura con l’Aquinate, Enrico è infatti convinto che nessuna essenza sia priva dell’essere che le compete come essenza: ché altrimenti si ridurrebbe al nulla. Le essenze (anche dette “specie”) sono piuttosto oggetti della conoscenza eterna propria di Dio, e in quanto tali sono dotate di essere ancor prima di concretizzarsi in individui. Affinché si concretizzino in individui, deve intervenire la creazione: essa è il frutto della libera volontà divina, la quale decide di conferire l’esistenza alle essenze, le quali sono già dotate di essere. Alla luce di ciò, Enrico è convinto dell’assoluta contingenza dell’intero creato, che può essere come non essere. In quanto dipendente dalla libera volontà di Dio e dalla Sua onnipotenza, il mondo non è necessario. Enrico crede che la distinzione tra due modi di agire della potenza divina – un modo assoluto non vincolato ad alcunché (la cosiddetta potentia absoluta) e un modo ordinato e vincolato alla scelta del miglior ordine possibile (la cosiddetta potentia ordinata) – sia fuorviante e foriero di errori insidiosi: secondo la potentia ordinata, infatti, ci si trova costretti ad ammettere che l’agire di Dio è necessitato e che dunque Egli non può agire diversamente da come agisce; in altri termini, si nega la libertà di Dio. Secondo la potentia absoluta, poi, si cadrebbe invece nella contraddizione di ammettere la libertà divina senza però riconoscere a Dio il miglior agire possibile; detto altrimenti, ci si troverebbe costretti ad ammettere che Dio è sì libero nel suo agire, ma il suo agire non è il migliore tra quelli possibili, proprio perché non ordinato univocamente. La distinzione tra i due tipi di potentiae deve dunque essere gettata a mare in quanto contraddittoria. Enrico di Gand, sul piano gnoseologico, si contrappone per primo a una lunga tradizione: egli infatti sostiene che per spiegare la conoscenza si può fare a meno di ipotizzare l’esistenza reale di specie intelligibili, mediane tra l’intelletto e le immagini particolari degli oggetti ricevuti per via sensoriale. Secondo Enrico, infatti, non v’è distinzione tra le immagini particolari e quelle universali, le quali non sono se non un risultato di un’operazione universalizzante compiuta dall’intelletto; non si tratta di un’astrazione di una specie universale esistente nelle cose particolari – come voleva la tradizione aristotelica –, ma piuttosto di un’universalizzazione dell’immagine particolare.
EPIETRO D’ABANO

Nel novero dei più accaniti nemici della filosofia elaborata da Tommaso d’Aquino va ascritto Enrico di Gand: nato in una data imprecisata, che oscilla tra il 1217 e il 1223, egli fu insegnante di teologia a Parigi a partire dal 1276 e mantenne l’incarico fino alla morte, sopraggiunta nel 1293. Significativamente Enrico fu uno dei teologi che formularono l’elenco delle proposizioni condannate dal vescovo Stefano Tempier nel 1277. Gli scritti principali di Enrico di Gand sono i Quodlibeta e la Summa teologica: quest’ultima è però rimasta incompiuta. Nello sferrare il suo attacco frontale al tomismo, Enrico prende di mira quello che era il caposaldo irrinunciabile della filosofia di Tommaso: la distinzione tra essenza ed esistenza. In rottura con l’Aquinate, Enrico è infatti convinto che nessuna essenza sia priva dell’essere che le compete come essenza: ché altrimenti si ridurrebbe al nulla. Le essenze (anche dette “specie”) sono piuttosto oggetti della conoscenza eterna propria di Dio, e in quanto tali sono dotate di essere ancor prima di concretizzarsi in individui. Affinché si concretizzino in individui, deve intervenire la creazione: essa è il frutto della libera volontà divina, la quale decide di conferire l’esistenza alle essenze, le quali sono già dotate di essere. Alla luce di ciò, Enrico è convinto dell’assoluta contingenza dell’intero creato, che può essere come non essere. In quanto dipendente dalla libera volontà di Dio e dalla Sua onnipotenza, il mondo non è necessario. Enrico crede che la distinzione tra due modi di agire della potenza divina – un modo assoluto non vincolato ad alcunché (la cosiddetta potentia absoluta) e un modo ordinato e vincolato alla scelta del miglior ordine possibile (la cosiddetta potentia ordinata) – sia fuorviante e foriero di errori insidiosi: secondo la potentia ordinata, infatti, ci si trova costretti ad ammettere che l’agire di Dio è necessitato e che dunque Egli non può agire diversamente da come agisce; in altri termini, si nega la libertà di Dio. Secondo la potentia absoluta, poi, si cadrebbe invece nella contraddizione di ammettere la libertà divina senza però riconoscere a Dio il miglior agire possibile; detto altrimenti, ci si troverebbe costretti ad ammettere che Dio è sì libero nel suo agire, ma il suo agire non è il migliore tra quelli possibili, proprio perché non ordinato univocamente. La distinzione tra i due tipi di potentiae deve dunque essere gettata a mare in quanto contraddittoria. Enrico di Gand, sul piano gnoseologico, si contrappone per primo a una lunga tradizione: egli infatti sostiene che per spiegare la conoscenza si può fare a meno di ipotizzare l’esistenza reale di specie intelligibili, mediane tra l’intelletto e le immagini particolari degli oggetti ricevuti per via sensoriale. Secondo Enrico, infatti, non v’è distinzione tra le immagini particolari e quelle universali, le quali non sono se non un risultato di un’operazione universalizzante compiuta dall’intelletto; non si tratta di un’astrazione di una specie universale esistente nelle cose particolari – come voleva la tradizione aristotelica –, ma piuttosto di un’universalizzazione dell’immagine particolare.
ILDEGARDA DI BINGEN
Hildegard von Bingen (1098 – 17 settembre 1179), conosciuta come Santa Ildegarda di Bingen, fu una monaca benedettina e mistica tedesca del XII secolo. Nacque, ultima di dieci fratelli, a Bermersheim, vicino ad Alzey, nell’Assia renana, nell’estate del 1098, un anno prima che i crociati conquistassero Gerusalemme. Fondatrice del monastero di Bingen, Ildegarda fu spesso in contrasto con il clero della Chiesa cattolica; tuttavia, riuscì a ribaltare il concetto monastico che fino ad allora era, e per molto tempo ancora sarebbe stato, inamovibile, preferendo una vita di predicazione aperta verso l’esterno a quella più tradizionalmente claustrale. Quando ormai era ritenuta un’autorità all’interno della Chiesa, Papa Eugenio III – nel 1147 – lesse alcuni dei suoi scritti durante il sinodo di Treviri. Per l’epoca in cui è vissuta, Ildegarda di Bingen è stata una monaca controcorrente e anticonformista; ha studiato a lungo occupandosi di teologia, musica e medicina. Ha lasciato alcuni libri profetici – lo Scivias (Conosci le vie), il Liber Vitae Meritorum (il Libro dei meriti della vita) e il Liber Divinorum Operum (il Libro delle opere divine) – e una pletora di lavori musicali, raccolti sotto il nome di Symphonia harmoniae celestium revelationum, diviso in due parti: i “Carmina” (canti) e l’ “Ordo Virtutum” (La schiera delle virtù, opera drammatica musicata). Un notevole contributo diede pure alle scienze naturali, scrivendo due libri che raccoglievano tutto il sapere medico e botanico del suo tempo e che vanno sotto il titolo di Physica (Storia naturale o Libro delle medicine semplici) e Causae et curae (Libro delle cause e dei rimedi o Libro delle medicine composte). Ebbero anche grande fama le sue lettere a vari destinatari e che trattano di diversi argomenti, nelle quali Ildegarda risponde soprattutto a richieste di consigli di ordine spirituale. Una posizione centrale nel pensiero di Ildegarda – di carattere assai forte ma cagionevole di salute – la occupa la Viriditas, l’energia vitale intesa come rapporto filosofico tra l’uomo – con le sue riflessioni e le sue emozioni – e la natura, preziosa alleata anche per guarire dalle malattie. Le visioni di Ildegarda erano iniziate in tenera età e avrebbero contrassegnato un po’ tutta la sua esistenza. All’età di otto anni, proprio per queste visioni, era stata messa nel convento di Disibodenberg dai nobili genitori, Ildeberto e Matilda di Vernescheim, dove sarebbe stata educata da Jutta di Spanheim, a sua volta una giovane aristocratica ritiratasi in monastero. Prenderà il velo tra il 1112 e il 1115 dalle mani del vescovo Ottone di Bamberg. Ildegarda studiò sui testi dell’enciclopedismo medievale di Dionigi l’Aeropagita e Agostino. Iniziò a parlare – e a scrivere – delle sue visioni (che definiva visioni non del cuore o della mente, ma dell’anima – solo intorno al 1136 quando aveva ormai quasi quarant’anni. Trasferitasi al convento di Rupertsberg, da lei stessa fondato, si dice facesse vestire sfarzosamente le consorelle, adornandole con gioielli, per salutare con canti le festività domenicale. Nella sua visione religiosa della creazione, l’uomo rappresentava la divinità di Dio, mentre la donna idealmente impersonificava l’umanità di Cristo. Nel 1147-48 il sinodo di Magonza riconobbe che nelle sue visioni c’era “la mano di Dio” e, da quel momento, il nome di Ildegarda divenne sempre più famoso nella cristianità. Nell’arco di una dozzina di anni, tra la fine del 1159 e il 1170, compì quattro viaggi pastorali predicando nelle cattedrali di Colonia, Treviri, Liegi, Magonza, Metz e Werden. Papa Giovanni Paolo II in una lettera per l’ottocentesimo anniversario della sua morte, salutò in Ildegarda la “profetessa della Germania”, la donna “che non esitò a uscire dal convento per incontrare, intrepida interlocutrice, vescovi, autorità civili, e lo stesso imperatore (Federico Barbarossa)”. E al genio di Ildegarda farà ancora cenno nell’enciclica sulla dignità femminile Mulieris Dignitatem. Monaca aristocratica Ildegarda ha più volte definito se stessa come “una piuma abbandonata al vento della fiducia di Dio”. Fedele peraltro al significato del suo nome, protettrice delle battaglie, fece della sua religiosità un’arma per una battaglia da condurre per tutta la vita: scuotere gli animi e le coscienze del suo tempo. Non ebbe timore ad uscire dal convento per conferire con vescovi e abati, nobili e prìncipi. Lei, che era in contatto epistolare con il monaco cistercense Bernardo di Chiaravalle, non ebbe timore a sfidare con durissime parole l’imperatore Federico Barbarossa, fino ad allora suo protettore, quando questi oppose due antipapi al papa legittimo Alessandro II. L’imperatore non si vendicò dell’ affronto, ma lasciò cadere il rapporto di amicizia che fino ad allora li aveva legati. Nel 1169 pare riuscisse in un esorcismo su una tale Sigewize, che aveva fatto ricoverare nel suo convento, dopo che altri monaci non erano approdati a nulla: nel rito da lei personalmente condotto – cosa del tutto inusuale per una donna- volle tuttavia la presenza di sette sacerdoti maschi. A fondamento dell’esperienza mistica di Ildegarda v’è il presupposto che le immagini ricorrenti nelle visioni abbiano un valore simbolico e che dunque sia necessario ricercarne il significato: influenzata dalle tesi della scuola di Chartres, Ildegarda è convinta della corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo; nei suoi scritti, ella introduce parecchie personificazioni: la Sapienza che crea il mondo pervadendolo; la Caritas, che rivela come tutta la creazione sia teofania. Quella di Ildegarda è pertanto una mentalità fortemente simbolica, che riconduce ogni realtà a un significato recondito che va ben oltre il suo contenuto immediato: ogni cosa è figura di altro, dai numeri ai colori, dagli animali ai metalli.
BERENGARIO DI TOURS
Berengario (999-1088 circa), famoso esponente della scuola Scolastica, nacque a Tours, nella valle della Loira in Francia, nel 999 (secondo altre fonti nel 1010); studiò dapprima alla scuola della città, e successivamente alla famosa scuola di teologia di Chartres, sotto la guida del vescovo Fulberto (vescovo dal 1007 al 1029). Alla morte di quest’ultimo, nel 1029, Berengario tornò a Tours, diventando il direttore della locale scuola di San Martino.
Nel 1039, Berengario fu nominato arcidiacono di Angers dal vescovo Uberto, ma continuò a vivere e a lavorare a Tours.
Nel 1047 Berengario entrò in discussione con Lanfranco di Pavia, abate del monastero di Le Bec in Normandia e futuro arcivescovo di Canterbury (n. 1005, arcivescovo: 1070-1089), a proposito della natura della Eucarestia. Questo problema è, in certo senso, connesso a quello dell’onnipotenza di Dio, giacché riguarda un evento che sembra sfuggire alla regolarità della natura e delle sue leggi. Il corpo e il sangue di Cristo sono realmente presenti nel pane e nel vino? Oppure pane e vino sono soltanto segni o simboli di realtà spirituali? È questa la vexata quaestio dell’Eucarestia; e si tratta, in realtà, di una polemica già affrontata circa 200 anni prima da:
Pascasio Radberto, secondo cui, nella sua opera più importante, De corpore et sanguine Domini (Del corpo e sangue del Signore), l’essenza (ovviamente non l’apparenza) del pane e del vino realmente si trasformava in quel Corpo e in quel Sangue, che era nato da Maria e aveva patito sulla croce,
Ratramno di Corbie, il quale insisteva sul fatto che la presenza di Cristo nell’Eucarestia fosse un mistero, non riducibile ad una trasformazione alla lettera del pane e del vino, e
Giovanni Scoto Eriugena, il quale dichiarò che la trasformazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo durante la messa era da intendersi in senso simbolico.
Lanfranco si allineò al pensiero di Pascasio Radberto e Berengario a quello di Scoto Eriugena, ribadendo che, dal punto di vista razionale, gli sembrava inconcepibile l’effettiva trasformazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, denominata transustanziazione. Appoggiandosi all’impianto filosofico elaborato da Aristotele, in particolare alle nozioni di “sostanza” e “accidente”, Berengario perviene alla conclusione secondo cui il pane e il vino sono soltanto simboli di realtà spirituali. Il punto di partenza del suo ragionamento è che se una sostanza scompare, allora scompaiono anche le sue proprietà (giacché non possono sussistere accidenti senza sostanza): riferito all’Eucarestia, ciò significa che se la sostanza del pane e del vino scomparisse, allora dovrebbero scomparire anche le loro proprietà accidentali (ad esempio il sapore, l’odore, il colore, ecc); ma dal momento che esse non scompaiono, allora anche la sostanza del pane e del vino continua a sussistere. A questa conclusione – è bene sottolinearlo – Berengario perviene per via meramente razionale, convinto che ciò sia legittimo alla luce del fatto che l’uomo è immagine di Dio proprio in forza del possesso della ragione. Alle tesi di Berengario si oppone, come abbiamo avuto modo di accennare, Lanfranco di Pavia, nel suo scritto del 1066 Sul corpo e sul sangue del Signore: per Lanfranco nel pane e nel vino v’è una presenza reale del corpo e del sangue di Cristo; per sostenere questa tesi, anch’egli non meno di Berengario si avvale della dialettica, nella convinzione che essa sia indispensabile, purché accompagnata dalla fede.
Denunciato dal suo avversario, Berangario fu fatto imprigionare su ordine del re Enrico I di Francia (1031-1060) e successivamente condannato dal concilio di Vercelli del 1050.
Indubbiamente gli fu utile, più di una volta, l’amicizia con Ildebrando di Soana, il potente ed influente arcidiacono, che ebbe un ruolo decisivo nella politica papale tra il 1050 ed il 1073, anno in cui diventò lui stesso papa con il nome di Gregorio VII (1073-1085).
Le condanne contro Berengario furono pronunciate al concilio di Parigi (1051), Tours (1055), Roma (1059), Poitiers (1075), Saint Maixeut (1076) ed infine nuovamente a Roma nel 1078, dove, in un concilio convocato in Laterano dall’amico Ildebrando, diventato nel frattempo Papa Gregorio VII, Berengario firmò un atto di fede, in cui affermava di credere:
“che, dopo la consacrazione, il pane diventa il vero Corpo di Cristo, quel corpo nato dalla Vergine”,
“che il pane ed il vino sull’altare, grazie al mistero della preghiera santa e del parole del nostro Salvatore, vengono convertiti in sostanza nel Corpo e Sangue del Signore Gesù Cristo”.
In cambio, Gregorio stabilì che Berengario non potesse essere perseguitato per le sue idee. Tuttavia, tornato in Francia, Berengario, come al solito, ritrattò, ma fu infine convinto a firmare una definitiva rinuncia alle sue idee al concilio di Bordeaux del 1080.
Berengario morì in solitudine sull’isola di San Cosma, vicino a Tours nel 1088.
Centoventisette anni dopo la sua morte, nel 1215, al Quarto Concilio Laterano, la transustanziazione divenne un dogma della fede, per poi tornare al centro di una vivace discussione ai tempi della Riforma protestante.
BRADWARDINE
A cura di Enrico Gori Thomas Bradwardine (1290 circa – 26 agosto 1349) fu un arcivescovo inglese, spesso chiamato “Il Dottore Profondo”. Nacque a Hartfield nel Sussex o a Chichester. Fu educato al Balliol College, a Oxford, dove divenne dottore in teologia e si guadagnò la reputazione di allievo profondo, abile matematico e teologo capace. Successivamente si trasferì al Merton College, in una Confraternita. Fu eletto Cancelliere Universitario e Professore di teologia. Da Cancelliere della diocesi di Londra divenne cappellano e confessore di Edoardo III, che assisté nelle guerre in Francia. Tornato in Inghilterra, fu nominato prebendario di Lincoln, arcidiacono della stessa città (1347) e, nel 1349, arcivescovo di Canterbury. Morì di peste a Lambeth il 26 agosto 1349, quaranta giorni dopo la consacrazione. Nel suo Racconto del cappellano delle monache, Chaucer mette Bradwardine allo stesso livello di Agostino. La sua vasta opera è un trattato contro i Pelagianisti intitolato De causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum, edito da GHenry Savile nel 1618, nel quale trattava la teologia matematicamente. Il Papa gli conferì perciò il titolo di “Dottore Profondo”. Scrisse anche il De geometria speculativa ; De Arithmetica practica; De Proportionibus; De Quadratura Circuli; e l’Ars Memorativa. Bradwardine fu uno dei Calcolatori di Oxford, del Merton College e della Oxford University, e studiò meccanica con John Dumbleton. I Calcolatori di Oxford distinguevano la cinematica dalla dinamica, enfatizzando la cinematica ed approfondendo la velocità istantanea. Dimostrarono anche il seguente teorema: un corpo che si muove a velocità costante percorrerà un totale di spazio ed impiegherà un totale di tempo uguali ad un corpo accelerato la cui velocità è la metà della velocità finale del corpo accelerato. Dimostrarono anche la legge della caduta dei gravi molto tempo prima di Galileo. Il matematico, fisico e storico della scienza Clifford Truesdell ha scritto: “Le fonti recentemente pubblicate ci dimostrano […] che le principali proprietà cinematiche del moto uniformemente accelerato, che si credevano dovute a Galileo, furono scoperte e dimostrate dagli Scolastici del Merton College. In principio, le qualità degli antichi Greci furono sostituite, almeno per quanto riguarda il moto, da valori numerici che da sempre fanno parte del sapere scientifico occidentale. L’opera si diffuse rapidamente in Francia, Italia ed altri parti d’Europa. Quasi subito, Antonio da Casale e Nicole Oresme riuscirono a rappresentare i risultati con grafici geometrici introducendo il legame tra fisica e geometria che divenne uno dei pilastri del pensiero scientifico occidentale”. Nel trattato De proportionibus, Bradwardine estende la teoria delle proporzioni di Eudosso anticipando la crescita esponenziale che sarà sviluppata da Eulero e Bernoulli, e la teoria dell’interesse composto. Per dimostrare il teorema sopra esposto, è necessario avere il concetto di limite: ne segue che Bradwardine dovette usare argomenti del suo tempo. Il matematico e storico della matematica Carl O. Boyer scrive: “Bradwardine sviluppò la teoria boeziana di doppio o triplo, o più generalmente, quella che è poi la proporzione n-esima. […] Le opere di Bradwardine contenevano principi fondamentali di trigonometria presenti negli autori arabi”.
PIETRO AUREOLO
A cura di Mai Saroh Tassinari
Anche se il francescano francese Pietro Aureolo (1280-1322) non ha suscitato tanta attenzione quanta il suo più giovane contemporaneo Guglielmo di Ockham, tuttavia su molte tematiche Aureolo fu probabilmente tanto influente tra i pensatori del XIV secolo quanto Ockham. Aureolo spesso rifiutava esplicitamente le idee di Tommaso d’Aquino e di Duns Scoto e ideò delle tesi interessanti, innovative e spesso controverse su un’intera gamma di argomenti filosofici e teologici – come ad esempio la sua teoria della conoscenza – e molte delle sue opinioni fecero nascere dibattiti tra pensatori successivi quali Gregorio da Rimini.
Vita e opere
Come per molti dei suoi contemporanei, siamo in possesso di pochissimi dati certi della vita di Aureolo (alias Peter Aureole, Peter Aureol, Petrus Aureoli, il Doctor Facundus). In base alla sua carriera più tarda, sembra ragionevole supporre che fosse nato intorno al 1280 e abbiamo le prove che fosse originario della regione vicino alla città di Cahors, in Francia. Sappiamo che entrò nell’ordine francescano della provincia di Aquitania e supponiamo che ciò accadde un po’ prima del 1300. Dalla struttura del sistema educativo francescano contemporaneo, possiamo dedurre che studiò a Parigi nella prima decade del XIV secolo, ma le testimonianze che qualche studioso ha fornito che Aureolo avesse ascoltato Duns Scoto a Parigi, o che si trovasse sicuramente a Parigi nel 1304, non sono sicure. La prima opera scritta da Aureolo, riguardante il tema della povertà francescana (Tractatus de paupertate et usu paupere), sembra essere stata scritta nel 1311 o, al più tardi, nei primi mesi del 1312. Sappiamo che durante quest’anno egli stava insegnando a Bologna, probabilmente nel convento francescano della città. Fu lì che autorizzò il suo Tractatus de principiis naturae, la sua unica opera non-teologica. Alla fine del 1314 si trovava a Tolosa, dove sembra che insegnasse, anche questa volta, in un convento francescano ed è probabile che i due trattati che scrisse in difesa dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria (e in opposizione alle critiche dominicane rispetto a tale argomento) risalgano a quel periodo (Tractatus de concepitone Beatae Mariae Virginis e Repercussorium). In una o in entrambe le città deve anche aver tenuto delle lezioni universitarie su un’allora diffuso libro di testo di teologia, le Sentenze di Pietro Lombardo, e il suo imponente commento sul primo libro delle Sentenze, il suo Scriptum super primum Sententiarum – più di 1100 pagine, nella sua prima versione a stampa (Roma 1596) – fu quasi certamente terminato nell’autunno del 1316, quando Aureolo arrivò a Parigi, mandato dall’ordine francescano per guadagnarsi il suo dottorato. Egli lesse le Sentenze a Parigi dal 1316 al 1318. Papa Giovanni XXII, il suo mentore, scrisse al Cancelliere di Parigi una lettera datata 14 luglio 1318, nella quale chiedeva che gli fosse concesso il dottorato; la lettera riuscì nel suo intento e verso la fine del 1318 Aureolo venne eletto mastro reggente in teologia dell’ordine francescano di Parigi. Ricoprì questa carica fino al 1320 o al 1321, impartendo lezioni sulla Bibbia (dalle quali risultano parecchi commentari biblici esistenti ancora oggi) e tenne almeno una serie di discussioni quodlibetali. Nel 1321, venne elevato da Giovanni XXII al grado di Arcivescovo di Aix-en-Provence, ma morì subito dopo aver ottenuto l’incarico, forse il 22 gennaio 1322.
Le sue opere sono soprattutto di natura teologica, essendo state scritte in relazione ai suoi compiti e in quanto studente e professore di teologia. Ad ogni modo, soprattutto il suo commentario sulle Sentenze di Pietro Lombardo è una miniera di pensieri filosofici che comprendono una vasta gamma di argomenti di metafisica, epistemologia, psicologia, filosofia naturale ed etica; inoltre è la sua opera più importante e influente; ne possediamo varie versioni. Oltre lo Scriptum, che venne redatto in larga parte prima che egli arrivasse a Parigi nell’autunno del 1316, abbiamo delle reportationes (appunti di studenti) delle lezioni che tenne su tutti e quattro i libri delle Sentenze, alcune delle quali sono state evidentemente rielaborate in un modo o nell’altro da Aureolo stesso, mentre altre si trovano solo più nei manoscritti medievali. Una versione del suo commentario sui libri II e IV fu pubblicata a Roma nel 1605 (insieme alla sua Quodlibet). In parte perché il progetto di pubblicare un’edizione critica di tutte le opere di Aureolo è stato iniziato solo recentemente, la complessa relazione tra lo Scriptum pubblicato e le reportationes sul libro I delle Sentenze non è del tutto chiara.
Il pensiero
Il pensiero di Aureolo è inesorabilmente sistematico, vi si trovano alcune idee di base che affiorano di frequente in contesti filosofici e teologici estremamente variegati; esse rappresentano le sue convinzioni fondamentali e vengono applicate rigorosamente.
Aureolo mostra anche, attraverso le sue opere, un taglio pronunciatamene storico. Ciò vuol dire che, quando discute di un qualsiasi argomento filosofico o teologico, comincia col fare un’analisi dettagliata delle idee anteriori e contemporanee a proposito della materia in questione, offrendo per lo più compendi accurati di altre posizioni e critiche generalmente perspicaci. In base a questa analisi, il suo pensiero spesso si modella mano a mano che egli elabora delle teorie che si propongono di superare i difetti che nota nei suoi predecessori. Uno studio recente sulle citazioni fatte nello Scriptum ha dimostrato che i primi cinque autori universitari citati esplicitamente sono, in ordine inverso: Durando di St. Pourcain, Enrico di Ghent, Hervaesu Natalis, Tommaso d’Aquino e Duns Scoto. Mentre questi furono gli autori che certamente influenzarono di più il suo pensiero, confutò attraverso i suoi scritti molti altri teologici, tra il quali Guglielmo di Ware, Godrei di Fontaines, Bonaventura, Riccardo di Mediavilla, Thomas Wylton e Giglio di Rome. Inoltre, sicuramente conosceva molto bene il pensiero antico e quello arabo.
Infine, è noto per aver proposto delle soluzioni inusuali, a volte radicali, ai problemi tradizionali. Questa fu una delle ragioni per le quali il suo pensiero risultò così provocatorio agli occhi dei suoi contemporanei e a quelli dei suoi lettori, fino al XVII secolo.
Le categorie
Aureolo riteneva che solo cinque delle dieci categorie aristoteliche esistessero veramente nel mondo esterno alla mente (sostanza, qualità, quantità, azione e passione), le altre cinque (relazione, luogo, tempo, posizione e stato/abitudine) essendo puramente concettuali o dipendenti dalla mente. Perciò le categorie concettuali esistono solo potenzialmente, ma non effettivamente ed è possibile per la mente, in base alla conoscenza di una delle categorie effettive nella realtà esterna, formare il concetto della categoria concettuale corrispondente. Questa teoria è stata studiata soprattutto a proposito delle opinioni di Aureolo concernenti la categoria di relazione. In questo contesto, egli ritiene che le relazioni reali sono concettuali in natura, inesistenti nella realtà esterna, e quindi dipendenti dall’attività della mente; i tre tipi di relazioni reali originano, partendo dalla mente, la conoscenza, rispettivamente, della quantità, della qualità, dell’azione e della passione. Inoltre, Aureolo, in netto contrasto con la tradizione medievale che lo precede, pensa che le relazioni siano fra due termini e non in un soggetto nei confronti di un termine. L’influenza delle idee di Aureolo sulle categorie non è stata studiata a fondo, ma è interessante che Gregorio da Rimini dedichi gran parte della sua discussione sulla categoria di relazione a un radicale attacco della prospettiva di Aureolo.
Il concetto di essere
Aureolo modificò l’opinione di Duns Scoto sull’univocità del concetto di essere. Mentre accettava il punto di vista di Scoto secondo il quale l’essere è univoco sia tra Dio e le creature sia tra la sostanza e gli accidenti, tuttavia lo criticò pesantemente per ritenere che l’essere fosse ridotto ai genera più generali attraverso diverse “differenze qualitative” che non erano incluse nel concetto di essere. Secondo Scoto, l’essere stesso diventava come un genus che veniva contratto attraverso una differenza esterna. Aureolo rifiutava questa tesi sulla base che questa “differenza esterna” era un’illusione; egli riteneva che nulla sfuggisse al concetto di essere, poiché questo è un concetto indeterminato che comprende tutti gli esseri in ugual maniera. Esso non ha un contenuto determinato, ma contiene al suo interno, implicitamente, tutti gli altri concetti che la mente può formare. L’essere, quindi, non viene ridotto ai suoi sottocomponenti per mezzo di nessuna differenza aggiunta, ma semplicemente attraverso l’esplicitazione di ciò che è già contenuto implicitamente e indeterminatamente nel concetto di essere. Così come per molti altri argomenti, la storia della ricezione da parte di Aureolo della teoria dell’univocità del concetto di essere deve ancora essere scritta.
Contingenti futuri e prescienza divina
Aureolo sviluppò delle teorie influenti sui contingenti futuri e la prescienza divina che ebbero il loro punto di partenza in due convinzioni che sostenne saldamente. Dapprima, che l’immutabilità e la necessità si implicano vicendevolmente, quindi, siccome Dio è immutabile, se dovesse conoscere il futuro, il futuro sarebbe necessario. Questa stessa convinzione condusse Aureolo a rifiutare, almeno in alcuni contesti, l’uso della distinzione, frequente nel tardo medioevo, tra l’assoluto di Dio e i poteri predestinati; per Aureolo, non c’è una reale possibilità in Dio di desiderare altro da ciò che fa. In secondo luogo, considerò come principio fondamentale l’esistenza del libero arbitrio. Questi due principi lo condussero a teorizzare che Dio conosce il futuro, ma non come futuro; piuttosto, Dio conosce il futuro indistantemente, in quanto astratto dal tempo ed è questo modo speciale di conoscere il futuro che preserva la libertà umana ed evita il “determinismo” divino. In accordo con questo punto di vista, sviluppò una logica “trivalente”, in cui le proposizioni rivolte verso il futuro sono neutre, senza ammettere né la verità né la falsità, annullando perciò il principio di bivalenza (che dichiara che ogni proposizione può avere solo uno o due giudizi veri). La posizione di Aureolo sui contingenti futuri e la prescienza divina ebbe un grande impatto nel tardo medioevo, poiché ispirò spesso confutazioni che, ad ogni modo, prendevano in considerazione le critiche che egli aveva fatto nei confronti di Tommaso d’Acquino e Duns Scoto. Sembra che le critiche di Aureolo nei confronti delle precedenti teorie scolastiche e alcuni elementi della sua stessa teoria influenzarono l’umanista Pietro Pomponazzi intorno al 1520, e perfino Martin Lutero.
Predestinazione e libero arbitrio
Nell’ambito della predestinazione, il libero arbitrio è di nuovo un filo conduttore che sta alla base delle idee di Aureolo. Reputando che le spiegazioni precedenti sul modo in cui Dio sceglieva alcuni per la salvezza e dannava altri al castigo eterno lasciasse troppo poco spazio al libero arbitrio, propose una teoria secondo la quale Dio offre la sua grazia liberamente a tutti gli esseri umani. La salvezza è di coloro che accettano passivamente questa offerta, mentre coloro che oppongono resistenza, cioè coloro che rifiutano attivamente la grazia, vengono dannati. Perciò, per Aureolo, l’argomento centrale nella predestinazione è come gli esseri umani scelgono di reagire alla libera offerta di grazia. Egli ritiene di avere evitato ogni accenno di pelagianismo – secondo cui gli esseri umani possono meritare la salvezza in base ai propri meriti – perché, per questa teoria, gli individui non fanno niente attivamente per ottenere la loro salvezza; si chiede loro solamente di accettare passivamente la grazia senza opporre resistenza e questa accettazione passiva è, secondo Aureolo, una causa negativa della salvezza di una persona. Quando questa teoria venne proposta per la prima volta, venne considerato un modo estremamente innovativo di spiegare il processo della salvazione e venne sottoposta a critiche sferzanti da parte, tra gli altri, di Gregorio da Rimini; ma, sia attraverso un’influenza diretta che non, alcuni elementi appaiono nelle opere di alcuni pensatori quali Ockham.
Conoscenza e realtà: concettualismo e esse apparens
Aureolo fu un “concettualista”. Infatti, spesso è stato considerato come un precursore di Ockham, soprattutto in proposito al suo concettualismo. Con questo termine si vuole dire che solo i singoli, gli individui, hanno un’esistenza reale, esterna alla mente. Aureolo scrive: “omnis res, eo quod est, singulariter est”. Questo è uno dei suoi principi metafisici più basilari ed implica necessariamente che l’universalità e gli universali sono fenomeni mentali, creati in qualche modo dall’intelletto. Ciò che è importante per capire il suo concettualismo, quindi, è spiegare la sua teoria della conoscenza intellettuale: determinare il processo per il quale l’intelletto fabbrica questi concetti universali, definire che cosa sono questi concetti e quale relazione hanno con gli individuali che effettivamente esistono nel mondo.
Mentre solo gli individuali hanno una vera esistenza extra-mentale, ogni individuale, per sua stessa natura, ha diversi aspetti ontologici. Aureolo chiama questi aspetti rationes, affermando, ad esempio, che Socrate ha le rationes di sostanza, corporalità, sensitività, razionalità. Inoltre, rationes dello stesso tipo che si trovano in individui differenti sono simillimae. Ad esempio, la corporalità di Socrate è del tutto uguale a quella di Platone, che a sua volta è del tutto uguale a quella dell’asino Brunellus. Ciò che è maggiormente importante a proposito di queste rationes, in questo contesto, è che esse sono l’unità basica della conoscenza intellettuale: ogni ratio per sua stessa natura è in grado di fungere da base per un concetto, anche se il concetto che risulta dall’intellezione di una ratio può essere modificato dal modo in cui lo concepiamo (il nostro modus concipiendi), una differenza puramente psicologica, senza riscontri immediati nella realtà esterna. Si potrebbe dire che una ratio guida l’intelletto a formare un certo concetto, che poi subisce delle modificazioni secondo il modo in cui lo si concepisce. I concetti universali, quindi, hanno in queste rationes una base diretta negli individuali extra-mentali. Quali concetti universali formiamo, dipende da quanto vicino l’intelletto si “incentri” sull’informazione proveniente dall’oggetto della conoscenza e, quindi, da quanto forte sia l’impressione che un oggetto fa sull’intelletto: più ci si incentra da vicino, più forte è l’impressione e più specifico è il concetto universale che viene formato.
Per capire ulteriormente cosa sono i concetti universali, bisogna capire che cosa intenda Aureolo per concetti in generale. A questo scopo, è fondamentale la sua teoria riguardo l’esse apparens, per la quale, a tutti i livelli, le nostre facoltà cognitive, nello stesso processo di conoscere, pongono l’oggetto della conoscenza in un tipo speciale di esistenza, definita da Aureolo esse apparens. Per lui, in linea con il pensiero generale del Medioevo, il nostro apparato conoscitivo è diviso in una parte sensoriale (che comprende i cinque sensi, il senso comune, che unisce i dati sensoriali provenienti dei cinque sensi, e l’immaginazione, che immagazzina, recupera, e a volte manipola, i dati sensoriali e li invia all’intelletto) e una parte intellettuale (che comprende l’intelletto agente e quello possibile). In ogni atto cognitivo – sia sensoriale, sia intellettuale – la facoltà cognitiva pone l’oggetto della conoscenza in questo speciale tipo di esistenza e l’oggetto in questo speciale tipo di esistenza è l’oggetto così come viene percepito. Perciò, i concetti e le sensazioni sono semplicemente degli oggetti di cui si acquisisce la conoscenza in un tipo di esistenza diverso da quello che hanno nella realtà esterna. Aureolo impiega almeno due diversi approcci per sostenere questa tesi: uno basato sulla conoscenza intellettuale, l’altro su quella sensoriale.
La conoscenza intellettuale: la soluzione di Aureolo al problema di definire che cosa sia il concetto, parte dalla necessità di spiegare tre cose in una volta sola: la predicazione essenziale; la conoscenza intellettuale di oggetti extra-mentali; e la conoscenza scientifica e necessaria. Egli ritiene che la prima di queste richieste di spiegazione non verrebbe esaudita da nessuna teoria dei concetti secondo la quale il concetto è un tipo di rappresentazione della cosa, nel caso questa rappresentazione abbia un’essenza reale – benché mentale. Esempi di soluzioni di questo tipo che egli fornisce sono che un concetto potrebbe essere un atto intellettuale, o intelligibile, o un qualsiasi tipo di accidente che termina l’atto del comprendere. Tutte queste rappresentazioni hanno una qualche essenza reale. Secondo Aureolo, questi tipi di teorie rappresentazionali dei concetti renderebbero impossibile spiegare la predicazione essenziale, poiché, assumendone una qualunque tra di esse, se io predicassi, ad esempio, animale riferendomi all’essere umano, farei una falsa predicazione, in quanto il concetto di essere umano non sarebbe il concetto animale. Il problema fondamentale con le teorie di questo tipo che riguardano gli universali è che, se fossero corrette, allora gli universali non sarebbero affatto degli universali, ma sarebbero dei particolari con la propria vera essenza. Inoltre, non solo questi stessi tipi di teorie rappresentazionali dei concetti, ma anche qualsiasi teoria che ritiene che i concetti siano le idee platoniche, impedirebbero di avere una conoscenza intellettuale degli oggetti del mondo esterno, la seconda richiesta di spiegazione. Secondo entrambi i tipi di teoria, la nostra conoscenza si estenderebbe solo a queste entità realmente esistenti. Per Aureolo, saremmo intellettualmente ciechi nei confronti della realtà esterna. D’altro canto, potremmo sicuramente avere una conoscenza intellettuale degli oggetti esterni, se i nostri concetti fossero oggetti particolari nel mondo extra-mentale in quanto esistenti extra-mentalmente – una tesi che Aureolo critica – ma non saremmo in grado di avere una conoscenza scientifica e necessaria, la terza richiesta di spiegazione. In effetti, non potremmo dare dei giudizi universali di nessun tipo, perché non ci sarebbe niente di universale a proposito della nostra conoscenza; invece di sapere che tutti i muli sono sterili, sapremmo solo che questo e quel mulo sono sterili.
Dopo aver considerato tutti questi punti di vista e avendoli trovati mancanti di qualche cosa, Aureolo offre la sua alternativa: l’unico modo di spiegare in una volta sola la predicazione essenziale, la conoscenza intellettuale degli oggetti esterni e la conoscenza scientifica e necessaria è di considerare gli oggetti come dei particolari extra-mentali, ma con un tipo diverso di esistenza (modus essendi) dall’esistenza reale che hanno extra-mentalmente. Questo speciale tipo di esistenza viene definito esse apparens, ma usa molti sinonimi, tra i quali esistenza “intenzionale” o “oggettiva”. Ciò che lo caratterizza è che è un oggetto extra-mentale particolare, ad esempio Socrate, ma indistintamente mischiato alla concezione passiva, cioè alla formazione di un concetto di Socrate. Un concetto di Socrate è Socrate così come viene concepito.
Per Aureolo, Socrate e il concetto che comprende Socrate sono la stessa cosa, ma con tipi di esistenza diversi. Che siano “la stessa cosa”, viene detto abbastanza letteralmente: “una cosa e la sua intenzione non differiscono numericamente in rispetto a niente in assoluto”. Ciò per cui differiscono una cosa e un’intenzione, è una relazione, che non è “fissa o sovrapposta a una cosa, come possono essere altre relazioni, ma è piuttosto del tutto intrinseca e indistintamente unita ad essa”. Questa relazione intrinseca è l’apparenza della cosa in quanto oggetto di percezione (apparire) a colui che percepisce (da cui l’espressione esse apparens). Quindi, è intrinseco per ogni cosa avere due diversi tipi di essere: reale o extra-mentale da una parte, e intenzionale o oggettivo dall’altra. A differenza dell’essere reale, l’essere intenzionale ha bisogno di un percettore per attualizzarsi; ciò significa semplicemente che è mediante l’atto di essere concepita che una cosa si pone nell’essere intenzionale.
Infatti – e qui si ritorna al concettualismo – sulla base di ciò che ha detto Aureolo, si può dedurre che ogni cosa particolare, ad esempio Socrate, ha diverse esistenze potenziali intenzionali: una per ognuna delle sue rationes, quelle unità basiche della conoscenza intellettuale che guidano la mente a formare certi concetti su di lui e che sono Socrate; le rationes sono aspetti essenziali senza i quali un individuo non sarebbe l’individuo che è. Così, Socrate non è Socrate senza essere un animale razionale, cioè senza avere le rationes di sensitività e di razionalità. Socrate è un essere umano in ogni sua più piccola parte tanto quanto è Socrate e il concetto di “essere umano” è in tutto e per tutto Socrate nella misura in cui è “Socrate”. Perciò, per quanto riguarda la conoscenza intellettuale, Socrate (e in particolar modo la sua ratio di razionalità) guida a formare il concetto di “essere umano” e quel concetto è Socrate, una delle esistenze potenziali intenzionali di Socrate.
In questo modo Aureolo tenta di affrontare i problemi che aveva individuato nelle altre teorie dei concetti. Da una parte, prova a basare la nostra conoscenza il più fermamente possibile sulle cose esterne: un concetto è semplicemente il particolare extra-mentale concepito in un diverso tipo di esistenza da quello che ha extra-mentalmente, un modo di essere che è tuttavia intrinseco al particolare extra-mentale; il concetto non oppone nessuna barriera tra la mente che concepisce e l’oggetto concepito. Nello stesso tempo, comunque, Aureolo vuole preservare l’universalità dei concetti universali e il loro uso nelle predicazioni essenziali e nella conoscenza scientifica e ritiene che la sua teoria dei concetti lo faccia. Siccome rationes dello stesso tipo che si trovano in individui diversi sono “massimamente similari”, dirigono tutte la mente a formare lo stesso concetto. In questa maniera il concetto di “essere umano” che si crea da Socrate è lo stesso di quello che si crea da Platone, poiché sono entrambi basati sulla ratio massimamente similare di razionalità. Aureolo è chiaro sul fatto che un concetto universale è tutti i suoi particolari, una rosa è tutte le rose particolari, un animale è tutti gli animali particolari. Ciò significa che un animale è il concetto di animale e tutti gli animali esistenti allo stesso tempo.
La conoscenza sensoriale: L’intelletto non è l’unica facoltà cognitiva che funziona ponendo la cosa conosciuta in esse apparens: anche le facoltà sensoriali lavorano in questo senso. Infatti, Aureolo usa la conoscenza sensoriale, e la sua affermazione secondo la quale i sensi formano l’esse apparens, come ulteriore prova del fatto che anche l’intelletto si comporta in questa maniera. In un famoso passaggio dello Scriptum (passaggio conosciuto e criticato da Ockham) dà una descrizione della conoscenza sensoriale che parte da un gruppo di “esperienze” che egli ritiene che provino che i sensi conoscano l’oggetto percepito ponendolo attivamente nell’esse apparens. Così, se qualcuno si trova su una barca che si dirige verso la foce di un fiume, gli sembra che gli alberi della riva si stiano muovendo; quando un bastone viene fatto girare molto rapidamente, a chi lo guarda sembra che un cerchio colorato ruoti nell’aria; un bastone posto fino a metà nell’acqua sembra rotto; se premo sul mio occhio mentre guardo una candela, mi sembrerà di vederne due; guardando direttamente il sole, compare un’immagine residua. Aureolo cita otto esperienze come queste, ma per lui tutte portano alla stessa conclusione: che in ognuno di questi casi ciò che ci appare (cioè la nostra percezione erronea) non corrisponde direttamente alla realtà, ma è il risultato dei sensi che pongono l’oggetto nell’esse apparens. Si consideri il caso del bastone roteante: che cos’è il cerchio che appare nell’aria? Non può essere nulla di veramente esistente nel bastone stesso, poiché esso è diritto; né, ovviamente, un vero cerchio che rotea nell’aria. Infine, il cerchio non è una visione o qualcosa nell’occhio, poiché noi vediamo il cerchio e non la sua visione, e inoltre il cerchio ci appare essere nell’aria. L’unica spiegazione possibile è che il cerchio ci appare perché la nostra vista ha attivamente posto il bastone nell’esse apparens; più genericamente, ciò che vediamo in questi casi è “solo l’apparenza della cosa o la cosa nell’esse apparens.” L’errore sensoriale si spiega facendo riferimento all’attività fondamentale dei sensi e Aureolo insiste sul fatto che i sensi sono attivi nello stesso modo anche nei casi in cui funzionano correttamente; questo perché, siccome l’attività è una caratteristica nobile da avere, se nelle visioni erronee la vista pone attivamente la cosa vista nell’esse apparens, lo farà certamente anche in quelle veritiere. La differenza tra un’esperienza sensoriale veritiera e una erronea è che in quella veritiera il modo in cui l’oggetto della conoscenza appare e il modo in cui è nella realtà esterna coincidono; perciò in un’esperienza sensoriale veritiera non abbiamo maniera di dire che i sensi stanno ponendo l’oggetto nell’esse apparens. Quindi, queste esperienze di errore sensoriale sono di immensa importanza, poiché è solo tramite esse che si può discernere il ruolo imprescindibile che l’esse apparens e l’attività dei sensi giocano in tutta la conoscenza sensoriale.
Inoltre, Aureolo chiarisce in questo contesto che questo esse apparens non è una rappresentazione della cosa con la sua reale essenza; è piuttosto la cosa stessa semplicemente posta in un altro tipo di esistenza: l’esse apparens di un oggetto percepito è semplicemente quell’oggetto in quanto percepito. Ovviamente, ciò corrisponde alla sua teoria riguardo l’esse apparens nell’ambito della conoscenza intellettuale ed egli rende esplicita questa corrispondenza. Per andare dalla percezione sensoriale a quella intellettuale, usa un comune principio scolastico che è stato detto “il principio della gerarchia”: date due facoltà, una più bassa e l’altra più elevata (come i sensi e l’intelletto), se quella più bassa può compiere qualcosa di nobile, allora la più elevata può certamente fare lo stesso. L’attività dei sensi, quindi, ad esempio il fatto che i sensi pongono l’oggetto nell’esse apparens, siccome è nobile, dimostra che anche l’intelletto può porre l’oggetto nell’esse apparens. La teoria di Aureolo sulla percezione sensoriale è complicata dal fatto che egli sembra affermare che alcune delle esperienze sensoriali illusorie che cita esistano al di fuori della mente, ad esempio che il cerchio colorato sia nell’aria e non nella mente.
Tre affermazioni generali possono essere fatte sulla base di questa analisi sulla conoscenza e la realtà. Primo, Aureolo è un concettualista che ritiene che gli universali non siano niente di più che i concetti formati dalla mente, anche se questi concetti universali hanno una base diretta nella cosa particolare conosciuta (le rationes). Secondo, un principio che sottostà alla teoria della cognizione di Aureolo è che le facoltà cognitive sono fondamentalmente attive: tutta la conoscenza ha luogo perché una facoltà cognitiva pone l’oggetto della conoscenza nell’esse apparens, che è semplicemente l’oggetto della conoscenza in un tipo di esistenza diverso da quello che ha al di fuori della mente, l’essere dell’essere percepito. Così, Aureolo fa parte di una numerosa corrente di pensiero medievale (che deriva da Agostino e, in ultima istanza, da Platone) che rifiuta il fatto che l’animo e le sue facoltà siano passivamente influenzati dagli oggetti esterni; le facoltà cognitive sono attive. Terzo, riferendosi alle visioni erronee per mostrare che sia i sensi che l’intelletto producono l’esse apparens, Aureolo ha conferito all’errore una posizione centrale nella sua descrizione della conoscenza. Per dirla in maniera diversa, il problema per lui non è spiegare come possiamo avere una percezione e un’intellezione erronee (in contrasto con molte teorie sulla conoscenza); piuttosto, vuole spiegare come possiamo avere delle percezioni veritiere e come possiamo sapere quando sono veritiere. Questa è all’incirca una delle funzioni che la distinzione tra conoscenza intuitiva ed astrattiva ha avuto per alcuni autori medievali (ad esempio Duns Scoto e Ockham), anche se, come vedremo, Aureolo non la usa in questa maniera. Infatti, sembra più opportuno descriverlo come qualcuno che conserva come una sorta di principio assiomatico il fatto che, in circostanze normali, le nostre facoltà cognitive rappresentano il mondo in una maniera adeguata. Comunque, a parte ciò che pensava, le implicazioni scettiche della sua teoria dell’esse apparens non preoccuparono molti dei suoi lettori medievali e la teoria suscitò una risposta critica perché alcuni pensarono che desse un taglio troppo netto tra conoscenza e realtà.
Conoscenza intuitiva e astratta e limiti delle abilità cognitive umane
Duns Scoto, che introdusse la distinzione tra conoscenza intuitiva e astratta, riteneva che fossero distinte perché avevano degli oggetti diversi. Secondo lui, abbiamo una conoscenza astratta di un oggetto quando questo non ci è direttamente presente, mentre una conoscenza intuitiva può solo avere luogo quando l’oggetto esiste ed è davanti ai nostri occhi; dunque, la conoscenza intuitiva garantisce che l’oggetto esiste, a differenza di quella astratta. Si sa che Ockham prese le distanze da questo punto di vista, affermando che si può, in certi casi straordinari (cioè sovrannaturali), avere una conoscenza intuitiva di oggetti inesistenti. Anche Aureolo non era d’accordo con l’opinione di Scoto, perché pensava che la conoscenza intuitiva fosse possibile sia che l’oggetto fosse presente, sia che fosse assente. In maniera simile, una conoscenza astratta non dipende affatto dall’oggetto; lo stesso oggetto può essere conosciuto sia in modo intuitivo che astratto. Secondo Aureolo, che noi abbiamo un tipo di conoscenza o l’altro dipende esclusivamente dalle caratteristiche della conoscenza che stiamo avendo, da come l’oggetto ci appare. Egli afferma esplicitamente che la conoscenza intuitiva e quella astratta sono in realtà i due modi fondamentalmente diversi in cui l’esse apparens creato dalle facoltà cognitiva può apparirci. Per illustrare ciò, afferma che la vista è del tutto intuitiva, mentre la conoscenza immaginaria, cioè quando si conosce qualcosa tramite la facoltà interna dell’immaginazione, è totalmente astratta. Questa è la metafora centrale del tentativo di distinguere i due tipi di conoscenza: la vista è intuitiva, l’immaginazione astrattiva. Così, descrivendo la conoscenza sensoriale, Aureolo indica quattro caratteristiche che insieme permettono di determinare se una particolare conoscenza è intuitiva o astrattiva. Dapprima, una conoscenza intuitiva è caratterizzata dall’essere immediata o diretta, come quando vediamo un oggetto davanti a noi. Lo stesso non si può dire della conoscenza astrattiva o immaginaria; essa è mediata e richiede un qualche processo discorsivo. Aureolo fornisce il seguente esempio: un astronomo che sta seduto nella sua stanza può predire un’eclissi attraverso il calcolo e può addirittura immaginarla su questa base, ma ciò è qualcosa di totalmente diverso dal vedere l’eclissi direttamente. Una seconda caratteristica della conoscenza oculare o intuitiva è la presenza dell’oggetto. L’oggetto di una cognizione intuitiva sembra essere presente (sia che lo sia davvero o no), mentre l’oggetto di una cognizione astrattiva no. Nel caso dell’astronomo, egli può immaginare l’eclissi, ma nello stesso atto di far ciò sa che l’eclissi non sta avvenendo realmente davanti ai suoi occhi. La terza e la quarta caratteristica che menziona Aureolo sono più o meno uguali: una conoscenza intuitiva implica l’attualizzazione e l’esistenza del suo oggetto, a differenza di quella intuitiva. L’astronomo può immaginare l’eclissi, e addirittura immaginare un’eclissi che ha luogo in quel preciso istante, ma, di nuovo, lo stesso fatto che stia immaginando l’eclissi implica il riconoscimento che essa non sta avvenendo davvero.
Ciò che è fondamentale nella distinzione tra conoscenza intuitiva e astrattiva è il carattere della conoscenza così come ci appare; la distinzione tra di loro è fenomenologicamente determinata. Il rifiuto di Aureolo della distinzione di Scoto tra conoscenza intuitiva e astrattiva ha come punto di partenza diverse “esperienze” che richiamano le esperienze che aveva usato per dimostrare che i sensi pongono l’oggetto della conoscenza sensibile nell’esse apparens. Ad esempio, guardando direttamente al sole, o a un qualsiasi altro oggetto luminoso, appare un’immagine residua, perciò la visione del sole resta nell’occhio anche quando l’oggetto in sé è assente. Nei sogni possiamo avere l’esperienza di visioni, suoni e sensazioni tattili in assenza degli oggetti che provocano queste sensazioni; le persone che vengono ingannate dalle illusioni vedono spesso cose che non ci sono davvero. In tutte queste sensazioni, l’oggetto sembra essere effettivamente presente ed esistente, quando in realtà non lo è. Aureolo conclude con l’affermare che possiamo avere una conoscenza intuitiva di oggetti inesistenti.
Per quanto riguarda la conoscenza intellettuale, Aureolo dichiara che l’intelletto umano può avere una conoscenza intuitiva. Per dimostrarlo, si appella dapprima al principio di gerarchia menzionato in precedenza: siccome le facoltà più basse, i sensi, possono avere una conoscenza intuitiva, è certo che anche la facoltà più elevata, l’intelletto, possa averla. Inoltre, sulla base di un famoso passaggio dalla Lettera ai Corinzi di Paolo (13:12, “per ora guardiamo uno specchio offuscato, ma in seguito saremo faccia a faccia”), Aureolo ritiene che la beatifica visione di Dio sia una conoscenza intuitiva intellettuale.
Anche se la conoscenza intuitiva è possibile per l’intelletto, Aureolo, a differenza di Ockham, nega però che si possa avere una conoscenza intuitiva in questa vita. Siccome l’intelletto del viandante (viator – la persona in questa vita) dipende dai sensi e dalla loro cognizione dei particolari, Aureolo nega che possiamo avere (o, almeno, che possiamo sapere di avere) una conoscenza intellettuale diretta e presente, di tipo oculare; questa è una prerogativa degli angeli e dei beati in paradiso, non gravati dai sensi corporei. Tutta la nostra conoscenza intellettuale in questa vita è caratterizzata dalla discorsività e dalla mediatezza, che sono il marchio di una conoscenza astrattiva.
Aureolo non mette in discussione che, in condizioni normali, le nostre facoltà donateci da Dio funzionino come dovrebbero e che possano autocorreggersi; non sembra essere preoccupato riguardo possibili ramificazioni scettiche della sua teoria dell’esse apparens. Tuttavia, negando che gli esseri umani in questa vita abbiano una conoscenza intellettuale intuitiva, preparò il cammino per una delimitazione piuttosto rigida delle facoltà intellettuali dell’uomo.
Questo ultimo punto spiega alcune interessanti caratteristiche dell’atteggiamento di Aureolo nei confronti della conoscenza umana. In particolare, nonostante il fatto che rimanga dell’idea che Dio possa dare a una persona in questa vita una conoscenza astrattiva dell’essenza divina, e che questa conoscenza sarebbe in grado di servire da base per la conoscenza dimostrativa di tutti i dogmi della fede cristiana, mostra un pronunciato pessimismo riguardo le capacità cognitive umane. Così, discute a lungo sul fatto che in questa vita non siamo in grado di decidere di questioni quali se l’universo sia eterno o creato nel tempo. Aureolo ritiene che ciò dipenda dal fatto che non abbiamo una conoscenza intellettuale diretta, la quale ci permetterebbe di risolvere questo problema. In questo contesto, vediamo che il rifiuto della conoscenza intellettuale intuitiva in questa vita è alla radice di una visione in qualche modo pessimistica di ciò che può raggiungere la ragione umana: non abbiamo una conoscenza intuitiva diretta del mondo (tanto meno di Dio), solo una conoscenza astrattiva indiretta e questo pone dei limiti piuttosto stretti a proposito di ciò che il nostro intelletto può ottenere se privo di aiuti.
Anche la teoria della conoscenza intellettuale umana degli individuali denota l’influenza del suo rifiuto della conoscenza intellettuale intuitiva in questa vita. I concetti universali (formati attraverso il processo aristotelico di astrazione) ci appaiono sempre come cognizioni astratte, poiché ciò che è universale astrae da qualsiasi presenza ed immediatezza dell’oggetto della conoscenza. Ad ogni modo, c’era un numero di filosofi dell’ordine francescano, tra i quali Duns Scoto, che avevano dichiarato che gli individuali potevano essere conosciuti in quanto tali dall’intelletto. Aureolo rifiuta la tradizione francescana, perché la vera conoscenza intellettuale intuitiva ci è proibita in questa vita e non possiamo avere nessuna conoscenza intellettuale diretta dei singolari. Ribadisce che formiamo i concetti degli individuali solo attraverso la mediazione dei sensi e per mezzo di un processo discorsivo. (Riconoscendo che i sensi stanno percependo un individuale, l’intelletto può comprendere che esso può esistere ed essere presente, ma non abbiamo nessuna conoscenza intellettuale diretta, o concetto, di alcun individuale. Infine, afferma chiaramente che gli angeli e i beati, privi di corpi e di sensi corporei, avrebbero una conoscenza intellettuale diretta degli individuali, proprio come Dio quando vede la sua stessa essenza. Quindi un pessimismo riguardo le abilità cognitive umane è sistematico nel pensiero di Aureolo e ha la sua espressione più evidente nel suo dichiarare che non possiamo avere una conoscenza intellettuale intuitiva in questa vita.
ADELARDO DI BATH
CRONOLOGIA
1080 Adelardo nacque a Bath verso questa data.
1088 La ribellione a favore di Roberto di Normandia fu schiacciata da suo fratello William Rufus. Bath fu fortemente danneggiata e fu venduta al nuovo vescovo di Wells per 500 libbre.
1090 Il vescovo John di Tours (chiamato anche John de Villula) trasferì la sede del suo vescovado da Wells a Bath, e cominciò a costruire lì una nuova grande cattedrale. Si pensa che Adelardo abbia frequentato la scuola del Monastero Benedettino che divenne il priorato della cattedrale.
1100 Adelardo fu mandato a Tours, una delle grandi scuole vescovili fondate da Carlo Magno, dove egli avrebbe studiato le sette arti liberali: il trivio (grammatica, retorica e dialettica) e il quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica).
1105 Egli era in Francia quando suonava la cetra ( uno strumento a corde precorritore della chitarra ) alla regina. Questa doveva essere Matilde, la moglie di Enrico I. Nel De eodem et diverso descrive un bimbo che, trascinato dal ritmo della musica, ondeggiava le sue braccia con tanto entusiasmo da far ridere tutta la compagnia. Si dice che la regina Matilde sia stata “generosa coi poveri studenti e coi musici”. Iniziò a viaggiare per il mondo visitando Salerno, famosa per la sua scuola di medicina, la Sicilia, allora regno normanno, la Grecia e probabilmente Toledo.
1106 Quell’anno tornò a Bath. Testimoniò in un atto a favore del vescovo John. Allora era membro dello staff del vescovo, il suo nome essendo incluso tra quelli dei “ministri”.
1107 Era a Laon, in veste di tutore di suo nipote e di altri studenti. Qui probabilmente scrisse le Regulae Abaci, un trattato sull’uso dell’abaco, una specie di calcolatrice primitiva. È dedicato al suo “caro amico H.”, molto verosimilmente uno dei suoi studenti. Il suo lavoro filosofico De eodem et diverso deve essere stato scritto all’incirca in quel tempo. È dedicato a William, vescovo di Siracusa (1108 – 1116). In esso, si discute il problema della identità e della diversità in forma di allegoria. Una sera passeggiava a Tours lungo la Loira con uno dei suoi maestri e incontrarono due matrone: Filosofia e Filocosmia.Le idee della prima sono espresse da ciascuna delle sette arti liberali nelle personificazioni che appaiono successivamente. Filocosmia ha per sua serve Ricchezza, Potere, Onore Fama e Piacere. Naturalmente è Filosofia che tiene il cuore di Adelardo.
1109. Riprende nuovamente i suoi viaggi. Nei sette anni successivi visitò la Sicilia, l’Italia, l’Asia Minore, la Spagna e probabilmente l’Africa del Nord.
1114 Fu a Manistra, vicino ad Antiochia al momento di un terremoto. Egli potè aver avuto importanti manoscritti arabi in quell’area.
1116 Probabilmente è tornato in Inghilterra. Qui iniziò a scrivere Quaestiones Naturales. Lì illustra il suo desiderio di scoprire gli usi e i costumi della sua terra. Egli dice di aver “imparato che i suoi capi sono violenti, i suoi magistrati amanti del vino, i suoi giudici mercenari, i suoi protettori incostanti, i privati sicofanti, quelli che fanno promesse ingannatori, gli amici pieni di gelosia, e quasi tutti gli uomini narcisi”. Questo libro è in forma di dialogo tra zio e nipote. Il nipote pone 76 domande riguardanti fenomeni naturali; queste comprendono: perché il mare è salato? Perché alcuni animali vedono meglio la notte? Come fa il globo ad essere sostenuto dall’aria? Che cosa provoca le maree? Adelardo pensava che non ci fosse conflitto necessario tra scienza e religione: “non voglio togliere nulla a Dio, perché qualunque cosa è, è da lui e per lui”. Questo libro è dedicato a Riccardo vescovo di Bayeux (nominato nel 1107). Fu pubblicato per la prima volta nel 1480. Circa nello stesso tempo, scriveva De cura accipitrum, un trattato sui falchi. Egli ci dice che è basato sui “libri del re Harold”. Mostra una vasta conoscenza delle piante inglesi e delle malattie dei falchi, e pure una comprensione della falconeria. Le piante medicinali riportate sono molteplici.
Dopo il 1116. Negli anni seguenti, Adelardo fece due importanti traduzioni dall’arabo. La prima fu I tredici libri degli Elementi di Geometria di Euclide. L’originale fu scritto ad Alessandria d’Egitto nel 300 a.C. circa. Nessuna versione latina ci è giunta dall’Alto Medioevo, ma si fecero due traduzione dal greco all’arabo nell’VIII e nel IX secolo. La traduzione di Adelardo fu usata da Ruggero Bacone nel secolo seguente e divenne la base di tutte le edizioni europee fino al 1533. Le Tavole astronomiche di al-Khwarizmi furono ugualmente tradotte da Adelardo. Poiché l’originale non esiste più, la traduzione di Adelardo è molto importante. Altre traduzioni di Adelardo furono tre testi di astrologia – Centiloquium Ptolomei, Isagoge Minor (una breve introduzione all’astronomia) di Abu Ma`star e il Liber prestigiorum Thebidis, un libro sul significato delle immagini di Thabit b. Qurra. Può anche aver tradotto dal greco un libricino sulla chiromanzia.
1130. In quell’anno, Adelardo ricevette una piccola somma di denaro (o gli fu cancellata una multa) dai proventi del Wiltshire, secondo una scrittura del Pipe Roll. Si pensa verosimilmente che questo fu un riconoscimento per il lavoro fatto alla Tesoreria Reale e che Adelardo sia stato pratico dei metodi contabili lì usati (basati su una stoffa quadrettata posta su un gran tavolo) che si sa essere stati appresi a Laon.
1142. Dieci oroscopi per il re sono stati recentemente attribuiti ad Adelardo. Sono stati collegati ad eventi avvenuti tra il 1149 e il 1151. Uno ricorda un incontro tra un maestro e un suo vecchio allievo che possono essere Adelardo e Enrico II. Adelardo può essere stato il precettore di matematica del giovane Enrico quando questi era a Bristol con sua madre negli anni 1142 – 1146, stando là nella casa di suo zio Roberto di Gloucester, figlio naturale di Enrico I. Più tardi, Adelardo scrisse sull’astrolabio: De opere astrolapsus. È dedicato a un Enrico che aveva il re per nonno o zio. Al pari degli altri suoi lavori di matematica, è importante l’introduzione dei numeri arabi e l’uso dello zero, che resero possibile i calcoli eliminando l’abaco. Con l’astrolabio era possibile calcolare l’altezza di un edificio, la profondità dei fossi e dei pozzi e pure la latitudine e la longitudine di ogni punto della terra. Poiché mostrava le posizioni delle stelle e dei pianeti in relazione ai segni dello zodiaco, fu usato anche per le predizioni astrologiche. Forse il suo uso più importante fu per la determinazione del tempo, di giorno e di notte, che si protrasse nella navigazione ben addentro al XVII secolo.
1160. Si pensa che l’ultimo oroscopo reale sia stato fatto quell’anno. Non si sa quando Adelardo morì o dove è sepolto. Poco rimane della grande cattedrale normanna che può essere stata finita prima della sua morte, sebbene parte del pavimento possa essere visto attraverso la grata a destra della cappella Alphege nella Abbazia, e sebbene la base dei pilastri della croce possano essere visti fuori dalla parte est. Una parte nelle Abbey Heritage Vaults è dedicata ad Adelardo.
PENSIERO
Anche conosciuto come Athelhard (inglese) e Adelardus Bathonienses o Adelardues Bata (latino), Adelardo è stato considerato il primo scienziato inglese. Scrisse trattati sull’Abaco e sull’Astrolabio, il più importante strumento scientifico del suo tempo. Le sue traduzioni (con i commenti) di studi di matematica e di astronomia dall’arabo favorirono l’introduzione dei numeri arabi e l’uso dello zero in Occidente. Il suo libro sulla Filosofia Naturale mostrò come ragione e osservazione potrebbero essere usate per spiegare i fenomeni naturali. Adelardo di Bath fu un insegnante inglese del XII secolo. È soprattutto conosciuto per aver tradotto numerosi trattati arabi di astrologia, astronomia, filosofia e matematica in latino, compresi vecchi testi greci che esistettero solo nella loro versione araba, che così vennero introdotti in Europa. Per sette anni viaggiò attraverso il Nord Africa e l’Asia Minore. Studiò a Tours e insegnò a Laon. Il suo lavoro più noto è quello sui suoi studi arabi, compreso quelli raccolti col titolo di Perdifficiles Quaestiones Naturales (Questioni Naturali), primo gruppo stampato nel 1472, sotto forma di dialogo tra lui e un nipote tra il 1113 e il 1133. Nelle Questioni Naturali, egli mostra un qualche spirito originale di carattere scientifico, sollevando la questione della forma della terra (che credeva rotonda) e di come questa rimane ferma nello spazio, e pure l’interessante domanda di quanta strada fa un sasso gettato in un buco scavato attraverso tutta la terra o un sasso posto in mezzo al buco (l’odierno centro di gravità). Egli si domandava anche perché l’acqua avesse difficoltà ad uscire da un recipiente capovolto (ovviamente il recipiente deve avere una bocca relativamente stretta per l’effetto reciproco della pressione atmosferica e del vuoto che si crea nel vuotarsi del recipiente). Molte altre domande riflettono la cultura popolare dei suoi tempi. In tutto, le Questioni naturali constano di circa settanta questioni di filosofia della natura, incentrate soprattutto sui quattro elementi; in tale opere, Adelardo considera la cultura araba (che egli ebbe modo di conoscere direttamente in un suo viaggio a Gerusalemme) come espressione della scienza e della ragione. Scrisse, inoltre, un breve trattato sull’abaco (Regulae Abaci) e un trattato sull’astrolabio. Tradusse gli Elementi di Euclide in latino da una traduzione araba dell’originale greco. Johannes Campanus probabilmente lesse la traduzione di Adelardo degli Elementi ed è il libro di testo delle scuole europee di matematica. L’idea cardinale su cui poggia il pensiero di Adelardo è la convinzione secondo cui ogni cosa proviene da Dio ma avviene secondo ordine e ragione, con la conseguenza che, per spiegare la regolarità degli eventi di natura, non occorre fare riferimento alla volontà divina: basta ricercare i legami causali nella natura stessa delle cose. Adelardo scrisse anche un importante De eodem et Diverso (Della Identità e della Diversità) sotto forma di lettere indirizzate a suo nipote: si tratta di un testo di filosofia che oppone le virtù delle sette arti liberali agli interessi mondani. Nel De eodem et Diverso, Platone viene assunto come massimo filosofo dell’antichità.
TEODORICO DI FREIBERG
Teodorico di Freiberg (in latino Vriberg), domenicano, fu studente a Parigi nel triennio 1275-1277, poi maestro a Saint-Jacques dal 1293 al 1296. Morì poco dopo il capitolo di Piacenza, verso il 1310. Teodorico si inserisce nella cosiddetta tradizione albertina. Scritti logici: De origine praedicamentalium; De quidditate entium; De natura contrariorum; De magis set minus. Scritti fisici: De tempore; De elementis; De luce; De coloribus; De iride; De miscibilibus in mixto; De intelligentiis et motoribus coelorum; De corporibus coelestibus. Scritti psicologici e gnoseologici: De intellectu et intelligibili; De habitibus. Scritti di taglio metafisico: De esse et essentia; De accidentibus; De mensuris durationis rerum; Quod substantia spiritualis non sit composita ex materia et forma; De animatione coeli. Scritti teologici: Quaestio utrum in Deo sit aliqua vis superior intellectu; De cognizione entium separatorum; De subiecto theologiae; Quaestiones de theologia all’interno di Quaestiones de philosophia. In quello che possiamo ritenere il suo primo scritto, il De origine rerum praedicamentalium, risalente al 1284 circa, Teodorico discute il problema, per lui decisivo per la fondazione della sua filosofia, della struttura ontologica dell’esistente, quale si coglie nel campo della definizione. Per il domenicano è di fondamentale importanza indagare quale sia il nesso e il senso del rapporto che lega l’intelletto che definisce e l’ordine delle cose che sono conosciute. La convinzione di Teodorico è che, affinché sia garantita la possibilità della conoscenza, si debba verificare una delle seguenti condizioni: o il pensiero umano è definito dalle cose e dalla loro natura oppure queste ultime sono determinate dal punto di vista essenziale dall’intelletto. Nella quinta sezione del De origine Teodorico giunge a sostenere la seconda eventualità sopra esposta, sebbene limitatamente ad alcuni enti rispetto ai quali ha funzione di principio causale: l’oggetto dell’intelletto non è la cosa individuale in quanto tale, ma la quiddità, espressa dalla definizione e «causata» dall’intelletto secondo la ragione formale. La quiddità è da ritenersi distinta rispetto al phantasma, universale immaginativo, prodotto dalla facoltà dell’immaginazione per determinare universali facilmente esperibili nella realtà quotidiana. La ragione quidditativa della cosa ne è invece la definizione, che l’intelletto obiettiva in modo spontaneo. L’intelletto umano fornisce dunque le strutture quidditative per la definizione razionale del mondo: è possibile quindi affermare che è proprio l’intelletto che costruisce il mondo e che ne garantisce la conoscenza razionale e logicamente rigorosa. In tale modo, sotto il rispetto quidditativo, l’ontologia sembra coincidere con la gnoseologia: potremmo cioè dire, con una certa radicalità che viene fornita dall’originalissima speculazione di Teodorico intorno a questo punto e che non ha precedenti, che essere è uguale a essere conosciuto. Per questo motivo de Libera afferma che Teodorico è il padre della «metafisica dello Spirito». Per Teodorico, come si può desumere dal De visione beatifica, l’intelletto agente è mistico: non ammette cioè mediazione estrinseca con il proprio fondamento divino. Anzi con maggior forza il domenicano giunge ad affermare vigorosamente la perfetta coincidenza dell’intelletto agente, principio intrinseco di vita e principio causale dell’anima (De visione beatifica) con il principio divino. Il vero atto dell’intellezione è opera dell’intelletto agente e va al di là della facoltà immaginativa dell’uomo, che, come si è visto non procede oltre le intenzioni universali di senso ed uso comune. Ci troviamo dunque di fronte ad una conoscenza che è esclusivamente intuitiva e spontanea: non astrattiva o discorsiva. La dottrina dell’intelletto agente, che coincide in ultima istanza con l’abditum mentis di Agostino, il ricettacolo di tutte le verità eterne (rationes aeternae) è quindi legata alla dottrina dell’illuminazione del vescovo di Ippona ed ha il proprio naturale compimento nella dottrina della visione beatifica: la coincidenza dell’intelletto agente con il suo principio divino garantisce una beatitudine che si esplica nell’unione con Dio nell’ambito della contemplazione beatifica per essentiam; anzi Teodorico arriva addirittura ad affermare che l’intellectus in actu per essentiam, è l’esplicazione creativa e spontanea della totalità, la stessa che è già racchiusa negli intelletti in atto. Spostando quindi il problema della possibilità della conoscenza razionale universale a quello sommamente teologico della beatitudine nell’aldilà, Teodorico riesce ad investire l’essere umano di una nuova dignità e a spingere alle estreme conseguenze filosofiche la tematica dell’unione intellettuale dell’uomo con Dio. In questo modo spiega la creazione dell’uomo ad immagine di Dio dando un nuovo fondamento speculativo delle possibilità insite nella dottrina dell’imago Dei, «protagonista» delle riflessioni dei Cisterciensi. Si può parlare di una vera e propria scoperta della divinità e nobiltà dell’intelletto umano, imago dell’intelletto divino. Sotto questo particolare rispetto la riflessione del magister domenicano può essere accostata a quella di un suo illustre contemporaneo, Meister Eckhart, che indica nell’uomo nobile, vero nuovo fondamento antropologico dell’umanità, l’uomo del distacco, colui che si è appunto liberato da tutte le cose create e dai loro fantasmi, approdando in tal modo nella regione dell’intelletto eterno. Accanto all’attività di teologo Teodorico seppe sempre tenere viva la propria attività di uomo di scienza, scrivendo anche opere di fondamentale importanza, come il De iride et de radialibus impressionibus. Teodorico fornì una spiegazione scientifica valida del fenomeno dell’arcobaleno, che aveva già attirato l’attenzione di Roberto Grossatesta, Ruggero Bacone e Witelo. Il domenicano tedesco riuscì effettivamente a spiegare che l’arcobaleno è il risultato della rifrazione della luce nel suo spettro di colori. Nonostante Teodorico non fosse un fisico sperimentale e non padroneggiasse le dimostrazioni scientifiche, la sua ricerca fu svolta con intenti scientifici, inserendosi pienamente nell’ambito della tradizione albertina.
MARGHERIA PORETE
A cura di Eleonora Buonocore
Di Margherita Porete, originaria della contea dell’Hainaut, nelle Fiandre, vicina al Brabante e nata forse verso il 1250/1260, sappiamo molto poco: l’unico dato certo sulla sua vita è la sua condanna al rogo per eresia (pro convicta et confessa ac pro lapsa in heresim seu pro heretica), eseguita il 1° giugno 1310 in Place de Grève a Parigi. I cronisti del tempo la definiscono pseudomulier e quindi beghina, e anche beguine clergesse e beghine en clergrie mult suffissant, ovvero una beghina colta, facendo notare anche che essa aveva tradotto le Sacre Scritture in volgare, e suggerendoci in tal modo quale dovesse essere la sua cultura e la sua grande conoscenza della teologia, come del resto possiamo capire anche dal livello della sua riflessione ad un tempo mistica e spiccatamente filosofica. La storia del processo a Margherita e al suo libro, il Miroir des simples âmes, può essere scandito essenzialmente in due momenti. Una prima volta il Miroir fu bruciato a Valenciennes, in sua presenza, al termine di un processo diocesano fatto istituire da Guido da Colmieu, vescovo di Cambrai, in un anno imprecisato del suo episcopato (1296-1306). In questa occasione il vescovo diffidò inoltre Margherita dal dare pubblica lettura del suo libro in presenza di altre persone o dal farlo leggere da altri; ella invece continuò a far circolare il proprio libro dopo averlo probabilmente riscritto. Questa grande circolazione della sua opera (nonostante la condanna per eresia, il Miroir ci è giunto in tredici mss. completi, attestanti per lo meno quattro diverse traduzioni di un leggendario ma del tutto ignoto originale piccardo, forse già tradotto dalla stessa Margherita in latino), il fatto che comunque è attestata l’esistenza di proseliti della beghina, come vedremo nel secondo momento della sua avventura giudiziaria, possono far pensare che Margherita fosse un personaggio di spicco del movimento del Libero Spirito. Margherita non solo aveva continuato a diffondere il suo libro negli anni successivi alla prima condanna, ma addirittura aveva presentato il Miroir a Giovanni di Chateau-Villain, vescovo di Chalons-sur-Marne, forte del fatto che nel frattempo aveva ottenuto l’approbatio di tre religiosi, presente solo nelle antiche traduzioni latina e italiana. I tre religiosi sono: un certo “frater minor magni nominis, vitae et sanctitatis, qui frater Johannes vocabatur”, presumibilmente (come suggerisce R. Guarnieri) Giovanni Duns Scoto, Dom Franco di Villers, monaco cisterciense appartenente all’abbazia di Villers, della cui biblioteca Margherita era probabilmente frequentatrice; il magister in theologia Goffredo di Fontaines. Giovanni di Chateau-Villain, nonostante il Miroir avesse ottenuto l’approbatio dei tre chierici, denunciò il fatto a Filippo di Marigny, amico del re Filippo il Bello, invischiato nel processo dei Templari, il quale, nel frattempo, era divenuto vescovo di Cambrai. Margherita venne consegnata nelle mani del Grande Inquisitore di Francia, a Parigi, nel 1308. La Porete non presta giuramento di lealtà, e addirittura l’Inquisitore tenterà per più di un anno e mezzo di far parlare Margherita che non mostra alcun segno di cedimento. Il processo di Margherita è strettamente legato a quello di Guiard de Cressonessart, un begardo della diocesi di Beauvais, che si definiva l’Angelo di Filadelfia ed era legato al movimento gioachimita. L’Inquisitore Guglielmo di Parigi tentò in ogni modo di concludere il processo con l’abiura della beghina, ma infine fu costretto a consultare ventuno teologi dell’Università di Parigi per fornire un fondamento credibile all’accusa di eresia. Fra questi ventuno teologi nove si erano già espressi nel processo ai Templari e sei saranno protagonisti del Concilio di Vienne (1311-1312), con cui si sancirà la condanna di beghine e begardi. Nella condanna è riportato il testo di due delle quindici proposizioni che i teologi estrapolarono dal testo e indicarono come eretiche. Una terza proposizione è riportata dall’anonimo continuatore del Chronicon di Guglielmo di Nangis. Dopo il giudizio dei teologi, Margherita ebbe, secondo la prassi, un anno per pentirsi, che trascorse all’interno del convento parigino di Saint-Jacques. Mentre Guiard de Cressonessart confessò e fu condannato al carcere a vita, Margherita perseverò nel suo silenzio e fu condannata al rogo il 31 maggio 1310; la sentenza fu eseguita il 1 giugno 1310. La Porete andò al rogo mostrando segni tanto grandi della propria dignità da commuovere fino alle lacrime molti dei presenti.
Il Miroir, che R. Guarnieri pensa essere stato scritto nel 1290, era stato condannato, al pari della sua Autrice, ad essere cancellato dalla faccia della terra: per questo tutti quelli che lo avessero posseduto lo avrebbero dovuto consegnare all’autorità, pena la scomunica, entro la festa dei santi Pietro e Paolo (29 giugno). La storia è andata in modo diverso e il Miroir ha circolato adespota fino al 1946, quando R. Guarnieri dette notizia di aver identificato in Margherita Porete l’Autrice di una versione latina del Miroir dal titolo Speculum animarum simplicium in voluntate et in desiderio commorantium. Il testo è un prosimetrum in forma di dialogo tra vari personaggi (i principali sono Amore, Anima e Ragione), che accoglie in sé temi propri dell’amore cortese e del Catarismo, ben legati a temi propri della cultura filosofica e teologica, e che ha attirato inizialmente l’attenzione di alcuni storici del pensiero filosofico e teologico medievale per l’indubbia influenza che ha esercitato su Meister Eckhart. La prima parte, la più lunga, oltre a preferire una forma dialogica e non sistematica, sembra avere una forma a spirale, come suggerisce R. Guarnieri. La seconda parte, molto più breve, è un piccolo commento ad alcuni episodi biblici. B. Garì, in un suo recente studio, suggerisce che la seconda parte abbia un carattere quasi mistagogico.
Il Miroir è scritto per gli “smarriti”, coloro cioè che sono giunti al culmine del perfezionamento spirituale e alla totale perfezione nell’esercizio delle virtù, e quindi, in una parola, al grado della contemplazione. Gli “smarriti” percepiscono tuttavia l’esistenza di un ulteriore e più alto grado da raggiungere, la possibilità di un destino speciale, del destino che Anima-Amore-Dio espongono agli “uditori” del libro. Nel dialogo serrato cui il lettore è introdotto, si tenta di esporre, attraverso la povertà di parole che sono solo umane, come più volte Margherita stessa ammette, la condizione, o per meglio dire la non-condizione, mobile e difficilmente cristallizzabile, in cui si trova l’Anima annichilata. In una scala d’ascesa a Dio, scandita in sette gradi o sette modi d’essere, la contemplazione, corrispondente alla perfezione spirituale, è rapportabile solo al quarto grado. Al termine di un percorso ascensionale che ha condotto l’anima allo stato della contemplazione, l’azione del Lontanovicino, cioè Dio-Amore, il quale si manifesta come un lampo (esclar) nel sesto stato, produce la morte dello Spirito e l’annichilazione dell’Anima, che ormai priva di desiderio, di volontà propria, di tutte le opere, viene posta al quinto stato, dove vive di vita divina, vivendo senza se stessa affatto. La successione degli stati si inverte, quasi a significare il movimento della grazia, che procede dall’alto (da Dio) verso il basso, e l’Anima recupera nell’ulteriore stato della vita divina la propria precreaturalità. La Ragione è abbandonata in favore di Intelletto d’Amore (che fa pensare a Dante e alla Vita Nuova), che produce nell’Anima una conoscenza della Divinità che travalica il limite di quella razionale discorsiva, senza però infrangerlo (supera cioè la ragione inglobandola in qualcosa di ulteriore). Per questo si rinuncia alla via affermativa e si sceglie invece la teologia apofatica e le movenze della teologia negativa per parlare di Dio, che è l’Uno, di ascendenza neoplatonica, che entra all’interno dell’uomo che si è svestito della propria creaturalità e finitezza. Spesso il linguaggio utilizzato è improntato a quello di Dionigi l’Areopagita, specialmente nel capitolo 52, in cui è chiara anche la presenza dell’immagine del fuoco che trasforma il ferro, ripresa da Bernardo di Chiaravalle (De diligendo Deo). Nel sesto stato Dio si vede nell’Anima: questo sembra porre un’importante alternativa nell’ambito della discussione sulla visio beatifica. L’Anima annichilata, che ha riconosciuto il proprio nulla ontologico rispetto al tutto di Dio, sceglie di abbandonare la volontà propria. L’Anima che si è così annichilata in Dio, che vede sprofondate, inabissate in Lui, la memoria, l’intelletto e la volontà, è ormai l’essere stesso del Serafino: non conosce più per immagini, non accoglie più nessun contenuto sensibile delle cose o delle creature. In tal maniera Margherita sembra andare al di là della posizione scolastica. L’Anima annichilata non ha in sé né timore, né desiderio, né rimorsi di coscienza, non vuole né questo né quello ed è sempre senza se stessa, pur esercitando le proprie facoltà con grande efficacia. L’Anima annichilata, in un totale abbandono delle sue facoltà naturali, giunge ad uno stato di pura attività: quella che dal punto di vista dell’esercizio dell’individualità umana sembra essere pura passività, ma che da un punto di vista divino è nient’altro che l’attività ininterrotta dell’intelletto. Dal punto di vista dell’Anima annichilata è inutile perseguire la perfezione di uno spirito che tuttavia non garantisce la possibilità della divinizzazione, perché vincola senza possibilità di fuga alle opere, all’esercizio di una virtù costrittiva, ad un rapporto con un Dio che è anch’esso contenuto dal quale potersi liberare e da cui bisogna che l’Anima infine si liberi. L’Anima annichilata giunge in tal modo allo stato di perfetta signoria e al paese dei liberi annichilati: uno stato di assoluta libertà in cui sono estromessi timore, volontà, affettività, contenuti particolari, virtù, etc. L’Anima vive e deve vivere senza nessun perché, senza nessun portato della propria individualità. L’Anima, che ha rinunciato alla volontà e compiuto il salto antropologico, vive quindi un’esperienza che si inserisce senza dubbio nell’ambito della mistica speculativa. L’Anima annichilata sarebbe tuttavia destinata al silenzio, perché lo stato dell’Anima che vive di vita divina è in realtà incomunicabile. È possibile supporre, anche sulla base di alcuni luoghi testuali, che si assista ad una sorta di moto oscillatorio fra quarto e quinto stato, fra presenza e assenza della volontà, fra attività umana e attività divina, che garantisce la testimonianza della scrittura e la possibilità della comunicazione di questa esperienza limite. Fra le fonti di Margherita Guglielmo di Saint-Thierry e l’idea dell’unitas spiritus, Bernardo di Chiaravalle, Riccardo e Ugo di San Vittore; ma anche Dionigi l’Areopagita, il Liber XXIV philosophorum, probabilmente mediato da Alano di Lilla.
PIETRO DI GIOVANNI OLIVI
A cura di Elisa Chiti
Pietro di Giovanni Olivi nacque a Sérignan (diocesi di Béziers) nel 1248 e nel 1260, all’età di soli dodici anni, entrò nel convento francescano di Béziers. Poté seguire a Parigi l’insegnamento di Bonaventura, Guglielmo de la Mare, Giovanni Pecham e Matteo d’Acquasparta. Nel 1282, come conseguenza delle disposizioni del capitolo generale di Strasburgo, si apre una certa ostilità nei riguardi dell’Olivi, esponente di spicco degli Spirituali. Nel 1287 il nuovo Ministro Generale dell’Ordine, Matteo d’Acquasparta, invia Olivi, per allontanarlo dalla polemiche seguite al capitolo, come lettore di teologia a Firenze, nello studium del Convento di Santa Croce. Rientrato in Francia Olivi riesce ad uscire indenne dal nuovo attacco sferrato contro di lui al capitolo generale di Parigi (1292) e trascorre gli ultimi anni della propria vita in una relativa serenità. Accetta e legittima la rinuncia di papa Celestino V (1294) e l’elezione canonica di papa Caetani. Muore nel 1298, circondato da grande venerazione. In un clima assolutamente anti-spirituale, Giovanni XXII condannerà la Lectura super Apocalypsim (1326). Olivi fu anche il maestro di Ubertino da Casale, presso lo studio teologico di Santa Croce. Fra i suoi scritti più importanti, oltre alla Lectura, il Commentarium in quattuor libros Sententiarum, la Summa super Sententias, i Quodlibeta, il De perlegendis philosophorum libris, l’Expositio super Regulam fratrum minorum, alcuni trattati di etica economica in cui si affronta il problema dell’usura e il Tractatus de paupertate minorum. Nella Lectura super Apocalypsim (1296), opera a carattere fortemente cristocentrico, le due maggiori fonti di ispirazione del francescano sono Gioacchino da Fiore e Riccardo di San Vittore, in cui Olivi espone la propria dottrina delle sette età e dei tre status in cui è divisa la storia della chiesa. Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente filosofico e teologico di Olivi, aspetto molto considerato dalla storiografia contemporanea, è sottolineato in particolare il suo agostinismo declinato allo scopo del raggiungimento di una sintesi o quantomeno di un accordo con posizioni aristotelico-tomistiche. Olivi è assertore della pluralità delle forme sostanziali: l’anima è formata da tre potenze (vegetativa, sensitiva e intellettiva), ma solo le prime due sono senza mediazione forma del corpo, mentre la potenza intellettiva è unita al corpo tramite le altre due potenze. Ciò potrebbe essere motivo di disgregazione dell’unità dell’anima; invece il carattere spirituale delle tre potenze ne cementa l’unità. Su questo punto si scontra con una certa decisione con la tesi di Tommaso d’Aquino: se l’intelletto non fosse infatti libero dal legame formale con il corpo, l’anima intellettiva non sarebbe in grado di intendere, non sarebbe libera di liberarsi dal corpo e in ultima istanza non sarebbe immortale. Da questa tesi sembra scaturire l’originale dottrina dell’Olivi circa la personalità umana, in cui veramente si esplica il suo neoagostinismo di matrice francescana: il primato della volontà, intrinsecamente autonoma e alla base di ogni libertà, che dà valore all’essere umano stesso. Queste riflessioni saranno alla base di alcune importanti riflessioni sulla volontà di Duns Scoto. In base all’agostinismo di Olivi ci si potrebbe aspettare, sul piano gnoseologico, una piena fiducia nella teoria dell’illuminazione; al contrario il maestro francescano sembra preferire la dottrina aristotelico-tomistica dell’astrazione, cioè di una conoscenza dal basso in alto.
MICHELE PSELLO
A cura di Elisa Chiti
Michele Psello nacque vicino a Costantinopoli nel 1018 da famiglia di medio livello sociale e per parte di padre di antico ceppo aristocratico. Il suo nome originario era Costantino, ma lo mutò in Michele quando entrò nell’ordine monastico. La madre insisté perché fosse data a Psello un’educazione superiore e nel 1041-1042 entrò a far parte dell’amministrazione, rivestì in seguito la carica di giudice a Filadelfia e riuscì infine a divenire segretario imperiale. Nel 1043 divenne il segretario personale di Giovanni Monomaco. Psello rivestì in seguito la carica di «console dei filosofi» nell’Università secolare. Psello divenne presidente del senato all’ascesa dell’usurpatore Isacco Comneno e da questa posizione a lui favorevole si oppose a Michele Cerulario. Alla morte di Isacco Comneno, Psello favorì l’ascesa di Costantino Duca e divenne il precettore dei futuri regnanti, fra cui Michele Duca (1071-1078), suo allievo. Nel 1078 Niceforo III Botaniate lo estromise dalla vita di corte e lo costrinse a ritirarsi in monastero. Psello morì probabilmente verso il 1096-1097. La produzione di Michele Psello è molto vasta: la sua produzione oratoria, di carattere prevalentemente encomiastico, comprende due panegirici per Monomaco. Importante è la sua opera Sinossi delle leggi, miscellanea in versi di norme legislative. La Cronografia è senza dubbio l’opera pselliana più importante: sette libri di storia che coprono il periodo che va dal regno di Basilio II (976-1025) a quelli di Romano III e Michele VII. Fra le sue opere filosofiche le più importanti sono le due che riguardano l’anima: il trattato De anima e la Psicogonia platonica, in cui Psello cerca di applicare i metodi numerici e armonici nel tentativo di spiegare la formazione dell’anima. Altre opere importanti dal punto di vista filosofico furono anche i Commentarii al Timeo di Platone e al De interpretatione e alla Fisica di Aristotele, oltre che agli scritti di Porfirio. Importanti anche il De omnifaria doctrina e gli scritti sugli Oracoli caldaici.
Psello ricerca l’uniformità dell’anima nelle sue partizioni (vegetativa, sensitiva e razionale), e tale problema è legato alla consustanzialità divina, non accontentandosi della spiegazione della fruizione del corpo da parte dell’anima. La soluzione di Psello è molto complicata: l’anima è una sostanza, ma dal momento che si può scindere nelle sue facoltà è divisibile, e nel contempo, considerata separatamente da questa divisione è indivisibile. In questo modo l’anima si trova ad essere intermedia fra due estremi: gli enti intelligibili e quelli sensibili. Uno dei punti di maggiore difficoltà della filosofia di Psello è senza dubbio il problema del raffronto fra Dio in quanto Unità e Dio in quanto Trinità, che viene raffrontato con la prima triade enadica di Proclo. Per evitare distinzioni fra le Tre Persone, Psello fa procedere dal Padre lo Spirito Santo, al pari del Figlio. Il Padre è così incausato e il Figlio e lo Spirito Santo hanno pari dignità, ma la superiorità del Padre è in realtà sottolineata solo nel momento i cui si cerca di sottolineare il movimento di riconversione delle due ipostasi causate nel principio sostanziale dell’Unità divina. Accettando la creazione Psello è costretto ad abbandonare il modello cosmologico emanatistico neoplatonico: il mondo è creato e vincolato a generazione e distruzione. Molto importante è anche la demonologia del filosofo bizantino, con la sua ampia divisione in demoni intellettivi, secondo l’intelletto, razionali, razionali ed irrazionali secondo l’essenza, materiali e punitivi. I demoni sono ovviamente quelli di ascendenza platonica, e anche in questo caso rivestono un ruolo intermedio fra mondo umano e divino.
ULRICO DI STRASBURGO
A cura di Elisa Chiti
Ulrico di Strasburgo, o di Engelbrect, (m. 1277), domenicano strasburghese autore di un’opera intitolata Summa de bono, attese all’elaborazione di un possibile sviluppo della filosofia di Alberto Magno (una sorta di contaminazione fra la concezione dell’universo di Dionigi l’Areopagita e la concezione di stampo neoplatonico rielaborata da Avicenna). Il De summo bono, o Summa de bono segue da vicino la struttura del commento albertino al De divinis nominibus dionisiano, almeno limitatamente ai primi due libri. Nell’opera teologica del domenicano strasburghese, tuttavia, è possibile rintracciare anche la presenza di certe argomentazioni di ascendenza aristotelica. L’intento dell’opera è quello, ispirato alla Elementatio theologica di Proclo, di rinnovare, o per meglio dire rifondare, le regole su cui si basano le dimostrazioni della scienza teologica, attraverso il successivo ricorso alla teologia assiomatica cui avevano dato vita due maestri del XII sec.: Alano di Lilla e Nicola di Amiens. La teologia per Ulrico deve muovere da principi del tutto auto evidenti e fondati essenzialmente sul ragionamento. Il principio su cui si può reggere la scientificità della teologia è l’identificazione della verità con la divinità. Ulrico fa propria la concezione avicenniana delle intelligenze separate e attribuisce alle intelligenze motrici delle sfere celesti il compito di comunicare alla materia le successive forme, in un fluxus che segue il movimento di derivazione degli esseri da Dio. L’influenza del Liber de causis e del Neoplatonismo è evidente, come nel più tardo Bertoldo di Moosburg, nell’equivalenza di creazione ed illuminazione della prima causa, pura luce formale ed intellettuale. Per Ulrico, che dichiara apertamente di conoscere il Liber de causis sotto tale rispetto, la prima delle cose create è l’essere. L’essere è diverso da quello puro di Dio, che lo precede ed è in niente mescolato al non-essere. L’essere creato è infinito in potenza rispetto alle altre cose, ma assolutamente finito rispetto a Dio, e reca in sé gli inizi della molteplicità, da riconoscersi nello scarto concettuale fra sostanza e accidente. L’essere creato è poi allo stesso tempo la forma prodotta dall’intelletto divino, e per questo motivo un’intelligenza, allo stesso tempo sostanza intellettuale e atto d’intelligenza, potenzialità infinita, nel mutuo coincidere di essere, forma e luce, che descrive nel fluxus un successivo movimento illuminativi della creazione del molteplice. La diffusione della prima luce è mediata dalle intelligenze o angeli. L’atto della creazione risulta in tal modo anche un processo illuminativo che può essere ripercorso nell’atto della conoscenza. I risultati speculativi raggiunti all’interno del pensiero di Ulrico anticipano in una certa misura quelli che saranno gli esiti ancora più radicali della mistica speculativa.
GIOVANNI PECKHAM
A cura di Michela Pereira
Giovanni Peckham (o Pecham) fu uno dei più rappresentativi filosofi inglesi della seconda metà del XIII secolo. La sua biografia è scarsamente documentata, ma sappiamo che fu reggente di teologia a Parigi e lettore nello studio francescano di quella città negli anni 1269-72, essendo nata a Patcham, nel Sussex, probabilmente attorno al 1230. Aveva studiato arti ad Oxford verso la fine del decennio successivo, ed era poi entrato nell’ordine francescano, recandosi a Parigi per gli studi teologici. Agli anni parigini risalgono diversi commenti biblici, il commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e forse il Tractatus de anima. Sempre in questo periodo Giovanni Peckham fu un personaggio di spicco nel fronte dei teologi conservatori che si opponevano all’insegnamento di Tommaso d’Aquino. La sua posizione, tipicamente francescana, si colloca sul percorso di elaborazione interno all’Ordine a partire dalla posizione di Bonaventura, e la sua critica a Tommaso precede quella di Duns Scoto. Punto centrale del dibattito con Tommaso, contro il quale era ancora impegnato negli anni ’80, dopo la morte dell’Aquinate, fu il tema dell’unicità della forma sostanziale, cui Peckham contrappose l’adesione all’ilemorfismo e alle dottrine psicologiche e gnoseologiche della tradizione agostiniana (dualismo anima/corpo, dottrina della conoscenza per illuminazione). Fu un maestro di notevole successo, ma non sviluppò dottrine di particolare originalità o rilievo.
Verso il 1271-72 tornò ad Oxford, come lettore dello studio francescano. Gli interessi scientifici, che nell’università inglese erano profondamente radicati e avevano conosciuto uno sviluppo notevole con l’insegnamento di Roberto Grossatesta, cessato nel 1235, offrivano uno spazio all’attenzione di Giovanni Peckham per l’astronomia e l’ottica, testimoniati dai suoi scritti scientifici (Perspectiva communis, Theorica planetarum, Tractatus de sphaera, Tractatus de numeris), oltre che dalla quantità di materiali scientifici inclusi nel Tractatus de anima, e nelle due raccolte di questioni antropologiche (Quaestiones de anima, Quaestiones de beatitudine corporis et animae). In queste opere Peckham mostra di subire un forte influsso delle ricerche di Ruggero Bacone, con cui aveva sicuramente avuto contatti negli anni ’60 a Parigi. Nel 1277 fu chiamato come maestro di teologia alla curia papale e nel 1279 venne nominato arcivescovo di Canterbury. Morì nel 1292.
GIOACCHINO DA FIORE
A cura di Elisa Chiti
Gioacchino da Fiore nacque in Calabria nel 1145. Dal 1191 fu abate del chiostro da lui fondato in San Giovanni in Fiore e qui morì nel 1202. Venne collocato da Dante nel cielo del Sole per la sapienza del suo spirito profetico. Gioacchino scrisse tre grandi opere per molti versi complementari: Concordia Novi et Veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim, Psalterium decem chordarum. Scrisse anche uno scritto teologico polemico contro Pietro Lombardo, oggi perduto, il De unitate seu essentia Trinitatis; uno scritto contro gli ebrei, l’Adversus Iudaeos; il De articulis fidei; i Tractatus super quattuor Evangelia. È discussa l’autenticità del Liber figurarum, un albo composto di figure e grafici. A partire da una rigorosa esegesi del testo biblico, Gioacchino formulò una filosofia della storia imperniata sulla corrispondenza delle tre età della Storia alle tre persone della Trinità. Elementi analoghi alla visione gioachimita della storia sono presenti anche nelle visioni di Ildegarda di Bingen, strutturate su una ossatura biblica profetica e apocalittica; e, come gli scritti di Ildegarda, anche quelli di Gioacchino sono caratterizzati dalla presenza di immagini e diagrammi non puramente esornativi, ma indispensabili per cogliere il significato più profondo delle sue intuizioni. Secondo Gioacchino da Fiore all’era del Padre, caratterizzata dalla rigidità della Legge veterotestamentaria, è succeduta quella del Figlio, “l’era media” contrassegnata dalla centralità della Chiesa romana; ad essa succederà l’età dello Spirito, i “tempi nuovi” in cui il mondo sarà trasfigurato dalla venuta dello Spirito della gioia. Il succedersi delle ere è indipendente dai comportamenti degli uomini, che possono soltanto cogliere i segni dei tempi e adattarsi ad essi: è del resto lo stesso piano di Dio che porta gli uomini dallo stato animale a quello psichico a quello pneumatico o spirituale. Il segno dell’età dello Spirito che viene saranno proprio gli “uomini nuovi”, di fronte ai quali la Chiesa proverà un invincibile terrore; gli sconvolgimenti descritti nell’Apocalisse segneranno il momento del passaggio. Secondo la tradizione semitica, lo Spirito Santo corrisponde al principio femminile di Dio. Questo aspetto in qualche misura traspare anche nell’accostamento operato a Chartres dello Spirito Santo con l’anima del mondo e la natura, e nell’esegesi di Gen. I, 2, “sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio”. Nel Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti, Gioacchino precisa il suo punto di vista: modifica la visione della storia trasmessa da Agostino alla teologia medievale. La teoria agostiniana proponeva un’interpretazione cristocentrica della storia. Il monaco florense la rifiuta a favore di quella trinitaria che implica una trasformazione del ruolo della gerarchia ecclesiastica e della funzione dei sacramenti e della Bibbia. La nuova chiesa che Gioacchino attende è l’Ecclesia spiritualis. Le dottrine di Gioacchino da Fiore vennero condannate in quello stesso Concilio Lateranense del 1215 che stabilì l’impossibilità di creare nuovi ordini monastici e impose l’obbligo della clausura alle donne che abbracciavano la vita religiosa. Dopo la morte furono attribuiti a Gioacchino molti commenti esegetici, profezie e vaticini. Fra questi è piuttosto noto il Tractatus super Hyeremiam, risalente al 1230 circa e proveniente da ambienti florensi o francescani. La dottrina di Gioacchino diede vita ad un vasto movimento denominato gioachimismo, che ebbe seguito soprattutto fra i francescani spirituali, specialmente Gerardo di Borgo San Donnino, Pier di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale che si ispirarono all’abate per delineare i caratteri della “terza età” nella storia della salvezza caratterizzata dalla piena e rigorosa attuazione della regola francescana in opposizione con la chiesa corrotta. Altri temi propriamente gioachimiti quello del papa angelico e dell’imperatore degli ultimi tempi, che ha il ruolo di unire il mondo.
FRIDEGISO DI TOURS
A cura di Manuela Sini
Di origine anglosassone, intorno al 796 Fridegiso di Tours accompagnò Alcuino, di cui fu discepolo, alla corte di Carlomagno, dove fu maestro alla scuola palatina. Seguì Alcuino all’abbazia di Saint-Martin di Tours, della quale divenne abate nell’804, succedendo al maestro. Fu in seguito abate di Saint-Omer e Saint-Bertin e dall’819 cancelliere di Ludovico il Pio fino all’834, anno della sua morte. L’unico dei suoi scritti ad esserci pervenuto è il De substantia nihili et tenebrarum (o Epistula de nihilo et tenebris ad proceres palatii). Agobardo di Lione nel Contra obiectiones Fridegisi abbatis liber dà notizia di altri testi scritti da Fridegiso, di cui uno in cui si sosteneva la preesistenza delle anime. Dall’800 all’860 la questione della natura del nulla e delle tenebre che Agostino aveva sollevato nel De Ordine e nel De Genesi fu molto dibattuta tra i maestri della scuola palatina, mettendone in luce gli interessi logici e grammaticali nel metodo utilizzato per l’argomentazione. Nel De substantia nihili et tenebrarum Fridegiso pone la questione del nulla domandandosi non se il nulla esista bensì se consista in qualcosa e, eventualmente, se sia possibile indagare sulla natura di questo qualcosa. Per provare e sostenere la consistenza del nulla Fridegiso fa ricorso alla grammatica, una delle arti liberali, in particolare al modo in cui i grammatici definiscono il nome. Poiché ogni nome finito significa qualcosa di finito, si deduce che ciò valga anche per il nulla. L’argomentazione procede con la definizione del nome quale vox significativa (il nome che nomina una cosa si distingue dalla significazione, che media fra i due); ogni significazione si riferisce a ciò che significa. Da ciò Fridegiso deduce che il nulla esiste, ed è qualcosa. Altra questione è il sapere e il dire in cosa questo qualcosa consista, argomentazione per la quale Fridegiso invoca l’autorità delle Sacre Scritture, in particolare il racconto che della creazione si dà nel Genesi, secondo il quale tutto ciò che è creato da Dio è creato dal nulla. Ora, questo nulla è distinto dalla materia informe come dalla causa primordiale delle cose. La conclusione è che non può essere conosciuta la natura del nulla, anche se questa deve essere qualcosa di grande e chiarissimo, dal momento che da esso Dio ha fatto le più grandi creature, cioè gli angeli e gli uomini. Diversamente dal nulla, Fridegiso considera le tenebre come qualcosa di creato. Qui il suo procedimento chiama in causa il come e il perché i nomi siano stati imposti alle cose create: i nomi significano dei referenti la cui realtà non può essere messa in discussione; da tale definizione deriva che un soggetto dichiara una sostanza. L’oscurità, di cui Fridegiso segue le tracce attraverso tutte le Scritture Sacre, deve essere quindi qualcosa di materiale e corporeo, e possedere dunque delle dimensioni spaziali.
GIOVANNI (IAN) HUS
A cura di Lidia Lanza
Nato probabilmente nel 1369, Giovanni (Ian) Hus svolse la sua attività di predicatore e teologo negli anni del regno di Carlo I (1346-78), imperatore con il nome di Carlo IV, caratterizzati, in particolare a partire dal 1382 (anno in cui Anna, sorella del re, sposò Riccardo d’Inghilterra) da un intensificarsi dei contatti intellettuali, oltre che diplomatici, tra Boemia e Inghilterra. Importante centro politico dell’impero e in contatto, come tale, anche con la sede pontificia di Avignone, Praga diveniva anche, in quegli anni, sede arcivescovile e sede universitaria, e, pertanto, luogo di incontro e di scambio tra professori e studenti provenenti dalle altre università europee. Hus vi svolse la sua prima formazione: studente dal 1394, venne eletto decano della Facoltà delle Arti nel 1401; baccelliere in teologia nel 1404, fu nominato rettore nel 1409. Praga era anche teatro di un movimento di riforma religiosa, che si intensificò a partire dal 1378, anno del Grande Scisma, e trovò il suo centro propulsore nella cappella di Betlemme, di cui Hus divenne rettore (1402). Risale all’anno del baccellierato in teologia l’inizio del commento alle Sentenze di Pietro Lombardo. Nel 1405 redige i suoi commenti alla Bibbia, organizzati secondo una struttura che ai vari concetti fa seguire i passi biblici che li illustrano e un’interpretazione che tende a comporre gli eventuali derivanti dalla Scrittura. Hus manifesta la sua adesione alle teorie espresse da Wyclif sin dal commento alle Sentenze, opera in cui, accanto ad una dottrina teologica tradizionale, compaiono le proposizioni fondamentali del realismo propugnato da Wyclif, che Hus adotta contro l’orientamento terminista e nominalista che prevaleva alla facoltà teologica. I legami dottrinali tra i due non sono, tuttavia, univoci. Innanzitutto, Hus non possiede un sostrato metafisico analogo a quello sotteso alla riflessione di Wyclif. Quanto alla riflessione teologico-ecclesiologica, è possibile ravvisare alcune differenze tra i due pensatori. È il caso, per non citare che un esempio, della dottrina eucaristica: nonostante le accuse mossegli dalle autorità ecclesiastiche, la sua interpretazione in proposito resta, dal commento al IV libro alle Sentenze sino al De coena Domini, scritto quando era prigioniero a Costanza, nell’ambito dell’ortodossia. L’influsso di Wyclif sulla riflessione e l’opera di Hus è di ordine pratico più che teorico: è infatti nella sua attività di predicatore e di riformatore della chiesa boema che Hus manifesta a pieno il suo debito nei confronti delle idee espresse da Wyclif. Di questi egli condivide la denuncia dello stato in cui versava, in quegli anni, l’istituzione ecclesiastica, esponendosi in difesa delle tesi wycliffite condannate a Praga. La condivisione, pur non incondizionata, delle teorie e delle istanze riformatrici di Wyclif, unita alla intransigenza della sua opera riformatrice e alla veemenza delle sue prediche, pronunciate in lingua ceca, gli alienarono le simpatie del clero boemo e dell’università: alla scomunica comminata dall’arcivescovo di Praga contro quanti manifestano una condivisione delle idee di Wyclif (1409) segue la decisione dello stesso di mandare pubblicamente al rogo i libri di Wyclif, nel quale si riconosce la matrice delle idee dei riformatori e di Hus. Colpito da scomunica nel 1412, Hus è costretto a lasciare Praga. Avendo rifiutato di ritrattare le proprie posizioni, a suo giudizio conformi a quanto tràdito dalla Sacra Scrittura, è condannato come eretico al rogo (1415). La sua critica allo stato in cui versava in quegli anni l’istituzione ecclesiastica trova espressione in numerose opere, sia in ceco che in latino. Bersaglio della sua opera di polemista e, in maniera ancora più diretta e veemente, dei suoi sermoni, è la corruzione delle istituzioni ecclesiastiche: la pretesa che vuole l’operato del clero insindacabile da parte dei fedeli laici, da queste asserita, è rifiutata con decisione da Hus. Il trattato De ecclesia manifesta con estrema lucidità la dicotomia esistente tra la chiesa istituzionale e la comunità dei cristiani uniti dal vincolo della fede, la preghiera e l’osservanza dei precetti divini. Solo questa chiesa, che Hus, seguendo Wyclif, chiama universitas praedestinatorum, è santa e cattolica e riunisce nel corpo mistico di Cristo i veri credenti. In maniera più accentuata rispetto a Wyclif, Hus ritiene che solo la condotta e le azioni rivelano chi è parte della comunità dei predestinati: solo costoro possono essere a buon diritto considerati vescovi o pontefici. Quanti occupano indegnamente una carica, a qualunque grado della gerarchia appartengano – ivi compresa la suprema autorità di tale gerarchia, il pontefice – non possono essere considerati detentori legittimi della carica che detengono, né veri cristiani: è lecito e doveroso, in questi casi, disobbedire a costoro e deporli dalla carica che rivestono. Supporta tale considerazione la convinzione che l’autorità pontificia è un’istituzione umana, che Hus, così come Wycliff, vede come contingente e temporale, sottolineandone la storicità e, in ultima analisi, l’inessenzialità. La condanna al rogo come eretico ha contribuito ad alimentare l’immagine di Hus eroe della rivolta boema, nella quale ampio spazio avevano rivendicazioni di carattere nazionale; nonostante le repressioni e le dissensioni tra le varie correnti, il movimento hussita si consolida, sino a giungere all’elezione a re di Boemia di un suo esponente, Giorgio Podedraj.
ALESSANDRO DI HALES
Alessandro di Hales, primo maestro francescano presso l’Università di Parigi, nacque a Hales (nei pressi di Gloucester) intorno al 1170-1180. Dal 1238 in poi, Alessandro cedette la cattedra al suo allievo Giovanni de la Rochelle. Morì il 15 agosto del 1245. Il suo nome resta legato alla poderosa opera Summa theologica: nell’Opus minus, Ruggero Bacone sostiene che i Frati Minori “gli hanno attribuito questa grande Summa di enorme peso e non fatta da lui, bensì da altri”. Bacone ha ragione e, insieme, torto: la Summa di Alessandro è infatti sicuramente frutto di una compilazione, ma non estranea ad Alessandro. Dal momento che Bonaventura la cita nel Preambolo alla seconda parte del suo Commento alle Sentenze, la Summa di Alessandro doveva esistere già intorno al 1250. Non sappiamo comunque a quando risalga di preciso. Per quel che possiamo ricostruire a partire da quell’opera, il pensiero di Alessandro si ispirava alla teologia agostiniana, impiegata però per risolvere alcuni nodi problematici che si erano imposti con la scoperta di Aristotele. Se dunque non possiamo sapere in cosa consistesse effettivamente il contributo filosofico di Alessandro, è comunque lecito ammettere che tra i suoi principali meriti vi fu quello di dare il primo impulso al gruppo dei teologi francescani ad assimilare il nuovo sapere filosofico con l’aiuto dei principi posti da Agostino di Ippona. Il pensiero di Alessandro fu proseguito – come si è detto – dal suo successore, Giovanni de la Rochelle, che morì l’8 febbraio del 1245. Forse allievo, sicuramente amico, di Roberto Grossatesta, Alessandro è rimasto famoso soprattutto per la vasta Summa theologica, che costituì un testo di riferimento importante per il pensiero teologico francescano, essendo prevalentemente una compilazione ispirata al pensiero di Agostino e dei Vittorini. Poiché – come si è detto – è forgiata sulla base di varie fonti, è difficile estrapolare dalla Summa il pensiero genuino di Alessandro. Egli è tuttavia autore di un commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, opera profondamente influenzata dall’agostinismo e solo a tratti dall’aristotelismo. La scelta di insegnare teologia attraverso un commento e non più direttamente sulla Bibbia accese una dura polemica ad Oxford, i cui maestri seguirono infine l’esempio di Alessandro, contrariamente alle direttrici del vescovo Roberto Grossatesta. Alessandro seguì in alcuni aspetti la cosiddetta metafisica della luce. Fra i suoi allievi più famosi si ricorda, oltre al già menzionato Giovanni della Rochelle, Bonaventura da Bagnoregio, che ebbe nei confronti del suo maestro una sincera e profonda venerazione.
GIOVANNI DE LA ROCHELLE
Successore di Alessandro di Hales, dal 1238, all’Università di Parigi, Giovanni de la Rochelle morì il 15 agosto del 1245. Egli fu autore di numerosi scritti teologici (Summa de virtutibus, Summa de vitiis, Summa de articulis fidei, Summa de anima): mostrando uno spiccatissimo spirito filosofico, egli si oppose a quanti a quel tempo volevano limitare lo studio e l’esercizio della filosofia, e attribuì quell’ostilità verso il sapere filosofico all’intervento dello stesso Satana (che non vuole che i Cristiani siano dotti). Giovanni de la Rochelle introduce la distinzione tra tre facoltà, seguendo l’apocrifo agostiniano De spiritu et anima: l’intelletto conosce gli intelligibili creati (angeli, anime), l’intelligenza conosce il vero e il bene immutabile, vale a dire Dio. Ispirandosi anche all’insegnamento di Avicenna, egli cerca di mettere in relazione la dottrina dell’intelletto agente con la dottrina agostiniana dell’illuminazione divina sulla base di un aristotelismo alquanto eclettico. L’intelletto agente per Giovanni è come la luce intellegibile di Dio stesso, sempre in atto nell’anima umana. In tal modo ogni uomo possiede un intelletto agente, che è come l’impronta di Dio nel singolo uomo. Anche gli angeli e Dio sono concepiti come intelletti agenti, superiori agli intelletti agenti dell’anima di ciascun uomo, ma in stretta relazione con essi in quanto capaci di illuminarli alla conoscenza delle cose superiori e divine. Le sensazioni sono per Giovanni il risultato dell’azione esercitata dai corpi sugli organi, in virtù della mediazione dell’ambiente fisico che è per la vista il trasparente, per l’udito l’aria, per l’olfatto i vapori esalati dagli oggetti, per il gusto la saliva, per il tatto la carne. I dati di questi sensi particolari sono accentrati nel “senso comune”, che li conserva e li coniuga per formare i “sensibili comuni” (comuni a parecchi sensi), come grandezza, movimento, riposo, numero, ecc. Il senso comune – chiamato “sensus formalis” da Avicenna – è un senso interno. Per liberare da queste immagini specifiche o comuni le nozioni astratte, occorre l’intervento della “facoltà intellettiva” (virtus intellectiva), che non dipende da alcun organo particolare ma è tutta presente per intero nel corpo umano: “est in toto corpore tota”, dice Giovanni. L’astrazione non sta nel separare realmente gli elementi costitutivi dell’oggetto, ma nel considerarli separatamente, grazie a una “valutazione” (aestimatio) che li distingue gli uni dagli altri raggruppando le somiglianze e sopprimendo le differenze, ma senza disgiungerle del tutto dal sensibile. L’“illuminazione” agostiniana veniva per questa via compatibilizzata, in certa misura, con la dottrina arabo-aristotelica dell’“intelletto agente” (nous poietichòs): infatti, per Giovanni, l’intelletto si divide in intelletto in potenza rispetto agli intelligibili come una tavoletta sui cui non è ancora stato scritto nulla e in intelletto agente, che nella nostra anima è come la luce intelligibile di Dio stesso, sempre in atto. Ciascuna anima umana, individualmente considerata, ha un suo intelletto agente, che le è proprio e che è in essa il suggello di Dio sulla sua opera. Tale intelletto è la facoltà più alta dell’anima: “intellectus agens, id est vis animae suprema”, scrive Giovanni. Egli ammette la possibilità di più intelletti agenti separati, e lo fa per rendere compatibile con il Cristianesimo una dottrina originariamente non-cristiana: è un intelletto agente separato ogni sostanza spirituale distinta dall’anima, superiore ad essa e capace di agire su di essa per darle dall’esterno conoscenze che essa non potrebbe guadagnare con la luce naturale del suo intelletto agente. Gli angeli e Dio possono dunque essere intesi, per Giovanni, come tanti intelletti agenti: gli angeli istruiscono l’uomo su ciò che riguarda gli angeli, e Dio su ciò che ha a che fare con le verità sovrannaturali – come la Trinità –, riguardanti il solo Dio.
ALMARICO DI BÉNE
Almarico di Béne – diocesi di Chartres – fu professore di logica e di teologia a Parigi. Morì nel 1206 o nel 1207 e fu accusato, quand’era ancora in vita, di insegnare dottrine pericolose. La prima condanna ufficiale di cui sappiamo risale però al 1210. In quel momento, esisteva già un nutrito gruppo di “almariciani” (amauriciani), seguaci fedeli di Almarico, le cui dottrine vennero censurate dall’autorità ecclesiastica. Il problema nasceva da un’asserzione di Almarico, secondo quanto ci ricorda Enrico di Susa: Almarico “disse che Dio era tutto” (dixit quod Deus erat omnia), spiega Enrico di Susa. La formula era derivata da Scoto Eriugena, autore tornato in voga in quel periodo: Dio è l’esse omnium, a questo si riduceva tale formula, che poteva però essere intesa sia nel senso “causale” in cui la intendeva San Bernardo (Dio è causa di tutto), o nel ben più pericoloso – di marca panteistica – senso per cui l’essere di Dio coinciderebbe con quello di tutte le cose. Non sappiamo come effettivamente intendesse Almarico quell’asserto: quel che sappiamo è che egli fu accusato di intenderlo come Eriugena, risolvendo Dio nell’essere delle cose, in maniera pienamente panteistica. In effetti, alcuni suoi seguaci “almariciani” impressero una curvatura spiccatamente panteistica a quella posizione: così, Bernardo – allievo fedele di Almarico – poteva direttamente argomentare che tutto è uno, in quanto tutto ciò che è, è Dio. Ma simili posizioni, per quel che sappiamo, non sono presenti in Almarico. Pare tuttavia che egli abbia accettato la teoria di Eriugena delle “teofanie”: anche questo aspetto, comunque, non prova nulla, dato che non sappiamo quale effettivamente fosse l’interpretazione che Almarico ne dava.
EIRICO DI AUXERRE
Eirico di Auxerre (841-876) fu monaco dell’abbazia benedettina di Saint-Germain. Ins seguito, studiò ad Auxerre, a Ferrières, sotto la guida di Servato Lupo, successivamente a Laon, dove come maestro ebbe l’irlandese Elia. Eirico fu un poeta latino: a lui dobbiamo una ricca raccota di autori classici e numerosi commenti grammaticali, di grande importanza. In qualità di maestro di dialettica, Eirico ci ha lasciato alcune glosse all’apocrifo agostiniano Categoriae decem e gliene sono state attribuite altre al De dialectica di Agostino, al De interpretatione di Aristotele e all’Isagoge di Porfirio. È interessante il fatto che Eirico intendesse le Categoriae decem non come una traduzione letterale, ma come un libero adattamento delle Categorie di Aristotele svolto dallo stesso Agostino. Oltre ad Agostino e ad Aristotele, tra gli autori che hanno esercitato una maggiore influenza su Eirico non va dimenticato Scoto Eriugena, dal quale viene desunta la nozione di “natura”, come emerge nitidamente da un estratto pubblicato a Hauréau. Natura è, secondo la lezione eriugeniaa, tutto ciò che è e ciò che non è, compreso ciò che sta al di là della conoscenza sensibile (dunque Dio stesso). L’“essere” è per Eirico ogni essenza semplice e immutabile creata da Dio, come Animale (il genere animale) e gli elementi semplici. Ciò che è costituito dai quattro elementi, va incontro al processo di dissoluzione, muore e i suoi stessi elementi si risolvono nella totalità da cui derivano. La lezione di Scoto Eriugena è massicciamente ereditata da Eirico. Egli rigetta il realismo dei generi e delle specie. Gli universali sono soltanto dei nomi che consentono al pensiero, affollato dalla moltitudine indistinta degli individui singoli, di riassumerli sotto termini la cui comprensione è sempre più ristretta e l’estensione sempre più larga: cavallo (specie), animale (genere), essere infine, che racchiude tutto.
REMIGIO DI AUXERRE
Remigio di Auxerre (841-908) fu il più celebre tra gli allievi di Eirico di Auxerre (841-876). Dal maestro, ereditò la cattedra ad Auxerre, e successivamente venne chiamato a insegnare a Reims e a Parigi, compiendo quella che può essere a tutti gli effetti etichettata come una “carriera brillante”. La sua opera di grammatico fu di grandissimo rilievo: essa consta di commenti alle grammatiche di Donato, di Prisciano, di Foca, di Eutiche, e di numerosi poeti, in particolare di Persio e di Giovenale. In qualità di teologo, Remigio compose delle profonde analisi della Genesi e dei Salmi, rivelando l’influenza di Ambrogio di Milano (In Exaemeron) e di Agostino di Ippona. In veste di filosofo, Remigio compose nel 901-902 le glosse marginali alla Dialectica dello pseudo-Agostino, che un tempo venivano abitualmente attribuite a Eirico. Compose inoltre un importante commentario a Marziano Capella, risalente sempre intorno al 901-902. Infine, scrisse diversi commentari, agli Opuscula e alla Consolatio philosophiae di Boezio. Come già su Eirico, anche su Remigio è decisiva l’influenza teorica di Scoto Eriugena: a tal punto che in origine i commenti di Remigio agli Opuscula di Boezio vennero attribuiti a Eriugena stesso. Il commentario a Marziano Capella rivela una forte influenza platonica.
PIER DAMIANI

Biografia
Pier Damiani nacque a Ravenna nel 1007. Ebbe un’infanzia dura e dolorosa, come ci narra il suo biografo S. Giovanni da Lodi, ma non è facile riconoscere quanto vi sia di vero nel suo racconto fortemente mitizzato. Affidato dapprima alle cure di una donna che viveva nella casa di un prete, fu raccolto, essendo rimasto presto orfano, da un fratello, ma non è sicuro che per questo abbia preso, in segno di riconoscenza, il cognome Damiani. Studiò a Ravenna, poi a Faenza e a Parma e, fra i suoi maestri, cita un prete di nome Mainfredo e Ivo di Chartres. Iniziò la sua attività come professore nelle arti del trivio e del quadrivio, ma alcuni fatti, in cui egli vide la mano di Dio, lo persuasero a cambiare vita. Verso il 1035 entrò nell’eremo di Fonte Avellana, fondato poco prima del Mille e molto noto nel Medioevo. La sua personalità si impose subito in quel piccolo gruppo di eremiti e nel 1043 venne eletto priore. Tre anni dopo assiste all’incoronazione imperiale di Enrico III a Roma ed entra in rapporti con l’ambiente di corte. I suoi successivi contatti furono numerosi e cordialissimi: si recò più volte in Germania, l’imperatrice Agnese fu sua penitente e tentò di trattenere Enrico IV dal divorzio con Berta. Dal 1050 in poi, Damiani partecipò alla riforma ecclesiastica collaborando con gli scritti e con l’intervento personale all’energica azione riformatrice iniziata da Leone IX . Questo papa lo nominò priore del convento di Ocri e, almeno per i primi anni, intrattenne con lui un buon rapporto di amicizia. Anche sotto i pontificati di Stefano IX, di Niccolò II e di Alessandro II, Damiani godette di una posizione di primo piano tanto da venir creato, nel 1057, cardinale e vescovo di Ostia, ma Stefano IX era stato costretto a minacciarlo di scomunica per fargli accettare quella carica. In tali uffici assolse varie incombenze (ambasciatore papale a Cluny, paciere a Milano, a Firenze e in altre città) ma la vita di curia non era adatta a lui, carattere troppo aspro e spirito troppo indipendente. Dopo molte insistenze, sempre respinte, verso il 1067 ottenne finalmente di poter rinunciare all’episcopato e ritornò al chiostro, pur continuando a dare il suo aiuto nella riforma della Chiesa. Poco prima che il suo amico Ildebrando salisse al trono papale, Pier Damiani moriva il 22 febbraio 1072 a Faenza, dove fu sepolto nella chiesa di S. Maria fuori porta.
Pier Damiani fu, dunque, innanzi tutto, un monaco, maestro di vita religiosa e soprattutto di vita eremitica, sull’esempio di S. Romualdo di cui scrisse anche la biografia. Le sue opere, specialmente quelle dirette ai monaci, sono piene di concetti di quella “dottrina dell’eremo” – come la chiama Palazzini – formulata da Damiani stesso e rimasta poi classica: il monastero è una preparazione all’eremo, cui tutti i monaci dovrebbero tendere, come più alta forma di vita religiosa.
Un altro aspetto della figura di Damiani è delineato dal Blum che lo ha definito “consigliere dei Papi”; fu questo, infatti, il suo compito principale nella vita pubblica del periodo pregregoriano.
Damiani era afflitto dai mali della Chiesa, di cui condannò molto energicamente le manifestazioni più palesi, le cosiddette “piaghe del secolo”: la simonia e il nicolaismo. Durante la prima metà dell’XI secolo, nel periodo in cui Damiani era priore di Fonte Avellana, ben otto papi avevano occupato successivamente, e a volte si erano disputati, la sede apostolica. Dopo la morte di Silvestro II (1003), con cui sembrava iniziato un periodo di riforma, la situazione era di nuovo precipitata nell’antica corruzione e il papato era diventato appannaggio delle grandi famiglie aristocratiche. Essendo stato, quindi, spettatore di questi anni agitati e profondamente corrotti, Damiani comincia ad agire in prima persona scrivendo ed incontrando i pontefici. Iniziò con Gregorio VI, il primo papa che sembrò far sperare al mondo l’attuazione di una riforma e si tenne sempre a contatto con gli altri papi che gli succedettero, divenendo quando più quando meno, uomo di fiducia e di consiglio. Ma la vocazione a consigliere dei pontefici non era dettata da altro che dal desiderio di affrettare la riforma della Chiesa. Quest’altro aspetto della figura di Damiani, il riformatore, lo portò ad avere molteplici contatti con le più note personalità ecclesiastiche e laiche dell’epoca. Egli, però, non seppe misurare, almeno in tutta l’estensione, la radice profonda del male riposta nell’investitura laica che implicava la sottomissione della Chiesa all’Impero. Anzi, Damiani era persuaso che la riforma della Chiesa poteva essere realizzata solo con l’accordo dei due poteri spirituale e temporale. Nella Disceptatio Synodalis, che compose per difendere Alessandro II dall’antipapa Onorio II, egli si propose unicamente di ricreare l’intesa tra la santa Sede e la corte germanica, senza rendersi sempre conto dell’importanza dei sacrifici accettati in vista della loro riconciliazione. Infatti, Damiani, in questo suo scritto, sembra smentire il decreto del 1059 in cui Niccolò II stabiliva che l’elezione del pontefice spettava in primo luogo ai cardinali vescovi e non all’imperatore. Ammiratore dell’istituzione imperiale, come aveva funzionato al tempo di Enrico III, egli non vide fra Chiesa e Impero la possibilità di rapporti diversi da quelli fino ad allora seguiti. Di altro parere era, invece, il suo collega nelle ambascerie papali, Ildebrando da Soana, futuro Gregorio VII, che ingaggiò la lotta contro le investiture per respingere l’ingerenza dei laici nelle elezioni dei pontefici, dei vescovi e degli abati. Per Damiani la preoccupazione maggiore era di combattere strenuamente l’incontinenza e far rivivere nel clero la virtù della purezza e della castità perfetta.
Contro la simonia, Damiani scrisse il Liber Gratissimus in cui, pur condannando questa pratica, sosteneva che i sacramenti amministrati dai preti simoniaci conservavano la loro validità perché non era dagli uomini ma da Cristo che traevano la loro efficacia. Questa posizione, però, era in disaccordo con ciò che l’autore aveva sostenuto negli scritti precedenti, in cui si era battuto fieramente contro i simoniaci. Probabilmente, Damiani cambiò il suo giudizio perché, nel frattempo, aveva saputo che anche il vescovo da cui era stato ordinato era simoniaco! Contro di lui, a causa di questo suo ripensamento, si scagliò Umberto di Silva Candida, sostenitore della tesi rigorista, il quale negò decisamente la validità del sacerdozio di Damiani.
Dopo le discussioni sollevate dal Liber Gratissimus, molto criticato nell’ambiente ecclesiastico, si verificò un certo allontanamento tra Leone IX e Pier Damiani. Ciò potrebbe essere spiegato, secondo Lucchesi, dalla posizione di Umberto di Silva Candida nella questione delle ordinazioni, poiché questi fu un cardinale molto influente su Leone IX. Altri studiosi invece ritengono che l’allontanamento sia stato determinato dalla risposta che il papa diede a Pier Damiani riguardo al suo libro.
In altri opuscoli, Damiani si occupò della necessità di una vita illibata da parte dei chierici e vi espresse le sue idee sul celibato e sulla castità del clero. In particolare, egli scrisse nel De caelibatu sacerdotum (1059) un’esortazione al papa Niccolò II, che era il dedicatario dell’opuscolo, affinché esercitasse tutto il rigore dei sacri canoni contro i prelati immorali e perché deponesse quelli che violavano la castità
. Nella lettera inviata a Cuniberto, vescovo di Torino, e in quella indirizzata alla principessa Adelaide di Susa (1064), si scaglia contro quei chierici intemperanti che vivono velut iure matrimonii confoederentur uxoribus e rivolge un’apostrofe alle concubine degli ecclesiastici chiamandole “empie tigri”, “arpie” e “vipere furiose”.
Un altro costume del clero che Pier Damiani riteneva dovesse essere risanato molto urgentemente era la pratica dell’omosessualità. Così, fin dai primi anni della sua attività di consigliere papale, si adoperò per guarire la Chiesa da questo “male abominevole” e, a questo scopo, scrisse il Liber Gomorrhianus dedicandolo al papa Leone IX, confidando nella volontà riformatrice del pontefice. In questo opuscolo, Damiani fa un’analisi particolareggiata di questa terribile colpa, usando termini arditi e severi.
Comunque Damiani, nonostante la grande opera di riforma che intraprese, sentì sempre la nostalgia per la vita eremitica, tant’è che negli ultimi anni della sua vita volle tornare al suo amato eremo di Fonte Avellana, rinunciando alla sede di Ostia. Dante colloca Pier Damiani nel settimo cielo fra i contemplativi e lo mostra nella sua veste di fiero fustigatore della dilagante corruzione ecclesiastica e come spirito innamorato della vita eremitica. Egli aveva un carattere ardente, nonostante il continuo sforzo di vincersi, un po’ ombroso, tanto da essere paragonato a San Girolamo. Per usare le parole di P. Brezzi, “[…] in lui vi era una assoluta purezza d’intenzione, elevatezza morale, noncuranza dei mezzi termini, fervore inesauribile, forza di convinzione”.
Breve introduzione
Pier Damiani si fa portavoce di un cristianesimo ascetico che, capovolgendo il primato della vita comunitaria quale era stato stabilito dalla “Regola” di Benedetto da Norcia, ravvisa la perfezione della vita monastica nell’eremitaggio. Il fulcro della vita perfetta è, secondo Pier Damiani, la simplicitas, da lui opposta alla curiositas profana (tipicamente filosofica: la ragione socratica, curiosa di tutto) che spinge a investigare razionalmente i misteri divini; per argomentare contro la dialettica, Pier Damiani si vede costretto a fare anch’egli uso delle armi dialettiche, soprattutto nel suo scritto Sull’onnipotenza divina. In quest’opera, egli vuol mettere in luce come il linguaggio, la grammatica e le regole della dialettica restino chiuse entro limiti meramente umani e non siano in alcun modo in grado di attingere alla vera natura di Dio. Di fronte all’onnipotenza di Dio, quale è rivelata dalle Scritture, tutti gli strumenti linguistici e razionali puramente umani rivelano una totale inadeguatezza. E poichè onnipotenza significa poter fare ciò che si vuole senza limiti nè costrizioni, Pier Damiani arriva a sostenere che Dio può perfino far sì che il passato non sia avvenuto. In questo senso, allora, parlare di passato non ha più senso per Dio, il quale è eterno presente, nè si può pensare che la potenza di Dio possa essere limitata da un presunto ordine intrinseco alla natura. In realtà ogni evento, anche appartenente all’ambito degli eventi producentisi in natura, è voluto e sancito da Dio e questo volere è per gli uomini ineluttabilmente imperscrutabile: ciò vuol dire che ogni fenomeno, anche quelli che si presentano con la massima regolarità e quelli più banali, è un miracolo. Dio, inoltre, non è limitato da alcuna necessità logica, neppure dal principio di contraddizione: egli può operare anche ciò che all’uomo può apparire logicamente impossibile.
Il Liber Gomorrhianus
Pier Damiani scrisse il Liber Gomorrhianus intorno alla seconda metà del 1049. Il libro è la prima delle opere dell’autore che censura gli abusi sessuali degli ecclesiastici e, nello stesso tempo, come dice Brundage, è “l’espressione più esplicita contro la sessualità deviante di tutta la letteratura del periodo riformatore”.
Bailey definisce il LG una “composizione straordinaria” e, sotto alcuni punti di vista, “l’asserzione medievale più importante sul soggetto dell’omosessualità”. Infatti, prima di Damiani, nessuno aveva affrontato in modo sistematico il problema dell’omosessualità e, soprattutto, nessuno aveva mai denunciato apertamente l’esistenza di questa pratica in ambiente ecclesiastico. Damiani che, come abbiamo visto, desiderava ardentemente promuovere l’attività riformatrice dei pontefici, soprattutto al fine di restaurare la disciplina nella gerarchia ecclesiastica, volle dimostrare quanto fosse urgente risanare i costumi del clero. Così, nel LG, si scaglia contro il dilagare in nostris partibus del quadruplice vizio contro natura, ne analizza i vari tipi di comportamento e le situazioni in cui questi vengono compiuti proponendo un’unica drastica soluzione: tutti gli ecclesiastici colpevoli di qualsiasi atto omosessuale devono essere immediatamente degradati, a qualunque grado essi appartengano. Damiani ritiene “completamente assurdo che quelli che si macchiano abitualmente con questa malattia purulenta osino entrare nell’ordine o rimanere nel loro grado […] perché è contrario alla ragione e alle sanzioni canoniche dei Padri”. Comunque, egli aggiunge, “non affermo questo come pretesto per proporre una bozza di sentenza definitiva […], ma semplicemente per spiegare la mia opinione a riguardo”. Egli non prevede attenuanti anzi, rispetto all’opinione comune sulla gravità delle varie pratiche, Damiani formula un giudizio ancora più severo considerando anche la masturbazione fra gli atti innaturali e, forse, benché non lo dica esplicitamente, anche la fellatio. Damiani non assegna penitenze, non commina né digiuni, né preghiere, nessuna pena sarebbe mai sufficientemente pesante per l’espiazione di una colpa così abominevole. Se i peccatori in questione fossero dei laici, sicuramente li redarguirebbe con decisione e con durezza, ma impartirebbe loro una penitenza per riavvicinarsi a Dio e per ricevere il perdono. Ma qui gli scellerati sono dei sacerdoti, sono dei ministri del Signore! A costoro non deve più essere permesso di toccare il corpo e il sangue di Cristo, le loro mani sono sudicie e indegne. Per questi ecclesiastici nient’altro deve essere previsto se non la degradazione e l’allontanamento dall’ordine.
Damiani, anche se ammette una certa gradualità nelle colpe omosessuali, punisce la masturbazione, il rapporto interfemorale e la penetrazione anale nello stesso modo. “Perciò — egli dice — non si deve rallegrare colui che non pecca con un altro, se da solo cade nelle lussuriose contaminazioni dell’adescamento”. Per questa sua severità e intransigenza, o come la chiama Brundage, ossessione, questo opuscolo di Damiani costituisce un unicum nella letteratura medievale cristiana. Credo, però, che sia più giusto dire che è la materia trattata, l’analisi dettagliata dei fatti e la drastica condanna in esso pronunciata che rendono il LG il primo vero documento decisamente contro l’omosessualità.
Secondo Payer il LG fu “il primo di una lunga serie di trattati e contro trattati sulla materia che avrebbero caratterizzato il movimento di riforma fino alla fine del secolo”. A questo riguardo, bisogna precisare che, prima di Damiani, si trovano numerosi riferimenti all’omosessualità, ma tutti sono contenuti nei penitenziali o nelle collezioni canoniche che, come abbiamo visto, non si possono di certo considerare dei trattati. Dopo Damiani, anche i canonisti del periodo gregoriano si interessarono alle questioni sollevate dal LG. Il Decretum di Ivo di Chartres, per esempio, contiene numerosi canoni che condannano la sodomia, la bestialità, la pederastia e la fellatio e per queste colpe sono previste anche pene più severe rispetto agli altri peccati, ma egli attinge queste prescrizioni dalle raccolte canoniche precedenti. Nei penitenziali non si discute del problema dell’omosessualità, di quanto detestabile sia questa colpa e di come venga commessa, in essi ogni questione è studiata in relazione alla penitenza più giusta da imporre, non viene esaminata la radice del peccato come ha fatto Damiani. Credo, quindi, che si possa dire con sicurezza che, almeno nel primo Medioevo, non furono scritti sull’omosessualità altri trattati di una certa estensione paragonabili al LG.
Boswell fa riferimento a Damiani inserendolo in quel “piccolo e rumoroso gruppo di asceti” che risvegliò la violenta ostilità di Crisostomo il quale affermava che gli atti omosessuali non solo erano peccaminosi, ma così gravi da essere paragonati più all’assassinio che alla golosità o alla fornicazione. Per tutto il periodo della riforma questi uomini, continua Boswell, “lottarono per interessare la Chiesa istituzionale alla loro crociata, per cambiare le opinioni della gente e dei teologi in materia”. Le autorità ecclesiastiche non stabilirono mai delle punizioni per il comportamento omosessuale e finsero di non sentire quelle poche lamentele che ricevevano dai riformatori. Oltre a Damiani che cercò, con scarso successo, di interessare al problema Leone IX e Alessandro II, lo stesso Ivo di Chartres denunciò a papa Urbano II, il pontefice che promosse la prima crociata, i nomi di alcuni prelati altolocati che erano ben conosciuti per essere coinvolti in attività omosessuali, ma anche la sua protesta cadde nel vuoto. Quasi certamente nello stesso tempo, si cercò di introdurre in Inghilterra una legislazione ecclesiastica che definiva peccaminoso il comportamento omosessuale. Il concilio di Londra del 1102 prese delle misure per far sì che il pubblico venisse informato della scorrettezza di tali atti e insistette perché la “sodomia” venisse confessata come peccato. Sant’Anselmo di Canterbury si oppose alla pubblicazione del decreto e in una lettera all’arcidiacono Guglielmo, disse: “questo peccato è stato finora così comune che difficilmente si prova imbarazzo per esso e, perciò, molti sono caduti in tale peccato perché erano inconsapevoli della sua gravità”.
Boswell sottolinea giustamente che questa indifferenza della Chiesa istituzionale al comportamento omosessuale è ancora più straordinario perché fu proprio durante questo periodo che furono fatti i più strenui sforzi per rinvigorire il celibato ecclesiastico. Intanto, un altro gruppo all’interno della Chiesa cominciò a sostenere “il valore positivo delle relazioni omosessuali e le celebrò in una esplosione di letteratura gay cristiana” basata sull’esempio dell’amicizia fra Gesù e Giovanni.
In questo contesto, quindi, senza alcun dubbio, il LG riveste un ruolo unico e particolare che sembra preludere all’intolleranza che nascerà nel XIII secolo e che punirà l’omosessualità anche con la pena di morte.
Lucchesi ha individuato un’altra novità importante contenuta nel LG rispetto agli altri lavori precedenti. Fu scritto per essere sottoposto all’autorità del papa e riceverne conferma, ma anche per essere presentato all’attenzione di un sinodo: dum plurimorum consensu et iudicio res geritur. Dunque, Damiani non solo chiede al papa di approvare con una sua decretali pagina le punizioni che egli propone per i colpevoli, ma pensa anche di offrire materiale di lavoro ad un prossimo sinodo, e cioè “prepara” un prossimo sinodo.
Evidentemente Damiani riponeva molta fiducia in Leone IX, ma questi, come vedremo nel prossimo capitolo, tempera alquanto la severità del provvedimento proposto dall’autore e, a quanto pare, nessun concilio discusse mai il problema dell’omosessualità.
Pier Damiani e Leone IX
Leone IX (1049-1054) fu il primo “papa pellegrino” della storia, fu quello che venne a Roma in abiti da viandante e che nel suo breve pontificato visitò quasi tutta l’Europa cristiana. Egli seppe circondarsi di insigni personalità. Infatti, fu allora che Ildebrando lasciò definitivamente il monastero per porsi ai fianchi del papa e che vennero a Roma Umberto di Silva Candida, l’alter ego di Leone IX, Federico di Lorena, futuro Stefano IX, et ex Ravennatium partibus Petrus Damianus vir eloquentissimus.
Leone IX fu il primo vero papa riformatore. Nei sinodi tenutisi sotto il suo pontificato dichiarò guerra alla simonia e all’incontinenza del clero. Pier Damiani partecipò personalmente a ciascuno di questi sinodi e spesso le sue testimonianze sono le uniche pervenuteci circa i problemi discussi in tali assemblee. Nelle lettere contro i sacerdoti intemperanti, Damiani parla di un interdictum papae Leonis e di un decreto dello stesso pontefice contro le prostitute dei preti, entrambi emanati durante il sinodo dell’aprile del 1049. Damiani, non contento di quanto veniva discusso e decretato dal sinodo, cercò di lavorare per conto suo su certe problematiche che gli stavano particolarmente a cuore. E fu così che iniziò a concretizzare la sua opera a favore della Chiesa componendo il Liber Gomorrhianus e dedicandolo, come abbiamo visto, allo stesso Leone IX.
In risposta al LG, il pontefice scrive a Pier Damiani una cortese lettera di apprezzamento per il libello che gli ha inviato e lo rassicura di aver dimostrato a se stesso di essere un nemico della contaminazione della carne. Ne gradisce lo stile franco e il ragionamento sincero che, indiscutibilmente, lo rendono degno di combattere la lotta conto i peccati dalla parte della giustizia.
Anche Leone condanna questo vizio, questo “desiderio osceno” che allontana dalla virtù cristiana chiunque lo commetta e che, a maggior ragione, è detestabile se compiuto da dei sacerdoti: “come può uno essere ecclesiastico o chiamarsi tale, quando non ha temuto di macchiarsi di sua propria volontà?” Proprio i ministri del Signore che “avrebbero potuto chiamarsi non solo tempio sacro di Dio, ma anche il santuario in cui l’Agnello di Dio è stato immolato in splendida gloria”, proprio loro conducono una vita tanto disgustosa.
Quindi, Leone approva la punizione che Damiani ha previsto per questi peccatori, perché è in accordo non solo con l’autorità dei sacri canoni ma anche con il giudizio del papa stesso (nostro iudicio). Egli definisce il tono pungente di Damiani “santa indignazione” e lo rassicura circa la validità delle sue affermazioni. Tuttavia, Leone IX ritiene opportuno imporre la sua autorità apostolica, come lo stesso Damiani aveva chiesto, in modo “da rimuovere ogni scrupoloso dubbio a quelli che leggono”. Dunque, sebbene l’autorità sacra preveda l’espulsione per coloro che si sono “macchiati” in uno qualsiasi dei quattro modi enumerati da Damiani, “noi — dice Leone IX — agiremo più umanamente”. Egli, infatti, desidera e ordina che gli ecclesiastici non coinvolti in tali attività “da lunga abitudine o con molti uomini” rimangano nello stesso grado che occupavano quando erano stati dichiarati colpevoli, e che solo quelli in stato particolarmente peccaminoso vengano degradati dal loro rango. In particolare, chi ha peccato nei primi tre modi — masturbazione solitaria, masturbazione reciproca e coito interfemorale — dopo un periodo di penitenza, può ritornare al grado ecclesiastico che ricopriva prima. Ma non c’è speranza di recuperare la carica per chi ha peccato in questo stesso modo ma per lungo tempo oppure per poco tempo ma con molti uomini. La stessa sorte spetta a quelli che si sono uniti mediante la penetrazione anale poiché hanno commesso il delitto più grave ed impronunciabile.
Leone IX entra in merito alla gravità degl’atti omosessuali seguendo accuratamente la “classificazione” di Damiani e stabilendo una specie di gradualità fra i diversi comportamenti. Tale distinzione sembra soddisfare la richiesta, formulata da Damiani nel LG, di stabilire “chi, tenendo conto, certamente, della diversità [dei peccati], possa ricoprire misericordiosamente questo ufficio”. Nonostante ciò, le sue precisazioni rimangono molto vaghe, sembra che volutamente lasci imprecisato che cosa intenda con “abitudine” e con “pochi” o “molti” uomini, come se volesse fornire degli appigli per gli accusati.
Nelle parole di Leone si legge chiaramente un atteggiamento molto tollerante. Da un lato, sembra voler accontentare Damiani comminando la degradazione laddove la gravità del peccato sia proprio innegabile. Dall’altro lato, non si inasprisce contro i peccatori ma, anzi, usa un tono comprensivo, sed nos humanius agentes. Leone IX non giustifica la sua affermazione, la impone (volumus, atque etiam iubemus) e il tono, nel seguito della lettera, non cambia. Egli attribuisce al suo scritto la validità di un decreto: “Se qualcuno oserà fare critiche o porre dubbi su questo decreto di direzione apostolica, sappia che sta mettendo in pericolo la sua carica”.
Bailey, che sembra sia stato influenzato da K.H. Mann, ha interpretato questa frase come un ammonimento per Pier Damiani. Al contrario Boswell dice in modo un po’ confuso, che non si tratta affatto di una minaccia diretta a Piero. Questo ammonimento viene chiarito dalla frase successiva in cui Leone aggiunge che “chi non commette il vizio ma lo incoraggia, costui è, giustamente, considerato colpevole di morte al pari di chi muore nel peccato”. Ma, chi è che incoraggia il vizio? Colui che non lo vuole estirpare, che non lo vuole punire e che quindi è pronto a criticare le disposizioni di Leone.
L’affermazione non si riferisce direttamente a Pier Damiani ma a quelli che avrebbero preferito cancellare il decreto di Leone, quindi, con tutta probabilità agli accusati, cioè ai preti omosessuali. Tuttavia è implicito che questo sia un monito rivolto anche a Damiani che, desiderando un intervento più severo da parte del papa, avrebbe potuto protestare contro un provvedimento invece così comprensivo
È chiaro che Leone non è molto ben disposto verso il LG, i complimenti che rivolge a Damiani sono frasi di circostanza, lo saluta come un paladino della giustizia e lo premia con l’augurio della grazia eterna, ma, poco prima, gli dice “hai scritto ciò che sembrava meglio per te” sottintendendo che le sue opinioni personali non erano necessariamente identiche a quelle di Damiani. Non bisogna dimenticare che Damiani aveva chiesto a Leone di scrivere una pagina decretali, di radunare degli “uomini spirituali e prudenti per compiere questo necessario esame” e per togliere, così, ogni dubbio dal suo cuore. Questa richiesta però non fu accolta da Leone IX. Infatti, non solo la risposta del papa non può essere considerata un decreto conciliare, ma non risulta nemmeno che in qualche concilio se ne sia discusso. Le testimonianze dei sinodi di Leone ci parlano di numerosi interventi contro la simonia o il matrimonio ecclesiastico, ma non contro l’omosessualità.
Come abbiamo detto, durante gli ultimi anni del pontificato di Leone IX, fra i due si verificò un certo allontanamento. Bailey e Mann, che hanno frainteso le parole di Leone, ipotizzano che il diverbio fra i due sia stato provocato proprio dalla risposta del papa a Damiani. Ma, come dice Boswell, la prova di tale allontanamento deve essere ricercata in un’altra lettera che Damiani scrive a Leone IX tra il 1050 e il 1054.
Questa lettera mostra chiaramente che fra i due c’era stata una rottura abbastanza netta, perché Damiani dice in modo esplicito di volersi riconciliare con Leone IX e di essere pronto a fare ulteriori penitenze per meritarlo. Nello stesso tempo, l’autore non risparmia battute pungenti per Leone: è doveroso credere che Dio abiti nel suo cuore e che lo convinca a cedere alla benevolenza di chi scrive. Per capire che cosa sia successo di così tanto grave fra Damiani e Leone, analizziamo il contenuto della lettera.
Innanzitutto, l’autore si scaglia contro i suoi accusatori, contro quell’”antico nemico” che ha affilato le lingue dei maligni contro di lui e che, quotidianamente, si ingegna nella costruzione di nuove menzogne. Damiani è amareggiato e sorpreso perché “l’astuta capacità degli uomini” è riuscita ad ingannare anche il papa facendogli credere queste menzogne. Eppure il Signore insegna che non bisogna giudicare con troppa facilità le cose che non si conoscono. Di Sodoma e Gomorra, egli infatti dice: “Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me”.
Dunque, Damiani rimprovera Leone IX per aver dato credito alle falsità sul suo conto senza verificare la loro corrispondenza con la verità e per non aver usato nei suoi confronti quella cautela che solitamente utilizza con tanta prudenza. Ma i suoi accusatori e l’”antico nemico” chi sono? Perché lo accusano?
Secondo Lucchesi, il LG avrebbe suscitato un certo scalpore sia tra il pubblico sia nell’ambiente pontificio e, quindi, in questa lettera indirizzata a Leone IX, Damiani risponderebbe alle perplessità e alle proteste mosse contro di lui. In effetti, più volte nel LG, il peccato di omosessualità e il diavolo che lo istiga vengono chiamati “nemici” dell’uomo. Inoltre, chi meglio delle persone colpite nel LG avrebbe avuto motivo di accusarlo e di inventare menzogne contro di lui.
Damiani non ci dice di che cosa lo accusino, non sappiamo se le malignità formulate contro di lui fossero insinuazioni circa le sue tendenze sessuali oppure semplici condanne al suo stile troppo pungente e violento. Sicuramente, qualche illazione sul suo orrore per il sesso e sulla sua triste visione della sessualità umana sarà stata fatta, ma nella lettera c’è un chiaro riferimento al suo carattere da temperare: ” Per questo motivo, invoco e umilmente scongiuro quel testimone della mia coscienza […] affinché subito ordini con la sua autorità che voi mi mitighiate, se lo giudica opportuno per la mia salvezza”.
Un altro spunto per collegare la lettera con il LG ci è fornita dalla citazione del clamor Sodomorum et Gomorrhaeorum. Damiani dice che come Dio, prima di punire le due città, ha mandato gli angeli a constatare se le accuse mosse nei loro confronti erano fondate, così anche noi non dobbiamo credere alle malvagità se non dopo averle verificate. Dunque, Leone IX prima di dar fede alle falsità che le persone colpite nel LG avevano formulato contro Damiani, doveva accertarsi della sincerità e delle buone intenzioni che avevano mosso l’autore a denunciare il loro comportamento osceno. Questi elementi credo che siano sufficienti per dire, in accordo con Capecelatro, che probabilmente dopo una prima reazione favorevole o, comunque, non contraria al LG, Leone IX abbia, in seguito, cambiato la sua posizione forse a causa di alcune voci maligne che aveva sentito sul conto di Damiani. Questa ipotesi, inoltre, spiegherebbe anche la mancata applicazione dei provvedimenti stabiliti da Leone e l’assenza di ogni altra discussione sull’argomento, oltre che il tono arrabbiato della lettera di Damiani che forse aveva visto vanificarsi tutte le sue fatiche. Egli si difende, come già aveva fatto nel LG, affermando che non teme gli odi e le cattiverie di nessun uomo mortale perché è sicuro di aver agito per amore di Cristo e secondo la voce della sua coscienza.
In conclusione, la risposta di Leone è la risposta di un pontefice più interessato a mantenere la stabilità all’interno del clero che a punire le relazioni omosessuali. È molto significativo che Leone IX fosse in disaccordo con Damiani su questo problema perché, a detta del secondo, il papa era d’accordo che le prostitute a servizio dei preti fossero rese schiave, una punizione davvero severa per una pratica così comune.
Pier Damiani, Alessandro II e il “furto” del Liber Gomorrhianus
Papa Alessandro II (Anselmo da Baggio) fu un riformatore ardente e deciso dei costumi ecclesiastici. Egli era stato collega di Pier Damiani nella legazione del 1059, quando, per volere del papa Niccolò II, si recò a Milano per la riforma di quella Chiesa e di altre della Lombardia. Pier Damiani coadiuvò Alessandro II in ogni maniera per rafforzarlo nella sua posizione contro l’antipapa Onorio II (Cadalo, vescovo di Parma). Infatti, egli difese, nel 1061, la causa di Alessandro II davanti all’Assemblea di Augusta, e compose proprio a questo fine la Disceptatio synodalis inter regis advocatum et Romanae ecclesiae defensorem.
Fliche descrive Alessandro II come un uomo equilibrato, quasi timoroso e poco energico, e molto legato al suo consigliere Pier Damiani, soprattutto nei primi anni del suo pontificato. In seguito, affermata la legittimità della sua elezione e rafforzato nelle sue posizioni, il papa porta avanti le idee riformatrici dei suoi predecessori, accentrando il potere ecclesiastico attorno alla Santa Sede. Anch’egli cercò di ricondurre il clero alla continenza e alla povertà, vigilando sulla rigida applicazione dei decreti pontifici sul nicolaismo e sulla sodomia. Scrivendo ai vescovi di Dalmazia, Alessandro II ordina che un vescovo, un prete o un diacono che prendono moglie o conservano quella che hanno già, dovranno essere deposti, abbandonare il coro e non percepire rendite ecclesiastiche fino a completa resipiscenza. Egli impone ai preti fornicatori la rigida proibizione di assistere alla Messa e ordina pene severe per “quelli che osano vendere o comprare un ordine sacro, o un bene della Chiesa, ugualmente sacro”: nella Chiesa di Dio nulla può essere venduto, né i beni né, a maggior ragione, i sacramenti. Perciò, nulla vien cambiato nelle direttive apostoliche riguardanti la riforma della Chiesa: la legislazione precedente rimane rigorosamente in vigore.
Però, proprio Alessandro II che sosteneva con tanto vigore la riforma e che, come abbiamo detto, riceveva spesso consigli ed aiuti da Pier Damiani sembra che abbia addirittura cercato di sopprimere il LG.
In una lettera, indirizzata ai suoi due alleati curiali, i cardinali Stefano e Ildebrando (futuro Gregorio VII), Pier Damiani racconta che il papa gli aveva chiesto in prestito il manoscritto di un suo lavoro col pretesto di volerne avere una copia ad uso personale. Durante la notte, però, Alessandro II chiude a chiave il manoscritto in un cassetto e, in seguito, si rifiuta di ridarlo all’autore. Damiani, che nella lettera racconta l’episodio ai due cardinali, si dice offeso da questo furto e si lamenta a lungo con toni infuriati e appassionati contro il comportamento del papa.
L.K. Little ritiene con certezza che il libro in questione sia il LG e questa tesi, sostenuta per primo da A. Capecelatro, è ritenuta corretta anche da J. Boswell e J. Brundage. N. Tamassia, che si è occupato dell’aspetto legale di questa lamentela di Damiani, commenta come segue la lettera. Questa lettera non può non avere carattere giocoso. Si sa che gli autori sono felici, quando sono vittime di questi furti, e Pier Damiani, per quanto se ne dolesse apparentemente, restava sempre un retore […] non ignaro che tutti attendevano i suoi scritti con una certa ansietà.
Secondo J.J Ryan, la lamentela di Damiani non è un gioco retorico, la sua preoccupazione sembra abbastanza reale. Egli ritiene però che il LG non abbia nulla a che fare con l’incidente raccontato nella suddetta epistola perché, a suo avviso, è molto improbabile che Pier Damiani avesse con sé, a Roma, il LG quindici anni dopo la sua composizione, cosa che, invece, non esclude Boswell visto che l’autore cercava ancora di interessare il papato alla riforma di tali questioni.
Ryan cerca di dimostrare che il libro in questione è un’altra opera di Damiani ma fornisce poche prove a sostegno della sua ipotesie non dà peso all’affettuosa descrizione del volume sottratto che, secondo Boswell, è applicabile solo al LG.
In effetti, Pier Damiani descrive questo suo libro come un figlio, come quell’unicum filium (quindi ancora più prezioso per la sua unicità) che aveva stretto a sé con il dolce abbraccio di un genitore, che gli era costato tanta fatica e che aveva quasi strappato alla povertà del suo misero ingegno. L’autore si esprime con toni affettuosi come se parlasse di una persona cara e cerca di rendere partecipi gli amici Stefano ed Ildebrando del suo rammarico e del suo risentimento per il furto subito, triste ricompensa per il duro lavoro. Inoltre, l’atteggiamento canzonatorio ed evasivo del papa infastidisce ulteriormente Damiani che non esita a paragonare il pontefice ad un pazzo “che scaglia tizzoni e frecce di morte” e che poi si giustifica dicendo che era uno scherzo. Se Alessandro ritiene, come dimostra con il suo comportamento, che il sacerdote sia un attore, allora anche Damiani si sente autorizzato a giocare e a scherzare con il nome del papa, formulando così una serie di velate minacce circa il suo possibile destino. Infatti, Alessandro II porta lo stesso nome di quel pontefice che fu flagellato e di quel ramaio, avido di denaro, che S. Paolo affida al Signore perché lo punisca secondo le sue opere. Inoltre, Damiani ricorda al papa l’aiuto che gli prestò contro Cadalo e tutte le tribolazioni che dovette sopportare a servizio unicamente della sede apostolica. Perché dopo tante pene, per le quali merita di certo la beatitudine, deve subire l’oltraggio del furto e, per giunta, da parte di una persona che credeva amica?
Queste parole così pungenti non sono certamente una finzione letteraria, Damiani è veramente dispiaciuto per la perdita del suo “amico codice”.
Ma l’indignazione dell’autore era dovuta solamente all’atteggiamento irrispettoso e canzonatorio del papa, al fatto che gli aveva sottratto il libro con un sotterfugio e che non si decideva a restituirglielo, oppure il libro aveva un valore particolare per Damiani? Che cosa implicava il furto di questo suo lavoro? Egli non ci fornisce nessun elemento per rispondere a queste domande e per stabilire con certezza quale sia il libro rubato. È chiaro, comunque, che l’affronto ricevuto dal papa è il motivo principale della reazione di Damiani. Ma, forse, senza forzare troppo l’interpretazione della lettera, si possono formulare altre ipotesi quali, ad esempio, che si trattasse dell’unica copia in suo possesso e che, quindi, il furto significasse per Damiani la perdita irreparabile di un suo intero lavoro. Oppure che l’argomento in esso trattato fosse particolarmente importante per Damiani, come si legge fra le righe della sua affettuosa descrizione del manoscritto e nei ripetuti solleciti che egli fa al papa per riavere il suo libro. Ma queste ipotesi non sono sufficienti, benché Boswell dica il contrario, per identificare il libro in questione con il LG. C’è un altro elemento però da prendere in considerazione e che, a mio avviso, è determinante per la comprensione della lettera. Damiani, dopo aver ricordato al papa di essersi comportato come i Daniti che rubarono tutti gli averi di Mica, lo prega di non allontanare da sé il misero autore di quel libro a causa di “un incidente di così poco conto”. È difficile stabilire a che cosa si riferisca Damiani ma di certo sottintende un fatto spiacevole legato all’opera in questione. Era stato l’argomento discusso nel libro o forse qualche considerazione dell’autore ad aver provocato un incidente, ad aver suscitato del malcontento o delle reazioni negative? Neanche questo possiamo sapere con certezza. Se però interpretiamo il “fatto spiacevole” come una qualche reazione negativa nei confronti di un suo lavoro, allora quasi certamente possiamo identificare l’amico codice con il LG. Nessun’altra opera di Damiani, infatti, ricevette delle critiche così forti come quelle seguite al LG, tali da indurlo a difendersi tenacemente come ha fatto nella lettera inviata a Leone IX.
A questo poi si deve aggiungere che non era nelle intenzioni di Damiani dare quel lavoro ad Alessandro — “sapeva che non lo avrebbe potuto ottenere da me in altro modo” —, ma perché allora lo aveva con sé? Forse voleva solamente chiedergli un parere sulla qualità del suo componimento, forse voleva provare nuovamente, come aveva fatto con Leone IX, a proporre dei severi provvedimenti contro l’omosessualità del clero.
Se accettiamo l’ipotesi che la lettera parli veramente del LG, allora ci dobbiamo chiedere che cosa indusse Alessandro II, che pure sosteneva con forza la riforma della Chiesa, a nascondere quel libro anziché usarlo come spunto per legiferare contro le immoralità del clero. Forse perché era troppo violento e diretto o perché proponeva sanzioni troppo pesanti. Boswell sembra insinuare che lo stesso Alessandro II avesse delle ragioni personali che lo spingevano a tale gesto, poiché era allievo di Lanfranco di Pavia, famoso per il suo attaccamento ai giovani monaci. Senza alcun dubbio, comunque, Alessandro II considerava il LG “scomodo” e forse temeva, visto i precedenti, le reazioni che avrebbe potuto suscitare.
Dopo questa ultima vicissitudine, non sappiamo quale sia stata la storia del LG. Secondo J. Brundage, che a sua volta utilizza il pensiero di Little, Pier Damiani, nella lettera ai due cardinali, implorerebbe con successo, i due amici di recuperare il LG e di restituirlo al suo autore. In questa lettera, però, non c’è traccia di una simile richiesta. Anzi, Pier Damiani coinvolge molto poco Ildebrando e Stefano: a loro indirizza la lettera e a loro chiede una penitenza per le dure parole pronunciate contro il papa. A parte questi due chiari riferimenti, il testo della lettera sembra rivolgersi ad un pubblico molto più vasto a cui Damiani sfoga la sua amarezza per l’ingiustizia subita.
Un libro “scomodo”
Dopo aver preso in esame le varie ipotesi circa la storia del LG, a partire dal motivo che indusse Damiani a comporlo fino agli insuccessi subiti, prima con Leone IX e poi con Alessandro II, siamo giunti alla conclusione che la Chiesa dell’XI secolo cercò in tutti i modi di evitare la discussione circa la pratica omosessuale in ambiente ecclesiastico. Inoltre, l’indifferenza della Chiesa istituzionale è ancora più straordinaria se paragonata all’accanimento con cui impose il celibato ecclesiastico. I cento anni successivi al 1050, infatti, rappresentarono il culmine del prestigio morale papale e un periodo di riforma e di vigore spirituali senza confronto nel cattolicesimo romano.
Per questi motivi, come dice Boswell, “è difficile dimostrare che l’indifferenza verso la sessualità gay fosse semplicemente conseguenza di apatia”. Probabilmente la denuncia e la condanna dei rapporti omosessuali fra ecclesiastici avrebbe coinvolto troppe personalità insigni del tempo, e forse proprio quelle che con più tenacia condannavano la corruzione e il malcostume. Come per la simonia, contro cui si dovettero moderare i provvedimenti a causa della vasta diffusione del problema, così anche per la pratica dell’omosessualità un intervento decisivo, come quello di Damiani, avrebbe allontanato dagli ordini o degradato molti ecclesiastici. D’altra parte, Boswell dimostra in maniera abbastanza verosimile che c’era più di una relazione casuale tra la sessualità gay e alcune riforme effettuate durante questo secolo. Egli riporta delle testimonianze in cui i preti omosessuali vengono accusati di essere più desiderosi degli eterosessuali di rinvigorire le proibizioni contro i matrimoni ecclesiastici. Una satira contro un vescovo riformatore lo accusa specificamente di essere ostile al matrimonio ecclesiastico proprio a causa delle sue inclinazioni omosessuali:L’uomo che occupa questa sede [episcopale] è più Ganimede di Ganimede. Senti perché esclude gli sposati dal clero:
Egli non ama i servizi di una moglie. Ci sono testimonianze di accese dispute tra il clero gay e quello sposato su quale delle due predilezioni dovesse essere stigmatizzata. Un ecclesiastico sposato chiede alla gerarchia ecclesiastica:
Tu che fai passare nuove leggi ed emani severi statuti
E che ci tormenti, correggi in primo luogo quel sudiciume
Che più gravemente danneggia e che maggiormente allontana dalla legge.
Perché eviti di imporre pene severe ai sodomiti?
Questo tipo di malattia (che minaccia il mondo con la morte)
Sarebbe giusto che fosse estirpata per prima.
Questi documenti sono un’ulteriore prova del fatto che il LG trattava un argomento proibito e che quindi era un libro estremamente scomodo.
I papi non lo criticarono mai pubblicamente perché altrimenti avrebbero contraddetto il loro programma di riforma, ma cercarono in tutti i modi, e con successo, di lasciarlo fuori dalla lista dei provvedimenti riformatori.
In linea con la tesi di Boswell, possiamo concludere che, probabilmente, il LG riscosse poco successo non solo perché la sua diffusione avrebbe gettato una pessima luce sul clero, ma anche perché avrebbe sollevato un problema che in quel momento non era fra i più urgenti da risolvere.
Comunque, è giusto ribadire che, nonostante, o meglio, grazie alle sue vicissitudini, il LG costituisce una fonte storica unica all’interno del Medioevo.
ALANO DI LILLE

Alano da Lille (Alain de Lille) era nato a Lille (in Francia) nel 1125 circa. Formatosi alla scuola di Chartres, egli insegnò a Parigi e a Montpellier. Negli ultimi anni della sua vita si fece monaco cistercense nell’abbazia di Cîteaux, ove morì nel 1203. Fu teologo, importante per l’aver rivendicato alla teologia una dignità pari a quella delle altre scienze. Opere letterario- filosofiche sono Pianto della natura (De planctu naturae) in prosa e versi, e Anti Claudianus (Anticlaudianus) in versi, in cui concepisce la natura secondo i modi neoplatonisti della scuola di Chartres, e la raffigura allegoricamente come portatrice di armonia e dell’ordine stabiliti dal creatore, ma continuamente violati dagli uomini che cedono ai vizi. I suoi modelli letterari sono desunti da Boezio (La consolazione della filosofia) e Platone (Timeo), ma anche dalla mistica ebraica (in particolare l’allegoria del carro, nell’Anti Claudianus). Della vita di Alano di Lille (anche noto come Alanus ab Insulis) si sa in realtà ben poco. Probabilmente prese parte al Concilio Laterano nel 1179; in seguito stabilì la sua residenza a Montpellier (talvolta viene chiamato Alanus de Montepessulano), visse per qualche tempo al di fuori delle mura di ogni monastero ed infine si ritirò a Citeaux, dove morì nel 1202. Egli conobbe una fama assai diffusa durante la sua vita e la sua conoscenza, più diversificata che profonda, gli guadagnò il soprannome di Doctor universalis. Tra le sue numerose opere, due poemi lo elevano ad un posto di rilievo tra gli autori della letteratura latina medievale. Uno di questi, il De planctu naturae (Il pianto della natura), è un’ingegnosa satira dei vizi dell’umanità; l’altro, l’Anticlaudianus, è un trattato di morale, la cui forma richiama il pamphlet di Claudiano contro Rufino, è scritto in versi gradevoli e in un latino di relativa purezza. Come teologo, Alano di Lille prese parte alla reazione mistica della seconda metà del XII secolo d.C. contro la filosofia scolastica. Il suo misticismo, comunque, è ben lontano da essere assoluto come quello dei membri della Scuola di San Vittore (Ugo e Riccardo soprattutto). Nell’Anticlaudianus egli opera una sintesi di questo tipo: la ragione, guidata dalla prudenza, può senz’altro aiuto scoprire la maggior parte delle verità della fisica; per l’accesso alle verità religiose deve invece affidarsi alla fede, giacchè senza il suo appoggio non può pervenire a verità alcuna. Questa regola è completata nel suo trattato, Ars catholicae fidei, come segue: la teologia stessa può essere dimostrata dalla ragione, sicchè fede e ragione non confliggono, ma anzi si integrano l’un l’altra. Alano azzarda persino un’applicazione immediata di questo principio, e prova a dimostrare geometricamente i dogma definiti nel Credo, compiendo un’operazione per molti versi spericolata (specie se consideriamo l’epoca in cui egli ha operato). Questo audace tentativo è del tutto fittizio e fondato su null’altro che parole, ed è soltanto l’impiego di vari vocaboli non utilizzati in tale contesto (assioma, teorema, corollario, ecc.) a dare al suo trattato una parvenza d’originalità. Alano di Lille è stato spesso confuso con altri “Alano”, in particolare con Alano l’arcivescovo di Auxerre, Alano l’abate di Tewkesbury, Alano di Podio, ecc. Gli sono stati attribuiti alcuni avvenimenti delle loro vite, così come alcune delle loro opere: per questo motivo la Vita di San Bernardo dovrebbe essere attribuita a Alano di Auxerre e il Commentario su Merlino ad Alano di Tewkesbury. Il filosofo di Lille non è neanche l’autore di un Memoriale rerum difficilium, pubblicato sotto il suo nome; e vi sono inoltre fortissimi dubbi sul fatto che il Dicta Alani de lapide philosophico sia frutto della sua penna. D’altro canto, sembra ora essere praticamente dimostrato che Alano di Lille sia l’autore dell’ Ars catholicae fidei e del tratto Contra haereticos. Dal punto di vista teologico, Alano equipara la dignità della teologia a quella delle altre scienze: le verità teologiche sono dedotte da alcuni princìpi o regulae fidei in modo rigoroso. Tra le sue opere teologiche vanno citate: Summa “Quoniam homines”; De fide catholica contra haereticos, il cui intento era quello di confutare le dottrine dei càtari albigesi, dei valdesi, degli ebrei e dei mussulmani. Sulla scia di Boezio, Alano formula il progetto di una teologia come scienza, costituita su assiomi propri ed esposta in ordine deduttivo, cui darà esecuzione con il trattato Regulae de sacra theologia. A partire da una massima immediatamente evidente di impronta neoplatonica (“Monas est qua quaelibet res est una”: “La monade è ciò per cui ogni cosa è una”), Alano deduce i diversi momenti della realtà. Di incerta attribuzione tra Alano e Nicolas d’Amiens il De arte catholicae fidei, procede analogamente alle Regulae per definizioni, postulati e assiomi, nell’intento di fornire una tecnica della giustificazione razionale della fede cristiana, valida per ogni essere razionale.
PASSI DALLE OPERE DI ALANO SULLA NATURA
Sommo padre, Dio eterno, forza viva,
unica forma di bene, via del giusto, sede dell’onesto,
fonte del vero, sole della giustizia, asilo di pietà,
principio e fine, modo, misura, suggello,
causa delle cose, ragione immanente, profonda Noûs,
sapienza vera, autentica luce ignara delle tenebre,
origine somma, perfetta bellezza del mondo, vita perenne,
che governi le cose create e coordini
quelle che verranno, fai vivere ciò che nasce,
riporti ogni cosa ad un ordine numerico, dando consistenza
a ciascuna cosa in virtù del peso che le conferisci,
e tieni tutto quanto fermo ad una misura costante,
tu che realizzi le specie delle cose
e l’ombra del mondo sensibile […]
(Alano di Lilla, Anticlaudianus, V, 278-305)
Figlia di Dio e madre delle cose,
vincolo del mondo e suo stabile nesso,
bellezza della terra, specchio delle cose che passano,
luce del mondo;
pace, amore, virtù, governo, potere,
ordine, legge, fine, via, guida, origine,
vita, luce, splendore, forma, immagine,
regola del mondo;
tu che governi con le tue redini il mondo,
che stringi d’un nodo concorde tutte le cose
che tu hai stabilito, e col cemento della pace
unisci cielo e terra;
tu che applichi le idee pure di Noûs
e forzi ogni specie di esseri,
tu che rivesti di forme la materia e con le tue dita
dài forma alla forma;
(Alano di Lilla, Liber de planctu naturae)
ROBERTO GROSSATESTA

Roberto Grossatesta nacque verso il 1168 nel Suffolk e studiò ad Oxford . Dopo un soggiorno a Hereford , presso il vescovo William de Vere , sino alla morte di quest’ ultimo nel 1198 , tornò probabilmente ad Oxford . Qui , fra il 1209 e il 1214 , scoppiarono disordini tra studenti e cittadini , e i maestri , incluso forse Roberto , si recarono a Parigi . Nel 1214 egli é di nuovo ad Oxford come magister regens in teologia e successivamente cancelliere dell’ università . Grossatesta ha scritto un gran numero di opere giovanili in latino e in francese quando era un clericus (vedi la biografia più sotto); tra queste una intitolata Chasteua d’amour, un poema allegorico sulla creazione del mondo e sulla redenzione cristiana, nonché parecchi altri poemi e testi in prosa sull’economia domestica e sull’etichetta cortese. Egli inoltre ha scritto un notevole numero di opere teologiche, tra le quali l’importante Hexaëmeron, negli anni 1230. Grossatesta tuttavia viene considerato un pensatore originale soprattutto per merito delle sue opere concernenti questioni scientifiche e riguardanti il metodo scientifico. Nel periodo che va, grosso modo, dal 1220 al 1235 ha scritto una lunga serie di trattati scientifici, tra i quali: De sphera, un lungo testo su vari argomenti. De accessione et recessione maris. sulle maree. De lineis, angulis et figuris, sulle argomentazioni matematiche nelle scienze naturali. De iride, sul fenomeno dell’arcobaleno. Grossatesta ha scritto anche svariati commenti su Aristotele; tra questi il primo commento occidentale sull’Analytica Posteriora e uno sulla Fisica. Nei suoi lavori degli anni 1220-1235, in particolare i commentari aristotelici, Grossatesta delineò l’intelaiatura del corretto metodo scientifico. Anche se non seguì sempre i suoi stessi consigli nel corso delle sue ricerche, le sue opere sono considerate strumentali nella storia dello sviluppo della tradizione scientifica occidentale. Grossatesta fu il primo degli scolastici a comprendere pienamente la visione aristotelica del percorso duale del ragionamento scientifico, riassumendo particolari osservazioni in una legge universale e quindi ricavando da leggi universali la previsione dei particolari. Grossatesta chiamò questo processo “risoluzione e composizione”. Quindi ad esempio, guardando ai particolari della Luna è possibile arrivare a leggi universali sulla natura. Al contrario, una volta che queste leggi universali sono comprese, è possibile fare previsioni e osservazioni su altri oggetti oltre la Luna. Inoltre, Grossatesta disse che entrambi i percorsi devono essere verificati attraverso la sperimentazione allo scopo di verificarne i principi. Queste idee fondarono una tradizione che giunse fino a Padova e a Galileo Galilei nel XVII secolo. Nonostante l’importanza che la “risoluzione e composizione” avrebbe acquisito per il futuro della tradizione scientifica occidentale, più importante per il suo tempo fu l’idea della subordinazione delle scienze. Ad esempio, guardando geometria e ottica, l’ottica è subordinata alla geometria perché l’ottica dipende dalla geometria. Quindi Grossatesta concluse che la matematica era la principale tra tutte le scienze e la base per tutte le altre, poiché ogni scienza naturale dipende in ultima analisi dalla matematica. Egli sostenne questa conclusione guardando la luce, che egli credeva essere la “prima forma” di tutte le cose, fonte di tutta la generazione e il moto (approssimativamente ciò che oggi conosciamo come biologia e fisica). Quindi, poiché la luce poteva essere ridotta a linee e punti, e perciò completamente spiegata nell’ambito della matematica, la matematica costituiva per lui l’ordine più alto delle scienze. Ricevette la sua formazione a Oxford dove divenne esperto in legge, medicina e scienze naturali. Giraldo Cambrense, del quale aveva fatto conoscenza, lo presentò, prima del 1199, a William de Vere, vescovo di Hereford. Grossatesta aspirava ad un posto nella casa del vescovo, ma essendo stato deceduto il suo sostenitore, intraprese da sè lo studio della teologia. È possibile che abbia visitato Parigi a questo scopo, ma alla fine si stabilì a Oxford come professore e come capo dei francescani. Il suo successivo avanzamento di grado fu la cancelleria dell’università. Egli si distinse notevolmente come lettore, e fu il primo rettore della scuola che i francescani fondarono a Oxford attorno al 1224. La cultura di Grossatesta venne altamente lodata da Ruggero Bacone, che era un critico severo. Secondo Bacone, egli conosceva poco il greco o l’ebraico e prestava poca attenzione alle opere di Aristotele, ma prevaleva tra i suoi contemporanei per la sua conoscenza delle scienze naturali. Tra il 1214 e il 1231 Grossatesta resse in successione gli arcidiaconati di Chester, Northampton e Leicester. Nel 1232, dopo una grave malattia, rinunciò a tutti i suoi benefici e le promozioni, ad eccezione di una prebenda che deteneva a Lincoln. La sua intenzione era di passare il resto della vita in contemplativa religiosità, ma mantenne l’incarico di cancelliere e nel 1235 accettò il vescovato di Lincoln. Egli intraprese senza indugio la riforma della morale e della disciplina clericale in tutta la sua vasta diocesi. Questo schema lo mise in conflitto con più di una corporazione privilegiata, ma in particolare con il suo stesso ordine, che contestò vigorosamente la sua pretesa di esercitare il diritto di ispezione nelle sue comunità. La disputa si surriscaldò dal 1239 al 1245. Venne condotta da ambo le parti con indecorosa violenza, e quelli che più avevano approvato lo scopo principale di Grossatesta, ritennero necessario avvertirlo dell’errore commesso nell’essere troppo zelante. Nel 1245, grazie ad una visita personale alla corte papale di Lione, si assicurò un verdetto favorevole. In politica ecclesiastica il vescovo apparteneva alla scuola di Becket. Il suo zelo per la riforma lo portò ad avanzare, per conto delle corti, pretese cristiane che era impossibile venissero ammesse dal potere secolare. Egli incorse due volte nel rimprovero di Enrico III su questo argomento, anche se poi toccò a Edoardo I sistemare la questione di principio in favore dello stato. La devozione di Grossatesta alle teorie gerarchiche del suo tempo sono attestate dalla corrispondenza con il suo ordine e col re. Contro il primo confermò le prerogative dei vescovi e contro il secondo asserì che era impossibile per un vescovo non considerare gli ordini della Santa Sede. Dove le libertà della chiesa nazionale entravano in conflitto con le intenzioni di Roma, egli stava dalla parte dei suoi compatrioti. Così nel 1238 chiese che il re rilasciasse alcuni studiosi di Oxford che avevano assalito il legato Otho. Ma almeno fino al 1247 si sottomise pazientemente alle interferenze papali, accontentandosi della protezione (per via di uno speciale privilegio papale) della sua diocesi da chierici stranieri. Era più impaziente con le esazioni reali; e dopo il ritiro dell’Arcivescovo Sant’Edmondo si costitui come portavoce dello stato clericale nel gran Consiglio. Nel 1244 sedette nel comitato incaricato di considerare una domanda di sussidio. Il comitato rigettò la richiesta, e Grossatesta impedì un tentativo del re di separare il clero dal baronaggio. “È scritto”, disse il vescovo, “che uniti restiamo in piedi e divisi cadiamo”. Fu comunque ben presto chiaro che il re e il papa erano alleati per annullare l’indipendenza del clero inglese, e dal 1250 in avanti Grossatesta criticò apertamente i nuovi espedienti finanziari a cui papa Innocenzo IV era stato costretto dal suo disperato conflitto con l’impero. Nel corso di una visita fatta ad Innocenzo in quell’anno, il vescovo presentò a papa e cardinali un memoriale scritto, nel quale attribuiva tutti i mali della chiesa all’influenza maligna della Curia. La cosa non produsse effetti, anche se i cardinali ritennero che Grossatesta fosse troppo influente per essere punito per la sua audacia. Grandemente scoraggiato dal suo fallimento, il vescovo pensò di ritirarsi. Alla fine comunque, decise di continaure la lotta impari. Nel 1251 protestò contro un mandato papale che invitava il clero inglese a versare a Enrico III un decimo delle proprie entrate per finanziare una crociata e attirò l’attenzione sul fatto che, col sistema della raccolta di fondi, una somma di 70.000 marchi veniva sottratta annualmente all’Inghilterra dagli incaricati di Roma. Nel 1253, essedogli stato ordinato di offrire la sua diocesi a un nipote del papa, scrisse una lettera di rimostranza e rifiuto, non al papa in persona, ma ad un suo commissario, Maestro Innocenzo, attraverso il quale aveva ricevuto il mandato. Il testo della rimostranza, come riportato dagli annali di Burton e da Matthew Paris, è stato forse alterato da un falsario che aveva meno rispetto per il papato di quanto ne avesse Grossatesta. Il linguaggio è più violento di quello impiegato altrove dal vescovo, ma la questione generale, che il papato può chiedere obbedienza solo se i suoi ordini sono consoni all’insegnamento di Cristo e degli apostoli, è quello che ci si attende da un riformatore ecclesiastico dell’epoca di Grossatesta. Ci sono più motivi di sospettare della lettera indirizzata “ai nobili d’Inghilterra, ai cittadini di Londra, e alla comunità dell’intero reame,” nella quale Grossatesta viene rappresentato mentre denuncia senza mezzi termini la finanza papale in tutti i suoi rami. Ma anche in questo caso si deve avere una certa tolleranza per la differenza tra gli standard di decoro moderni e medioevali. Grossatesta figurò tra gli amici più intimi del professore francescano Adam Marsh. Tramite Adam giunse ad una stretta relazione con Simon de Montfort. Dalle lettere del francescano emerge che il conte aveva studiato un trattato politico di Grossatesta sulle differenze tra la monarchia e la tirannia, e che aveva abbracciato con entusiasmo il progetto di riforma ecclesiasitca del vescovo. La loro alleanza iniziò già nel 1239, quando Grossatesta si sforzò di portare la riconciliazione tra il re e il conte. Ma non c’è motivo di supporre che le idee politiche di Montfort siano maturate prima della morte di Grossatesta, ne tantomeno che quest’ultimo si sia troppo occupato della politica secolare, eccetto quando questa toccava gli interessi della Chiesa. Grossatesta capì che il malgoverno di Enrico III ed il suo patto senza principi con il papato rendevano ampiamente conto della degenerazione della gerarchia inglese e del lassismo nella disciplina ecclesiastica, ma difficilmente può essere definito un costituzionalista. Era già un uomo anziano, con una salda reputazione, quando divenne vescovo. Come statista ecclesiasitco mostrò lo stesso zelo impetuoso e la stessa versatilità di cui aveva dato prova nella sua carriera accademica, ma la tendenza generale degli autori moderni e stata quella di esagerare le sue funzioni politiche ed ecclesiastiche e di ignorare la sua attività come scienziato e studioso. L’opinione del suo tempo, così come viene espressa da Matthew Paris e Ruggero Bacone, fu molto differente. I suoi contemporanei, pur ammettendo l’eccellenza delle sue intenzioni come statista, evidenziano i suoi difetti di carattere e discrezione, ma vedono in lui il pioniere di un movimento scientifico e letterario. Non solamente un grande ecclesiastico che patrocinò lo studio nel suo tempo libero, ma anche il primo matematico e fisico del suo tempo. È certamente vero che anticipò in questi campi del pensiero alcune delle idee più brillanti alle quali Ruggero Bacone diede successivamente più ampia risonanza.
RUGGERO BACONE

Ruggero Bacone nacque fra il 1210 e il 1220 in Inghilterra a Ilchester , nella contea di Somerset , e studiò a Oxford , dove venne a conoscenza delle dottrine di Roberto Grossatesta sulla luce e sull’ illuminazione . Successivamente fu a Parigi sino al 1247 ; qui conobbe Alessandro di Hales , da lui criticato per la sua ignoranza in fisica e metafisica , e insegnò forse nella facoltà delle Arti , commentando opere di Aristotele . Nel 1247 , tornò ad Oxford ed entrò in contatto con il francescano Adam Marsh , che vi insegnava teologia ; poi é di nuovo a Parigi nel 1251 , dove glossa il Secretum secretorum , un’ opera di alchimia , che egli credeva di Aristotele , e , infine , é ancora ad Oxford . In questo periodo Bacone compone commenti ad opere di Aristotele e una ventina di scritti di medicina , alchimia , astronomia , tra cui una ” Epistula de secretis operibus naturae et de nullitate magiae ” . Verso il 1257 entra nell’ ordine francescano , ma dopo il 1260 subisce le conseguenze del nuovo corso impresso all’ ordine da Bonaventura e sancito nel Concilio di Narbona , che implicava il divieto agli appartenenti all’ ordine di comunicare con estranei senza l’ approvazione delle autorità : Bacone , infatti , avvertirà questa misura come un limite alla comunicazione del sapere . Nel 1264 Guido Fulcodi , già collaboratore del re di Francia Luigi IX e con il quale Bacone era già stato in contatto , diventa papa con il nome di Clemente IV e chiede a Bacone di inviargli la sua opera , volta a rinnovare il sapere e a superare le difficoltà che travagliano la cristianità all’ interno e all’ esterno , con la minaccia dei tartari e quella culturale dell’ Islam . Bacone condivide con Adam Marsh il senso del pericolo di un avvento dell’ Anticristo , mago capace di approfittare delle discoride che attraversano il mondo cristiano e servirsi del potere della sapienza per trasformare ogni cosa in male . Esso deve essere combattute con le armi del vero sapere ; la crociata é una questione non solo militare , ma intellettuale e religiosa insieme . La formazione scientifica che Bacone ha ricevuta lo convincono che il dibattito accademico del suo tempo presenta gravi pecche. Aristotele è conosciuto solo attraverso traduzioni scadenti; nessuno dei professori vuole cimentarsi con lo studio del greco. Analoga situazione per lo studio delle Sacre Scritture. La scienza fisica non viene sviluppata attraverso esperimenti secondo lo stile degli aristotelici, ma mediante argomentazioni basate sulla tradizione. Bacone si allontana dalla routine scolastica e si dedica allo studio delle lingue e alla ricerca sperimentale. L’unico insegnante che rispetta è un certo Petrus de Maharncuria Picardus, cioè “della Piccardia”, probabilmente identificabile con un matematico chiamato anche Petrus Peregrinus di Piccardia, che forse è l’autore di un trattato manoscritto, il De Magnete, conservato nella Bibliotheque Imperiale di Parigi. Il contrasto tra la poca notorietà di quest’uomo con la fama goduta dai loquaci giovani dottori suscita la sua indignazione. Nei suoi libri Opus Minus e Opus Tertium, Bacone porta avanti una violenta invettiva contro Alessandro di Hales ed un altro professore che, a suo parere, impara insegnando agli altri e adotta un tono dogmatico che gli consente di essere accolto a Parigi tra gli applausi come se valesse quanto Aristotele, Avicenna o Averroè. Bacone incontra poi il Cardinale Guy le Gros de Foulques, che si interessa delle sue idee e gli chiede di compilare un trattato sistematico. Bacone inizialmente esita a causa della regola dell’Ordine francescano che vieta che i suoi membri pubblichino alcunché senza un permesso specifico. Ma il cardinale diventa il papa Clemente IV e torna a sollecitare Bacone di ignorare il divieto e di scrivere il suo trattato in segreto. Bacone allora acconsente e nel 1267 invia al papa la sua opera, intitolata Opus Majus, un trattato sulle scienze (grammatica, logica, matematica, fisica e filosofia). Questa viene seguita nello stesso anno da una Opus Minus, un sommario delle idee più rilevanti della sua prima opera. Nel 1268 riesce ad inviare al papa la sua Opus Tertium; questi però muore quello stesso anno. Bacone cade allora in disgrazia e successivamente dallo stesso Ordine francescano viene imprigionato per la seconda volta nel 1278, con l’accusa di diffusione di idee dell’alchimia araba, ma senza dubbio anche per il fatto che le sue proteste contro l’ignoranza e l’immoralità del clero avevano fatto nascere nei suoi confronti una accusa di stregoneria. Bacone rimane imprigionato per più di dieci anni, fino a che l’intercessione di alcuni nobili inglesi gli assicura la liberazione. Nei suoi scritti Bacone reclama una riforma degli studi teologici. Si dovrebbe dare meno enfasi alle distinzioni filosofiche minori discusse nella Scolastica, mentre la stessa Bibbia dovrebbe tornare al centro dell’attenzione e i teologi dovrebbero studiare approfonditamente le lingue nelle quali i testi originali sono stati composti. Egli in effetti padroneggia parecchie lingue e lamenta la corruzione dei testi sacri e delle opere dei filosofi greci dovuta ai numerosi errori di traduzione e di interpretazione. Inoltre Bacone spinge tutti i teologi a studiare accuratamente tutte le scienze e di aggiungerle al normale curricolo universitario. Pagina con studi d’ottica di BaconeBacone disponeva di una delle più autorevoli intelligenze del suo tempo, e forse di tutti i tempi, e nonostante i tanti svantaggi e impedimenti che deve subire, riesce a compiere molte scoperte e ad avvicinarsi ad un numero ancora maggiore. Egli rifiuta di seguire ciecamente le autorità precostituite, sia sul piano teologico che su quello scientifico. La sua “Opus Majus” contiene trattazioni di matematica, ottica, alchimia e manifattura della polvere da sparo, le posizioni e le estensioni dei corpi celesti, compresa la chiara affermazione della rotondità della terra; l’opera inoltre anticipa successive invenzioni come il microscopio, il telescopio, gli occhiali, le macchine volanti e le navi a vapore. Bacone studia anche l’astrologia ed è convinto che i corpi celesti esercitino una influenza sul fato e la mente degli umani. A lui si deve anche una critica al calendario giuliano allora in uso. Per primo dopo gli scienziati ellenistici riconosce lo spettro visibile in un bicchiere d’acqua, secoli prima dei lavori di ottica di personaggi come Marcantonio de Dominis, Cartesio e Isaac Newton. A lui si devono anche misurazioni sull’arcobaleno. Egli fu un entusiasta sostenitore e praticante del primato dell’esperienza come mezzo per acquisire conoscenze intorno al mondo. Secondo Bacone, infatti, tre sono i modi in cui l’uomo può attuare la conoscenza della verità: con la conoscenza interna (data da Dio tramite illuminazione), con la ragione (che per Bacone da sé non è sufficiente) o con l’esperienza sensibile (ossia tramite i 5 sensi), ma solo quest’ultima modalità ci consente di avvicinarci massimamente all’oggettiva conoscenza del reale. Sulla base di questa concezione empirica della conoscenza, Bacone tentò anche di tracciare una enciclopedia generale delle scienze, tale da liberare il sapere da tutte quelle dispute oziose tipiche della scolastica precedente, vittima del principio di autorità e di una applicazione astratta e distorta della ragione. Secondo Bacone suprema scienza è la matematica, sussidiaria di tutte le altre scienze, e solo la connessione di questa con l’esperienza concreta del reale può consentire all’uomo di scorgere i rapporti quantitativi e matematici che reggono il mondo sensibile. Conoscere è quindi un modo per ri-conoscere la realtà, cioè fare esperienza sensibile di quella rivelazione che è già presente nelle Scritture; ma conoscere significa anche entrare in possesso di una capacità tecnica, che secondo Ruggero Bacone potrà mettere in condizione l’uomo, in futuro, di manipolare la realtà e modificarla, ad es. costruendo macchine per volare oppure per sollevare pesi etc. Va tuttavia sottolineato che le affermazioni di Bacone, pur innovando il pensiero medioevale nella direzione di un vero e proprio metodo empirico appropriato alla scienza, costituiscono soltanto un primo e astratto passo in questo percorso di autonomia del sapere dalla fede. Le sue affermazioni restano infatti del tutto generiche e vaghe sul metodo con cui concretamente condurre l’esperienza nella conoscenza del reale. Molti autori, soprattutto a partire dall’epoca rinascimentale, sono stati attratti dalla figura di Ruggero Bacone come l’incarnazione del saggio e sottile possessore di conoscenze negate ai più e forse proibite, simile a un dottor Faust. Intorno alla sua figura sono cresciute numerose leggende e storie impossibili a verificarsi, ad esempio quella che egli avesse creato una testa di ottone parlante in grado di rispondere ad ogni quesito; questa diceria ha un ruolo centrale nell’opera teatrale Friar Bacon and Friar Bungay scritta da Robert Greene intorno al 1589. Probabilmente la più completa ed accessibile descrizione della vita di Ruggero Bacone è contenuta nel libro Doctor Mirabilis, scritto nel 1964 dall’autore di fantascienza James Blish. Si tratta del secondo libro (inedito in Italia) di una trilogia quasi religiosa, intitolata After Such Knowledge (o Apocalisse), e si configura come un racconto completo, a tratti autobiografico della vita di Bacone e del suo sforzo volto a sviluppare una “scienza universale”. Si tratta di un testo basato su ricerche approfondite anche per un accademico e ricco di riferimenti, comprese ampie citazioni dalle opere del protagonista, ma presentato secondo lo stile romanzesco; l’autore lo considera un’opera di fantasia o una visione.
RAIMONDO LULLO

Raimondo Lullo (Palma de Mallorca, 1235 – Palma de Mallorca, 29 giugno 1315) è stato un filosofo spagnolo, di cultura e lingua catalana, fra i più celebri nell’Europa del tempo. Raimondo Lullo – Ramon Llull in catalano– fu filosofo, scrittore e missionario. Suo padre, per i servigi prestati al re Giacomo I di Aragona, ricevette onorificenze e terre nell’isola di Maiorca. Nel 1247 Raimondo è nominato paggio del re e in seguito siniscalco e maggiordomo dell’Infante. Nel 1257 sposa Bianca Picany dalla quale ha due figli ma nel 1262 avviene la svolta nella sua vita. Nella sua Vita Coetanea Lullo narra la propria conversione: ha cinque visioni di Cristo e alla quinta si convince che, benché peccatore, sia chiamato da Dio. Decide di farsi missionario e di convertire i musulmani e gli ebrei, i quali, già credendo nell’esistenza di un essere del quale non si può pensare altro di maggiore, come insegna Anselmo d’Aosta, devono necessariamente essere cristiani. Ma, nonostante le visioni, continua a condurre la solita vita licenziosa finché, dopo aver ascoltato una predicazione su San Francesco d’Assisi, si consiglia col domenicano Raimondo di Peñafort, che lo convince: nel 1263 vende tutti i suoi beni lasciandone una parte alla moglie e ai figli, e consacra la propria esistenza alla penitenza. Si compra comunque un servo che gli insegni l’arabo, lingua utile alla conversione dei falsi credenti. Dopo un pellegrinaggio a Santiago de Compostela, studia filosofia, teologia, medicina, il latino, il provenzale e l’arabo; assimila parte della cultura dell’epoca: Aristotele, Platone, Sant’Agostino, Anselmo d’Aosta, Riccardo di san Vittore, i filosofi arabi. Compone una prima versione dell’Ars magna e il Libro della contemplazione in Dio. Chiamato a Montpellier dal re Giacomo II, vi compone l’Arte dimostrativa; fonda a Mallorca, nel 1276, il collegio di Miramar (Deià) per preparare i futuri missionari mediante lo studio delle lingue e dalla sua Ars magna. Comincia ora la sua carriera di missionario laico, percorrendo mezza Europa e specialmente le coste del Mediterraneo, sollecitando aiuti dai regnanti e dai papi ed esponendo la sua Ars magna nelle piazze e nelle università, in particolare a Parigi, dove riceve il titolo di maestro delle Arti, ma non di maestro di teologia perché sposato e privo degli ordini sacri. Vi scrisse vari libri e disputò contro gli averroisti. Nel 1295 si fa terziario francescano ad Assisi. Brevemente a Maiorca nel 1300, dove continua a scrivere e a disputare contro arabi ed ebrei, riprende i suoi viaggi che lo portano a Cipro, in Armenia, a Rodi, Malta, Napoli, Genova, Montpellier, Parigi, nel nord Africa. Qui viene incarcerato; rilasciato, riprende i viaggi: dopo un naufragio, va a Pisa e si ritira nel convento di san Domenico dal 1307 al 1308, continuando a scrivere. Una sua nuova permanenza a Parigi provoca una persecuzione contro gli averroisti, da lui considerati eretici perché mantengono separata la filosofia dalle verità di fede. Dedica al re di Francia Filippo il Bello l’Albero della filosofia d’amore. Partecipa nel 1311 al Concilio di Vienne, dove chiede invano la ripresa delle crociate e di vietare l’insegnamento dell’averroismo, e riprende a viaggiare: aggredito a Tunisi, viene sottratto a stento al linciaggio e imbarcato in gravissime condizioni in una nave genovese fino a Maiorca dove muore nel 1315. In virtù della sua tragica morte fu beatificato come martire da Papa Pio IX; la sua festa liturgica è il 30 giugno. Statua dedicata a Raimondo Lullo nell’università di BarcellonaIl corpus lulliano comprende 243 opere riconosciute come autografe e 44 forse apocrife: fra quest’ultime, tutte quelle di argomento alchemico. Scrisse in arabo, in latino e in catalano. Sono opere di filosofia, teologia, mistiche, pedagogiche, di medicina, di scienze naturali, di fisica, matematica, letterarie e poetiche. Tra le tante, Ars magna; De levitate et ponderositate elementorum; Vita coetanea; Ars amativa; Felix de les meravelles; il Libro dell’ordine di cavalleria; il Libro del pagano e dei tre savi; il Libro della contemplazione di Dio; Lo sconforto; Logica nova; Ars generalis. Il De amic i amat, 365 versi in catalano, espone l’ascesi dell’uomo a Dio, con influssi di poesia trovadorica e riferimenti al Cantico dei Cantici e alla mistica araba. Il Plant de nostra dona Santa Maria e il Desconhort i cant de Ramon sono le sue migliori prove liriche: egli converte il catalano popolare in lingua letteraria tanto da porsi come il più notevole scrittore di questa lingua. Scrisse anche il racconto, utopistico e insieme autobiografico, Blanquerna, verso il 1284, ricco di idee, di vita e di spiritualità, dove espone anche i suoi piani di educazione dei cristiani e dei mussulmani; il Felix de les maravelles, intorno al 1288, è una sorta di racconto enciclopedico, dalle scienze naturali alla teologia; scrisse anche un manuale cavalleresco, il Del Ordre de Cavayleria. La Dottrina puerile, forse composta nel 1273, è il primo manuale conosciuto di istruzione dei bambini scritto in una lingua romanza. La sua pedagogia ha lo scopo di provvedere ai mezzi per conseguire la salvezza spirituale e, insieme, la cristianizzazione degli infedeli. Formulò anche i principi di un insegnamento intuitivo e analogico, raccomandò che la lingua nativa si insegnasse prima della latina, e che fossero docenti stranieri a insegnare la loro lingua. Auspicò anche la creazione di una lingua universale. La sua filosofia è influenzata da Sant’Agostino e dalle correnti mistiche francescane; non distinguendo nettamente filosofia e teologia, costruisce una sapienza cristiana secondo i suoi prevalenti intenti apologetici, per cui si può parlare di un suo razionalismo apologetico. Conosce Aristotele attraverso il filosofo arabo al-Ghazali da cui trasse un Compendio di logica, assimilandone la dottrina delle proposizioni e del sillogismo, ma la sua logica non è quella scolastica, formale o di seconda intenzione, distinta dalla teologia, bensì è un mezzo per ragionare sulle verità divine. Il problema che Lullo cerca di risolvere deriva da Aristotele che distinse i principi comuni a ogni scienza dai principi propri di ciascuna. Si tratta, per Lullo, di trovare una scienza generale, tale che, nei principi di questa, siano contenuti i principi di tutte le scienze particolari. L’Ars generalis, 1308, redazione finale di una precedente Ars compendiosa inveniendi veritatem o Ars magna primitiva, del 1274, vuole dunque essere la scienza suprema, da cui dipendano tutte le altre; non è propriamente una logica ma un’arte di ricerca. Mentre per Aristotele i principi non si basano su dimostrazioni ma derivano dall’esperienza e dall’induzione, Lullo crede di risolvere ogni problema con precisione matematica: parte dal presupposto che ogni proposizione sia riducibile a termini e i termini complessi siano riducibili a più termini semplici o principi. Supposto di aver completato il numero di tutti i termini semplici possibili, combinandoli in tutti i modi possibili si otterranno tutte le proposizioni vere possibili: nasce così l’arte combinatoria, anche come forma di mnemotecnica, in quanto facilita la memorizzazione delle nozioni di base. Questa concezione potrebbe avere avuto influenza sui successivi sviluppi del calcolo computazionale e su questioni riguardanti l’intelligenza artificiale. Occorre ora scoprire tutti i termini semplici e trovare la regola che li combini. Egli individua 9 predicati assoluti, che sono i nove attributi divini: bontà, grandezza, eternità, potenza, sapienza, volontà, virtù, verità e gloria; 9 relazioni: differenza, concordanza, contrarietà, principio, mezzo, fine, maggioranza, minoranza ed eguaglianza; ma poi deve aggiungere 9 questioni, 9 soggetti, 9 virtù e 9 vizi. Nel trattato Dell’ascesa e discesa dell’intelletto prova un nuovo metodo dialettico che prescinda dalle combinazioni dei termini. Con un movimento di ascesa l’intelletto raggiunge i principi primi, con il moto contrario acquisisce la conoscenza dei termini particolari. L’Albero della scienza è un testo di enciclopedia delle scienze, un tentativo di unificare tutto il sapere in uno schema gerarchico. L’insieme delle scienze si collegano fra di loro configurando un albero ove la trama dei concetti raffigura la realtà del mondo e di Dio. La metafisica lulliana è teologica, nel senso che si fonda sulla Rivelazione. Cerca di dare le prove dell’esistenza di Dio secondo la dottrina scolastica: Dio e le nove dignità divine sono la causa delle perfezioni create, cosicché tutte le creature mostrano gradualmente la loro somiglianza con Dio e dunque l’universo, secondo la tradizione agostiniana, è lo specchio del divino, il libro su cui s’impara a conoscere Dio, un sistema di segni che dimostrano la realtà divina. Dio è l’Idea eterna mentre le creature sono Idee nuove provenienti da Dio e dunque idee divine ma finite: la creazione non è pertanto avvenuta ab aeterno ma nel tempo. A Lullo furono attribuite numerose opere a carattere alchemico ma sono tutte apocrife; tra le più note è il Liber de segretis naturae seu de quinta essentia nel quale l’anonimo che si richiama a Lullo sostiene che mentre Dio può esercitare solo il bene, l’uomo può cadere nel male perché dispone solo del fuoco per purificare le cose terrene, ma con l’aiuto dei principi essenziali e con la fede può realizzare trasmutazioni naturali e raggiungere il bene. La scelta tra il bene ed il male appartiene al libero arbitrio, che è una conseguenza dell’ignoranza umana la quale è però voluta dalla stessa volontà divina ed è perciò anch’essa un bene. Alla sua morte restarono attivi i suoi seguaci in Francia, tra i quali Tommaso de Myésier che nel 1325 pubblica l’Electorium Remundi dove applica le dottrine del maestro alla cosmologia. Nel corso di tutto il secolo si attribuiscono a Lullo numerose opere di alchimia, astrologia e magia, con reazioni polemiche che portano la Sorbona a vietarne l’insegnamento nel 1390. I due secoli successivi segnano l’acme del successo di Lullo studiato, fra gli altri, da Nicola Cusano, Pico della Mirandola e Giordano Bruno. La sua arte si presta bene all’esigenza, fortemente sentita nel Rinascimento, di una scienza enciclopedica: fra le tante opere emergono il De arte cyclognomica, 1569, di Cornelio Gemma, le Syntaxes artis mirabilis di Pedro Gregoire di Tolosa e l’Opus aureum, 1589, di Valerio de Valeriis. L’interesse per l’arte combinatoria e la mnemotecnica, che ha radici risalenti a Cicerone, è affermata nell’Explanatio compendiosaque applicatio artis Raymundi Lulli, 1523, di Bernardo de Lavinheta e soprattutto nei De umbris idearum, Cantus Circaeus e Sigillus sigillorum di Giordano Bruno. Nel pensiero di Cartesio, soprattutto per quanto riguarda la sua concezione del metodo filosofico, vi è presenza di intuizioni lulliane. L’arte di Lullo infatti serve a risolvere ogni problema, attraverso la scomposizione di ogni quesito in parti più piccole e successivamente la riduzione in lettere dell’alfabeto. Queste lettere fanno parte di ruote che saranno in grado di fornire infinite combinazioni. Se si osserva quanto descritto nella prima parte del discorso sul metodo non si potrà che riscontrare una comunanza di idee di questi due filosofi. Inoltre sembra che il nome di Lullo sia l’unico nome di filosofo citato in un testo, Il discorso sul metodo, in cui compaiono solo Cartesio e Dio. Anche Leibniz è interessato agli studi sulla lingua e alla sua concezione della logica. Dall’analisi dei filosofi che teorizzano la nuova scienza risulta innegabile la connessione con alcune idee cardine del pensiero di Lullo, quale l’ideale enciclopedico, l’utilizzo della matematica (scartata dal profeta della scienza moderna, Francesco Bacone) e il calcolo computazionale. Da queste ricerche risuta chiaro quanto l’importanza del pensiero di Lullo non sia inscritta solamente nella mnemotecnica, ma attraversi anche riflessioni teoreticamente più importanti come la struttura della scienza della logica e del linguaggio.
DIONIGI L’AREOPAGITA

BREVE INTRODUZIONE
Dionigi è il primo a tematizzare in modo sistematico l’apofatismo, ovvero a elaborare una ” teologia negativa “.
In sintesi ciò significa che è molto di più ciò che di Dio, Mistero infinito, non possiamo conoscere, che non ciò che di Lui possiamo conoscere.
La sua teologia si scandisce in tre momenti: 1) teologia katafatica (o positiva): il Mistero è conoscibile mediante i suoi effetti, cioè la creatura, che Gli è in qualche modo simile; in questo senso possiamo dire che Dio è tutto ciò che nel creato è perfezione: ad esempio vita, piuttosto che morte, potenza, piuttosto che impotenza, intelligenza, amore, libertà, giustizia. 2) teologia apofatica (o negativa): le perfezioni che attribuiamo a Dio non sono tali quali le conosciamo nella nostra esperienza di creature: tra Creatore e creatura vi una distanza infinita, dunque una dissimiglianza maggiore della somiglianza; in questo senso possiamo dire che Dio è non-vita, non-potenza, non-intelligenza etc., nel senso che non è tali perfezioni come le conosciamo noi. 3) teologia superlativa : il Mistero ha in sè tutte le perfezioni presenti nel creato (katafatismo), ma non quali le conosciamo noi (apofatismo), bensì in grado infinitamente perfetto; in questo senso possiamo dire che Dio è super-vita, super-potere, super-intelligenza etc. In Dionigi manca quello che per la cultura occidentale, da S.Agostino in poi, è diventata una componente essenziale, la storia: l’immagine del mondo che egli trasmette è quella di una contemplante, pacificata adorazione liturgica. Ma, se tale concezione può integrare la frenesia attivistica tipicamente occidentale, non può eliminare il senso drammatico della storia come lotta.
IL PENSIERO
Vissuto verso la fine del V secolo, quando ormai il cristianesimo era la religione ufficiale dell’impero, Dionigi fu un convinto neoplatonico convertito al cristianesimo e desideroso di determinare un punto di convergenza fra la nuova fede e l’ultima grande filosofia pagana. Nella sua dottrina si possono rintracciare i temi centrali del neoplatonismo procliano: 1) Dio (l’Uno di Proclo) è al di là dell’essere e del conoscere, assolutamente altro, ineffabile. È principio sovraessenziale che risiede nelle tenebre, la “tenebra divina” che è “luce inaccessibile”. Conoscere Dio è non conoscere, negare cioè ogni categoria logica e ontologica; 2) la struttura gerarchica della realtà che deriva per emanazione da Dio e che si articola in una serie di gradi ontologici che trovano la loro fondazione nel processo di comunicazione della bontà divina e la loro perfezione nel ritorno a Dio, che è Bene e Uno; 3) l’unione (hènosis) dell’anima a Dio mediante l’estasi, vale a dire uscendo da sé stessi e appartenendo totalmente a Dio. Nel processo creativo, o emanazione, Dio si manifesta: è quindi possibile attribuire a Dio tutti gli aspetti, gli attributi degli esseri creati. Secondo questo metodo si costituisce la teologia affermativa o catafatica che applica a Dio le affermazioni particolari relative agli esseri (Dio è bontà, bellezza, essere, vita, etc.). Ma nessun nome intelligibile può designare propriamente ciò che Dio è, poiché è al di sopra di tutti gli esseri creati designati da questi nomi. La teologia affermativa deve pertanto cedere il passo a quella negativa o apofatica, alla via, cioè, che procede per negazione, così da negare di Dio ogni cosa che possa dirsi delle creature (Dio non è essere, non è vita, non è luce, etc.): questo è il metodo più proprio per parlare di Dio e risalire a lui nelle “tenebre” della sua “luce inaccessibile”. Secondo Dionigi, infatti, queste negazioni devono essere intese non già in senso privativo, bensì in senso trascendente, e per questo motivo la teologia negativa può essere concepita come super-affermativa: ad esempio, Dio è super-bene, super-essere, super-vita. Poiché Dio è assolutamente estraneo ad ogni forma di conoscenza perché al di là di ogni affermazione e negazione, e quindi al di fuori di ogni discorso razionale, solo chi supera ogni forma di conoscenza può unirsi al principio del tutto, all’Uno inconoscibile: “Proprio perché non conosce più nulla, conosce al di sopra dell’intelligenza”. Al vertice del processo apofatico resta una conoscenza che non è conoscenza, una visione soprarazionale nelle tenebre : ” la tenebra divina è luce inaccessibile in cui si dice che risieda Dio “. Quindi nella ” totale assenza di parole e di pensieri ” si realizza l’unione (hènosis) della mente umana con l’Uno. L’uomo per conoscere Dio si deve unire a Dio, e perché ciò sia possibile deve uscire da sé stesso e diventare uno con Dio mediante l’estasi. La conoscenza di Dio presuppone, pertanto, la divinizzazione dell’uomo. La tradizione mistica medievale attingerà sempre a Dionigi i grandi temi della ineffabilità divina, della tenebra luminosissima, dell’unione con Dio nell’assenza di ogni conoscenza, nell’unità semplicissima della mente umana. La teologia negativa dell’Areopagita è così interessante che viene da chiedersi come mai dopo di essa non si sia sviluppato l’ateismo. Dionigi infatti pone un Dio talmente al di là dell’umana comprensione che se la sua teologia non restasse ferma alla contemplazione mistica, ma procedesse oltre, anche di poco, col ragionamento logico (beninteso), alla fine la conclusione non potrebbe essere che una: Dio non esiste per l’uomo e, se esiste, gli è del tutto indifferente. Una teologia di questo tipo non poteva che nascere in un’epoca di decadenza, cioè in un’epoca in cui la comunità cristiana era consapevole di non aver realizzato i propri ideali. L’apofatismo di Dionigi, che è diverso da quello della Patristica orientale, in quanto di tipo filosofico-religioso più che teologico, è servito, o meglio, è stato usato per giustificare il fallimento della rivoluzione cristiana, rimandandone l’esito a un futuro escatologico, e contribuendo ad approfondire la separazione tra uomo e Dio. E’ probabile però che le intenzioni di Dionigi fossero semplicemente quelle di testimoniare un fallimento in atto. La strumentalizzazione è avvenuta in un secondo momento. La sua teologia, tuttavia, è molto più tollerante di quella cattolico-romana, che ha sempre avuto la pretesa di realizzare adeguatamente la volontà di Dio. Da notare che quando il cattolicesimo ha smesso d’avere questa pretesa, s’è trasformato, nel nord Europa, in protestantesimo, il quale, non a caso, ha ribadito subito l’assoluta differenza o alterità tra uomo e Dio. La differenza tra ortodossia e protestantesimo, in questo senso, sta nel fatto che la prima affermò l’apofatismo in un contesto sociale ancora dominato, nonostante tutto, dai valori pre-borghesi; il secondo invece ha allontanato Dio dall’uomo per poter legittimare (quanto consapevolmente non importa) il modo di produzione capitalistico. Tornando a Dionigi, si può affermare che la mistica può diventare intollerante solo nel caso in cui -come in Heidegger- si pretende di dire l’ultima parola sull’essere, cioè nel caso in cui la contemplazione è “forzata” e l’attesa di un “avvento illuminante-proteggente” è in realtà l’attesa da parte di un “metafisico” (un filosofo di professione) che vuole essere confermato e non smentito nelle proprie convinzioni. Viceversa, la teologia negativa di Dionigi era “aperta”, poiché consapevole del “declino” ideale (non storico) del cristianesimo (il declino storico, in Oriente, avverrà dopo il Mille, in concomitanza con le crociate occidentali). Non era una teologia conservatrice, anche se evitava di affrontare temi di carattere sociale. Era piuttosto una teologia aristocratica, senza essere decadente. Denunciava un limite senza offrire una soluzione per superarlo.
PASSI DALLE OPERE
Identità e Differenza di Dio
Il Medesimo è soprasostanzialmente eterno, invariabile, rimane sempre in se stesso, è sempre nella stessa maniera e si mantiene ugualmente presente a tutte le cose, collocato egli stesso per se stesso e da se stesso stabilmente e intemeratamente nei bellissimi confini di un’Identità soprasostanziale, senza cambiamento, senza perdita, inflessibile, invariabile, non mescolato, immateriale, semplicissimo, senza bisogno, senza crescita, senza diminuzione, senza nascita: non nel senso che non sia ancora creato o che sia incompiuto (…) ma congiunge gli esseri gli uni con gli altri, in quanto abbondante e causa di identità che contiene in antecedenza in sé, alla stessa maniera, anche le cose contrarie secondo una sola ed unica Causa sovraeminente di tutte l’identità.
(Dionigi Areopagita, De divinis nominibus, IX, 4, 912 B-C)
Dio è Alterità per il fatto che mediante la sua provvidenza è presente a tutti e si fa tutto in tutti per la salvezza di tutti, rimanendo in se stesso e fermo nella sua propria identità, mantenendosi secondo un’azione unica e ininterrotta e dandosi con una forza che non viene mai meno per la deificazione di quelli che si rivolgono a lui. Bisogna credere che la diversità delle figure varie di Dio secondo le multiformi apparizioni indicano qualche cosa di diverso da ciò che appaiono per coloro ai quali appaiono (…). Ora guardiamo la stessa Diversità divina, non come un mutamento entro l’Identità inconvertibile, ma come Unità di lui capace di moltiplicarsi e procedimenti della fecondità che produce tutti gli esseri .
(Dionigi Areopagita, De divinis nominibus, IX, 5, 912 D – 913 B)
ALBERTO MAGNO

Alberto Magno (Lauingen, 1206 – Colonia, 15 novembre 1280), conosciuto anche come Sant’Alberto il Grande, Alberto di Colonia o Doctor Universalis, era un vescovo domenicano. Egli è considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del medioevo sia per la sua grande erudizione che per il suo impegno a livello logico-filosofico nel far coesistere fede e ragione applicando la filosofia aristotelica al pensiero cristiano. Fu, inoltre, anche il maestro di San Tommaso d’Aquino. La Chiesa cattolica lo venera come santo protettore degli scienziati e come Dottore. Alberto, figlio minore del Conte di Bollstädt, nacque a Lauingen (Svevia) nel 1205 o nel 1206, anche se molti storici indicano quale suo anno di nascita il 1193. Nulla di certo è noto della sua istruzione primaria, se sia stata ricevuta in casa o in una scuola del circondario. Da giovane, comunque, fu mandato a proseguire i suoi studi presso l’Università di Padova, città scelta sia perché vi risiedeva un suo zio, sia perché Padova era famosa per la sua cultura delle arti liberali, per le quali il giovane svevo aveva una speciale predilezione. La data di questo viaggio a Padova non può essere determinata con precisione. Nell’anno 1223, dopo aver ascoltato i sermoni del Beato Giordano di Sassonia, secondo Maestro Generale dell’ordine dei predicatori, divenne un domenicano. Gli storici non riportano se gli studi di Alberto continuarono a Padova, Bologna, Parigi, o Colonia. Comunque, dopo averli completati, insegnò teologia a Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Strasburgo e Colonia. Si trovava nel convento di Colonia, intento nello studio del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo, quando, nel 1245, gli fu ordinato di recarsi a Parigi. Qui si laureò all’università che più di ogni altra veniva celebrata come scuola di teologia. Durante il viaggio da Colonia e Parigi ebbe tra i suoi ascoltatori Tommaso d’Aquino, un giovane silenzioso e riflessivo del quale riconobbe il genio ed a cui predisse la futura grandezza. Il nuovo discepolo accompagnò il suo maestro a Parigi e, nel 1248, tornò con lui al nuovo Studium Generale di Colonia, del quale Alberto era stato nominato Rettore, mentre Tommaso divenne secondo professore e Magister Studentium. Al Capitolo Generale dei Domenicani tenutosi a Valenciennes nel 1250, insieme a San Tommaso d’Aquino ed a Pierre de Tarentaise, elaborò le norme per la direzione degli studi, e per la determinazione del sistema di meriti all’interno dell’ordine. Quindi, nel 1254, fu eletto provinciale per la Germania, incarico difficile che ricoprì con efficienza e responsabilità. Nel 1256 si recò a Roma per difendere gli ordini mendicanti dagli attacchi di Guglielmo di Saint-Amour, il cui libro, De novissimis temporum periculis, fu condannato da Papa Alessandro IV il 5 ottobre 1256. Durante la sua permanenza nell’Urbe, Alberto ricoprì l’ufficio di Maestro del Sacro Palazzo (istituito ai tempi di San Domenico) e colse l’occasione per commentare il Vangelo secondo Giovanni. Nel 1257, però, per dedicarsi allo studio ed all’insegnamento, rassegnò le dimissioni dall’ufficio di provinciale. Nell’anno 1260 fu consacrato vescovo di Ratisbona. Umberto di Romans, Maestro Generale dei Domenicani, temendo di perdere i servigi di Alberto, tuttavia, cercò di impedirne la nomina, ma fallì. Alberto, infatti, governò la diocesi fino al 1262 quando, dopo che furono accettate le sue dimissioni, riprese volontariamente l’ufficio di professore presso lo Studium di Colonia. Nel 1270 inviò una memoria a San Tommaso, che si trovava a Parigi, per aiutarlo nella disputa con Sigieri da Brabante e gli averroisti. Questo fu il suo secondo trattato contro il filosofo arabo (il primo fu scritto nel 1256 con il titolo De Unitate intellectus Contra Averroem). Nel 1274 fu invitato da Papa Gregorio X a partecipare ai lavori del secondo Concilio di Lione, alle cui conclusioni prese parte attiva. L’annuncio della morte di San Tommaso a Fossanova, durante il viaggio che aveva intrapreso per partecipare ai lavori del Concilio, fu un duro colpo per Alberto, che lo commentò dichiarando che “La luce della Chiesa” si era estinta. Il suo antico spirito e vigore tornarono a galla nel 1277, quando fu annunciato che Etienne Templier, arcivescovo di Parigi, ed altri volevano condannare gli scritti di San Tommaso perché li consideravano poco ortodossi. Per tale motivo si mise in viaggio alla volta di Parigi, deciso a difendere la memoria del suo discepolo. Qualche tempo dopo, nel 1278 (anno in cui scrisse il suo testamento) ebbe dei vuoti di memoria; la sua forte mente a poco a poco si offuscò, il suo corpo fiaccato da una vita austera di privazioni e di lavoro cedette sotto il peso degli anni e morì nel 1280. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Colonia. Fu beatificato da Papa Gregorio XV nel 1622; la sua festa ricorre il 15 novembre. Nel settembre 1872, i vescovi tedeschi riuniti a Fulda inviarono alla Santa Sede una petizione per la sua canonizzazione. Finalmente, nel 1931, Papa Pio XI lo elevò agli onori dell’altare e lo proclamò Dottore della Chiesa. Nel 1941 Papa Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori delle Scienze naturali. Sono state pubblicate due edizioni dell’Opera Omnia di Alberto, la prima a Lione nel 1651 a cura di Padre Pietro Jammy, O.P., l’altra a Parigi (Louis Vivès) nel 1890-99, sotto la direzione dell’Abate Auguste Borgnet dell’Arcidiocesi di Reims. La cronologia delle opere fu stilata da Paul von Loë nella sua “Analecta Bollandiada” (De Vita et scriptis B. Alb. Mag., XIX, XX e XXI). La sequenza logica, invece, fu estrapolata da Padre Mandonnet, O.P., nel Dictionnaire de théologie catholique. L’elenco che segue indica gli argomenti dei vari trattati, i numeri si riferiscono ai volumi dell’edizione Borgnet. Logica: sette trattati (I 2). Scienze fisiche: Physicorum (3); De Coelo et Mundo (“Il cielo e il mondo”), De Generatione et Corruptione (“La generazione e la corruzione”), Meteororum (4); De Mineralibus (“I minerali”) (5); De Natura locorum, De passionibus aeris (9). Biologia: De vegetabilibus et plantis (“I vegetali e le piante”) (10); De animalibus (“Gli animali”) (11-12); De motibus animalium (“I moti degli animali”), De nutrimento et nutribili (“Il nutrimento e il nutribile”), De aetate (“L’età”), De morte et vita (“La morte e la vita”), De spiritu et respiratione (“Lo spirito e la respirazione”) (9). Psicologia: De Anima (“L’anima”) (5); De sensu et sensato (“Il senso e il sensato”), De Memoria, et reminiscentia, De somno et vigilia, De natura et origine animae, De intellectu et intelligibili (“L’intelletto e l’intellegibile”), De unitate intellectus contra Averroistas (“L’unità dell’intelletto contro gli Averroisti”) (9). Philosophia pauperum (“Filosofia dei poveri”): Morale e Politica: Ethicorum (7); Politicorum (8). Metafisica: Metaphysicorum (“Metafisica”) (6); De causis et processu universitatis (10). Teologia: Commentario su Dionigi l’Aeropagita (14); Commentario alle Sentenze di Pietro Lombardo (25-30); Summa Theologiae (31-33); Summa de creaturis (34-35); De sacramento Eucharistiae (“Il sacramento dell’Eucaristia”) (38); Super evangelium missus est (37). Esegesi: Commentari sui Salmi e sui Profeti (15-19); Commentari sui Vangeli (20-24); Sull’Apocalisse (38). Sermoni: De quindecim problematibus (“Su quindici problemi”), edito dal Mandonnet nel suo Siger de Brabant (Friburgo, 1899). L’autenticità delle opere seguenti non è stata accertata: De apprehensione (5); Speculum astronomiae (“Specchio di astronomia”) (5); De alchimia (38); Scriptum super arborem Aristotelis (38); Paradisus animae (37); Liber de Adhaerendo Deo (“Il dover accostarsi a Dio”) (37); De Laudibus Beatae Virginis (36); Biblia Mariana (37); Compendium theologicae veritatis (“Compendio della verità teologica”); De causis et proprietatibus elementorum (“Le cause e le proprietà degli elementi”); De erroribus philosophorum (“Gli errori dei filosofi”); De fato (“Il fato”); De lapidibus (“Le pietre”); De praedicabilibus (“Le cose lodevoli”); De praedicamentis (“Le categorie”); In categorias Aristotelis (“Nelle categorie di Aristotele”); Super geometriam Euclidis (“Sulla geometria di Euclide”). L’influenza esercitata da Alberto sugli studiosi dei suoi tempi e su quelli degli anni seguenti fu, naturalmente, molto grande. La sua fama è dovuta in parte al fatto che fu il precursore, la guida ed il maestro di San Tommaso d’Aquino, ma sicuramente è stato grande anche di per sé. È interessante notare come questo frate medioevale in mezzo ai suoi molti doveri di religioso, come provinciale del suo ordine, come vescovo e legato pontificio, come predicatore di una crociata, pur effettuando molti faticosi viaggi tra Colonia, Parigi e Roma e frequenti escursioni in varie parti della Germania, abbia potuto essere in grado di comporre una vera enciclopedia, contenente trattati scientifici su quasi ogni argomento dello scibile umano, mostrando una conoscenza della natura e della teologia che sorprese i suoi contemporanei, e ancora suscita l’ammirazione dei dotti dei nostri tempi. Fu, realmente, un Doctor Universalis. Di lui, i critici moderni hanno scritto: “Sia che lo consideriamo un teologo o un filosofo, Alberto è stato sicuramente, uno dei più straordinari uomini della sua età; si potrebbe dire, uno dei più meravigliosi uomini di genio che sono apparsi in passato ” (Jourdain, Recherches Critiques). Non sorprende che Alberto si fosse basato sulle fonti di informazioni che esistevano ai suoi tempi, in particolare sugli scritti scientifici di Aristotele. Tuttavia egli diceva: “L’obiettivo delle scienze naturali non è semplicemente accettare le dichiarazioni [narrata] degli altri, ma investigare le cause che sono all’opera in natura” (De Mineralibus Libro II, tr. ii, i). Nel suo trattato sulle piante affermò il principio: Experimentum solum certificat in talibus (L’esperimento è l’unica guida sicura in tali indagini). (De Vegetalibus, VI, tr. ii, i). Profondamente versato come era in teologia, egli dichiarava: “Nello studiare la natura non abbiamo a indagare come Dio Creatore può usare le sue creature per compiere miracoli e così manifestare la sua potenza: abbiamo piuttosto a indagare come la Natura con le sue cause immanenti possa esistere” (De Coelo et Mundo, I, tr. iv, x). Anche se sulle scienze naturali preferiva Aristotele a Sant’Agostino, egli non esitava a criticare il filosofo greco. “Chiunque creda che Aristotele fosse un dio, deve anche credere che non commise alcun errore. Ma se si crede che Aristotele sia stato un uomo, allora è stato certamente passibile di errori, così come lo siamo noi.” (Physic. lib. VIII, tr. 1, xiv). In realtà Alberto dedicò un lungo capitolo a ciò che egli definiva “gli errori di Aristotele” (Sum. Theol. P. II, tr. i, quaest. iv). In una parola, il suo apprezzamento per Aristotele era critico. Egli merita credito non solo per aver portato l’insegnamento scientifico del filosofo greco all’attenzione degli studiosi medievali, ma anche per aver indicato il metodo e lo spirito in cui tale insegnamento doveva essere recepito. Come il suo contemporaneo, Ruggero Bacone (1214-1294), Alberto fu un infaticabile studioso della natura ed applicò la stessa energia allo studio delle scienze sperimentali, con tale zelo che fu accusato di trascurare le scienze sacre (Enrico di Ghent, De scriptoribus ecclesiastici, II, x). In realtà, circolarono molte leggende che gli attribuivano poteri magici. Dr. Sighart (Albertus Magnus) ha esaminato queste leggende, e si è sforzato di recuperare la verità da storie false o esagerate. Altri biografi si sono accontentati del fatto che la versatezza di Alberto nelle scienze fisiche poteva essere stato il fondamento su cui si basavano tali storie. La verità, naturalmente, si trova tra i due estremi. Alberto coltivò assiduamente le scienze naturali; era un’autorità nella fisica, in geografia, in astronomia, mineralogia, chimica (alchimia), zoologia e fisiologia. In tutti questi soggetti la sua erudizione era vasta e molte delle sue osservazioni sono tuttora valide. Meyer scriveva (Gesch. der Botanik): “Nessun botanico che sia vissuto prima di Alberto può essere paragonato a lui, tranne Teofrasto, che non conosceva; e dopo di lui nessuno ha dipinto la natura in tali vividi colori, o l’ha studiata così approfonditamente, fino all’arrivo di Conrad von Gesner, e Andrea Cesalpino. Tutti gli onori, dunque, vanno tributati all’uomo che ha fatto tali stupefacenti progressi nella scienza della natura, da non trovare nessuno, non che lo sopravanzi, ma che lo eguagli nei tre secoli successivi.” L’elenco delle sue opere pubblicate è sufficiente a scagionarlo dall’accusa di trascurare la teologia e le Sacre Scritture. D’altro canto, egli espresse il suo disprezzo per tutto ciò che sapeva di incantesimo o di arte magica. Egli non ammise mai la possibilità di creare l’oro con l’alchimia o attraverso l’uso della pietra filosofale; ciò è evidente dalle sue parole: “L’arte da sola non può produrre una forma sostanziale”. (Non est probatum hoc quod educitur de plumbum esse aurum, eo quod sola ars non potest dare formam substantialem – De Mineral. Lib. II, dist. 3). Ruggero Bacone e Alberto dimostrarono al mondo che la Chiesa non è contraria allo studio della natura: la scienza e la fede possono andare di pari passo; la loro vita ed i loro scritti sottolineano l’importanza della sperimentazione e dell’indagine. Bacone fu infaticabile e coraggioso nelle indagini, anche se, a volte, la sua critica fu troppo forte. Ma di Alberto disse: Studiosissimus erat, et vidit infinita, et habuit expensum, et ideo multa potuit colligere in pelago auctorum infinito (Opera, ed. Brewer, 327). Alberto rispettava l’autorità e le tradizioni, era prudente nel proporre i risultati delle sue indagini e, di conseguenza, “contribuì molto più di Bacone al progresso della scienza nel XIII secolo” (Turner, Hist. of Phil.). Il suo metodo di trattamento delle scienze fu storico e critico al tempo stesso. Raccolse in una grande enciclopedia tutto ciò che era noto ai suoi tempi e poi espresse le sue opinioni, principalmente sotto forma di commentari sulle opere di Aristotele. Talvolta, tuttavia, era titubante e non espresse il suo pensiero, probabilmente perché temeva che le sue teorie, che per quel periodo erano piuttosto “avanzate”, avrebbero potuto provocare disappunto e commenti non favorevoli. Dicta peripateticorum, prout melius potui exposui: nec aliquis in eo potest deprehendere quid ego ipse sentiam in philosophia naturali (De Animalibus, circa finem). Nell’opera di Augusta Theodosia Drane “Scuole Cristiane e studiosi” (pagina 419 e seguenti) vi sono alcune interessanti osservazioni su “alcuni pareri scientifici di Alberto che mostrano quanto egli dovette alle sue sagaci osservazioni dei fenomeni naturali, e in che misura era in anticipo rispetto alla sua epoca…. Parlando delle isole britanniche, alludeva alla comune idea che esisteva nell’oceano occidentale un’altra isola — Tile, o Thule –, inabitabile a causa del sua clima, ma che”, affermava,” forse non era ancora stata visitata dall’uomo”. Alberto elaborò anche una dimostrazione della sfericità della terra; qualcuno ha anche sottolineato come le sue idee sull’argomento condussero, in seguito, alla scoperta dell’America (Mandonnet, in Revue Thomiste, I, 1893; 46-64, 200-221). Si ipotizza infine che Alberto Magno sia stato il primo ad aver isolato l’arsenico nel 1250. Più importante dello sviluppo delle scienze fisiche fu la sua influenza sullo studio della filosofia e della teologia. Egli, più di chiunque dei grandi scolastici che precedettero San Tommaso, diede alla filosofia ed alla teologia cristiana la forma e il metodo che, sostanzialmente, si sono conservati fino ai giorni nostri. Nel marcare il sentiero che fu seguito da altri, Alberto condivise la gloria di essere stato un pioniere con Alessandro di Hales († 1245), la cui Summa Theologiae fu il primo scritto, dopo tutte le opere di Aristotele, a diventare famoso a Parigi. La loro applicazione della metodologia e dei principi aristotelici per lo studio della dottrina rivelata funsero da base per il sistema scolastico, che postulava l’unione di ragione e fede. Dopo Averroè, Alberto fu il principale commentatore delle opere di Aristotele, i cui scritti studiò con la massima assiduità, ed i cui principi adottò per sistematizzare la teologia, che intendeva come esposizione scientifica e difesa della dottrina cristiana. La scelta di Aristotele come maestro provocò forti opposizioni. I commentari ebraici ed arabi sulle opere del filosofo avevano originato tali e tanti errori nell’XI, XII e XIII secolo, che per alcuni anni (1210-1225) lo studio della metafisica e della fisica aristotelica furono vietati. Alberto, tuttavia, sapeva che Averroè, Pietro Abelardo, Amalrico di Bennes e altri avevano tratto false dottrine dagli scritti del filosofo; sapeva, inoltre, che sarebbe stato impossibile arginare la marea di entusiasmo a favore degli studi filosofici e così decise di purificare le opere di Aristotele da razionalismo, averroismo, panteismo ed altri errori e quindi mettere la filosofia pagana al servizio della causa della verità rivelata. In questo seguì l’insegnamento agostiniano (II De Doct. Christ., xl), che sosteneva che le verità trovate negli scritti dei filosofi pagani dovevano essere adottate dai difensori della fede, mentre le loro opinioni erronee dovevano essere abbandonate o spiegate in un senso cristiano. (San Tommaso, Summa Theol., I, Q. lxxxiv, a 5). Tutte le scienze inferiori (naturali) avrebbero dovuto essere al servizio (ancillae) della teologia, che è la scienza superiore (ibidem, 1 P., tr. 1, quaest. 6). Contro il razionalismo di Abelardo e dei suoi seguaci, Alberto sottolineò la distinzione tra verità naturalmente conoscibile e misteri (la Trinità e l’Incarnazione), che non possono essere conosciuti senza la rivelazione (ibidem, 1 P., tr. III, quaest. 13). Scrisse due trattati contro l’averroismo, che distruggeva l’immortalità e le responsabilità individuali, insegnando che vi è una sola anima razionale per tutti gli uomini. Il panteismo, invece, fu confutato insieme all’averroismo quando la dottrina sugli Universali, il sistema noto come realismo moderato, fu accettata dai filosofi scolastici. Sebbene seguace di Aristotele, Alberto non trascurò Platone. Scias quod non perficitur homo in philosophia, nisi scientia duarum philosophiarum, Aristotelis e Platonis (Met., lib. I, tr. V, c. xv). Per questo erravano quando dicevano che era solo la “Scimmia” (simius) di Aristotele. Nella conoscenza delle cose divine la fede precede la comprensione della Divina verità, l’autorità precede la ragione (I Sent. , Dist. II, a 10); ma nelle materie che possono essere naturalmente conosciute, un filosofo non dovrebbe assumere una posizione che non sia pronto a difendere con la ragione (Ibidem , XII; Periherm. , 1, I, tr. L, c. i). La logica, secondo Alberto, era una preparazione all’insegnamento della filosofia come la ragione era il mezzo per passare dal noto all’ignoto: Docens qualiter et per quae devenitur per notum ad ignoti notitiam (De praedicabilibus, tr. I, c. iv). La filosofia era sia contemplativa che pratica. La filosofia contemplativa abbraccia la fisica, la matematica, e la metafisica; la filosofia pratica (morale) è monastica (per l’individuo), domestica (per la famiglia), o politica (per lo Stato e la società). Escludendo la fisica, gli autori moderni conservano ancora la vecchia divisione della filosofia scolastica in logica, metafisica (generale e speciale) ed etica. In teologia Alberto occupa un posto tra Pietro Lombardo, il Magister Sentenziarum, e San Tommaso d’Aquino. Nell’ordine sistematico, nella precisione e nella chiarezza superò il primo, ma fu inferiore al proprio illustre discepolo. La sua Summa Theologiae, segnò un passo in avanti rispetto alla consuetudine del suo tempo sia sull’osservazione scientifica, sia nell’eliminazione delle questioni inutili, sia nella limitazione delle argomentazioni e obiezioni; rimanevano, tuttavia, molti degli impedimenta che San Tommaso considerava sufficientemente importanti da richiedere un nuovo manuale di teologia ad uso dei novizi (ad eruditionem incipientium), come il “Dottore Angelico” commentava nel prologo della sua Summa. La mente del Doctor Universalis era così pregna della conoscenza di molte cose che non poteva sempre adeguare le sue esposizioni della verità alle capacità dei novizi nella scienza della teologia. Quindi, addestrò e diresse un alunno che diede al mondo una concisa, chiara e perfettamente scientifica esposizione e difesa della dottrina cristiana. Fu proprio grazie agli indirizzi di Alberto che San Tommaso scrisse la sua Summa Teologica.
TOMMASO D’AQUINO

MAXI-RIASSUNTO
Al centro della novità costituita dall’ingresso delle opere filosofiche greche nel mondo latino e dei susseguenti conflitti sulla loro compatibilità con la fede cristiana, Tommaso d’Aquino prende decisamente posizione a favore di Aristotele, sviluppando anzitutto una precisa distinzione di piani tra discorso filosofico e discorso teologico. Entrambi prendono a proprio oggetto le ultime realtà, ma lo fanno con punti di partenza differenti: il primo quella della ragione naturale, il secondo quello della rivelazione di Dio. Solo il discorso teologico raggiunge dunque il fine soprannaturale dell’uomo, ma quello filosofico risulta non solo pienamente giustificato, ma anche indispensabile: l’esistenza di Dio è per esempio dimostrabile razionalmente, e solo con questa premessa la teologia cristiana può cominciare a muovere i suoi passi. Quest’ultima ha del resto un carattere pienamente scientifico in quanto al suo interno rispetta i criteri dell’argomentazione logica quanto qualsiasi altra scienza. L’originalità della metafisica di Tommaso discende in gran parte dall’integrazione creativa di tratti neoplatonici nel quadro aristotelico di fondo. L’elemento risultante che verrà dai posteri ritenuto più caratteristico è la distinzione reale tra essere ed essenza: l’“essenza” di ogni cosa, in quanto contingente, significa una semplice possibilità, che si realizza solo quando si esprime in un “atto di essere”. Questa distinzione costituisce anche il punto di partenza per dimostrare l’esistenza di Dio e la creazione del mondo: essendo contraddittorio affermare che una cosa conferisce l’essere a sé stessa e non potendosi andare all’infinito, bisogna ammettere che all’origine ci sia lo “stesso essere sussistente”, qualcosa cioè in cui essere ed essenza non sono distinti, che va chiamato “Dio”. Una valutazione profondamente positiva della realtà creata emerge dalla teoria dei trascendentali, che mostra che ogni cosa che esiste possiede, in quanto esistente, le caratteristiche dell’unità, della verità, della bontà, della bellezza, che le vengono partecipate da Dio. La psicologia e la morale applicano tale sguardo positivo alla realtà umana. Riguardo all’anima, in polemica con gli agostiniani, Tommaso ritiene che essa ha il potere naturale di conoscere la realtà e non ha dunque bisogno di una continua illuminazione da parte di Dio. Riguardo alla morale viene rivendicato il valore di un’etica naturale, che non è annullata dalla constatazione che il fine della perfetta beatitudine a cui aspira l’uomo non può essere raggiunto con le sole forze naturali. Nella valutazione dell’atto umano Tommaso accoglie fin dove gli era possibile le coraggiose proposte di Abelardo, che assegnavano un ruolo determinante all’intenzione con la quale si agisce: per questo l’uomo ha sempre il dovere di agire seguendo la propria coscienza, e contemporaneamente il dovere di conoscere sempre meglio che cosa è veramente bene . Uno dei tratti più caratteristici del pensiero di Tommaso d’Aquino è senza dubbio il tentativo di armonizzare, nella loro reciproca autonomia, filosofia e teologia. Per Tommaso il problema si poneva in maniera molto forte: la sostanziale accettazione della filosofia aristotelica, che pareva a prima vista conciliabile con molta difficoltà con il pensiero cristiano, poteva suscitare l’impressione di una subordinazione della rivelazione al pensiero razionale (come sembrava essere avvenuto nella filosofia araba di Averroè [1126-1198]). Bisogna quindi anzitutto mostrare che oltre le scienze filosofiche è necessaria all’uomo un’altra dottrina, superiore per valore alle scienze filosofiche e certa quanto esse. La necessità della teologia è fondata da Tommaso sulla necessità della rivelazione stessa: dato che l’uomo è diretto per la sua natura ad un fine che eccede le sue capacità naturali (un tema che diverrà più chiaro parlando della morale), per la salvezza dell’uomo è necessaria una rivelazione divina. La dottrina basata sulla rivelazione non va però confusa con la teologia razionale: quest’ultima prende a proprio oggetto Dio così come egli può essere conosciuto alla sola luce della ragione (come per esempio aveva fatto Aristotele), la teologia rivelata così come egli ha voluto rivelare sé stesso. In questo modo è assicurata anche l’autonomia della speculazione puramente razionale: tutt’altro che essere esautorata, essa diviene invece la premessa (il preambulum) della teologia, presentando le verità cui l’uomo può giungere con le sue sole forze, che attendono poi completamento dalla rivelazione. Un caso tipico è costituito dall’esistenza di Dio: Il fatto che dio esista, e altre cose di questo tipo che tramite la ragione naturale possono essere note su dio, come viene detto in Rom. 1,19, non sono articoli [= princìpi] di fede, ma premesse agli articoli: infatti la fede presuppone la conoscenza, così come la grazia presuppone la natura, e come la perfezione presuppone ciò che può essere reso perfetto. Tuttavia nulla proibisce che ciò che di per sé è dimostrabile e conoscibile venga accettato come credibile da qualcuno che non capisce la dimostrazione (Somma teologica 1, q2a2ad1). L’ultima annotazione significa questo: l’esistenza di Dio è per esempio una verità razionale, e quindi può essere “conosciuta”; ma chi non ne capisce la dimostrazione potrà semplicemente “credervi”, per esempio fidandosi di chi gli assicura che essa è corretta (se così non fosse la fede cristiana sarebbe accessibile solo al filosofo!). Ma la teologia in sé (o “sacra dottrina”, come preferisce chiamarla Tommaso) può essere definita “scienza”? Ecco per intero la discussione del problema:Per il secondo articolo si procede così: sembra che la sacra dottrina non sia una scienza. Infatti ogni scienza procede da princìpi noti per sé. Ma la sacra dottrina procede dagli articoli di fede, che non sono noti per sé, non essendo ammessi da tutti: la fede infatti non è di tutti, come si dice in 2Tess. 3,2. Dunque la sacra dottrina non è una scienza. Inoltre, la scienza non riguarda le cose singolari. Ma la sacra dottrina tratta di cose singolari, per esempio delle gesta di Abramo, Isacco e Giacobbe, e simili. Dunque la sacra dottrina non è una scienza. Ma contro c’è ciò che dice Agostino in De Trinitate 14,7: “A questa scienza si attribuisce solo ciò tramite cui la fede che dà la salvezza viene generata, nutrita, difesa, rafforzata”. Ma ciò non appartiene a nessuna scienza se non alla sacra dottrina. Dunque la sacra dottrina è una scienza. Rispondo dicendo che la sacra dottrina è una scienza. Ma bisogna sapere che ci sono due generi di scienze. Infatti alcune sono quelle che procedono da princìpi noti alla luce naturale dell’intelletto, come l’aritmetica, la geometria e le scienze di questo tipo. Altre invece sono quelle che procedono da princìpi noti alla luce di una scienza superiore: come la prospettiva procede da princìpi resi noti dalla geometria, e la musica da princìpi noti tramite la matematica. E in questo modo la sacra dottrina è una scienza, perché procede da princìpi noti alla luce di una scienza superiore, vale a dire la scienza che posseggono dio e i beati. Quindi, come la musica crede ai princìpi trasmessile dal matematico, così la sacra dottrina crede ai princìpi rivelatile da dio. Alla prima obiezione dunque bisogna dire che i princìpi di qualsiasi scienza o sono noti per sé, o si riconducono alla notizia di una scienza superiore. E tali sono i princìpi della sacra dottrina, come è stato detto. Alla seconda bisogna dire che le cose singolari vengono trasmesse nella sacra dottrina non perché si tratti principalmente di essi: ma vengono introdotti sia come esempio di vita, come nelle scienze morali; sia anche per rendere chiara l’autorità degli uomini tramite cui giunse a noi la rivelazione divina, sulla quale si fonda la sacra Scrittura ovvero la sacra dottrina (Somma teologica 1, q1a2).In sintesi: la teologia trae i suoi princìpi da una “scienza” superiore, che è la conoscenza che Dio ha di sé stesso (e che posseggono per quanto possibile anche coloro che sono giunti alla beatitudine eterna); e come il musicista si fida delle informazioni che il matematico gli dà riguardo alla sua scienza, così il teologo (come ogni altro credente) si fida delle notizie che Dio ha dato di sé stesso rivelandosi. Ma il carattere scientifico della teologia è assicurato dal suo metodo razionale e argomentato, che permette di ricavare conclusioni logiche da premesse di fede e anche di ragione. Ciò non significa per Tommaso (come s’intenderà più tardi) che la teologia sia esclusivamente una scientia conclusionum, una scienza cioè che non fa altro che tirare conseguenze da princìpi indiscutibili: anche nei confronti dei princìpi di fede la ragione ha infatti il compito di mostrare che essi sono credibili. Ciò può essere fatto in due modi: o evidenziando l’autorità del rivelante, o dimostrando che i princìpi rivelati non solo non sono contrari alla ragione, ma anzi si trovano intimamente d’accordo con essa. La fede non è infatti concepita come qualcosa di irrazionale e privato, ma l’atto tramite cui accettiamo come vero sulla base di buoni motivi qualcosa rivelato da qualcuno. Questo è il senso anche delle molte dimostrazioni di “convenienza”: delle opere di Dio non è possibile mostrare la necessità (ciò significherebbe negare la libertà di Dio); si può però, a posteriori, comprendere che sono coerenti con la sua natura. Un esempio tipico tra i molti possibili è la discussione sull’incarnazione di Dio: La stessa natura di dio è la bontà. … Quindi qualsiasi cosa appartenga al carattere del bene è conveniente a dio. Ma appartiene al carattere del bene che si comunichi ad altri. … Quindi al carattere del sommo bene appartiene che si comunichi alla creatura nel modo più alto. Ciò in verità avviene per il fatto che “congiunge a sé la natura creata di modo che venga una sola persona da tre elementi, verbo, anima e carne”, come dice Agostino in De Trinitate 13,17. Dunque è chiaro che fu conveniente che dio si sia incarnato (Somma teologica 3, q1a1c). Bisogna inoltre notare che Tommaso, nonostante affermi che l’unico scopo dei fatti “singolari” è servire o da esempio morale o da prova dell’autorità, non può rimanere fedele a quest’assunto di origine aristotelica. Una parte importante della Somma Teologica è infatti dedicata a Cristo: alla sua persona, alla sua vita, alla sua passione, morte e resurrezione, tutti aspetti o fatti singolari per eccellenza. È evidente allora che, malgrado le affermazioni di principio contrarie, la teologia di Tommaso non può rinunciare a quel fatto del tutto unico e particolare che è costituito dal compimento della salvezza nella storia. In questo modo la fede cristiana, eminentemente storica, rivendica i suoi diritti, costringendo Tommaso a trasgredire tacitamente le regole della scientificità della cultura del suo tempo. Riassumendo, in Tommaso la ragione svolge un triplice compito a servizio della teologia: 1) dimostra le premesse che permettono l’accoglienza dei princìpi di fede; 2) mostra la “credibilità”, cioè in ultima analisi la coerenza, dei princìpi di fede; 3) offre il metodo argomentativo tramite cui dedurre dalle premesse razionali e dai princìpi di fede ulteriori verità. Nel seguito toccheremo quasi esclusivamente gli aspetti più originali della filosofia di Tommaso che, proprio per le ragioni dette, è facilmente separabile dalle discussioni teologiche. Si noterà tuttavia che si tratta di una separazione che ha un carattere provvisorio: la filosofia è infatti secondo Tommaso capace di comprendere i propri stessi limiti, e dunque di attendere un completamento da una scienza guidata da una luce superiore alla ragione naturale. Inoltre, il ruolo chiarificatore che la ragione assume nei confronti degli articoli di fede fa sì che molte delle discussioni filosoficamente più interessanti si trovino in un contesto propriamente teologico.Nelle sue linee generali, la metafisica di Tommaso si presenta come un’intenzionale ripresa di Aristotele, le cui opere proprio in quell’epoca cominciavano a circolare nella loro interezza nel mondo culturale di lingua latina. L’aristotelismo di Tommaso d’Aquino è tuttavia fortemente impregnato di elementi neoplatonici, desunti da varie fonti (Porfirio [232-304], Proclo [410-485], Dionigi l’Areopagita [5º secolo], ibn Sînâ ovvero Avicenna [980-1037]). L’influenza neoplatonica si può rilevare anzitutto nella maggiore sottolineatura della distinzione tra gli enti sensibili e quelli puramente intellegibili, distinzione che in Aristotele veniva attenuata dall’identificazione dell’ousía con la “forma”. Secondo Tommaso ciò è pienamente vero solo nel caso degli enti privi di materia (detti “sostanze separate” e identificati con gli angeli), la cui natura o essentia (questa è l’originaria traduzione latina di ousía) è solo forma; ma nel caso degli enti necessariamente possedenti materia (le “sostanze composte”, per esempio l’uomo), l’essentia è il composto di forma e materia. Tale precisazione di sapore neoplatonico in Tommaso sembra però ottenere un risultato contrario a quello originario: non una svalutazione delle sostanze composte, ma piuttosto una maggiore stima della corporeità. Affermare che la materia fa parte dell’essenza significa infatti sostenere per esempio che la perfezione dell’uomo include necessariamente anche la corporeità (donde la giustificazione razionale dell’articolo di fede sulla resurrezione della carne). Parimenti influenzata dal neoplatonismo è la diversa concezione dell’essenza. Mentre in Aristotele l’ousía e il tí én éinai (l’“essere-per-ciascuna-cosa”) erano anzitutto singolari, in Tommaso l’essentia (o quidditas) è universale, e viene così ad avvicinarsi alla nozione logica di éidos, cioè di specie. Da qui nasce un problema che in Aristotele non poteva porsi: vale a dire il problema dell’individuazione. Se l’essentia è universale, ma la realtà è del resto solo singolare (in questo Tommaso accetta integralmente la critica d’Aristotele a Platone), che cosa conferisce l’individualità alla singola cosa? Sfruttando un’osservazione marginale di Aristotele e seguendo Avicenna, Tommaso risponde che si tratta della materia: Il principio di individuazione è la materia. Da ciò sembrerebbe seguire che l’essenza, che comprende in sé la materia e assieme la forma, sia soltanto particolare e non universale. … E dunque bisogna sapere che non la materia comunque intesa è principio d’individuazione, ma solo la materia determinata (materia signata). E dico materia determinata quella che viene considerata sotto certe dimensioni. … Nella definizione dell’uomo viene posta la materia non determinata: infatti nella definizione dell’uomo non si pone questa carne e queste ossa, ma carne e ossa in assoluto, che sono la materia non determinata dell’uomo (Sull’ente 2,6). Nel caso dell’uomo dunque, non è l’anima in quanto tale che conferisce individualità (l’anima è forma), ma solo in quanto fatta per unirsi ad un corpo (“la moltiplicazione delle anime è secondo la moltiplicazione dei corpi”, Somma teologica 1, q72a2ad2). Diverso è il caso degli angeli: non avendo essi materia, l’individualità sarà necessariamente data dalla forma, che dunque sarà diversa per ogni angelo e si identificherà con lui. È comunque solo l’ente pienamente individuato che può ricevere il nome di “sostanza” (traduzione del greco hypóstasis), indicante ciò che sussiste realmente e autonomamente. In questo mutamento di prospettiva c’è anche una importante conseguenza di carattere gnoseologico. Con l’affermazione dell’universalità dell’essenza Tommaso riesce infatti ad aggirare una difficoltà della filosofia aristotelica, nascente dalla giustapposizione tra l’individualità della realtà e l’universalità della scienza: in quale modo la scienza può allora avere una sua verità? In Tommaso il problema è risolto perché l’universale non è solo un prodotto dell’astrazione dell’intelletto (universale post rem), ma è anche realmente presente nella singola cosa (universale in re), anzi la precede pure (neoplatonicamente) nella mente di Dio, che possiede i modelli esemplari di tutte le cose create (universale ante rem, ovvero ideae). Questa era già la soluzione che aveva dato al problema degli universali Pietro Abelardo. La scienza dunque è valida anzitutto perché non si basa solo su generalizzazioni (in quanto tali fallibili), ma sulla capacità che l’intelletto possiede di riconoscere l’universale incarnato nelle singole cose. La totale assenza di materia negli angeli (sostenuta in polemica con il contemporaneo Bonaventura [1221-1274], che vedeva in essi la presenza di una “materia spirituale”) pone di fronte ad un ulteriore problema. Affermare che essi sono forme pure non equivale forse a designarli come “atti puri”, eguali quindi a Dio stesso? Tommaso evita questa conseguenza con la dottrina della distinzione reale tra esse ed essentia: Qualsiasi cosa non faccia parte della comprensione dell’essenza o quiddità, le viene dall’esterno ed entra in composizione con l’essenza, perché nessuna essenza potrebbe essere compresa senza ciò che fa parte dell’essenza. Ma ogni essenza o quiddità può essere compresa senza che si comprenda alcunché del suo essere di fatto (de esse suo facto). Posso infatti comprendere che cos’è l’uomo o la fenice, e tuttavia ignorare se abbiano essere nella natura reale (an esse habeant in rerum natura). Dunque è evidente che l’essere è altro dall’essenza o quiddità (Sull’ente 5,3). Ciò significa che le cose di cui abbiamo esperienza sono contingenti, non posseggono cioè in sé stesse nulla che richieda necessariamente la loro esistenza. Anche nell’angelo, liberamente creato da Dio, c’è dunque una tale composizione tra essere ed essenza, che impedisce di considerarlo un essere assolutamente “semplice”. Fin qui, Tommaso segue sostanzialmente l’opinione che era già stata di Guglielmo di Alvernia (1190-1249). Il passo ulteriore è invece più originale. Come più chiaramente viene detto in testi successivi al Sull’ente e l’essenza, la relazione tra essenza ed essere va chiarita con l’aiuto dei concetti aristotelici di potenza e atto: Nelle cose materiali si trova una duplice composizione. La prima è quella di forma e materia, dalle quali viene costituita una certa natura [ovvero essenza]. Ma la natura così composta non è il suo essere, ma piuttosto l’essere è il suo atto. Dunque la stessa natura è in rapporto con il suo essere come una potenza con un atto. Dunque, eliminata la materia, e posto che la stessa forma sussista senza materia, rimane ancora il rapporto della forma con lo stesso essere, come della potenza con l’atto. E questa composizione bisogna intenderla negli angeli (Somma teologica 1, q50a2ad3). Quindi, i termini potenza e atto possono indicare due cose distinte: o la materia in rapporto alla forma (questo è il significato aristotelico), o l’essenza (materia più forma o forma pura) in rapporto all’essere. Quest’ultimo andrà quindi definito “l’attualità di tutti gli atti” — per questo viene spesso chiamato anche actus essendi — e costituisce l’autentico vertice della conoscenza metafisica. In questo modo Tommaso integra all’interno della metafisica aristotelica la tendenza neoplatonica a considerare l’“essere” come un qualcosa dotato di una sua autonomia (non solo concettuale, ma reale) rispetto a tutte le possibili determinazioni degli enti. La distinzione di Tommaso tra essere ed essenza, per quanto non venga presentata con molta enfasi da lui stesso, venne presto ritenuta il tratto più caratteristico del suo pensiero, e come tale vivacemente contestata o difesa, per lo più sotto la forma della coppia concettuale essentia / existentia (un termine quest’ultimo poco amato da Tommaso). Tale distinzione ha così costituito un punto di riferimento fondamentale per pressoché tutte le filosofie posteriori, fino all’esistenzialismo contemporaneo. Un’importanza particolare ha nella metafisica di Tommaso d’Aquino la teoria dei “trascendentali” (come saranno in realtà solo più tardi chiamati), sostanzialmente originale rispetto ad Aristotele (ma in parte ripresa da Alessandro di Hales [1185-1245]). I trascendentali sono gli attributi generalissimi che riguardano l’ente in quanto tale. Essi quindi oltrepassano, “trascendono” le categorie (o “predicamenti”), che dividono invece l’ente in differenti generi (altro è la sostanza, altro la quantità, e così via). La distinzione tra i trascendentali non è quindi reale, ma solo di ragione (e infatti “convertuntur”, dice Tommaso); proprio per questo però essi aiutano a comprendere la ricchezza di un termine — “ente” — che altrimenti rischierebbe di rimanere vago e indeterminato. Il passo più completo sui trascendentali si trova nella prima questione Sulla verità, che opera una precisa deduzione dei caratteri dell’ente: Alcune cose vengono dette aggiunte all’ente per il fatto che esprimono un modo dell’ente stesso che non viene espresso dal nome “ente”. Ciò accade in due maniere: nella prima cosicché il modo espresso è un qualche modo speciale dell’ente [= categorie]. … Nella seconda cosicché il modo espresso sia un modo generale che consegue ad ogni ente; e questo modo può essere inteso in due maniere: nella prima in quanto consegue a qualsiasi ente in sé; nella seconda in quanto consegue ad un ente in rapporto ad un altro. Se è nella prima maniera, ciò avviene in due maniere, perché esprime nell’ente qualcosa o affermativamente o negativamente. E non si trova nulla che sia detto affermativamente in modo assoluto, che possa essere inteso in ogni ente, se non la sua essenza, secondo la quale si dice che esso è; e così viene assegnato il nome “cosa”, che differisce da “ente”, secondo ciò che dice Avicenna all’inizio della Metafisica, perché “ente” viene tratto dall’atto di essere, ma il nome “cosa” esprime la quiddità o essenza dell’ente. E la negazione che consegue ad ogni ente in maniera assoluta è la non divisione, che viene espressa dal nome “uno”: infatti l’uno non è nient’altro che l’ente indiviso. E se il modo dell’ente viene inteso nel secondo modo, cioè secondo il rapporto di una cosa all’altra, ciò può avvenire in due maniere. Nella prima secondo la divisione di un ente dall’altro, che viene espressa dal nome “qualcosa”: infatti si dice “qualcosa” come se si dicesse “un’altra cosa”; dunque come l’ente viene detto “uno” in quanto è in sé non diviso, così viene detto “qualcosa” in quanto è diviso dagli altri. Nella seconda maniera secondo l’accordo di un ente con un altro; e ciò però non può avvenire se non si prende qualcosa che possa per natura accordarsi con ogni ente: e ciò è l’anima, che è in un certo senso tutte le cose, come viene detto nel terzo libro Sull’anima. Ma nell’anima c’è una facoltà conoscitiva e desiderativa. Dunque l’accordo dell’ente con il desiderio viene espresso dal nome “buono”, così come all’inizio dell’Etica [Nicomachea] si dice che il buono è ciò che tutti desiderano. E l’accordo dell’ente con l’intelletto viene espresso dal nome “vero” (Sulla verità q1a1c). In conclusione, sei sono (contando anche ens) le nozioni trascendentali: ens, res, unum, aliquid, verum, bonum. Ciò significa che ogni ente (cioè ogni cosa che ha essere) è una cosa in quanto determinato (cioè in quanto ha un’essenza), è un’unità in quanto identico a sé (come già esplicitamente rilevava Aristotele), è un qualcosa in quanto distinto dagli altri enti, è vero in quanto conoscibile, è buono in quanto desiderabile. Questo in sintesi lo schema del ragionamento di Tommaso: attributi speciali (praedicamenta) attributi generali (trascendentia) conseguono all’ente in sé affermativamente (res) negativamente (unum [indivisio]) conseguono all’ente in rapporto ad altro secondo la divisione di un ente da un altro (aliquid [aliud quid]) secondo l’accordo di un ente con un altro con l’intelletto (verum) con il desiderio (bonum) Qualche osservazione aggiuntiva. La prima riguarda il verum. Il fatto che esso sia un trascendentale dell’ente non significa che la verità sia una proprietà più delle cose che dell’intelletto: Tommaso tiene infatti ferma la nozione aristotelica di verità come corrispondenza soggettiva tra la mente umana e la realtà. Piuttosto, ogni cosa ha già, in quanto possiede essere ed essenza, una naturale predisposizione ad essere conosciuta. La definizione di verità come adaequatio rei et intellectus, che rimarrà classica nei secoli, intende tener conto sia dell’aspetto soggettivo, che è primario, sia di quello oggettivo, che è derivato. La seconda notazione riguarda il trascendentale bonum. Esso suppone la tesi della “irrealtà” del male, che viene ripresa dal neoplatonismo: il male è soltanto la mancanza di bene, cioè di essere, e più precisamente di un essere dovuto: la cecità è un male per l’uomo, ma non per l’albero. L’ultima osservazione riguarda il pulchrum, “bello”. Esso riceve discreta attenzione, ma non viene incluso nella lista dei trascendentali in quanto sostanzialmente omologato al verum. Tommaso interpreta infatti l’esperienza estetica come il piacere che si accompagna spontaneamente alla percezione della verità: Il bello e il buono in un soggetto sono lo stesso, perché si fondano sulla stessa cosa, cioè sulla forma: e per questo il buono viene lodato come bello. Ma differiscono per il carattere. Infatti il buono propriamente riguarda il desiderio: infatti il buono è ciò che tutti desiderano. E perciò ha il carattere di fine: infatti il desiderio è quasi un certo movimento verso una cosa. Il bello invece riguarda la facoltà conoscitiva: vengono dette infatti belle quelle cose che piacciono quando sono viste. Dunque il bello consiste in una debita proporzione, perché il senso prova diletto nelle cose debitamente proporzionate, come in cose simili a sé; infatti anche il senso è una certa ragione, come ogni virtù conoscitiva. E giacché la conoscenza avviene per assimilazione, e la somiglianza riguarda la forma, il bello propriamente riguarda il carattere della causa formale (Somma teologica 1, q5a4ad1). La dottrina dei trascendentali acquista anche un immediato rilievo dal punto di vista conoscitivo. Seguendo Avicenna, Tommaso afferma ripetutamente che l’ens è il primo oggetto dell’intelletto. Quest’affermazione non è contrapposta all’altra (di origine aristotelica) secondo cui l’oggetto proprio dell’intelletto umano è costituito dalla quidditas rei materialis, ma ne costituisce piuttosto la base: ogni essenza può essere conosciuta infatti solo in quanto esistente, e ogni concetto si formerà dunque “per addizione” rispetto alla nozione trascendentale di ente. In questo modo viene affermata l’originaria e immediata consonanza della mente umana con la totalità della realtà, quantunque originariamente colta solo nella sua assoluta generalità (a questo proposito egli parla di esse commune). In questo modo è possibile fondare anche, in modo più rigoroso di quanto aveva fatto Aristotele, la supremazia del primo principio dell’intelletto, il principio di non contraddizione. Esso infatti è la diretta traduzione in un giudizio del trascendentale unum, così come in campo morale è il trascendentale bonum a costituire la premessa per il primo principio pratico: Nelle cose che cadono sotto l’apprensione di tutti, si trova un certo ordine. Infatti ciò che cade per primo sotto l’apprensione è l’ente, la cui comprensione è inclusa in tutte le cose che uno conosce. E dunque il primo principio indimostrabile è che è impossibile contemporaneamente affermare e negare, che si fonda sul carattere dell’ente e del non ente; e su questo principio si fondano tutti gli altri. Ma come l’ente è la prima cosa che cade sotto l’apprensione in assoluto, così il bene è la prima cosa che cade sotto l’apprensione della ragione pratica, che è ordinata all’azione: tutto ciò che agisce infatti agisce per un fine, che ha il carattere di bene. E dunque il primo principio nella ragione pratica è quello che si fonda sul carattere del bene, che è: il bene è ciò che tutti desiderano. Questo è dunque il primo precetto della legge: il bene dev’essere fatto e cercato, il male evitato. E su di esso si fondano tutti gli altri precetti della legge di natura: in modo che cioè facciano parte dei precetti della legge di natura tutte le cose da fare o da evitare che la ragione pratica conosce essere beni umani (Somma teologica 2/1, q94a2c). È difficile sopravvalutare l’importanza di questa dottrina. Con essa infatti sembra giungere alla propria meta l’originaria intenzione di Aristotele, quella di costruire una scienza dell’“ente in quanto ente”. La successiva storia della filosofia in gran parte seguirà questa intuizione di Tommaso, e già Giovanni Duns Scoto (1266-1308) definirà la metafisica scientia transcendens (una definizione questa che, seppure in una prospettiva diversa, giungerà fino a Kant). In maniera simile a quanto avveniva in Aristotele , lo studio dell’ente in quanto tale culmina per Tommaso nella teoria dell’ente sommo, ovvero nella teologia: Tutto ciò che compete a qualcosa o è causato dai princìpi della sua natura, come la capacità di ridere nell’uomo, o viene da qualche principio esterno, come la luce nell’aria per influenza del sole. Ma non può essere che lo stesso essere sia causato dalla stessa forma o quiddità della cosa (intendo come causa efficiente): perché così una qualche cosa sarebbe causa di sé stessa, il che è impossibile. Dunque è necessario che ogni cosa, tale che il suo essere è diverso dalla sua natura, abbia l’essere da un altro. E poiché tutto ciò che è tramite un altro si riconduce a ciò che è per sé come alla causa prima, dunque è necessario che ci sia qualcosa che sia causa dell’essere per tutte le cose per il fatto che essa è soltanto essere. Altrimenti si andrebbe all’infinito nella cause, giacché ogni cosa che non è soltanto essere ha una causa del suo essere, come s’è detto. È chiaro quindi che l’intelligenza [l’angelo] è forma ed essere, e che ha l’essere dal primo essere che è soltanto essere (et quod esse habeat a primo esse quod est esse tantum); e questo è la causa prima, che è dio (Sull’ente 5,4). Perciò, Dio dev’essere indicato come ipsum esse subsistens, come cioè l’unico ente che è l’essere, a differenza di tutti gli altri che hanno l’essere. Non soltanto egli s’identifica con la sua essenza (come gli angeli), ma anche con il suo stesso essere. In questo modo viene confermato razionalmente il nome che Dio rivela sul roveto ardente: “Così dirai a loro: “Io Sono mi ha mandato a voi”” (Es. 3,14): questo è infatti il nome che può indicare meglio di qualsiasi altro “il mare infinito dell’essere” (che però va tenuto chiaramente distinto dall’esse commune, l’essere che possiedono tutte le cose create considerate astraendo dalle loro determinazioni). Il brano che abbiamo riportato presenta anche la struttura fondamentale della prova dell’esistenza di Dio secondo Tommaso: la stessa esistenza di cose che posseggono un essere soltanto partecipato mostra la necessità di qualcosa che sia originariamente l’essere e dunque causa prima di tutto il resto — ciò che appunto si indica con la parola “Dio”. Si noti che questo ragionamento ha una forma induttiva di tipo aristotelico (si parte da ciò che è sott’occhio per giungere al principio primo), ma un punto di partenza niente affatto aristotelico, e cioè la distinzione reale di essenza ed essere nelle cose diverse da Dio. Un articolo celeberrimo della Somma Teologica (I, q2a3) elenca cinque diverse “vie” per dimostrare l’esistenza di Dio, alcune di ùispirazione pi aristotelica (la prima, la seconda, la quinta), altre di sapore più neoplatonico (la terza e la quarta). La struttura delle cinque vie è però simile: in tutte infatti si tratta di mostrare come ciò di cui si ha esperienza sarebbe inspiegabile se non si ammettesse un Dio che sta al di fuori del campo dell’esperienza stessa. Ecco in sintesi i ragionamenti seguiti: il movimento è impossibile se non si ammette un primo motore che non è mosso da nulla; il divenire è impossibile se non si ammette una prima causa efficiente; il contingente o possibile non può essere se non c’è qualcosa che è di per sé necessario (questa via si identifica con la dimostrazione prima considerata); i vari gradi di essere (e anche di verità, di bontà ecc.) sono impossibili se non c’è un ente supremo in riferimento al quale giudicarli; il finalismo della natura, anche inanimata, è impossibile se non c’è un intelletto che la ordina. Sulle stesse basi Tommaso dimostra razionalmente la creazione, cioè la produzione di tutte le cose “dal nulla” (cioè “non da qualcosa di preesistente”): È necessario dire che tutto ciò che è in qualsiasi modo, sia da dio (omne quod quocumque modo est, a deo esse). Se infatti qualcosa si trova in un’altra cosa per partecipazione, è necessario che sia causato in essa da ciò a cui conviene essenzialmente (così come il ferro diventa infuocato per opera del fuoco). Ma è stato mostrato … che dio è lo stesso essere sussistente per sé. E poi è stato mostrato che l’essere sussistente non può essere che uno. … Resta dunque che tutte le cose altre da dio non siano il loro essere, ma partecipino dell’essere (non sint suum esse, sed participant esse) (Somma teologica 1, q44a1c). E ricevere l’essere per partecipazione è proprio ciò che si indica con il termine “creazione” (ciò tuttavia non equivale a negare l’eternità del mondo, una tesi questa che viene confutata solo dalla rivelazione: è il tema dell’opuscolo Sull’eternità del mondo contro i mormoratori). La nozione platonica di “partecipazione”, assente dalla metafisica di Aristotele , diventa allora centrale in Tommaso: essa indica appunto la condivisione di qualche cosa da parte di chi la possiede originariamente e dunque definisce il rapporto originario tra Dio e le creature. Altrettanto importante è la nozione di “analogia”, che significa non più, come in Aristotele, solo l’uguaglianza di rapporti tra cose diverse (analogia proportionalitatis), ma anche la diversità di rapporti rispetto ad una stessa cosa (analogia attributionis). In questo secondo senso, l’analogia è una qualifica primaria della nozione di “ente”: l’essere infatti si trova in tutte le cose, ma non nello stesso modo, soprattutto nelle creature e in Dio: le prime “hanno” essere, il secondo “è” essere. È perciò possibile formulare su Dio affermazioni che, pur limitate, non sono tuttavia false. La stessa cosa si dovrà anzi dire a proposito di tutti gli attributi che si possono dire di lui: Alcune cose vengono dette di dio in maniera analoga, e non puramente equivoca, né univoca. Infatti non possiamo nominare dio se non a partire dalle creature. … E così qualsiasi cosa venga detta di dio e delle creature si dice per il fatto che c’è un qualche ordine della creatura rispetto a dio, come al principio e alla causa in cui preesistono in modo eminente tutte le perfezioni delle cose. E questo modo di comunanza si trova tra la pura equivocità e la semplice univocità. Infatti nelle cose che vengono dette per analogia non c’è una sola relazione (ratio), come in quelle univoche, né una relazione totalmente diversa, come nelle equivoche: ma il nome che così viene detto in molti modi significa diverse proporzioni nei confronti di qualcosa di unico (Somma teologica 1, q13a5c). Uno dei più importanti fili conduttori per parlare analogicamente di Dio è costituito per Tommaso dalla teoria dei trascendentali. Se infatti Dio è “ente” nel significato più alto, i trascendentali gli competono per eccellenza: “qualsiasi cosa conviene all’ente in quanto ente è necessario che si trovi soprattutto nel primo ente” (Commento a Boezio, Sulla trinità, q1a4ob1). Si potrà dunque dire che Dio è assolutamente unico (in quanto unum), che racchiude in sé ogni possibile verità (in quanto verum), che è massimamente desiderabile da qualsiasi ente intelligente (in quanto bonum). Cose simili si potrebbero senza dubbio dire per gli altri trascendentali (anche se Tommaso non lo fa esplicitamente): Dio possiede l’essenza più ricca e anzi infinita (in quanto res), è massimamente individuato perché il suo essere coincide con la sua essenza (in quanto aliquid). Anche in questo modo Tommaso si pone sulla scia di Aristotele, considerando la teologia (razionale) come il coronamento della scienza dell’ente in quanto tale: ma contemporaneamente l’immagine di Dio — già ad un livello puramente razionale — muta profondamente: se da una parte c’è un Dio “pensiero di sé stesso” che non può amare il mondo pena la perdita della propria perfetta attualità, dall’altra c’è un Dio che proprio in quanto atto puro partecipa il proprio essere a tutte le creature, come dono dalla propria ricchezza. Infatti, il fatto stesso che le cose di cui abbiamo esperienza ci sono pur non godendo della coincidenza di essere ed essenza dimostra che il loro essere è ricevuto in dono. Ciò che si deve dire dell’essere va allora ripetuto per tutti gli altri trascendentali: Dio partecipa l’essenza, l’individualità, l’unità, la verità, la bontà a tutto il creato, che così porta la traccia della sua perfezione. Per la sua importanza storica, conviene inoltre toccare il problema della potenza di Dio (affrontato con dettaglio nelle questioni Sulla potenza e riassunto nella Somma). In Dio c’è potenza? Certamente essa non c’è nel senso in cui si oppone all’atto: Dio è infatti atto puro. Tommaso sfrutta però un secondo significato di potenza, che era stato già evidenziato (ma meno usato) da Aristotele: la potenza cioè non come possibilità di essere modificato, ovvero imperfezione (potentia passiva), ma come possesso di un principio di movimento o mutamento, ovvero perfezione (potentia activa). In questo secondo senso Dio non solo è potente, ma anzi onnipotente, essendo perfettissimo. Ma che cosa significa che egli può tutto? Dio viene detto onnipotente perché può tutte le cose possibili in assoluto. … Ma l’essere divino, sul quale si fonda il carattere della potenza divina, è l’essere infinito, non limitato a qualche genere dell’ente, ma recante in sé la perfezione di tutto l’essere. Dunque qualsiasi cosa possa avere il carattere di ente fa parte delle cose possibili in assoluto, rispetto alle quali dio viene detto onnipotente. Ma nulla si oppone al carattere di ente, se non il non ente. Esso dunque ripugna al carattere del possibile in assoluto, che è sottomesso alla potenza divina, perché implica in sé l’essere e contemporaneamente il non essere. … Tutte le cose dunque che non implicano contraddizione fanno parte di quelle cose possibili rispetto alle quali dio viene detto onnipotente (Somma teologica 1, q25a3c). Tale precisazione consente a Tommaso d’Aquino di respingere l’opinione secondo cui il mondo creato da Dio sarebbe “il migliore possibile”: Quando si dice che Dio può fare qualcosa meglio rispetto a ciò che fa, se “meglio” è un nome, è vero: infatti di qualsiasi cosa può farne un’altra migliore. … Ma se “meglio” è un avverbio e riguarda il modo da parte di colui che fa, allora Dio non può fare meglio di come fa: perché non può fare con maggiore sapienza e bontà (Somma teologica, 1, q25a6ad1). Insomma, lo stesso concetto di “mondo migliore possibile” è contraddittorio, perché di qualsiasi cosa finita è sempre possibile una più perfetta (allo stesso modo, per esempio, è contraddittorio il concetto di “numero maggiore possibile”). Tuttavia anche in Tommaso, soprattutto nelle opere giovanili, si trovano dichiarazioni di ispirazione neoplatonica (analoghe a quelle che molto pi saranno caratteristiche di Leibniz ), in cui viene riconosciuto anche al male un ruolo nella bontà complessiva del mondo: Un universo in cui non ci fosse nulla di male non avrebbe tanta bontà quanta ne ha quest’universo, perché non ci sarebbero in quello tante buone nature quante in questo, in cui ci sono alcune nature buone alle quali non si aggiunge del male, e alcune alle quali si aggiunge: ed è meglio che ci siano entrambi i tipi di nature piuttosto che le prime soltanto (Commento al Libro delle sentenze, 1, d44q1a2ad5). La facoltà di parlare analogicamente di Dio non toglie che la sua essenza sia assolutamente impossibile da conoscere tramite le facoltà naturali dell’anima umana: questa, che essendo unita al corpo è la forma di una materia, può infatti conoscere solo ciò che le è connaturale: cioè le cose individuate nella materia (tramite i sensi) e le forme universali astratte dalle cose (tramite l’intelletto). Ma conoscere lo stesso essere sussistente che è Dio è al di sopra delle possibilità naturali di qualsiasi intelletto creato, che possiede l’essere solo per partecipazione. Dimostrare che Dio c’è (an est) è infatti ben diverso dal sapere che cosa egli sia (quid est). In questo modo Tommaso interpreta l’affermazione del prologo del vangelo di Giovanni: “Dio nessuno lo ha mai visto” (1,18), e contemporaneamente valorizza la tradizione della teologia “negativa” o “apofantica” (soprattutto Dionigi l’Areopagita), secondo la quale di Dio si può dire propriamente solo ciò che egli non è. D’altra parte, l’ignoranza dell’essenza di Dio è l’unico motivo per cui Tommaso contesta Anselmo d’Aosta (1033-1109), che riteneva che l’affermazione dell’esistenza di Dio sia “per sé nota”, cioè immediatamente evidente. Il difetto di questa opinione non consiste per Tommaso (come spesso poi affermato) in un indebito passaggio dal piano mentale a quello reale (per quanto riguarda Dio è perfettamente lecito dedurre dall’essenza l’esistenza), ma nella supposizione che l’uomo conosca l’essenza di Dio, il che equivale sostanzialmente ad una petitio principii. Ma dato che così non è, il concetto di Dio come essere sussistente viene formato dall’uomo solo a partire dalle cose contingenti che sono a lui più vicine: Questa proposizione: dio esiste, in quanto è in sé, è nota per sé, perché il predicato è identico al soggetto: dio infatti è il suo essere. … Ma poiché noi non sappiamo di dio che cosa egli sia, per noi non è nota per sé, ma ha bisogno di essere dimostrata tramite le cose che sono più note dal nostro punto di vista e meno note dal punto di vista della natura, vale a dire tramite gli effetti (Somma teologica 1, q2a1c). Il risultato finale della metafisica di Tommaso è dunque differente da quello di Aristotele: la domanda sull’essere, che muove la meraviglia dell’uomo, può giungere alla fine solo ad una indicazione, ma non ad una risposta intellettualmente completa. Si potrebbe dire che anche davanti ad una pietra risulta impossibile chiarire fino in fondo che cosa significhi per essa esistere: si potrà sì dire che ciò vuol dire avere l’atto di essere partecipato da colui che è l’essere, ma quale sia l’essenza dello stesso essere rimane ignoto. La metafisica culmina così in un grande interrogativo, dietro al quale però è già assicurato che non si trova il nulla, ma al contrario la sovrabbondanza di tutte le perfezioni che conosciamo solo imperfettamente e limitatamente e tuttavia desideriamo spontaneamente nella loro totalità. Il problema dell’essere si sposta così dal campo speculativo al campo morale. Come la fisica nel suo complesso, anche la dottrina dell’anima è in Tommaso pressoché interamente ripresa da Aristotele. Alcune correzioni dovevano però essere introdotte per renderla compatibile con la rivelazione cristiana. I due punti più delicati erano costituiti dalla dottrina dell’intelletto agente (o “produttivo”) e dall’immortalità. Riguardo al primo, Tommaso, prendendo posizione in una celebre questione che Aristotele aveva lasciato poco definita, ritiene che vada necessariamente ammesso che l’intelletto agente sia qualcosa appartenente alla singola anima: Alcuni hanno affermato che quest’intelletto separato secondo la sostanza sia l’intelletto agente, che, quasi illuminando le immagini sensibili, le rende attualmente intellegibili. Ma, concesso che ci sia un tale intelletto agente separato, purtuttavia bisogna affermare che nella stessa anima ci sia una qualche facoltà partecipata da quell’intelletto superiore, tramite la quale l’anima umana le rende attualmente intellegibili. … E questo lo conosciamo sperimentalmente, quando percepiamo di astrarre forme universali da condizioni particolari, il che significa renderle attualmente intellegibili. Infatti nessuna azione conviene a qualche cosa se non tramite un qualche principio che gli inerisca formalmente. … Ma l’intelletto separato, secondo i documenti della nostra fede, è dio stesso, che è creatore dell’anima. … Dunque da lui l’anima umana partecipa la luce dell’intelletto (Somma teologica 1, q79a4c). In questo modo Tommaso modifica drasticamente anche la dottrina agostiniana dell’illuminazione: l’uomo conosce non perché attualmente lo illumini Dio (che alcuni identificavano con l’intelletto agente unico di cui parlava Avicenna), ma perché il suo proprio intelletto ha ricevuto — una volta per tutte — una luce naturale sufficiente a garantire l’autonomia e la correttezza della sua conoscenza. A maggior ragione risulta confutata la teoria di Averroè e dei suoi seguaci, che teorizzavano l’unicità anche dell’intelletto possibile, affermando così un’unica anima per tutta la specie umana (questo è l’argomento affrontato nell’opuscolo polemico Sull’unità dell’intelletto contro gli averroisti). La posizione di Agostino e dei contemporanei maestri francescani viene rifiutata anche da un altro punto di vista: in quanto cioè essa sosteneva che nell’uomo esistano più “forme”, che cioè le anime intellettiva, sensitiva e vegetativa siano realmente distinte. Seguendo Aristotele, Tommaso afferma invece che nell’uomo c’è un’unica anima intellettiva, che assume anche le funzioni delle anime inferiori e dev’essere dunque definita ancora “forma corporis”. Infatti, è lo stesso uomo che percepisce di sentire (tramite il corpo) e di pensare (tramite il solo intelletto). Ciò è un ulteriore segno che solo l’unione di anima e corpo può essere indicata come “uomo”. Ma non viene in questo modo negata l’immortalità? Tommaso ritiene di no. La chiave dell’argomentazione è costituita dal mostrare che l’anima intellettuale, quantunque sia forma del corpo, è tuttavia un principio incorporeo e sussistente, cioè autonomo. Gli atti intellettuali infatti manifestano un carattere di universalità che non può essere attribuito ai sensi corporei, neanche come semplici strumenti: la corporeità impedirebbe infatti, essendo legata al qui e all’ora, lo svolgimento di una conoscenza universale. Ora, qualcosa di sussistente può corrompersi solo perdendo la propria forma. Ma l’anima è forma, ed è impossibile che una cosa si separi da sé. Dunque l’anima è incorruttibile. Ma c’è anche un argomento più immediato, di sapore agostiniano, tramite il quale si può indurre l’immortalità dell’anima: Un segno di questa cosa può essere preso anche dal fatto che ciascuna cosa naturalmente desidera essere a suo modo. Ma nelle cose conoscenti il desiderio segue la conoscenza. Il senso non conosce l’essere se non sotto il qui e l’ora: ma l’intelletto apprende l’essere assolutamente e secondo ogni tempo. Dunque chiunque ha intelletto desidera naturalmente essere sempre. Il desiderio naturale non può del resto essere vano. Dunque ogni sostanza intellettuale è incorruttibile (Somma teologica I q75a6c). Il presupposto è ovviamente costituito dalla coerenza e dalla bontà dell’intera natura, che, in quanto esistente grazie alla partecipazione dell’essere divino e ad esso orientata, non può mai ispirare un desiderio irrealizzabile. Sul piano teologico, con un argomento simile si può sostenere la convenienza della resurrezione finale dei corpi: quantunque infatti — come si vedrà — l’anima può giungere di per sé alla beatitudine, la riunione con il corpo la renderà più perfetta. La dottrina dell’anima di Tommaso suscitò numerose discussioni presso i contemporanei. In essa infatti sembravano essere presenti troppe concessioni alla filosofia pagana, che rendevano problematici perfino elementi essenziali della fede cristiana. Dietro alle discussioni speculative c’era tuttavia una questione fondamentale di atteggiamento culturale: in Tommaso la rivendicazione della verità della psicologia aristotelica supponeva implicitamente una piena valutazione dell’autonomia e della globale bontà dell’essere umano — anima e corpo — che poteva apparire pericolosa per la religione cristiana. Il tempo avrebbe in realtà dato ragione a Tommaso, e la sua psicologia divenne addirittura parte dell’insegnamento ufficiale della Chiesa: nel 1312 il Concilio di Vienna addirittura anatematizzerà chi affermi che “anima rationalis seu intellectiva non sit forma corporis humani per se et essentialiter” (DS 902). Anche nella morale Tommaso d’Aquino si ispira da vicino ad Aristotele, tanto che la sua esposizione sembra spesso obbedire solo alla preoccupazione di mettere maggiore ordine e precisione nella teoria aristotelica. In realtà, la stessa assunzione dell’etica aristotelica è molto significativa: essa sottolinea, una volta di più, che il piano puramente naturale — quello che era stato raggiunto dalla filosofia pagana — mantiene una sua autonomia e validità anche all’interno della prospettiva cristiana. L’aspetto più interessante della morale di Tommaso consiste allora proprio nel modo in cui quest’ultima viene integrata all’interno della struttura classica. Il punto di partenza, così come per Aristotele, consiste nel precisare che l’uomo agisce sempre — in maniera più o meno consapevole — in vista di un fine, e nel cercare quale mai possa essere questo fine. Anzitutto bisogna mostrare come tutti i beni naturali, che sono alla portata delle sole forze dell’uomo, non riescono a soddisfare la sua sete di felicità: né le ricchezza, né gli onori, né la fama, né il potere, né la perfezione corporale, né il piacere, né la perfezione dell’anima, né in generale alcun bene creato può costituire la sua felicità ovvero beatitudine: La beatitudine infatti è un bene perfetto, che sazia totalmente il desiderio: altrimenti non sarebbe il fine ultimo, se restasse ancora qualcosa da desiderare. Ma l’oggetto della volontà, che è il desiderio umano, è il bene universale (così come l’oggetto dell’intelletto è il vero universale). Da ciò è evidente che nulla può soddisfare la volontà dell’uomo all’infuori del bene universale. Ed esso non si trova in nulla di creato, ma solo in dio, perché ogni creatura ha solo una bontà partecipata. Dunque solo dio può soddisfare la volontà dell’uomo, secondo le parole del Salmo 102,5: “Colui che ricolma di beni il tuo desiderio”. Dunque, solo in dio consiste la beatitudine dell’uomo (Somma teologica 2/1, q2a8c). Dire che Dio è la beatitudine dell’uomo però non basta. Bisogna precisare più da vicino in quale modo l’uomo possa conquistare questa felicità ultima: La beatitudine ultima e perfetta non può consistere in altro che nella visione dell’essenza divina. Affinché ciò sia evidente bisogna considerare due cose. In primo luogo, che l’uomo non è perfettamente beato finché gli resta qualcosa da cercare e desiderare. In secondo luogo, la perfezione di qualsiasi facoltà è in rapporto al genere del suo oggetto. Ma l’oggetto dell’intelletto è il che cos’è, cioè l’essenza della cosa. … Dunque la perfezione dell’intelletto procede in tanto in quanto esso conosce l’essenza di qualche cosa. Se dunque un intelletto conosce l’essenza di qualche effetto, tramite la quale non possa essere conosciuta l’essenza della causa (non si possa cioè sapere che cosa sia la causa), non si deve dire che l’intelletto abbia raggiunto in senso assoluto la causa, sebbene tramite l’effetto possa conoscere della causa che essa c’è. E dunque all’uomo rimane naturalmente il desiderio, quando conosce l’effetto e sa che esso ha una causa, di sapere anche che cosa sia quella causa. E questo desiderio è la meraviglia, che causa la ricerca, come viene detto all’inizio della Metafisica. … Se dunque l’intelletto umano, conoscendo l’essenza di qualche effetto creato, di dio sa soltanto che c’è, la sua perfezione non raggiunge ancora in senso assoluto la causa prima, ma gli rimane ancora un desiderio naturale di cercare la causa. Dunque non è ancora perfettamente beato. Dunque per la perfezione della beatitudine si richiede che l’intelletto giunga alla stessa essenza della prima causa (Somma teologica 2/1, q3a8c). In questo modo morale e metafisica vengono legate in modo ancora più stretto di quanto già avveniva in Aristotele. Se in lui la felicità maggiore veniva individuata — al termine dell’analisi del comportamento umano — nella vita teoretica, che però era realizzabile solo in maniera parziale (è impossibile per l’uomo passare la vita a contemplare soltanto), in Tommaso la stessa morale è fin dall’inizio mossa da quella meraviglia che costituisce il primo movente della ricerca, e dunque orientata ad un fine ultimo di sua natura assoluto e perfetto. Si realizza allora un curioso contrasto: il fatto stesso che l’uomo possa desiderare il bene perfetto mostra che egli di fatto lo può raggiungere (altrimenti esisterebbe un desiderio naturale smentito dalla natura stessa, il che è contraddittorio); ma tuttavia le sue forze naturali sono palesemente insufficienti a raggiungerlo: ciascuna creatura infatti conosce “secundum modum substantiae eius”, cioè adattando l’oggetto conosciuto alla propria natura: ma l’essenza divina eccede infinitamente qualsiasi essenza creata. Ciò mostra la necessità di ammettere razionalmente la possibilità di altre virtù oltre quelle intellettuali (dianoetiche) e morali (etiche): quelle teologiche (o teologali), la cui realtà è testimoniata dalla rivelazione cristiana: C’è una duplice beatitudine ovvero felicità dell’uomo. Una proporzionata alla natura umana, cioè alla quale l’uomo può giungere tramite i princìpi della sua natura. Un’altra è la beatitudine che eccede la natura dell’uomo, alla quale l’uomo può giungere solo per virtù divina, secondo una certa partecipazione da parte della divinità, secondo ciò che viene detto in 2Pt. 1,4, che tramite Cristo siamo diventati partecipi della natura divina. E poiché una tale beatitudine eccede la proporzione della natura umana, i princìpi naturali dell’uomo, in base ai quali procede per agire bene secondo la sua proporzione, non bastano per ordinare l’uomo verso la suddetta beatitudine. Dunque è necessario che all’uomo vengano aggiunti da parte di dio alcuni princìpi per mezzo dei quali egli venga ordinato alla beatitudine soprannaturale. … E tali princìpi vengono detti virtù teologiche: sia perché hanno dio come oggetto, in quanto tramite esse veniamo rettamente ordinati verso dio; sia perché solo da dio vengono infuse in noi; sia perché solo tramite la rivelazione divina, nella Sacra Scrittura, simili virtù vengono tramandate (Somma teologica 2/1, q62a1c). Le virtù teologiche — così come enumerate da Paolo in 1Cor. 13,13 — sono fede, speranza e amore (caritas). Ciascuna di esse porta a perfezione un aspetto dell’anima razionale in relazione al suo fine ultimo: la fede perfeziona l’intelletto, la speranza il tendere della volontà al sommo bene, l’amore il suo conformarsi al fine ultimo. La loro trattazione è compito della teologia e non più della filosofia, ma ciò non toglie che anche su di esse è possibile e necessario riflettere in maniera razionale. Notiamo solo due aspetti interessanti. Il primo consiste nel fatto che le virtù teologiche, a differenza di tutte le altre (secondo Tommaso anche di quelle intellettuali), non consistono nel “giusto mezzo”: nei confronti di Dio non possono infatti esistere eccessi, ma anzi vi sono sempre difetti: nessun uomo — in quanto creatura finita — potrà infatti mai amare Dio o credere o sperare in lui quanto sarebbe giusto. Il secondo consiste nella preminenza che viene accordata all’amore. Esso è da giudicare la più grande delle virtù, anzi la loro stessa “forma” (in quanto indirizza tutte le altre al fine ultimo che è Dio), ed è l’unica ad avere un carattere definitivo: la fede riguarda infatti ciò che non si vede (dunque scomparirà quando si vedrà l’essenza divina), la speranza ciò che non si ha (e dunque non avrà più motivo quando si possederà Dio): solo l’amore conduce in assoluto all’unione con colui che si ama. Questo mostra anche che solo in un certo senso la meraviglia che motiva la vita morale è destinata ad essere spenta: nella visione dell’essenza divina infatti la cosa più importante non è comprendere Dio tramite l’intelletto, ma piuttosto amarlo: Le virtù teologiche hanno un oggetto che è al di sopra dell’anima umana. … Ma in ciò che è sopra l’uomo l’amore è più nobile della conoscenza. Infatti la conoscenza si realizza nel fatto che le cose conosciute sono nel conoscente; ma l’amore, nel fatto che l’amante viene attratto verso la cosa amata (Somma teologica 2/1, q66a6ad1). In questo modo il tipico intellettualismo greco, che Tommaso dapprima sembra condividere, viene corretto sulla base della creaturalità dell’uomo e degli insuperabili limiti del suo intelletto. Il primo oggetto del pensiero dell’uomo è l’essere: ma questo nella sua forma più perfetta, dunque come beatitudine, è destinato a rimanere sempre incomprensibile, chiedendo solo l’adesione dell’amore. Il principio della destinazione soprannaturale dell’uomo conferisce importanza centrale ad un tema che non poteva interessare molto un’etica puramente naturale: il problema cioè dei criteri di valutazione degli atti umani. Laddove in Aristotele il loro valore veniva immediatamente attribuito dalla capacità di contribuire ad una felicità naturale, in Tommaso essi sono tanto buoni quanto rendono l’uomo meritevole di ricevere in dono — dopo il corso della vita terrena — la visione dell’essenza divina. In questo modo la felicità naturale non viene però negata, ma piuttosto ordinata alla felicità completa e infinita cui l’uomo aspira. È per questo che il criterio fondamentale della moralità delle azioni resta ancora la recta ratio (corrispondente all’orthós lógos aristotelico): se la ragione è in grado di dirigersi verso un fine soprannaturale, essa sarà capace anche di ordinare le azioni dell’uomo verso di esso. È insomma alla ragione che spetta l’insostituibile compito di dare senso e valore all’intero campo dei comportamenti autenticamente umani. In questa prospettiva però si crea un grande problema, che costituirà nelle sue implicazioni tema di interminabili discussioni nella morale cristiana. Nella sua forma più semplice può essere espresso così: se tutto ciò che viene fatto volontariamente dall’uomo è scelto sub specie boni, cioè perché in esso viene visto qualcosa di buono, su quale base si potrà parlare dal punto di vista della volontà — l’unica che rende un’azione realmente umana — di un’azione cattiva? Ancora più semplicemente: come può esistere un peccato realmente imputabile all’uomo? Il problema nasce appunto perché viene presupposta l’esistenza di un giudice delle azioni umane che non guarda solo al loro aspetto materiale, ma piuttosto all’intenzione con la quale esse vengono compiute. La risposta di Tommaso (in buona parte ispirata a Pietro Abelardo) è piuttosto articolata. Anzitutto bisogna distinguere più cause che possono rendere cattiva un’azione umana: L’uomo, come anche qualsiasi altra cosa, ha naturalmente desiderio di bene (appetitum boni). Dunque il fatto che il suo desiderio devìi al male accade a causa di una qualche corruzione o disordine in qualcuno dei princìpi dell’uomo: così infatti si trova l’errore nell’azione delle cose naturali. Ma i princìpi degli atti umani sono l’intelletto e il desiderio, sia razionale (che viene chiamato volontà), sia sensitivo. Dunque il peccato negli atti umani accade sia per difetto d’intelletto, per esempio quando uno pecca per ignoranza; e per difetto del desiderio sensitivo, come quando uno pecca per passione; così anche per difetto di volontà, che è un suo disordine (Somma teologica 2/1, q78a1). Esaminiamo brevemente i tre casi. Il primo si verifica quando l’uomo agisce in sèguito ad un’ignoranza volontaria o a cui egli avrebbe potuto rimediare. Per esempio, nessuno potrà scusarsi dell’adulterio adducendo la sua ignoranza della legge di natura che proibisce di andare con la moglie di un altro: perché proprio questa ignoranza è colpevole. L’unica ignoranza che scusa un’azione in sé cattiva è infatti quella che non è causata da negligenza né tanto meno intenzionale. Ma che cosa accade se la ragione, senza alcuna colpa, presenta ad un uomo come buona un’azione che invece in sé è cattiva? L’uomo ha il dovere di seguirla; se viceversa agisse contro la propria ragione, commetterebbe peccato, perché sceglierebbe un’azione in quanto cattiva. Un esempio estremo e paradossale: Credere in Cristo per sé è cosa buona e necessaria alla salvezza: ma la volontà non vi si dirige se non secondo ciò che la ragione propone. Dunque, se dalla ragione ciò fosse proposto come un male, la volontà vi si dirigerebbe come ad un male: non perché sia in sé male, ma perché è male per accidente, in seguito all’apprensione della ragione (Somma teologica 2/1, q19a5). In conclusione: l’uomo ha sempre il dovere di agire secondo ragione (o, come anche si esprime Tommaso, “secondo coscienza”). Ma, parimenti, ha il dovere di rendere il più corretto possibile il giudizio della ragione. Il secondo caso succede quando l’uomo, pur conoscendo la legge universale (che è dettata dalla ragione), si lascia tuttavia sopraffare dalla passione sensibile, che gli suggerisce un bene che per quanto abbia una sua validità (per esempio il puro piacere), è tuttavia disordinato per l’uomo, in cui la forma essenziale è costituita dall’intelletto: si tratta quindi di un bene apparente, e non di un bene reale. Il terzo caso avviene quando l’uomo coscientemente preferisce un bene subordinato ad uno sovraordinato: quando per esempio preferisce la ricchezza (che in sé è un bene) alla vita di un altro uomo (che è un bene immensamente più grande): in questo caso si può quasi dire che l’uomo scelga coscientemente il male, sebbene sarebbe più corretto dire che sceglie consapevolmente un bene palesemente minore. Sostanzialmente originale rispetto ad Aristotele è anche la dettagliata trattazione che Tommaso offre del concetto di legge, definita come “ordinamento razionale diretto al bene comune, promulgato da colui che ha la cura della comunità” (“quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata”, Somma teologica 2/1, q90a4c). È lo strettissimo nesso con la ragione umana che permette di assumere la legge come criterio della bontà dei comportamenti. Ma non è certamente la legge umana quella che interessa di più Tommaso, ma piuttosto quella che, promulgata dal Dio onniprovvidente (o meglio coincidente con il suo intelletto), tende al massimo bene comune dell’intero universo: questo è il concetto di lex aeterna. Nella misura in cui essa viene partecipata all’uomo tramite la ragione, essa va poi chiamata lex naturalis. Questa tuttavia sarebbe sufficiente solo se l’uomo fosse ordinato ad un fine puramente naturale: ma dato che la sua destinazione è soprannaturale, è necessario che egli riceva anche una lex divina positiva, tramite le quale anche la legge naturale acquisti maggiore certezza ed efficacia. La legge divina — la cui trattazione è compito non più della filosofia ma della teologia — è quella che la rivelazione ci trasmette nella duplice forma di legge antica e legge nuova (cioè evangelica), la seconda delle quali perfeziona e adempie pienamente la prima. Ma in che cosa consiste la legge divina nella sua forma definitiva assunta nel Vangelo? Qui la risposta di Tommaso è molto originale: la legge nuova non è una legge scritta, non contiene quindi precetti, ma piuttosto è “la stessa grazia dello Spirito Santo, che viene data ai credenti in Cristo” (Somma teologica 2/1, q106a1c), che quindi è scritta nel cuore stesso dell’uomo. La legge nuova non è così un insieme di norme da rispettare, ma piuttosto la stessa capacità, donata da Dio all’uomo, di portare a realizzazione l’obiettivo della sua perfetta umanità e perfetta felicità, nella comunione con lui. Infatti, “come l’intenzione principale della legge umana è di fare amicizia reciproca tra gli uomini, così l’intenzione della legge divina è di costituire principalmente l’amicizia dell’uomo verso Dio” (Somma teologica 2/1, q99a1). Per questo la legge nuova non è una legge che condanna, ma piuttosto una legge che iustificat, cioè perdona: Alla legge del Vangelo appartengono due aspetti. Uno in maniera principale: cioè la stessa grazia dello Spirito santo data interiormente. Quanto a ciò, la legge nuova giustifica. Per questo Agostino dice in De Spiritu et littera, 17: “Là — cioè nell’Antico Testamento — la legge era posta dall’esterno, per spaventare gli ingiusti; qua — cioè nel Nuovo Testamento — è stata data dall’interno, per giustificarli”. Un altro elemento appartiene alla legge del Vangelo in maniera secondaria: cioè le testimonianze della fede e i precetti che ordinano gli affetti umani e gli atti umani. E quanto a ciò, la legge nuova non giustifica. Per questo l’Apostolo dice in 2Cor. 3,6: “La lettera uccide, ma lo Spirito dà la vita”. E Agostino spiega, in De Spiritu et littera, che con “lettera” s’intende qualsiasi scrittura che sta fuori dell’uomo, anche quella dei precetti morali quali sono contenuti nel Vangelo. Dunque anche la lettera del Vangelo ucciderebbe, se non ci fosse dall’interno la grazia sanante della fede (Somma teologica 2/1, q106a2c). Dunque, così come le virtù naturali vengono portate a perfezione e completate da quelle teologiche, così la legge naturale è assunta e trasfigurata all’interno della libera autocomunicazione di Dio attraverso quel dono di sé che è lo Spirito. Lo straordinario successo ottenuto lungo i secoli tanto dalla filosofia quanto dalla teologia di Tommaso d’Aquino è certamente un segno del loro valore. La profondità, l’equilibrio, l’armonia tra esigenze razionali ed esigenze di fede condussero rapidamente alla loro assunzione nell’insegnamento ordinario della Chiesa. Non va però dimenticato che il pensiero di Tommaso si sviluppa in un contesto culturale estremamente vivace e ricco, all’interno del quale la sua figura non è affatto quella di un genio isolato. Bisognerebbe anzi notare che la recezione dei secoli successivi, oltre che essere legata ad un giudizio sul valore delle tesi di Tommaso, è in gran parte motivata dalla sua grande sensibilità didattica. Il testo più letto e studiato diventa la Somma teologica, che si presenta espressamente come un’opera solo ad eruditionem incipientium, “per la formazione dei principianti”. Bisogna però rammaricarsi che spesso lo spirito del pensiero di Tommaso sia stato frainteso e dimenticato: la ricerca instancabile ed equilibrata di nuove soluzioni, rigorosamente confrontate usando tutti gli strumenti razionali e le più aggiornate premesse filosofiche, divenne così o una disquisizione puramente verbale su questioni pressoché impalpabili (che susciterà la rivolta del Rinascimento), oppure una stanca e arida ripetizione di tesi (che nella Chiesa cattolica sarà travolta dal rinnovamento ispirato dall’ultimo Concilio ecumenico). La riflessione e la valutazione della filosofia di Tommaso è così ancora oggi un compito in gran parte da svolgere.
MINI-RIASSUNTO
INTRODUZIONE : Tommaso fu forse il pensatore più importante del Medioevo e la sua influenza, nell’ambito della Chiesa cattolica, è tuttora fondamentale. Era un uomo grande e grosso, bruno, un po’ calvo ed aveva l’aria pacifica e mite dello studioso. Per il suo carattere silenzioso lo chiamarono “il bue muto”. Tutta la sua vita fu spesa nell’attività intellettuale e la sua stessa vita mistica la sua ricerca instancabile di Dio. Fu canonizzato nel 1323 .
RAGIONE E FEDE : Per conoscere Dio, che supera la comprensione della ragione, non basta la sola ricerca filosofica, ma occorre che Dio stesso intervenga e si riveli in un linguaggio accessibile all’uomo. La Rivelazione – e dunque la fede cristiana – non annulla né rende inutile la ragione. Inoltre le verità scoperte dalla ragione non possono venire in contrasto con le verità rivelate giacché entrambe procedono da Dio, che è luce e verità somma. Qualora apparisse un contrasto, è solo perché si tratta di conclusioni false o non necessarie o non si è indagato a sufficienza. La ragione può essere d’aiuto alla fede in tre modi : 1) dimostrando i preamboli della fede cioè quelle verità la cui dimostrazione è necessaria alla fede stessa (non si può credere in Dio se non si sa se esiste, se è uno o molti ecc., il che può essere fatto dalla ragione); 2) chiarire mediante similitudini le verità della fede, ad es. illustrando in un linguaggio accettabile i misteri della Trinità e dell’Incarnazione; 3) controbattere alle obiezioni che si possono fare alla fede dimostrando che sono false.
ESSENZA ED ESISTENZA, ANALOGICITA’ E PARTECIPAZIONE : Nel De ente et essentia Tommaso stabilisce il principio che, riformando la metafisica aristotelica, la rende “adatta” al cristianesimo : la distinzione reale tra essenza ed esistenza. Per Aristotele, potenza e atto corrispondevano a materia e forma. Secondo Tommaso invece l’essenza e l’esistenza stanno tra loro rispettivamente nel rapporto di potenza e atto. L’essenza (chiamata anche quiddità o natura) comprende sia la materia che la forma perché comprende tutto ciò che è espresso nella definizione della cosa. Per es. l’essenza dell’uomo, definito “animal rationale”, comprende sia la materia (animal) che la forma (rationale). Dall’essenza si deve distinguere l’esistenza perché si può comprendere che cosa sia un uomo o l’unicorno o l’araba fenice ma non è ancora detto che quegli esseri esistono nella realtà. Dunque l’essenza e l’esistenza sono distinte e stanno tra loro nel rapporto di potenza e atto. L’essenza è in potenza rispetto all’esistenza, mentre l’esistenza è l’atto dell’essenza. Ecco ora il punto fondamentale : l’unione dell’essenza con l’esistenza, ovvero il passaggio dalla potenza all’atto, ovvero l’individuo reale richiede per Tommaso l’intervento diretto e creativo di Dio. E’ solo Dio che può creare le cose facendole esistere; è solo Dio che può realizzare il passaggio dalla potenza all’atto, ossia dalla essenza all’esistenza, e dare così origine alle varie creature, siano angeli o uomini o animali o piante ecc. Vi sono perciò tre modi in cui l’essenza è nei vari esseri. In primo luogo, in Dio l’essenza è uguale all’esistenza. Solo in Dio essenza ed esistenza si identificano. In altre parole, l’essenza di Dio è di esistere : Egli esiste necessariamente, è eterno, è l’unico essere necessario cioè non può non esistere, mentre tutti gli altri esseri dipendono da lui. Negli angeli, che sono puri spiriti e quindi dotati di sola forma e non di materia, l’essenza è diversa dall’esistenza in quanto il loro essere è creato e finito e si identifica con la sola forma. Infine, negli uomini, negli animali ecc., cioè nelle creature composte di materia e di forma, l’essenza è comunque sempre distinta dall’esistenza ed esistono grazie all’intervento creativo di Dio. in sintesi, potremmo dire che Dio è l’essere, mentre le creature hanno l’essere. Dunque il termine “essere” non è lo stesso quando è riferito a Dio o alle creature. Tra l’essere di Dio e quello delle creature non vi è né identità né assoluta opposizione bensì analogia. Le creature, in quanto esistenti, sono simili a Dio ma Dio non è simile a loro : ecco il principio della analogicità dell’essere (analogo = simile ma di proporzioni diverse). In più, le creature hanno l’essere perché viene dato loro da Dio, il quale partecipa (=dona) loro l’esistenza. Così le creature hanno l’essere per partecipazione, mentre Dio è l’essere per essenza. La distinzione fra l’essere creato e l’essere eterno di Dio porta con sé due importanti conseguenze. In primo luogo permette a Tommaso di salvaguardare l’assoluta trascendenza (superiorità, diversità, alterità, soprannaturalità) di Dio nei confronti del creato e delle creature e di evitare ogni forma di panteismo (che identifica Dio col mondo). In secondo luogo, l’analogicità dell’essere rende impossibile un’unica scienza dell’essere : accanto alla filosofia vi è adesso la scienza che riguarda l’essere necessario e cioè la teologia, la quale è superiore in dignità a tutte le altre scienze, le quali, nei suoi confronti, diventano “ancelle della teologia”. Questo concezione porterà, fra l’altro, ad una graduale svalutazione dello studio della natura, che verrà a fatica ripreso solo più tardi, nel Rinascimento e oltre.
LE PROVE DELL’ESISTENZA DI DIO O LE “CINQUE VIE” : Anche se Dio è il primo nell’ordine degli esseri, non è però primo nell’ordine delle conoscenze umane, le quali iniziano dai sensi, mentre Dio è invisibile. E’ dunque indispensabile dimostrare che Dio esiste pur essendo invisibile, partendo allora dagli effetti, dalle creature, dal mondo visibile e mostrando come essi non siano spiegabili se non rifacendosi a Dio. Le prove dell’esistenza di Dio devono essere perciò a posteriori cioè a partire dalla nostra esperienza del mondo e non a priori ( che parte dal concetto di Dio per dedurne l’esistenza, come l’argomento ontologico di S. Anselmo, che Tommaso rifiuta per motivi che vedremo più avanti). Tommaso elabora così “cinque vie” per giungere a dimostrare che Dio esiste. La prima via è quella del moto, ed è desunta da Aristotele. Essa parte dal principio che tutto ciò che si muove è mosso da altro. Ora, se tutto ciò che è mosso a sua volta si muove, bisogna che anch’esso sia mosso da un’altra cosa e questa da un’altra ancora. Ma non è possibile andare all’infinito altrimenti non vi sarebbe un primo motore e neppure gli altri muoverebbero : infatti il processo all’infinito sposta solo il problema e non trova la ragione ultima del mutamento (in altri termini, il processo all’infinito spiegherebbe la trasmissione del moto ma non la prima origine e causa del moto). E’ dunque necessario arrivare ad un primo motore non mosso da altro, e “tutti riconoscono che esso è Dio”. Da notare che questo moto non è soltanto meccanico e fisico ma metafisico : dovunque c’è moto e quindi divenire che non basta a se stesso, c’è imperfezione che non ha in sé la sua spiegazione e richiede quindi l’intervento di Dio. La seconda via è quella causale. Nel mondo vi è un ordine tra le cause efficienti (causa efficiente è ciò che da origine a qualcosa) ma è impossibile che una cosa sia causa efficiente di se stessa, perché altrimenti sarebbe prima di se stessa, il che è assurdo. Anche in questo caso è impossibile un processo all’infinito, dunque bisogna ammettere una prima causa efficiente “che tutti chiamano Dio”. Rispetto alla prima via, qui si tratta della causalità efficiente, da cui dipende non solo il divenire ma l’essere delle cose. Dunque Dio non è solo il principio del divenire ma anche la causa, l’origine suprema di tutto ciò che esiste, che è da Lui conservato e creato,pur senza eliminare l’azione delle cause secondarie. La terza via è basata sul rapporto tra il possibile e il necessario. Vi sono cose che possono essere e non essere : infatti alcune nascono e finiscono, il che vuol dire appunto che sono possibili, possono essere e non essere. Ora, è impossibile che tutte le cose di tal natura siano sempre state, perché ciò che può non essere un tempo non esisteva. Se dunque tutte le cose possono non essere, in un dato momento non ci fu nulla nella realtà. Però, se questo fosse vero, anche ora non esisterebbe nulla, perché ciò che non esiste non comincia ad esistere se non per qualcosa che già esiste. Dunque non è vero che tutti gli esseri sono possibili ma bisogna ammettere che nella realtà vi sia anche un essere necessario, “e questo tutti dicono Dio”. La quarta via è quella dei gradi di perfezione. Si trova nelle cose il più e il meno di ogni perfezione, cioè di bene, vero, bello ecc. Vi sarà dunque anche il grado massimo di tali perfezioni e “questo chiamiamo Dio”. In altri termini, se gli enti hanno gradi diversi di perfezione, vuol dire che questi gradi non derivano dalle loro essenze, e dunque significa che li hanno ricevuti da un essere che dà senza ricevere, perché è la fonte di ogni perfezione, e cioè Dio. La quinta via è quella desunta dal governo delle cose. I corpi fisici (pianeti, stelle ecc.) operano per un fine, come appare dal fatto che operano quasi sempre allo stesso modo per conseguire la perfezione; donde appare che non a caso, ma per una predisposizione, raggiungono il loro fine. Ora, ciò che è privo di intelligenza non tende al fine se non perché è diretto da un essere conoscitivo e intelligente, come la freccia viene scoccata dall’arciere. Vi è dunque un essere sommamente intelligente da cui tutte le cose naturali sono ordinate ad un fine, “e questo essere chiamiamo Dio”.
LA TRINITA’,L’INCARNAZIONE E LA CREAZIONE DAL NULLA : Le verità fondamentali del cristianesimo – Trinità e Incarnazione – non sono dimostrabili con la semplice ragione però la ragione può cercare di chiarire in misura sufficiente il loro contenuto, mostrando che quello che rivela la fede non è impossibile. Per quanto riguarda il dogma della Trinità, la difficoltà è capire come l’unità della sostanza divina si possa conciliare con la trinità delle persone. Tommaso si serve a questo riguardo del concetto di relazione. Le persone divine sono costituite dalla loro relazione di origine : il Padre dalla paternità, cioè dalla relazione col Figlio; il Figlio dalla filiazione o generazione, cioè dal rapporto col Padre; lo Spirito dall’amore, cioè dalla relazione reciproca tra Padre e Figlio. Queste relazioni non sono accidentali in Dio (non vi può essere nulla di accidentale in Dio) ma reali : sussistono realmente nella essenza divina. Proprio l’essenza divina, dunque, nella sua unità, implicando le relazioni, implica la diversità delle tre Persone. Nell’Incarnazione, la difficoltà sta nel comprendere la presenza, nell’unica Persona di Cristo, delle due nature, divina ed umana. Ora, l’essenza o natura divina è identica con l’essere di Dio : Cristo ha natura divina ed è appunto Dio, sussiste come Dio, come persona divina. Egli è quindi una sola persona, quella divina. Data però la separabilità di essenza ed esistenza, Cristo, in quanto Dio, ha potuto benissimo assumere la natura umana (cioè l’anima razionale ed il corpo) senza essere “persona” umana. Si ricordi, a questo riguardo, il significato dei termini “persona” e “natura”. La “persona” indica una realtà distinta, che sussiste di per sé; la “natura” o “sostanza” o “essenza” indica ciò che è in comune ad individui della stessa specie, che quindi non esiste in sé ma solo nelle “persone” a cui è comune. Riguardo poi il problema della creazione dal nulla, Tommaso ritiene che non si possa dimostrare né l’inizio nel tempo né l’eternità del mondo e perciò lascia via libera per credere alla creazione nel tempo. L’essere del mondo viene da Dio : il fiat divino ha dato origine alle cose ma non si inserisce in una successione temporale. E’ un atto creativo che chiama le cose all’essere o, meglio ancora, fa che l’essere sia.
Guida allo studio del De Ente et Essentia di Tommaso d’Aquino
A cura di Andrea Porcarelli
1. Introduzione
L’opuscolo filosofico De Ente et Essentia (“Sull’ente e l’essenza”) è sempre stato considerato un sintetico compendio della metafisica tomista e per questo ha attirato l’interesse di molti commentatori e studiosi fin dal secolo XIII. Ancora oggi si presta molto bene ad essere usato in chiave didattica, aiutando a risolvere un problema non da poco per quanto concerne l’insegnamento della filosofia medievale: da un lato, infatti, vi è l’esigenza di un approccio al pensiero filosofico basato su un uso sostanzioso di testi, letti per ampie selezioni o integralmente, dall’altro lato vi sono autori di importanza cruciale (Tommaso D’Aquino è tra questi) che hanno disseminato le loro riflessioni in opere molto ampie (come la Summa Theologiae o la Summa Contra Gentiles). Una rilettura attenta degli opuscoli filosofici può consentire di superare tale ostacolo ed accostare in modo didatticamente efficace un autore come Tommaso D’Aquino.
Per quanto riguarda il periodo di composizione dell’opuscolo non vi è dubbio che esso faccia parte degli scritti giovanili di Tommaso. Tolomeo da Lucca afferma che fu scritto a Parigi, nel corso dei primi anni di insegnamento, quando Tommaso non era ancora maestro, ma propriamente Baccelliere Biblico, ossia assistente di cattedra che teneva lezioni e svolgeva un ruolo preciso nelle dispute. Se si tiene conto del fatto che Tommaso è giunto a Parigi nel 1252, ha iniziato a tenere lezioni come baccelliere nel ’54, ha conseguito la licentia docendi nei primi mesi del 1256 e fu accolto il 23 ottobre 1257 nella corporazione dei professori dell’Università parigina, possiamo collocare il nostro scritto tra il 1254 e il 1256, periodo in cui Tommaso scrisse tre libri: il Commento alle Sentenze, il De principiis naturae, il De ente et essentia. I principali interpreti collocano la composizione del De ente et essentia dopo quella del De principiis naturae, mentre Tommaso – in qualità di Baccelliere Biblico – commentava le Sentenze di Pier Lombardo, ad un’età di circa 29-30 anni.
Il motivo della composizione e i destinatari dell’opera possono essere desunti dalla dedica “ad fratres et socios”, ai confratelli ed ai compagni di studi. Fu probabilmente scritta per i compagni dell’Ordine che, giunti a Saint Jacques (il convento domenicano presso l’università di Parigi) per gli studi superiori, erano probabilmente spiazzati dalla novità rappresentata dall’uso delle nozioni filosofiche tratte dalla Metafisica di Aristotele. Probabilmente gli allievi avevano chiesto al loro giovane insegnante un compendio delle nozioni filosofiche fondamentali di cui si serviva e Tommaso ha probabilmente colto l’occasione per chiarire innanzitutto a se stesso il proprio lessico filosofico, che si andava progressivamente precisando. Del resto il genere letterario stesso dell’opuscolo filosofico o teologico (a differenza dei Commentari e delle Quaestiones disputatae, che sono frutto dell’attività didattica ordinaria) si caratterizza proprio per il legame stretto con l’occasione per cui è stato scritto, in genere legata ad esigenze espresse o inespresse di colui/coloro a cui è dedicato. Ricordiamo che i destinatari degli opuscoli di Tommaso sono i più diversi: il re di Cipro, la duchessa di Brabante, il Papa Urbano IV, l’Arcivescovo di Palermo, il Maestro Generale dell’Ordine domenicano, o – in tre casi – fra Reginaldo da Priverno (il suo segretario), a cui riserva sempre dediche molto cordiali.
I temi toccati dall’opuscolo saranno ripresi più volte nell’opera di Tommaso, sia direttamente – soprattutto nel Commento alla Metafisica di Aristotele e nelle Quaestiones Disputatae De Potentia – sia indirettamente, cioè utilizzando i concetti qui focalizzati per affrontare altre tematiche (per esempio nella Summa Theologiae o nella Contra Gentiles). Il pensiero di Tommaso mantiene, su queste tematiche, una profonda unità, anche se i diversi contesti, i diversi destinatari ed il diverso grado di complessità dei problemi incidono sui diversi livelli di profondità con cui le stesse tematiche sono affrontate nelle diverse opere.
Il testo (1) del De Ente et essentia ci è pervenuto in 165 manoscritti che riproducono il testo completo, 15 manoscritti incompleti, 39 edizioni a stampa (la prima delle quali, uscita a Padova, risale al 1475). L’edizione critica del testo è stata curata dai Domenicani di Santa Sabina (2) ed è apparsa nel 1976. Sono disponibili diverse traduzioni in lingua italiana (3).
Nel sintetizzare l’opuscolo seguiremo la distinzione in capitoli che risulta dall’Edizione Leonina (così chiamata perché si tratta della edizione critica delle opere di Tommaso voluta da papa Leone XIII iniziata dopo la pubblicazione dell’enciclica Aeterni patris) e dalla traduzione italiana di riferimento, ma gli stessi capitoli dell’opuscolo si inquadrano in uno schema strutturato che è bene premettere all’analisi del testo stesso, in modo da avere fin da subito uno sguardo di insieme.
1.1. Schema dell’opuscolo
Prologo-Intento dell’opera
Parte Prima- I termini del problema
Cap. I-Che cosa significano i termini “ente” ed “essenza”
Parte seconda – L’essenza si realizza diversamente nelle diverse realtà
Come l’essenza si realizza nelle sostanze composte (capp. II-III)
Cap. II-L’ente delle sostanze composte: come si differenziano le essenze delle sostanze composte.
Cap. III-Relazione tra l’essenza delle sostanze composte e le categorie logiche.
L’essenza nelle sostanze semplici (capp. IV-V)
Cap. IV-Negli enti semplici l’essenza non è costituita da materia e forma. Le sostanze semplici sono formate da essenza e atto di essere, ricevono l’atto di essere da Dio (in quanto causa efficiente), sono composte da potenza e atto.
Cap. V-L’essenza delle sostanze semplici (Dio, gli angeli e l’anima) e la loro relazione con le categorie logiche
L’essenza negli accidenti (cap. VI)
Cap. VI-Essenza dell’accidente. Distinzione degli accidenti dalla sostanza e tra di loro. Relazione tra l’essenza degli accidenti e le categorie logiche.
2. Sintesi del De Ente et Essentia
Prologo
Il breve prologo delinea l’intento dell’opera, che si configura come una sorta di “discorso sul metodo”, ovvero come una chiarificazione dei concetti fondamentali della metafisica e del loro uso filosofico; si sviluppa per gradi, secondo una propedeuticità che si modella sul modo di procedere della nostra intelligenza: a partire da ciò che le è più noto per giungere a ciò che è meno noto. Si sottolinea l’importanza – per evitare di commettere errori che potrebbero diventare sempre più gravi – di chiarificare fin da subito il significato dei termini (operazione che verrà compiuta nel capitolo primo).
Capitolo I
Il termine ente (4), propriamente parlando, può essere preso in due accezioni: a) l’una per cui esso “si divide nelle dieci categorie”, cioè l’ente reale, per cui non si può dire ente se non ciò che pone qualcosa nella realtà; b) l’altra “che significa la verità delle proposizioni”, vale a dire l’ente di ragione, per cui si può dire ente tutto ciò su cui è possibile formulare una proposizione affermativa. In questa seconda accezione si può dire che “sono” anche le privazioni e le negazioni (5).
“Ente” detto nel primo modo – come afferma Averroé – significa principalmente l’essenza e poiché l’ente, in tale accezione, si divide nelle dieci categorie è necessario che il termine “essenza” designi qualcosa che è comune a tutte le realtà che si collocano nei diversi generi e nelle relative specie. Poiché ciò in forza di cui una determinata realtà appartiene a un genere o a una specie viene indicato dalla definizione propria e formale, ne deriva che il termine essenza viene ad indicare – secondo l’espressione aristotelica – “ciò che l’essere era” (6), vale a dire il principio costitutivo dell’ente sotto l’aspetto formale. Un valore simile può essere dato al termine natura (7), che però designa l’essenza in quanto principio di operazioni: ogni essere esiste con una determinata essenza (che è ciò per cui è quello che è, ossia si colloca in un determinato genere e specie) ed agisce secondo la propria essenza, quindi ha una natura (l’uomo parla ed il cane abbaia, perché ciascuno agisce secondo la propria natura, cioè in conformità con la propria essenza, per cui appartengono a due specie diverse).
Si dicono enti in senso primario le sostanze (8), mentre gli accidenti vengono detti tali in senso derivato, per cui l’essenza si trova primariamente nelle sostanze, mentre negli accidenti si può parlare di essenza solo in un certo senso. Le sostanze, a loro volta, si dividono in semplici e composte: in entrambe vi è l’essenza, ma quelle semplici hanno un essere più nobile e sono causa delle sostanze composte, ma giacché per noi risulta più difficile la conoscenza dell’essenza di tali sostanze, è opportuno iniziare la trattazione dall’essenza delle sostanze composte, in modo che – partendo da ciò che è più agevole in rapporto al nostro modo di conoscere – il cammino di apprendimento risulti più adeguato.
Capitolo II
Le sostanze composte si dicono tali perché hanno una “materia” e una “forma”, ed entrambe sono elementi costitutivi della loro essenza. Che la sola materia non possa costituire l’essenza delle sostanze composte è evidente (visto che il motivo per cui si ascrive una sostanza ad una determinata specie è sul versante della forma e non della materia), ma neanche la sola forma coincide con l’essenza: infatti – si è detto – l’essenza è ciò che viene indicato mediante la definizione della realtà di cui stiamo parlando e la definizione delle sostanze naturali non contiene solo la forma, ma anche la materia, altrimenti le definizioni fisiche e quelle matematiche non differirebbero tra loro (9). Dopo avere escluso che la materia entri nelle definizione delle sostanze naturali “in aggiunta” all’essenza (questo è proprio degli accidenti) o che l’essenza designi la relazione tra materia e forma, Tommaso conclude: “rimane dunque che il termine essenza nelle sostanze composte significa ciò che è composto da materia e forma”, citando a suffragio di tale conclusione anche le posizioni di Severino Boezio, Avicenna e Averroé, per poi riprendere e precisare il discorso, dicendo che “concorda con questo anche la ragione, poiché l’essere di una sostanza composta non è soltanto della forma, né soltanto della materia, ma dello stesso composto. Ora l’essere è ciò secondo cui si dice che una cosa è. Perciò bisogna che l’essenza, per la quale una cosa è denominata ente, non sia soltanto forma, né soltanto materia, ma l’una e l’altra”. A questo punto, però, si pone il problema di conciliare tre elementi:
l’universalità dell’essenza di ciò che esiste (tutti gli uomini sono uguali in quanto uomini, come tutti i cavalli sono uguali in quanto cavalli, cioè hanno la stessa essenza);
il fatto che nell’essenza delle sostanze composte sono incluse sia la materia che la forma (è quanto si è appena affermato);
il fatto che il principio di individuazione dipenda dalla materia (se due cavalli sono uguali in quanto cavalli, si distinguono perché l’uno è questo cavallo e non quello).
Tommaso scioglie questo nodo precisando in che senso la materia vada considerata principio di individuazione: non in assoluto (il fatto che Socrate abbia un corpo “umano”, con carne e ossa, fa parte della sua essenza di uomo), ma in quanto “signata quantitate” (10) (cioè “materia contrassegnata dalla quantità”, nel senso che un individuo è tale non perché ha carne ed ossa, ma perché si tratta di questa carne e queste ossa).
Un ulteriore approfondimento di tali idee passa attraverso la precisazione dei rapporti tra genere e differenza specifica, cercando di fugare alcuni equivoci derivanti dalle speculazioni di quanti hanno confuso l’ente reale con l’ente logico. Se stiamo parlando dell’ente reale, infatti, il rapporto tra genere e specie non va concepito intendendo il primo come una sorta di realtà “chiusa” in se stessa, a cui le perfezioni proprie delle specie in cui si distingue si aggiungerebbero in modo quasi “estraneo”, mentre le diverse differenze specifiche sono contenute in modo implicito nella nozione del genere. Di conseguenza – scrive Tommaso – “se animale significasse soltanto una realtà che possiede una perfezione tale che possa sentire e muoversi mediante un principio esistente in essa, con esclusione di un’altra perfezione, allora qualunque perfezione ulteriore si aggiungesse starebbe rispetto all’animale a modo di parte, e non come contenuta implicitamente nel concetto di animale: e così animale non sarebbe genere; invece animale è genere in quanto significa una realtà dalla cui forma può provenire il senso e il moto, qualunque sia quella forma, sia essa un’anima soltanto sensitiva, oppure allo stesso tempo sensitiva e razionale. Così dunque il genere indica in modo indeterminato tutto ciò che è nella specie, giacché non significa la sola materia. Allo stesso modo la differenza significa il tutto e non soltanto la forma”. In altri termini potremmo dire che l’essenza dell’ente reale include in sé il genere, la differenza specifica e la stessa materia da cui le sostanze composte non possono prescindere, anche se ciascuna si rapporta all’essenza in modo diverso:
il genere (es. animale) designa la sostanza nel suo complesso, senza indicare la determinazione della forma che le è propria, per cui esso viene – in qualche modo – ricollegato alla materia, anche se non deve essere confuso (11) con essa (il termine “animale”, detto di un uomo, non indica semplicemente la sua parte materiale, ma la sostanza di quell’uomo in quanto essere capace di sensazione e movimento, prescindendo dalla forma razionale che gli è propria).
La differenza specifica (es. “razionale”, nel caso dell’uomo) viene desunta direttamente dalla forma, prescindendo in prima istanza dal riferimento ad una materia determinata.
La definizione, ossia la specie (“animale razionale”) li comprende entrambi, con un riferimento alla materia, designata dal genere, ed alla forma, designata dalla differenza specifica.
Il genere, la differenza specifica e la specie si rapportano – rispettivamente – alla materia, alla forma ed al composto (sinolo), ma non vanno identificati con essi, perché ciascuno di essi in realtà designa il tutto (la sostanza) sotto un determinato aspetto. Per questo diciamo che l’uomo è animale razionale e non che consta di animalità e razionalità, come invece diciamo che consta di anima e corpo, per cui sono corrette tutte e tre le seguenti affermazioni: l’uomo è un animale, l’uomo è razionale, l’uomo è animale razionale; mentre non è corretta nessuna delle due: l’uomo è corpo, l’uomo è anima.
A questo punto Tommaso considera il rapporto tra la specie e l’individuo, ovvero prende in esame la differenza tra l’essenza dell’individuo e l’essenza della specie. Se parliamo dell’ente reale vi è un certo parallelismo tra il rapporto che abbiamo descritto tra genere e specie ed il rapporto tra specie ed individuo: come la natura del genere è indeterminata rispetto alla specie, così la natura della specie è indeterminata rispetto agli individui e come il genere contiene indistintamente il principio formale delle diverse differenze specifiche delle specie che esso racchiude, così la specie contiene in sé indistintamente il principio materiale dell’individualità. È in questo modo che il termine “uomo” indica l’essenza della specie e si può predicare di tutti gli individui (Socrate è uomo), nel senso che non esclude la designazione della materia (per cui Socrate è un individuo diverso da Alcibiade), ma la contiene in modo indistinto. Se invece ci riferiamo all’ente di ragione, per cui intendiamo alludere all’essenza dell’uomo inteso come specie, allora usiamo il termine “umanità”, che non si può predicare degli individui (non si può dire “Socrate è l’umanità”) perché esclude il principio di individuazione ed è questo il motivo per cui degli individui non si può dare una definizione.
Capitolo III
Si può parlare dell’essenza in termini di genere o di specie, se questa viene intesa come un “tutto” che contiene indistintamente e implicitamente ciò che è proprio dell’individuo. La natura o essenza, così intesa, può a sua volta venire considerata in due modi: in primo luogo secondo la propria definizione, in astratto, in modo tale da escludere ogni determinazione accidentale che è propria degli individui; in secondo luogo l’essenza può essere considerata secondo l’essere che ha nei diversi enti ed in questa seconda accezione si può predicare dell’essenza anche qualche determinazione accidentale. La natura – considerata in tal modo – ha due livelli di esistenza: l’uno nelle realtà singolari, l’altro nella mente di chi le conosce. Nelle realtà individuali la natura o essenza ha un essere molteplice, che dipende dalla loro diversità, e tuttavia alla natura stessa – considerata in astratto – non appartiene nessuna di tali differenze in senso proprio. Si deve dunque affermare che la natura dell’uomo, considerata in assoluto, astrae da qualsiasi essere, in modo tale – però – da non escludere nessuno di essi. La natura umana, considerata in astratto, non coincide però con la nozione universale di “umanità”, che ha la caratteristica di essere “comune” a tutti gli uomini: se la natura umana (ancorché considerata in astratto) coincidesse semplicemente con l’universale “umanità” ognuno degli uomini (di cui si dice che ha la natura umana) avrebbe anche la caratteristica della “comunanza” che invece è propria della specie intesa in senso logico. La nozione della specie appartiene dunque alla natura umana – intesa in astratto – solo per quell’essere che questa (la natura umana) ha nell’intelletto e non per quello che ha negli individui. Interessante è l’esempio che Tommaso usa per chiarire questo delicato passaggio della propria opera; supponiamo che esista una statua raffigurante (dal punto di vista corporeo) una pluralità di individui (possiamo immaginare dei gemelli o degli individui dai tratti somatici molto simili), è facile constatare come l’immagine corporea (la figura) di quella statua avrebbe un suo essere individuale in quanto esistente in quella materia (marmo o bronzo) e l’aspetto della comunanza in quanto capace di rappresentare una pluralità di individui (tutti i gemelli che hanno quell’aspetto fisico) (12).
La natura umana – considerata in astratto, quindi prescindendo dalle differenze individuali – si predica di Socrate in senso proprio, mentre l’umanità (intesa come specie) è tale solo in forza di un accidente che le deriva dal fatto di esistere nell’intelletto umano (è proprio della specie il fatto di essere “predicabile di molti” in quanto nozione comune ad essi). Tuttavia, il motivo per cui l’intelletto individua nel genere e nella specie la caratteristica di cui sopra (il fatto di essere predicabile di molti allo stesso modo) ha un fondamento nella realtà delle cose, che hanno una loro unità per cui l’una si dice dell’altra: il fatto che di Socrate si possa dire che è “uomo”, come lo si può dire di Platone dipende dal fatto che la loro natura – considerata in astratto e prescindendo dalle differenze individuali – è effettivamente “una”: per questo motivo si dice che l’umanità (intesa come specie) è comune a tutti coloro di cui si può predicare (gli uomini). La nozione di specie si rapporta a quella di natura o essenza in forza di un accidente che questa assume quando esiste nell’intelletto umano.
Capitolo IV
Si discute sull’esistenza di sostanze totalmente immateriali (le intelligenze angeliche e le anime umane) di cui Avicebron sostiene che sono composte di materia e forma, mentre Aristotele dimostra che – essendo capaci di accogliere le forme intelligibili – devono essere a loro volta prive di ogni materialità, ma non sono prive della composizione tra essenza ed essere. È infatti possibile che esistano forme senza materia (visto che è la forma a conferire l’essere alla materia nelle sostanze materiali, e non viceversa), anzi si tratta di forme più vicine al principio primo che è Atto Puro e in esse coincidono la forma e l’essenza (mentre questo non accade per le sostanze materiali, in cui la stessa essenza è composta di materia e forma). Questo comporta il fatto che le essenze delle realtà composte, per il fatto di essere ricevute nella materia contrassegnata dalla quantità (che è principio di individuazione), si moltiplicano in forza della divisione della materia e possono essere identiche nella specie e diverse nel numero, mentre per le sostanze immateriali vi sono tante specie quanti sono gli individui, come affermava anche Avicenna.
Tali sostanze però non sono del tutto prive di ogni forma di composizione e di potenzialità, visto che nessuna di tali sostanze ha l’essere per essenza (questo si può dire solo dell’Essere assolutamente primo, che esiste in modo necessario, cioè l’Atto Puro), dunque vi è in esse – come in tutte le sostanze che esistono (13) – una distinzione reale tra essenza e atto di esistere.
Tutto ciò che caratterizza una determinata realtà o è causato dai principi della sua stessa natura (come è per l’uomo il fatto di essere capace di sorridere) o proviene da un principio estrinseco (come la luce nell’aria quando è illuminata); ma non è possibile che l’atto di essere di una determinata forma sia causato da quella stessa forma come causa efficiente. Quindi – dato che l’essere delle sostanze immateriali è distinto dalla loro forma o essenza – è necessario che ogni realtà in cui l’essere è distinto dalla sua essenza riceva l’atto di esistere da un altro. Tutto ciò che riceve da un altro qualcosa è in potenza rispetto ad esso e ciò che viene ricevuto rappresenta il suo atto, il che significa che la stessa essenza – in quanto tale – è in potenza rispetto all’atto di essere che riceve da Dio (14). Vi è pertanto una distinzione ed una gerarchia tra le intelligenze separate, secondo il grado della potenza e dell’atto: l’intelligenza superiore, che è più vicina (ontologicamente, cioè simile) al primo ha un grado maggiore di atto e minore di potenza, e così via. L’anima umana si trova in una situazione particolare: occupa l’ultimo posto (cioè il grado ontologicamente più basso) tra le sostanze intellettive, per cui il suo intelletto passivo si rapporta alle forme intelligibili come la materia prima si rapporta a quelle sensibili e – scrive Tommaso – “per il fatto che tra le altre sostanze intelligibili ha un grado maggiore di potenzialità, si fa talmente vicina alle altre realtà materiali, che la realtà materiale viene tratta a partecipare del suo essere, cosicché dall’anima e dal corpo risulta un solo essere in un solo composto; benché quell’essere, in quanto è proprio dell’anima, non sia dipendente dal corpo. Dopo questa forma che è l’anima si trovano le altre forme che hanno un grado ancora maggiore di potenza e sono più vicine alla materia, tanto che non possono sussistere senza la materia” (15).
Capitolo V
Da quanto affermato nei capitoli precedenti risulta chiaro come l’essenza si possa trovare nelle diverse realtà in tre modi, che Tommaso presenta secondo un ordine discendente: Dio, le sostanze puramente spirituali create, le sostanze composte di materia e forma.
In Dio l’essenza coincide con il suo stesso essere, nel senso che gli compete l’essere per essenza (è l’Essere Necessario) e che è perfettamente in atto (Atto Puro, non vi è nella sua essenza nulla che non sia anche esistente in atto); da ciò consegue che Egli non sia un genere né in un genere, è distinto da ogni essere, possiede in modo eminente ed eccellente tutte le perfezioni che si trovano in tutti i generi e che in Lui sono una cosa sola.
Nelle sostanze intellettuali create l’essere è distinto dall’essenza, benché la loro essenza sia priva di materia e coincida con la forma. Perciò il loro essere non è assoluto, ma è “ricevuto”, mentre la loro forma non è ricevuta in alcuna materia (16), per cui ognuna di esse è una specie a se stante (non si trova rispetto ad esse la pluralità degli individui della stessa specie), con eccezione dell’anima umana, a motivo del corpo a cui – per essenza – è unita. Riguardo alla possibilità, da parte nostra, di conoscere le differenze essenziali (cioè le differenze specifiche) che distinguono tali sostanze Tommaso propone una sintetica riflessione che risulta illuminante anche in rapporto al modo con cui ci è dato conoscere l’essenza delle realtà materiali: “si trovano in esse il genere, la specie e la differenza, benché le loro differenze specifiche siano per noi inconoscibili. Infatti anche nelle realtà sensibili ci sono ignote le differenze essenziali (che le distinguono tra loro); per cui tali differenze (che ci sono ignote) vengono indicate mediante le differenze accidentali che nascono da quelle essenziali, come la causa è designata mediante il suo effetto (…). Gli accidenti propri delle sostanze immateriali ci sono ignoti; per cui le loro differenze non possono essere indicate da noi, né per sé, né mediante le differenze accidentali” (17). Le differenze specifiche delle sostanze immateriali dipendono dal loro grado di perfezione.
In un terzo modo l’essenza si trova nelle sostanze composte di materia e forma, nelle quali l’essere è contrassegnato da un duplice legame con la finitudine e la potenzialità: l’atto di essere è finito e ricevuto da un altro essere e l’essenza stessa è ricevuta nella materia contrassegnata dalla quantità. Nelle sostanze corporee, propria a motivo della loro materialità, è possibile la molteplicità numerica degli individui di una stessa specie.
Capitolo VI
Tommaso introduce l’ultimo capitolo chiedendosi in qual modo si possa parlare di essenza degli accidenti. Questi, avendo una definizione incompleta (non è possibile definirli in modo completo senza dire anche “di quale soggetto” sono accidenti) che dipende dal fatto che hanno un essere solo accidentale (non possono esistere “in se”, ma solo “in altro”), avranno anche una “essenza incompleta”. Gli accidenti infatti ineriscono a sostanze che hanno già un loro “essere in sé” e causano in esse solo un essere secondario, perciò l’unione stessa dell’accidente con la sostanza non è a sua volta un essere in sé, ma ha una sua consistenza ontologica accidentale. Gli accidenti si possono a loro volta distinguere secondo il fatto che il loro essere (che si collega all’essenza delle sostanze a cui ineriscono) dipenda più dalla forma o dalla materia (18); le nozioni di genere, specie e differenza specifica vanno dunque intese – negli accidenti – in modo diverso rispetto alle sostanze. L’unione dell’accidente con il soggetto, infatti, non costituisce per sé un’unità essenziale, per cui dalla loro unione non risulta una natura che possa essere designata come genere o specie. Si distinguono i diversi tipi di accidenti (i nove predicamenti diversi dalla sostanza) secondo il modo diverso in cui si riferiscono alla sostanza: la quantità perché costituisce la misura delle sostanze corporee, la qualità in quanto disposizione della sostanza, e così via (19). All’interno di ciascuno di tali generi di accidenti le differenze specifiche (cioè i diversi tipi di qualità, di quantità, ecc.) si desumono dalla diversità dei principi da cui gli accidenti vengono causati e poiché gli attributi propri vengono causati dai principi propri del soggetto, questo entra nella loro definizione in luogo della differenza specifica, come ad esempio quando si dice che la scienza (cioè il possesso di determinate conoscenze organizzate) inerisce ad una determinata sostanza (un uomo) come accidente di tipo qualitativo (e si tratta di una qualità di specie diversa rispetto, ad es., al colore). Risulta pertanto evidente – conclude Tommaso – che l’essenza si trova in modo diverso nelle sostanze e negli accidenti, così come si trova diversamente nelle sostanze composte, nelle sostanze semplici e nell’essere perfettissimo in cui essenza ed esistenza coincidono.
3. Interpreti novecenteschi del De Ente et Essentia: Stein, Maritain, Gilson, Fabro
Storicamente, il primo celebre commento del De Ente et essentia è indubbiamente quello del Card. Gaetano (20), scritto per gli studenti di metafisica dell’Università di Padova nel 1493 e pubblicato nel 1496. Si tratta di un commento non molto ampio, ma acuto e originale, sostenuto dall’autorevolezza di un grande interprete del pensiero di Tommaso che ha certamente contribuito alla fortuna dell’opera nel corso della storia. Tra i commentari “antichi” del nostro testo possiamo citare anche quello di Pietro di Crokaert (21) pubblicato nel 1510, quello del De Ripa (22) e quello di Geronimo Contanero (23) del 1606.
I nodi concettuali maggiormente dibattuti dagli scolastici dei secoli successivi al XIII ruotano attorno alle definizioni fondamentali poste da Tommaso nell’opuscolo, a partire dagli stessi termini che ne costituiscono il titolo, con particolare riferimento alle modalità della distinzione tra essenza e atto di essere: i tomisti rigorosi sostengono la necessità di affermare una distinzione reale (distinctio realis), i suareziani contestano tale scelta e propendono per una differenza a livello puramente concettuale, che ha il suo fondamento nella reale contingenza dell’esistenza delle realtà create (distintio rationis cum fundamento in re, detta anche distinctio virtualis); gli scotisti parlano – a loro volta – di una differenza formale con un fondamento nella cosa stessa (distinctio formalis ex natura rei).
3.1. Edith Stein
Un posto peculiare nel panorama delle interpretazioni dell’opuscolo De Ente et Essentia va riservato a Edith Stein, che aveva elaborato all’inizio del 1930 un ampio studio dal titolo Potenz und Akt. Quando nel 1934 la direzione delle Carmelitane le affidò l’incarico di predisporre tale scritto per la pubblicazione, la Stein riscrisse interamente l’opera, ponendo al centro della propria riflessione un confronto plurilaterale tra le dottrine di Tommaso, rilette alla luce dei criteri interpretativi della fenomenologia husserliana, le riflessioni di Heidegger sul senso dell’essere e le sollecitazioni provenienti dal testo di Pwzywara (Analogia entis, la cui prima parte fu pubblicata nel 1931) e la prima delle allieve di Husserl, Hedwig Conrad-Martius. In tale orizzonte possiamo collocare la prospettiva in cui la Stein vede la centralità del problema dell’essere in vista dell’elaborazione di una philosophia perennis, nel senso più alto dell’espressione: “Se possiamo considerare predominante il problema dell’essere tanto nel pensiero greco che in quello medioevale – sia pure con la differenza che per i Greci questo problema sorgeva in relazione alla datità naturale del mondo creato, mentre per i pensatori cristiani (e in una certa misura anche per quelli ebrei e islamici) si allargava a motivo del mondo soprannaturale costituito da ciò che è offerto dalla Rivelazione -, costatiamo che il pensiero moderno, staccatosi dalla tradizione, è caratterizzato dal fatto d’avere considerato centrale il problema della conoscenza invece che quello dell’essere e d’aver sciolto di nuovo il legame con la fede e la teologia. (…) E si giunse alla scissione della filosofia in due correnti, che avanzarono separatamente, usando diversi linguaggi, senza preoccuparsi più di intendersi reciprocamente: da un lato la filosofia moderna e dall’altro la filosofia scolastica cattolica, che si riteneva philosophia perennis, ma che dal di fuori venne considerata come un fatto privato delle facoltà teologiche, dei seminari ecclesiastici e dei collegi religiosi. (…) Il flusso della vita, tuttavia, si è scavato un altro letto. Gli ultimi decenni hanno portato un cambiamento di situazione che si era preparato da varie parti e innanzi tutto in campo cattolico. (…) Non è sorprendente che occorressero proprio i decreti di Leone XII e di Pio I per dare nuova vita allo studio di san Tommaso, che ciò fosse indispensabile perché si sentisse prima di tutto l’urgenza di provvedere a un’edizione utilizzabile delle sue opere, che nelle biblioteche ci fosse ancora tanta dovizia di materiale manoscritto inedito e totalmente sconosciuto, e che solo negli ultimi anni si sia iniziata un’ampia opera di traduzione? (…) Il moderno rifiorire delle scienze dello spirito, esso stesso frutto della fine del secolo XIX e dell’inizio del XX ha sostanzialmente contribuito alla riuscita di queste imprese. Noi sappiamo oggi che il tomismo non è uscito dalla mente del suo maestro come un sistema già compiuto di concetti; sappiamo che è una vivente creazione dello spirito, di cui possiamo seguire la formazione e la crescita. Esso richiede d’essere assimilato da noi e di ritrovare in noi una nuova vita” (24).
Tre sono dunque i problemi di fondo che emergono nell’ontologia di Edith Stein: l’essere stesso, la struttura dell’ente e infine la sua articolazione nella molteplicità fenomenica. Scorrendo l’indice dell’opera da cui abbiamo preso le mosse si osserva immediatamente come le tre problematiche suddette vengano articolate in otto grandi temi che costituiscono i capitoli in cui si divide il testo:
il problema dell’essere;
atto e potenza come modi dell’essere;
essere essenziale ed essere attuale-reale;
essenza–essentia, ousia-sostanza, forma e materia;
l’ente in quanto ente (i trascendentali);
il senso dell’essere;
l’immagine della Trinità nella creazione;
significato e fondamento dell’essere individuale.
L’impostazione fenomenologica dell’analisi della Stein emerge con evidenza fin dalla scelta del punto di partenza dell’indagine sulla questione dell’essere, individuato nel “dato di fatto” dell’esistenza del proprio essere: “Tutte le volte che lo spirito umano nella sua ricerca della verità ha cercato un punto di partenza infallibilmente certo, si è imbattuto in questo qualche cosa inevitabilmente vicino: il dato di fatto del proprio essere. (…) Questa certezza del proprio essere è in certo senso la conoscenza più originaria; non è la prima nell’ordine temporale, poiché l’atteggiamento naturale dell’uomo è rivolto innanzitutto al mondo esterno, e occorre molto tempo prima che egli trovi finalmente se stesso; e non lo è nemmeno nel senso di un principio da cui si possano dedurre logicamente tutte le altre verità o in base al quale commisurare tutte le altre; ma lo è nel senso di ciò che mi è più vicino, che è da me inseparabile e perciò come un punto di partenza al di là del quale non si può andare. (…) Appena lo spirito si immerge con la riflessione nella considerazione del semplice dato di fatto del suo essere, gli si affaccia un triplice interrogativo: che cos’è l’essere di cui io sono consapevole? Che cos’è l’Io, che è consapevole del suo essere? Che cos’è quel moto dello spirito in cui mi trovo e in cui sono consapevole di esso in quanto mio e in quanto moto?” (25).
Le modalità dell’indagine della Stein procedono – in linea con l’impostazione husserliana – attraverso l’analisi delle unità di vissuto di cui si possono stabilire le condizioni di esistenza; al termine di questa disamina ella confronta le proprie conclusioni con quelle di Tommaso nel De Ente et essentia, mettendone in luce la sostanziale convergenza: “Concludiamo: la ousia nel senso più stretto e proprio, quello che in fondo importava ad Aristotele, è la sostanza cioè un reale fondato in sé, che contiene in sé la propria essenza e la sviluppa. L’essentia è la determinazione essenziale di questo ente inseparabile dall’essere, e che lo fonda. Negli esseri materiali ha la sua radice nella forma essenziale che dà forma alla materia; se sono oggetti materiali simpliciter, non si può separare la materia dalla forma: l’essenza è la materialità di una determinata specie, o forma; la materia è sempre formata in modo caratteristico, non è pensabile senza forma. Nei viventi la forma e la materia sono separabili: la forma è forma vivente, ossia anima. Ha il potere di dare forma al tutto in modo caratteristico e di animarlo. Il suo essere è vita, e la vita consiste nel dare progressivamente forma alla materia, e quindi in una attuazione progressiva dell’essenza, la cui caratteristica è appunto quella di dare forma alla materia. Gli esseri materiali estesi – inanimati e viventi – non esauriscono quanto si intende per ousia. L’ente sussistente esiste anche nel mondo dello spirito” (26).
La vera conclusione dell’opera della Stein, che dà il titolo alla medesima, consiste nell’esplicitazione dei nessi che distinguono da un lato e legano dall’altro l’essere temporale con l’essere eterno: “L’essere reale-temporale non è una realtà compiuta (= atto puro), ma la realizzazione di possibilità essenziali, aventi un inizio e un progresso. Questo implica l’opposizione tra essere autonomo e essere non-autonomo: l’inizio della realizzazione è il passaggio della possibilità essenziale alla realizzazione temporale o ingresso nell’essere reale (Dasein) temporale; la realizzazione graduale implica un ente che porta in sé delle possibilità non realizzate: qualcosa che non è ancora ciò che deve essere, però è già determinato nel suo dover essere, e quindi il suo procedere è prestabilito. L’essere reale-temporale è fondato su di sé e determinato in quanto all’essenza (ousia = sostanza). Le sue possibilità (potenze) non realizzate sono fondate in esso e il loro essere partecipa del suo essere. La loro realizzazione è la sua realizzazione e quindi il suo passaggio ad un grado superiore dell’essere” (27).
3.2. Jacques Maritain
Un contributo particolarmente significativo è quello di Jacques Maritain, la cui riflessione si inserisce nel dibattito sul primato dell’esistenza sull’essenza sollevato da Heidegger e Sartre. Maritain sostiene il primato non già dell’esistenza, ma dell’esistente, della concreta realtà dell’ente in cui la nostra intuizione intellettuale può cogliere l’essere, fondamento primo di ogni riflessione metafisica. “L’oggetto della metafisica (…) è l’essere in quanto essere, ens in quantum ens, l’essere non investito o incorporato nella quiddità sensibile, nell’essenza o natura delle cose sensibili, ma al contrario abstractum, l’essere liberato e isolato (per quel tanto che l’essere può fare astrazione dai suoi inferiori), è l’essere liberato e isolato dalla quiddità sensibile, l’essere visualizzato come tale e liberato nei suoi puri valori intelligibili. Quindi, la metafisica, al grado più elevato della conoscenza naturale, e nel momento in cui la conoscenza naturale diviene pienamente sapienza, fa emergere nei suoi valori puri, e svela ciò che è avviluppato e velato nella primissima conoscenza intellettiva. (…) Notiamo adesso che l’essere presenta due aspetti: l’aspetto essenza, che risponde innanzitutto alla prima operazione dello spirito (la formazione dei concetti è ordinata prima di tutto a cogliere, sia pure in molti casi ciecamente, le essenze, che sono attitudini positive a esistere); e l’aspetto esistenza, l’esse propriamente detto, che è il termine perfettivo delle cose, il loro atto, la loro ‘energia’ per eccellenza, la suprema attualità di tutto ciò che è. E non bisogna credere che questo secondo aspetto, sovrano e perfettivo dell’essere, sfugga all’intelligenza. I platonici tendono generalmente a limitare l’oggetto dell’intelligenza umana alle essenze, mentre la direzione profonda della filosofia di san Tommaso porta l’intelligenza, la filosofia, e la metafisica, non solo alle essenze, ma anche all’esistenza, a questo termine perfetto e perfettivo, a questo estremo completamento dell’essere” (28).
Tra le dottrine più caratteristiche – e più discusse – della riflessione di Maritain vi è quella dell’intuizione dell’essere in quanto essere, che egli esprime in questi termini: “L’essere che è oggetto del metafisico, l’essere in quanto essere, non è né l’essere particolarizzato delle scienze della natura, né l’essere vago del senso comune, né l’essere derealizzato della vera logica, né lo pseudo-essere della pseudo-logica, ma è l’essere reale in tutta la purezza e l’ampiezza della sua intelligibilità propria e del proprio mistero. Questo essere è sussurrato nelle cose e in tutte le cose, le cose lo dicono all’intelligenza, ma non lo dicono a tutte le intelligenze: solo a quelle che sanno intendere, per cui anche qui si può dire con ragione: qui habet aures audiendi, audiat. L’essere appare allora secondo i suoi caratteri propri come transoggettività consistente, autonoma e essenzialmente varia, perché l’intuizione dell’essere è nello stesso tempo intuizione del suo carattere trascendentale e del suo valore analogico. Non basta imbattersi nella parola essere, dire ‘essere’, bisogna avere l’intuizione, la percezione intellettuale dell’inesauribile e incomprensibile realtà così manifestata come oggetto. È questa intuizione che fa il metafisico” (29).
È nell’intuizione intellettuale dell’essere in quanto essere che il metafisico “vede” – secondo Maritain – la pluriforme ricchezza analogica dell’essere stesso e – in essa – il principio primo del conoscere, ossia il principio di non contraddizione: “Il filosofo, quando esprime il principio di identità, lo esprime in funzione dell’intuizione metafisica dell’essere, e, allora, vede in quel principio la prima legge fondamentale della stessa realtà, legge meravigliosa perché afferma ex abrupto il primo mistero dell’essere, la sua consistenza e nello stesso tempo la sua abbondanza, legge che si tradurrà nelle cose, secondo modalità infinitamente differenti e secondo un’infinita varietà di applicazioni; non è affatto in ragione di una specie di procedimento logistico che il metafisico vede e impiega il principio di identità, quasi che secondo tale principio, si debba ridurre al puro identico, cioè cancellare tutte le diversità e tutte le varietà dell’essere. Perché egli intuisce questo principio col suo modo di realizzazione analogico; nello stesso momento in cui ha intuito l’essere in quanto essere, l’essere nel suo puro tipo intelligibile, egli ha intuito il valore analogo, essenzialmente analogo, del concetto di essere, che è implicitamente molteplice e si realizza nelle diverse cose in modo da ammettere tra di esse delle differenze di essenza, anche totali e abissali; il principio di identità salvaguarda la molteplicità e la diversità delle cose e, ben lontano dal riportare tutte le cose all’identico, è, come dicevamo altrove, il custode della molteplicità universale, l’assioma delle diversità irriducibili dell’essere: se ogni essere è ciò che è, esso non è ciò che sono gli altri esseri” (30).
3.3. Étienne Gilson
Tra i grandi interpreti che nel ‘900 hanno proposto autorevoli interpretazioni del De Ente et essentia, va citato certamente Étienne Gilson, che nella sua celebre opera del 1948 (31), L’essere e l’essenza, si muove secondo le tre coordinate fondamentali della sua riflessione: l’analisi del patrimonio storico della filosofia, l’esplicitazione storico-critica delle problematiche gnoseologiche sottese alle diverse posizioni, per giungere fino a considerazioni di teologia naturale come momento culminante della speculazione metafisica a cui la riflessione gnoseologica deve sempre rimanere ancorata. Il nodo storico fondamentale che viene affrontato è quello del rapporto tra la tentazione “essenzialista” ed una metafisica dell’essere, nel corso dei secoli. Dopo avere preso le mosse dai filosofi della Grecia antica, Gilson giunge al dibattito proprio del pensiero medievale, esponendo in modo analitico le ragioni di Avicenna, Averroé, Sigieri di Brabante, per poi presentare – all’interno del proprio contesto storico – la riflessione metafisico-gnoseologica di Tommaso d’Aquino, di cui si coglie la specificità in questi termini: “Il rapporto dell’esistere con l’essenza si presenta quindi come quello di un atto che non è una forma, con una potenzialità che non è una materia, cioè con una sorta di potenzialità. È necessario ora stabilire la possibilità stessa di un tale rapporto, poiché ci si può domandare se, nel caso in cui l’atto di cui si tratta sia l’esistenza, la sua composizione con una potenza qualunque sia concepibile. Per poter entrare in composizione reale con l’esistenza, bisogna evidentemente che l’essenza stessa sia reale, cioè che essa esista; ciò che si chiama composizione reale di essenza e di esistenza, si dirà, dovrebbe dunque piuttosto chiamarsi composizione reale di esistenza e di esistenza, il che è assurdo. In altri termini, se l’essenza di cui si parla esiste, essa non deve più comporsi con l’esistenza; se essa non esiste, poiché non è nulla, essa non può comporsi col nulla. (…) Ora, ciò che dice proprio Tommaso, è che l’esistenza non è concepibile se non come quella di una sostanza che esiste. Poiché è esatto dire che, se noi la separiamo dal concetto di ciò che esiste, cioè dalla sostanza o dalla “cosa”, la “esistenza” come tale è un termine senza contenuto proprio, ma non bisogna affrettarsi a concludere che ciò che non è oggetto di concetto, non è oggetto di conoscenza, e che ciò che non è oggetto di conoscenza non è. È tuttavia quello che si fa; poiché, si dice – in quanto né per l’uomo né per Dio stesso l’atto d’essere non è concepibile al di fuori di un’essenza qualunque – l’esse non ha esistenza propria che gli permetta di comporsi con l’essenza, né di distinguersene. Qui non si tratta più semplicemente di scegliere tra due interpretazioni possibili dell’ontologia tomista, ma tra due concezioni eterogenee e della filosofia stessa. Sul fatto che non possediamo un concetto quidditativo dell’esse, tutti sono d’accordo; ma la difficoltà non è qui. Ci si dice che ciò che non è concepibile non è pensabile, e ciò che non è pensabile non è. Ora, può darsi precisamente che la metafisica di san Tommaso richieda un metodo più complesso di questo concettualismo intransigente, la cui legge sembra talvolta voler dominare l’intelletto di Dio stesso. Se l’ontologia tomista include, come abbiamo detto, quella di Aristotele, essa deve in effetti riconoscere la presenza, nella struttura di ciascun essere reale, di una causa dell’essere afferrabile da un concetto, che è l’essenza, ma se l’ontologia tomista comporta inoltre uno sforzo per oltrepassare quella di Aristotele, ponendo al di là dell’essenza un atto dell’essenza stessa, essa obbliga a riconoscere l’attualità propria di un esse che, poiché trascende l’essenza, trascende anche il concetto. Le argomentazioni in senso contrario sono formalmente impeccabili, ma esse provano che san Tommaso non avrebbe potuto distinguere realmente l’essenza dall’esistenza, se avesse identificato il reale con il pensabile e il pensabile con ciò che è oggetto di un concetto quidditativo. Come avrebbe potuto fare? Esigere che l’esse sia concettualizzabile, è volere che esso sia una cosa; ora, se ciò che abbiamo detto è vero, l’esse è l’atto costitutivo ultimo di ogni cosa; esso stesso non potrebbe esserne una. Resta dunque possibile, per un’ontologia che non sia un “cosismo” integrale, comporre l’esistere con l’essenza e distinguerlo” (32).
Gilson può poi passare all’analisi del rapporto tra essere ed essenza, mettendo in luce quello che dal suo punto di vista è il “cuore” dell’opera di Tommaso di cui qui ci stiamo occupando, ossia le modalità della distinzione tra essenza e atto di essere: “Il principio che fonda la necessità di questa distinzione si trova nel fatto stesso che finisce per renderla inconcepibile. L’esse, facciamo notare, non è concepibile che in un’essenza. Niente è più vero, ma è proprio per questo che, quando si parla di un atto finito di esistere, bisogna necessariamente che questo atto e la sua essenza siano aliud et aliud. Ci sono degli esseri finiti, è un fatto, e sono anche i soli esseri di cui abbiamo esperienza; ora, la possibilità di un essere finito suppone che il suo atto di esistere sia “altro” dalla sua essenza. Se si trattasse in effetti dell’esse puro, non sarebbe così. L’atto puro di esistere è integralmente atto, cioè lo è sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ordini, per la semplice ragione che essendo anteriore a tutti come la condizione della loro stessa possibilità, li trascende tutti. L’esse puro non è dunque solamente illimitato nell’ordine dell’esistenza propriamente detta, lo è anche nell’ordine dell’essenza, poiché precede quest’ordine e, di conseguenza, nessuna determinazione essenziale si applica ad esso. Ed è per questo, come san Tommaso nota nel De ente et essentia, che alcuni filosofi hanno potuto sostenere che Dio non ha essenza; poiché egli è l’esse puro, ciò che si chiamerebbe la sua quiddità, o essenza, si confonde in effetti necessariamente con il suo esse. Per ragioni legate senza dubbio alla sua dottrina dei nomi divini, san Tommaso sembra avere evitato di negare che Dio abbia una essenza; preferisce dire che l’essenza di Dio è il suo atto stesso di esistere. D’altronde in qualsiasi modo lo si esprima, il fatto resta quello che è: l’esse puro non è determinato da alcuna essenza che lo faceva essere tale. Al livello supremo dell’essere in cui tentiamo qui di elevarci, il problema del rapporto tra essenza ed esistenza svanisce, per riduzione dell’essenza all’atto puro di esistere” (33).
Gli interrogativi che lo storico della filosofia si pone di fronte a tali riflessioni sono numerosi e profondi, per cui lo stesso Gilson si preoccupa di approfondire ulteriormente il significato delle speculazioni metafisiche di Tommaso, anche per mettere in luce il rapporto che esse hanno con il dibattito filosofico del loro tempo e porre le premesse per capire per quali motivi siano state lette in un certo modo dagli autori delle epoche successive. Riportiamo ancora alcuni passaggi che ci sembrano importanti: “Non bisogna dunque immaginare la composizione metafisica di essenza e di esistenza come una composizione fisica tra due elementi, di cui ciascuna dovrebbe già godere, per renderla possibile, dell’esistenza concreta che la loro composizione ha per fine di spiegare. Un esistente non è composto da esistenti, ma da elementi che dipendono tutti dall’ordine dell’essere, sebbene sotto aspetti diversi. Non soltanto può darsi che questi elementi componenti non siano nulla gli uni senza gli altri, ma è necessario (…) che ciascuno di questi elementi non sia in effetti nulla di ciò che è l’altro. E questo è proprio il caso. In una sostanza concreta realmente esistente, la forma, presa in se stessa, è un non essere di esistenza attuale, poiché, precisamente in quanto forma, essa non ha nessun’altra esistenza se non quella di cui essa partecipa. Se ora si vuole parlare non più solamente di un non-essere di esistenza attuale, ma del non-essere dell’atto o della forma per cui qualcosa partecipa all’esistenza, allora è la materia, naturalmente priva di questo atto che diventa un non-essere; quanto alla forma sussistente, non si presenta più allora come un non-essere, ma come essente, al contrario, un atto. In senso proprio, presa in se stessa, essa è la forma che partecipa all’atto ultimo, che è l’esistere. Ritroviamo dunque qui, sotto un altro aspetto, l’ordine ontologico doppio di cui notavamo la presenza all’interno della sostanza stessa. La materia non ha essere attuale che per la forma; chi negherà tuttavia che vi sia, in san Tommaso, distinzione reale di forma e di materia? A sua volta l’unione della materia e della forma non ha esistenza che attraverso il suo atto di esse, rispetto al quale essa è essa stessa in potenza, da cui essa è a sua volta veramente distinta e inseparabile, e con il quale essa deve dunque necessariamente comporsi. (…) Queste analisi ci lasciano in presenza di un universo, il cui essere è, questa volta, tutt’altro che quello del mondo di Aristotele. Il cuore del reale non è più la sostanza che è, e neanche la forma, il cui atto la fa essere ciò che essa è, ma l’esse, il cui atto la fa esistere. Si ritrova naturalmente qui, ma su un altro piano e ad una profondità mai prima attinta, la formula neoplatonica del Liber de causis tante volte citata e commentata nel medioevo: prima rerum creatarum est esse. Essa non significa più ormai che la prima realtà che merita il nome di essere sia prodotta da un principio primo trascendente l’essere stesso, essa vuol dire invece che da un principio primo, che è esso stesso l’Esse assoluto, derivano per via di creazione gli atti di esse, finiti e delimitati dalla loro essenza, ma in ciascuno dei quali si trova anzitutto, come condizione della possibilità di tutto il resto, il suo proprio atto di esistere” (34).
Il testo di Gilson prosegue la sua analisi storica mettendo in luce come la possibilità del ritorno di qualche forma di “essenzialismo” sia sempre in agguato e ad essa tornano già gli scolastici immediatamente successivi all’Aquinate e molti dei grandi trattatisti che consegneranno al pensiero filosofico moderno una “ontologia” che sarà prevalentemente caratterizzata da posizioni di tipo essenzialistico. Contro tale ontologia insorgerà il pensiero moderno, da Cartesio a Kant e fino agli autori del XX secolo noti a Gilson mentre scriveva la sua opera. Parlando di Wolff, in particolare, Gilson sottolinea come egli definisca l’esistenza come il “complemento della possibilità”, fondandosi sulla definizione di “ente” più “essenzialista” che si possa immaginare: Ens dicitur quod existere potest, consequenter cui existentia non repugnat (35) (si dice “ente” ciò che può esistere, e – di conseguenza – ciò rispetto a cui non è contraddittoria l’esistenza). Le critiche di Kant e dei filosofi a lui successivi contro questo tipo di ontologia “essenzialista” non fanno altro che metterne in luce i limiti e le contraddizioni, senza con questo inficiare quella metafisica dell’atto di essere che è invece caratteristica del pensiero di Tommaso. Nei capitoli conclusivi del testo Gilson riflette, da storico, sulla “fortuna” della riflessione metafisica tomista, sui motivi del naufragio delle metafisiche essenzialiste, sull’opportunità di rilanciare – in un modo adeguato ai tempi in cui viviamo – prospettive metafisiche più aperte all’essere nella sua globalità. Potremmo considerare queste pagine come una sorta di “bilancio speculativo” della riflessione tomista sui temi dell’essere e dell’essenza, alla luce delle istanze (delle domande) poste anche dai filosofia a lui successivi e che solo in minima parte lo avevano potuto direttamente conoscere: “Le ontologie dell’essenza non commettono solamente l’errore di ignorare il ruolo dell’esistenza, ma si ingannano sulla natura dell’essenza stessa. Dimenticano semplicemente che l’essenza è sempre quella di un ente, che non viene espresso nella sua interezza dal concetto della sola essenza. Vi è, nel soggetto che ciascuna essenza designa, un elemento metafisico che trascende la stessa essenza. Come dire che la realtà corrispondente al concetto contiene sempre, oltre alla sua definizione astratta, quell’atto di esistere che, trascendendo insieme l’essenza e la sua rappresentazione concettuale, non può essere raggiunto nel giudizio. (…) L’errore fondamentale dei metafisici dell’essenza è quello di prendere la parte per il tutto e di speculare sull’essenza come se essa fosse l’ente. Le essenze non dovrebbero mai essere concepite come gli oggetti ultimi della conoscenza intellettuale, perché la loro stessa natura le impegna nell’ente reale concreto. Astratte dall’ente, esse esigono di reintegrarlo. Il fine dell’astrazione intellettuale non è quello di porre le essenze nel pensiero come delle presentazioni complete e sufficienti in se stesse. Noi non astraiamo le essenze in vista di conoscere delle essenze, bensì in vista di conoscere gli enti stessi ai quali esse appartengono. (…) A Tommaso d’Aquino piaceva ripetere, con Avicenna, che l’ente è ciò che cade in primo luogo sotto la presa dell’intelletto, e questo è vero, ma non significa che la nostra prima conoscenza sia il concetto astratto di una essenza pura che sarebbe quella dell’essere in generale. Ci si può anzi chiedere se una tale conoscenza è di per sé possibile. Ciò che si offre primariamente è qualche percezione sensibile, il cui oggetto è immediatamente conosciuto dall’intelletto come qualche “cosa” o come “un essere”, e tale apprensione diretta da parte di un soggetto conoscente comporta un’operazione duplice ma simultanea, con la quale egli coglie ciò che questo essere è e giudica che esso è. Questa ricomposizione istantanea dell’esistenza di un dato oggetto con la sua essenza non fa che prendere atto della struttura metafisica di tale oggetto, e la sola differenza sta nel fatto che anziché essere semplicemente colto dall’esperienza sensibile, esso è ormai conosciuto intellettualmente. (…) L’essere non è che venga per primo nel senso che ciò che viene dopo non sarebbe più essere. Giunto per primo, l’essere non se ne va mai più. L’essere accompagna tutte le mie rappresentazioni. E anche così non si è detto a sufficienza, poiché, in verità, ogni conoscenza è “conoscenza dell’essere”. La conoscenza non esce dall’essere in quanto fuori di lui non c’è niente. L’esempio classico, tante volte citato dagli scolastici, racchiude una profonda verità nella sua stessa banalità. Ciò che io non vedo a tutta prima che da lontano, all’inizio non è per me che qualche cosa, un “essere”; se l’oggetto si avvicina, vedo che è un animale, ma resta ancora “un essere”; se si avvicina ancora di più, saprò che è un uomo e, infine, che è Pietro, ma tutte queste successive determinazioni dell’oggetto conosciuto sono sempre e solo delle conoscenze via via più determinate di un essere. (…) L’essere dunque non è soltanto il primo oggetto di conoscenza intellettuale nel senso che sarebbe implicato fin dal primo oggetto conosciuto, ma altresì nel senso che è implicato in ogni oggetto conosciuto e che ogni conoscenza, quale che ne sia l’oggetto, è anche e anzi prima di tutto conoscenza dell’essere”(36).
3.4. Cornelio Fabro
Sulla stessa linea si colloca l’opera di Cornelio Fabro, che si colloca nel cuore del presente dibattito con almeno tre opere della sua ampia produzione: La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso (1939), Dall’essere all’esistente (1957), Partecipazione e causalità (1961). L’ente, inteso nel senso generalissimo di “ciò che in qualche modo ha l’essere” rappresenta il primo oggetto del nostro pensiero (“quod primo intellectus concipit”), la cui apprensione iniziale precede ogni funzione iniziale di tipo formalistico (incluso il principio di non contraddizione) che invece è resa possibile solo in seno a tale apprensione dell’ente. D’altro canto l’ente, nel tomismo autentico, non è unità di essenza ed esistenza (come pretende la scolastica essenzialistica o formalistica), ma è composizione reale di essenza ed esse partecipato, plesso concreto di potenza ed atto. Alla coscienza del primato dell’esse rispetto a tutte le altre perfezioni, però, non si giunge immediatamente, ma attraverso una “riflessione intensiva”, ovvero una resolutio di tutte le perfezioni formali nell’atto di essere inteso come loro principio fondante. Ripercorriamo attraverso un chiaro testo di Fabro i passaggi essenziali della sua argomentazione. “Ente è un termine participiale di senso attivo, che indica in concreto l’esercizio di una formalità, quella dell’essere: ENTE allora è ciò che è, Id quod est, come camminante è ciò che cammina. Ma questa indicazione grammaticale non basta; essa resta troppo vaga; poiché l’essere non è una formalità qualsiasi, ma al tutto speciale, e non suscettibile di un unico significato, ma di diversi, onde anche il concreto “Ente” è un concreto sui generis, la cui intelligibilità pone delle esigenze speciali. (…) Pertanto al termine concreto “Ente” corrispondono in astratto nel pensiero tomista due termini: “Essenza ed Essere”, che stanno a significare due attualità, dalle quali si comprende risultare l’ente reale, cioè l’essenza e l’actus essendi, ovvero l’esse essentiae e l’esse existentiae. Quando ci è noto di una cosa l’esse essentiae sappiamo “che cosa” è, e perché qualcosa venga a diversificarsi in mezzo alle altre con le quali coesiste; per l’esse existentiae sappiamo che c’è, che esiste di fatto, e non può esser ridotta o confusa con un concetto od un vano desiderio. Si noti subito però che “essenza” e “actus essendi” sono bensì due significati (intentiones) distinti, ma non indipendenti, cioè perfettamente separabili, poiché l’uno implica necessariamente un riferimento all’altro; non si può comprendere un’essenza se non in relazione all’esistenza, o come possibile se l’essenza è considerata in astratto, o come reale se l’essenza è considerata come realizzata di fatto in natura. Similmente l’esistere non è concepibile, per noi, se non come atto, possibile o reale, di qualche formalità: l’essere puro per sé sussistente, non è per noi oggetto di semplice apprehensio o intuizione, ma è una conclusione alla quale arriviamo dopo laboriosi ragionamenti, checché abbiano voluto dire gli ontologi, e questo per le condizioni particolari del nostro modo di conoscere che è finito e legato alla sensibilità (…). Ma il nostro intelletto, ciononostante, non resta sempre rinchiuso in una conoscenza di minimo contenuto nozionale: per la sua spiritualità può riflettere sui dati delle sue conoscenze, e considerare in un modo universale e intensivo i dati particolari che giacciono nelle prime nozioni, avute nella conoscenza spontanea (…). E si può osservare che l’essere, come ragione (astratta) di essere, in natura non esiste, come in natura non esistono né l’animalità, né l’umanità – ma esistono soltanto degli esseri, come esistono soltanto degli animali e degli uomini, individui. (…) Per S. Tommaso il mondo intelligibile delle essenze non è un “hortus conclusus”, risultante di elementi immobili che per un istante, che possiamo chiamare quello del pensiero categoriale o predicamentale, quello cioè della predicazione logico-formale del genere a riguardo delle sue specie, e della specie per gli individui. Ma nell’istante seguente della riflessione metafisica tutto quel mondo di perfezioni pure e formalità astratte e indivisibili offre spontaneamente, anzi suscita lui stesso, il movimento dialettico del pensiero, che relaziona le varie formalità fra di loro e rispetto alla formalità suprema, l’essere che è soltanto “essere”. (…) Possiamo pertanto dire che nel Tomismo è proprio l’essenza, considerata in relazione all’atto di essere, che obbliga la mente a trascendere i dati univoci delle astrazioni inferiori e a mettersi in cammino verso l’ultima fondazione di ogni cosa. Ciascuna formalità, per perfetta che sia, poiché è questa e non quella, le manca sempre qualche perfezione reale, resta sempre qualcosa di limitato e di ristretto nell’ordine dell’essere; se a riguardo delle formalità ad essa inferiori, può considerarsi come un partecipato, a riguardo dell’ultima formalità, quella dell’essere, essa resta un partecipante” (37).
Note
(1) Sia per la ricostruzione della storia dell’opuscolo, sia per la sua traduzione, ci serviremo del testo – molto accurato – di D. Lorenz, I fondamenti dell’ontologia tomista. Il trattato De Ente et essentia, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, a cui rimandiamo per ulteriori approfondimenti. Tale opera riporta, il testo latino dell’edizione leonina, la traduzione in lingua italiana curata da A. Lobato (Roma, 1989) ed un interessante apparato critico, con un chiaro commento delle singole parti dell’opera, particolarmente utile sul piano didattico.
(2) Sancti Thomae Aquinatis, De ente et essentia, in: Opera Omnia, tomo 43; cura et studio Fratrum Praedicatorum Santae Sabinae, Romae 1976, pp. 367-381.
(3) Citiamo alcune delle più importanti tra quelle apparse nel nostro secolo: B. Nardi, Tommaso d’Aquino. Opuscoli Filosofici scelti ed annotati, vol. 1, Bari 1915; C. Ottaviano, Tommaso d’Aquino. Saggio sull’essere e l’essenza, Lanciano 1930; V. Miano, S. Tommaso. Dell’ente e dell’essenza, SEI, Torino 1952; P. Montanari, Dell’ente e dell’essenza, Paoline, Roma 1959; G. Di Napoli, S. Tommaso d’Aquino. L’ente e l’essenza, La Scuola, Brescia 1959; P. Orlando, Tommaso d’Aquino. De ente et essentia, l’essenza dell’esistente, Dehoniane, Napoli 1986; A. Lobato, S. Tommaso d’Aquino. De ente et essentia, Città Nuova, Roma 1989; G. Galeazzi, L’ente e l’essenza di Tommaso d’Aquino, Paravia, Torino 1991.
(4) L’opuscolo De ente et essentia nasce con lo specifico intento di chiarificare i concetti fondamentali della metafisica, per cui la scelta dell’ente come punto di partenza ha principalmente questa motivazione; ma in altre opere (in particolare nelle Quaestiones disputatae De Veritate) Tommaso si spingerà fino ad affermare che l’ente è il “primum cognitum”, ciò che in primo luogo l’intelletto concepisce ed in rapporto a cui si forma tutte le altre nozioni. La prima distinzione che viene presa in esame è quella per cui si distingue l’ente reale (quello che si colloca nelle dieci categorie) e l’ente di ragione (quello “che indica la verità delle proposizioni”).
(5) Si può dire – ad esempio – che “la dispensa è vuota”, laddove il verbo essere (la copula) viene usato per designare un “non-essere” (cioè la mancanza di ciò che dovrebbe essere dentro la dispensa).
(6) La famosa definizione aristotelica dell’essenza, che i latini traducono con l’espressione “quod quid erat esse” (sintetizzata nel termine “quidditas”), viene espressa mediante l’uso del tempo imperfetto per due ordini di motivi. In primo luogo per sottolineare la priorità dell’essere reale su quello di ragione, cioè del costitutivo formale dell’essere, rispetto al nostro conoscerlo intellettivamente. In secondo luogo perché – per il nostro modo di conoscere – noi non ci rendiamo conto della vera natura di una cosa finché non abbiamo visto svilupparsi le sue potenzialità. Per esempio noi non sapremmo che la ghianda è il seme della quercia, se non avessimo mai visto una ghianda diventare una quercia, per cui possiamo dire – in linguaggio aristotelico e tomista – che la sua essenza (ciò in forza di cui la quercia è quercia e non un’altra realtà) è “ciò che il suo essere era”, nel senso che lo era già anche prima che noi lo vedessimo dispiegare le proprie potenzialità.
(7) Il termine natura ha, nel linguaggio della scolastica, un valore diverso da quello che siamo soliti attribuirgli oggi: per noi la natura è l’insieme della realtà corporea con le leggi che la regolano, per gli scolastici (per cui il termine si collega alla radice del verbo “nascor”, nascere, come del resto il termine greco corrispondente – physis – che si ricollega a phyo) la natura è il principio di attività di ogni ente, ciò per cui un ente agisce in un modo piuttosto che in un altro, il che dipende dal fatto che “è” in un modo piuttosto che in un altro, ovvero che esiste in una determinata essenza. Per questo si dice – nel testo di Tommaso – che la natura è l’essenza in quanto principio di operazioni.
(8) Cfr. Aristotele, Metafisica, libro IV, dove si afferma che “essere si dice in molti sensi”, ma tutti in riferimento ad uno, cioè alla sostanza, ovvero a quel modo dell’essere a cui compete di esistere “in se” e non “in altro” (come nel caso degli accidenti).
(9) Tommaso riprende in questo passaggio la dottrina aristotelica dei tre gradi di astrazione, distinguendo
– primo grado: la conoscenza di tipo fisico, che si colloca al primo grado di astrazione e prescinde solo dalla materia individuale (ma non dalla materialità come tale);
– secondo grado: la conoscenza di tipo matematico che prescinde dalla materia in generale e considera solo la quantità astratta:
– terzo grado: l’astrazione di tipo metafisico che considera l’ente in quanto ente.
I discorsi sulle realtà fisiche possono collocarsi a tutti e tre i gradi di astrazione, ma se vogliamo considerare l’essenza di ciascuna realtà (ossia ciò in forza di cui appartiene a quella specie e non ad un’altra), non possiamo prescindere dalla considerazione della sua materialità: per esempio nella nozione di “pianta” (che si definisce come “realtà corporea vivente di vita vegetativa”) non è possibile prescindere dalla sua “materia”, perché essa entra nel motivo per cui la pianta è tale si distingue – per essenza – dagli animali (“esseri viventi di vita sensibile”, cioè dotati di sensazione e movimento).
(10) Il problema del principio di individuazione rappresenta uno dei nodi più complessi della riflessione tomista sulla realtà fisica, cioè sulle sostanze composte di materia e forma: se il principio di individuazione fosse costituito esclusivamente dalla forma sarebbe necessaria una sorta di “essenza individuale”, per cui tutti gli esseri di una certa specie (es. gli uomini), costituirebbero altrettante specie distinte. Il principio di individuazione deve dunque collocarsi dalla parte della materia, ma non intesa “in astratto” – come parte dell’essenza – bensì “in concreto” (quasi la si potesse indicare nello spazio). Tale condizione viene designata con l’espressione “materia signata quantitate” (la materia “contrassegnata” dalla quantità) che a sua volta va distinta dall’accidente quantità (cioè la quantità dimensiva, per cui si dice – ad esempio – che un determinato cavallo pesa 500 chili) e si parla semplicemente di questa signatio da parte della quantità.
(11) Dal punto di vista logico il genere sta alla differenza specifica, come la forma alla materia, nel senso che esso viene determinato da quella, come la potenza viene determinata dall’atto e – quindi – come la materia viene determinata cioè attuata dalla forma; ma quando si parla dell’ente reale (e non solo dell’ente di ragione), allora il genere designa la sostanza nel suo complesso, prescindendo dalla determinazione che è propria della differenza specifica.
(12) L’esempio della statua che raffigura una pluralità di individui può aiutare a comprendere il rapporto tra essenza e forma specifica, ma non deve essere preso alla lettera: la statua ha un suo essere individuale (per cui è “quella” statua) e la sua forma corporea ha un essere individuale, ma considerata da un altro punto di vista (cioè dal punto di vista dell’intelletto umano che ravvisa in tale forma una somiglianza con la forma di una pluralità di individui) quella stessa forma diventa molteplice. Il caso dell’essenza considerata in astratto è più fine, perché non si tratta semplicemente di una somiglianza “estrinseca”, ma del motivo per cui ciascuna realtà è quella che è e non un’altra, anche se l’identificazione dell’essenza con la specie avviene totalmente sul piano dell’essere di ragione, cioè del modo in cui l’una e l’altra possono esistere nell’intelletto umano.
(13) È interessante notare come la distinzione tra essenza e atto di esistere, che riguarda tutte le sostanze diverse dall’Atto Puro, venga posta da Tommaso quando parla delle sostanze semplici e non di quelle composte di materia e forma: nelle sostanze semplici è più evidente la necessità di tale distinzione, perché se così non fosse vi sarebbe una sola sostanza semplice, cioè l’Atto Puro.
(14) È bene ricordare che – per Tommaso, come già per la tradizione platonico-aristotelica – le sostanze immateriali sono ingenerabili e incorruttibili, per cui se iniziano ad esistere (cioè ricevono l’atto di essere) possono riceverlo solo per creazione (non per generazione, tanto più che non ve ne sono – come si è detto – due della stessa specie), quindi lo ricevono necessariamente da Dio.
(15) La gerarchia delle forme che si ritrova nella tradizione platonica e neo-platonica, viene qui ripresa alla luce del commento (neoplatonizzante) di Avicenna ad Aristotele, con alcune precisazioni legate alla rilettura di Tommaso della dottrina sulla distinzione tra essenza ed atto di essere, tanto che la “gerarchia delle forme” di platonica memoria diviene una gerarchia dei diversi gradi di atto/potenza in rapporto all’essere: al livello più alto abbiamo l’Atto Puro, del tutto privo di ogni potenza, poi vi sono – in numero indefinito – le diverse specie (ogni individuo è una specie) di forme pure, in cui la composizione tra potenza e atto si colloca al livello della composizione tra essenza (che coincide con la forma) ed atto di essere; in una situazione del tutto speciale si trova l’anima umana (che da un certo punto di vista è forma sussistente, in quanto di natura intellettiva, ma dall’altro punto di vista ha un grado di perfezione nell’atto di essere talmente basso – tra le forme pure – che la sua essenza implica una partecipazione della realtà materiale); al di sotto dell’anima umana si trovano le essenze delle realtà sensibili (sostanze composte) le cui forme non possono sussistere separatamente dalla materia.
(16) Questo comporta, tra l’altro, che le sostanze immateriali (forme pure) sono perfettamente in atto rispetto alla loro perfezione formale, cioè – per usare una metafora umana – “nascono adulte” e non devono venire “educate”.
(17) Tommaso è pienamente consapevole che non possiamo conoscere in modo diretto le differenze specifiche tra le diverse sostanze materiali; cogliere quale sia la differenza “essenziale” tra oro e ferro – per esempio – ci è in qualche modo precluso dalla natura stessa della nostra conoscenza, salvo affermare che una differenza specifica tra le diverse sostanze materiali ci deve essere e che è da tale differenza specifica (a noi ignota) che dipendono le differenze accidentali (che invece ci è dato conoscere).
(18) Si è già visto che nelle sostanze composte di materia e forma (per le altre, ovviamente, il problema non si pone) sia l’una che l’altra fanno pare dell’essenza.
(19) Cfr. Aristotele, Metafisica, libro IX.
(20) Thomas De Vio (Caietanus), In De ente et essentia Divi Thomae Aquinatis Commentaria, Papie 1496; ed. critica a cura di M. H. Laurent, Marietti, Torino 1934.
(21) Petrus De Crokaert, Quaestiones super Opusculum Sancti Thomae De ente et essentia, Pargi 1510.
(22) Raphael De Ripa, Commentaria et quaestiones ad Sancti Thomae aquinatis De ente et essentia, Romae 1598.
(23) Hyeronymus Contanerus, Commentaria in opus Sancti Thomae De ente et essentia, Venetiis 1606.
(24) Edith Stein, Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere (tit. orig. Endliches und ewiges Sein – Versuch eines Aufstigs zum Sinn des Seins, Archivium Carmelitanum Edith Stein, Geleen NL, 1962), tr. it. di L. Vigone revisionata da A. Bello, Città Nuova, Roma 1988 (III ed. 1999), pp. 41-42.
(25) Ibidem, pp. 72-73.
(26) Ibidem, p. 304.
(27) Ibidem. pp. 376-377.
(28) J. Maritain, Sette lezioni sull’essere e sui primi principi della ragione speculativa (tit. orig. Sept leçons sur l’être et les premiers pricipes de la raison spéculative, Parigi 1934), tr. it. di M. Bracchi, M. Inzerillo, L. Frattini, Massimo, Milano 1981, pp. 47-48.
(29) Ibidem, p. 73.
(30) Ib., pp. 85-86.
(31) L’opera di Gilson, L’être et l’essence (Librairie Philosophique J. Vrin, Paris) esce in prima edizione francese nel 1948, dopo una serie di conferenze e lezioni tenute da Gilson presso il Collège de France, in un’edizione inglese ampiamente rielaborata l’anno successivo (Being and some Philosophers, Pontifical Institute of mediaeval Studies, Toronto) ed in una seconda edizione francese, per lo stesso editore parigino, nel 1962. Altre opere dello stesso autore che si possono collegare a questo tema sono: Réalisme méthodique, Téqui, Paris 1935; Réalisme thomiste et critique de la connaissance, Vrin Paris, 1939; Constantes philosophiques de l’être, Vrin, Paris, 1983 (pubbl. postuma).
(32) E. Gilson, L’essere e l’essenza, Tr. it. di L. Frattini e M. Roncoroni, Massimo, Milano 1988, pp. 100-102.
(33) Ib., pp. 103-104.
(34) Ib., pp. 106-108.
(35) C. Wolff, Ontologia, cit. da E. Gilson, L’essere e l’essenza, cit, p. 160.
(36) E. Gilson, L’essere e l’essenza, cit, pp. 279-282.
(37) C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino, SEI, Torino 1950 (II ed.), pp. 190-196, passim.
LA NOZIONE DI PARTECIPAZIONE IN TOMMASO D’AQUINO
A cura di Cosimo Lamanna
“Est autem partecipare quasi partem capere” è senza dubbio una delle affermazioni più secche con le quali Tommaso d’Aquino affronta e definisce il tema della partecipazione, vale a dire uno degli aspetti filosofici e religiosi più importanti del suo pensiero.
I dottori scolastici del secolo XIII per spiegare il significato del termine ‘partecipare’ si riferiscono immediatamente alla etimologia: Partecipare=partem-capere, ma non curandosi troppo di tale etimologia, passano senz’altro alle applicazioni dottrinali, come fa San Tommaso nel testo principale sull’argomento (Il De hebdomadibus).
Il verbo ‘partecipare’ ha un largo uso nel linguaggio ordinario: fra i più evidenti e correnti, è quello in cui il partecipare, nell’ambito di una concezione quantitativa, è un vero partem capere di qualche cosa, e suppone sempre che un tutto qualsiasi, nel campo degli interessi concreti, si sia scisso in parti, che vengono poi distribuite ai partecipanti. In questo caso il partecipare ha tutto il suo significato forte di prendere una parte fra le altre parti, sia come ricevere reale, sia come prendere una parte con esclusione formale delle altre parti.
Possiamo definire questo tipo di partecipazione, una partecipazione quantitativa, che nella sua intellegibilità è una nozione del tutto chiusa, che non pone alcun problema: problemi sorgono invece quando, applicato alla qualità e agli altri predicamenti quel significato si oscura e sembra andare incontro alla contraddizione[1].
Il linguaggio ordinario[2] presenta tanti altri usi del termine partecipare, e non sempre in essi è implicata la divisione di un tutto preesistente, anzi a volte questo tutto manca: partecipare alla gioia o al dolore ad esempio.
In base a ciò, si può dire che il partecipare nell’ordine quantitativo affetta direttamente l’oggetto della divisione mentre nel partecipare morale la partecipazione riguarda il modo. L’oggetto può essere presente tutto intero ai singoli partecipanti, ma esso tocca qualcuno di essi a preferenza secondo un modo intenso e proprio, e alle volte incomunicabile, in relazione al quale, secondo che più o meno si avvicinano, anche gli altri modi sono detti partecipazioni.
La ragione formale della partecipazione morale, o meglio il suo fondamento, non è dato dall’oggetto stesso, quanto dai legami particolari che i partecipanti possono stringere con colui il quale per primo compete l’oggetto della partecipazione: legami di amicizia, di parentela. Mentre nei rapporti quantitativi la comunanza era un effetto della partecipazione, in quelli d’ordine morale affettivo, la comunanza è invece la radice del partecipare[3].
Siamo quindi di fronte a due significati quasi antitetici e in sé inconciliabili, poiché guardano alla realtà sotto punti di vista del tutto disparati: nell’ordine metafisico che tutte queste esigenze del partecipare sono ridotte in ben legittime proporzioni.
Più facile dell’etimologia latina, sembra quella offerta dalla lingua greca, che è la madre legittima del termine, ove, se il significato resta più vago, è insieme meno esclusivo del latino partem capere. A partecipare corrispondono in greco due verbi ‘meteceim’ e ‘coinwnein’: il greco non sembra suggerire immediatamente partem capere, partem habere, ma piuttosto habere simul, habere cum alio, communicare cum aliquo in aliqua re[4].
2. LE FONTI DELLA NOZIONE TOMISTA
Gli studi più recenti hanno messo in luce il fatto che nessun dottore medievale può reggere il confronto con Tommaso d’Aquino, per l’ampiezza e la sicurezza dell’informazione positiva. In lui troviamo mirabilmente fuse in una sola persona la solerzia dello storico e la tendenza irrefrenabile del teorico a portare le idee al vertice della speculazione pura.
Tommaso arrivò certamente a una concezione dinamica della vita intellettuale, che lo portava a considerare i singoli risultati in una continuità armonica, che dai primi contatti incerti e parziali, giunge alla conquista definitiva e quieta della verità. E’ con questo modo di pensare che l’Angelico si rivolge alle fonti, non allo scopo di fare semplicemente la storia temporale delle idee, ma per la verità intemporale che esse racchiudono.
E’ molto importante riconoscere che San Tommaso non fu un puro storico, ma neppure un pensatore puro nel senso moderno del termine, cioè un contemplatore solipsista, deduttivo e universale, che s’affida a nozioni e principi, pochi di numero ed esclusivi nel contenuto. Il suo metodo ha un duplice carattere: da un lato si presenta come interpretazione storica delle Fonti, dall’altro è essenzialmente sintetico, nel senso che tende a accogliere tutti gli aspetti di verità, qua e là dispersi o mal compresi nei sistemi precedenti, e cerca poi di assimilarli e incorporarli in una unità vivente.
Nonostante il Santo Dottore sia stato piuttosto avaro nel rivelarci l’intimo lavorio del suo spirito, per quanto riguarda la nozione di partecipazione, esse sono state indicate in modo esplicito in due articoli delle Quaestiones disputatae. L’Angelico, infatti, nella Quaestio disputatae De veritate (q. XXI, art.5) chiedendosi se la bontà della creazione sia buona a causa della sua essenza, non esita a rispondere in modo negativo, sostenendo che, in base a quanto affermano Agostino, Boezio e l’autore del De Causis, le creature non sono buone per essenza, ma per partecipazione.
Nella Quaestio disputata De potentia (q. III, art. 5) pone il problema della creazione universale: Utrum possit esse aliquid quod non sit a Deo; la risposta è provata attraverso tre ragioni, delle quali la prima è riferita a Platone, la seconda ad Aristotele, la terza ad Avicenna: tutte e tre hanno per fondo comune la nozione di partecipazione. Se ora a questi sei autori aggiungiamo lo Pseudo Dionigi Aeropagita, che forse in questo affare è il più interessato di tutti gli altri, abbiamo ormai tutte le fonti principali, alle quali si è ispirata e può essere riferita, nel suo contenuto, la nozione tomista di partecipazione[5].
Il termine ‘partecipare’, ‘partecipazione’, ha senza dubbio un’origine platonica, e va letto alla luce della teoria platonica delle Idee, nell’ambito della quale esprime il rapporto che la realtà sensibile dei singoli (concreti), ha con quella intellegibile universale (astratta). Platone diede vita a questo dualismo per cercare di soddisfare l’esigenza di una sapere come conoscenza ’necessaria’ nei rapporti, e ‘oggettiva’ nel contenuto. Oggetto di un tale tipo di conoscenza, non poteva essere, agli occhi di Platone, la realtà sensibile, soggetta alla corruzione e al mutamento, ma la realtà ultrasensibile, eterna e immutabile.
Alla luce di questa ripartizione vanno letti i rapporti che hanno i sensibili, sempre cangianti, con le idee immutabili, e questa relazione è espressa, appunto, con il termine di partecipazione.
La instancabile ricerca dell’universale portava Platone ad asserire che l’uomo di cui c’è scienza, deve essere sempre, necessariamente, e quindi, in modo esclusivo tale. Si tratta quindi dell’uomo ideale, incorruttibile, contrapposto all’uomo sensibile, particolare. Vista in questi termini, la realtà sensibile, è considerata come un pallido riflesso, un’imitazione ispirata all’idea modello, che benché si comunichi alla cosa concreta, resta nella sua interezza e incorruttibilità, mentre la cosa concreta altro non è che un suo pallido riflesso, una sua caduca imitazione.
Il pensiero aristotelico, di contro, si oppone a questo modo di pensare e di leggere la realtà: Aristotele condanna l’idea di partecipazione[6], e cerca di rivalutare il mondo sensibile, da lui considerato come il punto di partenza della conoscenza: le forme universali vengono raggiunte per il tramite del particolare. Da questo punto di vista Tommaso si schiera con Aristotele, nella convinzione che le idee universali, hanno ragion d’essere solo nella mente, ma non esistono nella realtà.
Non ci sono quindi due realtà contrapposte, ma vi è una sola realtà, quella “sensibile”, punto di partenza obbligatorio per la conoscenza, che poi tramite l’astrazione[7] formula concetti universali. Ma se Aristotele era stato drastico nella sua critica alla nozione di partecipazione, almeno nella fase matura del suo pensiero, e aveva criticato nel I Libro della Metafisica[8], sia Platone che i Pitagorici, San Tommaso d’Aquino assume un diverso atteggiamento nei confronti della nozione di partecipazione, rivalutandola e superando la contrapposizione tra i due massimi pensatori greci, in una sintesi grandiosa e originale. L’opera di sintesi e conciliazione tra i due massimi pensatori greci compiuta dal Dottore Angelico può essere considerata epocale in quanto il divario tra i due pensatori, quali potevano essere conosciuti dalle opere di cui disponevano i medievali, appariva così rilevante, anzi sostanziale, che sembrava impossibile qualsiasi tentativo di realizzare un reale avvicinamento.
Tale infatti fu lo stato d’animo della maggior parte dei Padri della Chiesa e di buona parte dei maestri medievali, anche contemporanei del Santo Dottore, per i quali l’Aristotelismo rappresentava il tentativo supremo, per far deviare il cammino della ragione, che Platone aveva indirizzato verso il Cristo e la sua dottrina: atteggiamento, che a volte assunse delle forme esterne anche violente, di avversione alla penetrazione dell’Aristotelismo, come si può rilevare dalle condanne ecclesiastiche dell’inizio e della fine del secolo XIII.
La nozione tomista di partecipazione, che oserei dire, alla fine resta nello spirito essenzialmente aristotelica, ha potuto affermarsi e reggere agli urti polemici, grazie anche all’influsso di correnti intermediarie, delle quali la principale è rappresentata dal Neoplatonismo.
IL NEOPLATONISMO, INFATTI, CERCA DI REALIZZARE, GIÀ PRIMA DI TOMMASO, UNA CONCILIAZIONE DEL PENSIERO ARISTOTELICO CON QUELLO PLATONICO, OPERA QUESTA QUANTO MAI URGENTE PER UNA CIVILTÀ PAGANA, CHE DOVEVA MOSTRARE LA PROPRIA SUFFICIENZA DI FRONTE ALL’IDEA CRISTIANA CHE SI PROCLAMAVA UNIVERSALE, E CHE MINACCIAVA DI SOSTITUIRSI A TUTTO IL PASSATO. SI CERCÒ DI MOSTRARE CHE LE DIFFERENZE TRA I DUE FILOSOFI GRECI ERANO SOLO APPARENTI, ED ERANO DOVUTE ESCLUSIVAMENTE A DIVERSITÀ DI METODO, CHE A REALI DIVERGENZE DI DOTTRINA: ARISTOTELE VOLEVA PARLARE DELLE COSE SENSIBILI, PLATONE DEL MONDO INTELLEGIBILE.
Lo scontro tra Paganesimo e Cristianesimo, si concluse con la vittoria di quest’ultimo, che finì per incorporare l’eredità dottrinale del primo, dando così vita al Neoplatonismo cristiano[9].
Si passò da un atteggiamento di aperto contrasto, o almeno di riluttanza, nei confronti della speculazione greca, a quello di una calda simpatia nei tempi seguenti. I Padri della Chiesa[10] furono senza dubbio gli artefici di questo cambiamento di mentalità, animati dalla convinzione che a contatto della verità divina anche il frutto dell’umana speculazione potesse diventare buon vino.
Nella ricerca delle fonti della nozione di partecipazione, si possono distinguere per comodità di esposizione, due linee di ricerca: una greco-cristiana con Agostino, lo Pseudo Dionigi e Boezio, e una greco-araba con Avicenna e il De Causis; gli influssi di altre fonti, rispetto a queste indicate, non hanno che una valore relativo e secondario.
Per quanto riguarda Sant’Agostino[11], si può rintracciare all’interno della sua opera una linea filosofica di ispirazione Neoplatonica. Tommaso individuò subito questo carattere inconfondibile della speculazione Agostiniana, e lo fa notare soprattutto allorquando quella terminologia, così diversa dalla sua -aristotelica-, poteva creare qualche imbarazzo nell’esposizione del suo pensiero, e si fa premura di distinguere bene tra l’autorità che il Santo Vescovo aveva come dottore della Fede, da quella che poteva avere come filosofo.
Per quello che ci riguarda, Agostino si serve spesso del termine ‘partecipare’, per indicare le relazioni di dipendenza delle creature dal Creatore: tutto il creato, ogni bontà, verità, bellezza, vita finita, non sono che partecipazioni della bontà, verità, bellezza, vita divina infinita.
L’esuberante fioritura delle sue opere è piena di simili asserzioni, pervase da questo spirito trascendentale nella considerazione del creato, ma in nessuna parte delle sue opere, forse, come nella quaestio 46 delle 83 quaestiones, dedicata a celebrare le Idee, Sant’Agostino[12] ha espresso le sue convinzioni platoniche con maggiore eleganza e profondità. Questa questione ha avuto un’importanza capitale nella formazione della teologia Scolastica[13] e in particolare di quella tomista.
Un posto di primo piano, in questa ricerca delle fonti della nozione tomista di partecipazione, spetta senza dubbio allo Pseudo Dionigi Aeropagita. Grazie al nome di cui si coprì, questo profondo pensatore esercitò tale influsso sul pensiero medievale, da poter reggere il confronto con quello di Agostino[14]. Per quanto riguarda San Tommaso, il Durantel, nel suo vivace Saint Thomas et le Pseudo-Denis (1919), rilevò dalle opere dell’Aquinate più di 1702 citazioni espresse, tolte dal complesso degli Areopagitica, che inquadrano i punti più vitali del Tomismo.
Non si potrebbe meglio caratterizzare l’influsso di Dionigi su S. Tommaso, che dichiarandolo complementare di quello di S.Agostino: mentre la speculazione agostiniana può essere detta la metafisica del Vero e del Verbo, quella dell’Areopagita è la metafisica dell’Amore e del Bene, che è detto il nome proprio di Dio[15].
Nel De Divinis Nominibus, ove è esposta questa metafisica, il Bene o, più esattamente il Superbonum, è presentato nel suo aspetto formale, cioè secondo il suo diffondersi nelle varie partecipazioni alle creature: pur restando sempre in sé diviso e impartecipato nell’incomunicabilità della sua sostanza, si afferma che “tutto quanto è nel mondo emana da Lui, e tutto resta attaccato a Lui, come il raggio di luce al Sole…” ( Div. Nom. c.V).
Il superbonum è quindi causa di tutto, e la sua causalità arriva fino al non ens cioè la Materia; il male, come tale, non esiste, perché non è che la privazione di un bene (debito), onde i mali particolari non possono derivare da qualcosa che è male per essenza, poiché non sono tali per una qualche partecipazione, ma per una privazione di partecipazione[16].
La dialettica è sempre identica: ogni perfezione finita non è che un effetto della perfezione per essenza; così ogni esistente, ogni vivente, ogni sapiente, deriva da ciò che è, che vive, che è sapiente per essenza, e tutte le creature hanno in Dio le proprie ragioni, che Dionigi, per restare fedele alle Sacre Scritture, chiama praedefinitiones. Le creature vengono così a mostrare in sé una somiglianza di Dio, e diventano per il nostro intelletto le vie, risalendo le quali possiamo arrivare a quella conoscenza che di Lui è possibile. La nostra conoscenza di Dio, quindi, resta sempre indiretta e mediata, e possiamo indicare tre tappe: la prima, affermando che Dio è la causa di tutte le cose (via causale); la seconda, che non può avere alcuna delle imperfezioni e limitazioni proprie dei causati (via negationis); la terza, che le stesse perfezioni dei causati sono in lui in un modo eccedente (via eminentiae).
La teologia dei Nomi Divini passa così attraverso due fasi: una affermativa, quando ci solleviamo dalle creature a Dio, e un’altra negativa, quando, ritornando alle creature, siamo obbligati a negare di Dio, i modi di essere trovati in quelle, e a concepirlo al di sopra di tutti i predicati positivi e negativi.
Non di secondaria importanza è stato l’influsso di Boezio, cui Tommaso si rifà espressamente nei due commenti al De Trinitate e al De hebdomadibus.
Il programma della speculazione filosofica di Boezio è quello stesso del Neoplatonismo, quale lo poteva assumere un cristiano: realizzare una sintesi del Platonismo e dell’Aristotelismo, quale preparazione alla speculazione teologica, nella quale sarà congiunta alla Fede e la Fede alla ragione. E’ difficile precisare fin dove egli sia riuscito nel suo intento: sembra che spesso, anche sotto il formulario più platonico, non sia espresso se non il pensiero aristotelico, come nell’opuscolo De hebdomdibus, che interessa in modo tutto particolare la nozione tomista di partecipazione[17].
Circa il contenuto dell’opuscolo, è stato già detto nel capitolo precedente, e quello che mi preme precisare in questo capitolo, è l’influenza che esso ha avuto su Tommaso d’Aquino.
La maggior parte dei critici sono concordi nel ritenere che il significato dato da Boezio alle proposizioni ‘ipsum esse’ e ‘id quod est’, non è lo stesso che ha inteso Tommaso. L’Aquinate, infatti, ritiene che l’ ‘ipsum esse’ sia l’ ’actus essendi’, mentre l’ ‘id quod est’ rappresenti la sostanza concreta che funge da soggetto nell’atto esistenziale.
Ricerche critiche recenti, condotte sia dai difensori, come dagli avversari della distinzione reale, hanno portato al risultato concorde per il quale l’interpretazione più corretta dei testi boeziani non suggerisce, almeno direttamente, una distinzione reale fra essenza ed esistenza, poiché essa ne è completamente assente. L’identità che Boezio pone in Dio, è l’identità della sostanza e della forma divina, la distinzione che stabilisce nella creatura è una distinzione fra la sostanza prima e la sostanza seconda, non si tratta quindi di una distinzione tra essenza e atto di essere come la intende Tommaso. ‘Ens per participationem’ quindi, significa per Boezio l’ente finito e composto, nell’ordine della sostanza, di materia e forma, o a somiglianza di materia e forma, e non la composizione in ’linea essendi’ di essenza e atto di essere.
Boezio può essere considerato il vero intermediario tra Platone e Aristotele, come lui stesso mostra chiaramente non riuscendo a scegliere da che parte schierarsi. L’indecisione confessata dallo stesso Boezio indurrà Goffredo di San Vittore, nell’XI secolo, a vederlo seduto tra Platone e Aristotele, intento ad ascoltare ora l’uno ora l’altro[18].
Assieme a Boezio, per quanto riguarda l’origine della nozione di partecipazione predicamentale, va ricordato il neoplatonico Porfirio, di cui Boezio tradusse e commentò due volte l’Isogage i Categorias Aristotelis, operetta che fu tenuta in gran conto dai medievali.
Nell’Isogage Porfirio, cercando di coordinare i predicabili fra di loro, si serve sistematicamente del termine partecipazione: egli ritiene che per la partecipazione i molti predicabili vengono a formare come un’unità; ma la partecipazione non avviene sempre allo stesso modo, quella al genere e alla specie avviene sempre in modo uguale, non così per quanto riguarda gli accidenti, soprattutto per quelli separabili.
Quello che va notato è che mentre il termine partecipazione conserva in Porfirio un significato essenzialmente logico, e così pure nei Commenti di Boezio, nei testi tomisti, esso suppone un profondo significato metafisico[19].
Fra le influenze che hanno preparato la nozione tomista di partecipazione, ha un’importanza di primo piano quella che partì dal Neoplatonismo arabo: in particolare ai fini di questo lavoro, interessa la forma che la riflessione arabo-islamica assunse nell’opuscolo intitolato De Causis e nella filosofia del persiano Avicenna.
Per quanto riguarda il De Causis si tratta di un’opera di alta metafisica, composta tra il sec. IX e X, a lungo attribuita ad Aristotele, e conosciuta attraverso una traduzione della Scuola di Toledo, dal titolo De bonitate pura. In seguito Tommaso d’Aquino, servendosi della traduzione della Elementatio di Proclo fatta da Guglielmo di Moerbeke, notò la straordinaria somiglianza tra questa e il De Causis, e ne dedusse che quest’ultima non poteva appartenere ad Aristotele[20].
Per quanto riguarda la dottrina propria del De Causis, si può osservare che essa poggia tutta su di un realismo esagerato, che tiene l’immediata corrispondenza, come Platone, fra i gradi di astrazione intellettuale e quelli di essere nella realtà.
Al sommo degli esseri sta l’Uno e il Bene, causa prima, collocata ‘ante aeternitatem’, da essa derivano le Intelligenze pure, collocate ‘cum aeternitate’ (derivano le une dalle altre per un complicato processo di emanazione intellettuale, per cui la perfezione e purezza della prima, si viene degradando nella seconda).
Dall’intelligenza deriva l’ Anima mundi, che è detta ‘post aeternitatem’, e dall’Anima deriva la Natura, cioè il mondo dei corpi, che è solo effetto e non causa.
In questa sede, giova notare specialmente la nozione di ‘esse’, che è detto la prima formalità creata: prima rerum creatarum est esse. L’ ‘esse’ indica il contenuto più profondo delle cose, su cui tutto posa, e San Tommaso, collegando questa nozione a quella di Dionigi, e a quella che ha letto in Boezio, può arrivare in modo definitivo alla nozione di ‘esse’, che gli è propria, dell’esse cioè come atto ultimo, come actus omnium, forma formarum, nozione che sta a fondamento della nozione tomista di partecipazione[21].
Quanto all’influenza di Avicenna sul pensiero di Tommaso d’Aquino, si deve dire che quest’ultimo, specialmente nei primi anni di carriera, subì in grande proporzione l’influsso di questo pensiero, com’è evidente nel De ente et essentia, anche se tale influsso non fu mai esclusivo, poiché non manca di criticare alcune posizioni del filosofo persiano: l’emanatismo causale, la conoscenza divina indiretta dei singolari, e nozione di esse come accidens predicamentale, l’intelletto agente separato.
Nonostante ciò, bisogna ammettere che alcuni aspetti del pensiero tomista risentono del contributo di Avicenna[22]:
a) La soluzione tomista del problema è tirata sulla falsa riga di Avicenna, e sono ad esso riferiti anche i rapporti fra Genere e Materia, Differenza e Forma, cioè fra gli elementi della definizione e quelli della realtà concreta, rapporti con i quali si stabilirà la nozione tomista di partecipazione nell’ordine predicamentale.
b) La distinzione reale fra essenza ed essere nelle creature, riceve la prima elaborazione nel Tomismo in dipendenza quasi esclusiva, e spesso perfino verbale, da Avicenna.
Altrettanto si può dire delle nozioni avicenniane di necesse esse e di possibile esse: solo Dio è per se necesse esse, la creatura in quanto riceve tutto l’esse da Dio, e l’esse rimane del tutto al di fuori dalla sua essenza (come accidens).
c) La distinzione tra cause del divenire e cause dell’essere: solo Dio è causa dell’essere, le creature influiscono soltanto sul divenire[23].
In questa breve, ma essenziale ricostruzione, sono state ricordate soltanto quelle fonti che, dal testo stesso di S. Tommaso, appaiono aver avuto un influsso d’ordine sistematico in relazione all’argomento in questione: esse quindi non sono le uniche. Così dei Padri della Chiesa ho indicato soltanto Agostino e lo Ps.-Dionigi, ma per la sua profonda conoscenza della letteratura patristica l’Aquinate ha subìto certamente degli altri influssi: S.Ilario a proposito della distinzione reale e San Gregorio a proposito della conservazione di tutte le cose da Dio.
Riepilogando sembra che San Tommaso abbia distinto nelle sue fonti almeno tre aspetti diversi, secondo i quali era stata presentata la nozione di partecipazione:
1) Per Platone la ragione della partecipazione è fondata sul fatto che i molti sono trovati convenire in una formalità comune, che deve essere trascendentale ai molti: si tratta dell’unità, che deve precedere la moltitudine (Dialettica dell’Uno e dei Molti).
2) Per Aristotele la ragione di partecipazione è trovata nel fatto che una formalità si trova, in natura, realizzata in modi e in gradi diversi, secondo prius et posterius, magis et minus di perfezione: ciò non è possibile se non in quanto esiste di fatto qualcosa che abbia quella formalità in tutta la sua pienezza formale, alla quale più o meno gli altri partecipano, secondo che a essa sono più o meno vicini (Dialettica del Perfetto e dell’Imperfetto).
3) Per Avicenna infine la ragione della partecipazione è fondata nella distinzione reale che c’è in ogni creatura fra essenza ed essere, poiché a capo degli esseri vi deve stare un Essere che è atto puro e semplicissimo, che è atto ed essere secondo tutta la sua essenza; anzi non ha essenza, ma è solo essere (Dialettica del Semplice e del Composto).
Queste tre rationes per San Tommaso presentano un contenuto equivalente, ed egli usa nelle sue opere, indifferentemente ora dell’una e ora dell’altra. Il suo indomito ingegno ha saputo tutto ripensare, e riprendendo i problemi dall’interno del loro contenuto dottrinale, è riuscito ad affinare, rettificare e collocare al debito posto ogni nozione[24].
3. LA NOZIONE DI PARTECIPAZIONE NEL DE HEBDOMADIBUS
Il commento al De hebdomadibus di Boezio costituisce, secondo il giudizio dello stesso C.Fabro, il punto di partenza obbligatorio per una indagine sulla nozione tomista di partecipazione, poiché in quest’opera Tommaso espone di getto tutta la sua nozione di partecipazione.
Come ho già avuto modo di dire, in quest’opera sono scarsi, o quasi del tutto assenti i riferimenti alla tradizione e, insieme all’esposizione letterale del testo boeziano, troviamo esposto il genuino pensiero del Dottore Angelico su un problema filosofico di capitale importanza.
Nel testo boeziano è posta una differenza tra l’essere e il ciò che è[25], ed è proprio partendo dalla spiegazione di tale differenza che Tommaso introduce la nozione di partecipazione. La prima differenza consiste nel fatto che noi intendiamo l’astratto sempre come atto, e il concreto come soggetto di questo atto, che partecipa a suo modo al medesimo. L’ ‘ipsum esse’ è qui considerato come l’astratto di ‘ens’, così come il ‘currere’ è l’astratto di currens: il ‘currere’ è qui inteso come “ciò, o per partecipazione del quale,” il ‘currens’ corre, mentre l’ ’esse’ è considerato come quella formalità o attualità suprema per partecipazione alla quale è compreso esser di fatto tutto ciò che esiste in concreto.
A proposito della seconda differenza, Tommaso d’Aquino parla di partecipazione in questi termini: Est autem partecipare quasi partem capere. E’ questo il primo significato di partecipazione proposto nel commento, ed è questa quella che C.Fabro definisce partecipazione predicamentale[26], vale a dire quella nella quale i termini della relazione, partecipato e partecipante, restano nel campo dell’ente e della sostanza finita (predicamenti).
Nel De hebdomadibus ne sono presentati due modi: uno formale-nozionale, allorché si dice che “la specie partecipa al genere e l’individuo alla specie”, e uno reale nel senso che “la Materia partecipa alla Forma, ed il soggetto all’accidente”. Pur utilizzando un linguaggio aristotelico, nelle suddette affermazioni è contenuto il personale punto di vista di Tommaso, in quanto Aristotele non aveva mai parlato di attribuzione per partecipazione e identità sostanziale per il caso della specie e del genere.
Tommaso qui afferma, invece, che la specie partecipa al genere, che il genere è attribuito alla specie per partecipazione. Questa è una posizione importante e innovativa, nel contesto dell’Aristotelismo tomista, e indica anche quanto doveva essere importante per Tommaso d’Aquino, recuperare la nozione di partecipazione.
Nel De hebdomadibus Tommaso definisce la partecipazione come “ricevere una parte”, e aggiunge: “Inoltre ogni volta che un essere riceve in maniera particolare, ciò che a un’altra cosa appartiene universalmente, si dice che partecipa”[27]. A partire da queste osservazioni Tommaso distingue tre generi di partecipazione: quella del soggetto all’accidente, quella della materia alla forma, quella dell’effetto alla causa.
A tal proposito si può dire, secondo il Geiger[28], che “la specie, pur essendo sostanzialmente identica al genere, non ne possiede la ragione in tutta la sua generalità”. La partecipazione che, per Boezio, era prima di tutto, e forse esclusivamente, la composizione tra due elementi estranei l’uno all’altro, ma uniti in una sola realtà, diventa in San Tommaso un rapporto di similitudine, tra due stati più o meno perfetti di una stessa forma. Questa posizione appare nel De hebdomadibus allorché si afferma: homo dicitur partecipare animal quia non habet rationem animalis sucundum totam communitatem[29]; tuttavia se in questo passo la ‘communitas’ può essere intesa sia in ordine intensivo (di perfezione), sia in ordine estensivo (di predicazione), nella Contra Gentiles, la partecipazione è spiegata senza dubbio nell’ordine intensivo[30]; qui infatti appare chiaramente la differenza di perfezione tra il partecipante e il Partecipato, poiché il primo, possiede in maniera limitata e parziale, secondo il suo modo proprio, mentre Dio non possiede per partecipazione, ma assolutamente. Questa distinzione permette poi all’Aquinate di risolvere il difficile problema del testo, vale a dire in che modo le cose sono buone in ciò che sono, pur non essendo beni sostanziali[31].
In definitiva Tommaso dà una nozione sistematica del partecipare, come partem capere, che viene applicata ovunque si diano astratti e concreti, nell’ordine predicamentale delle nature particolari ai rispettivi universali, nei principi dell’essere concreto, e nell’ordine dei rapporti causali.
I tre significati che si susseguono: partecipazione del particolare all’universale, del soggetto alla forma e dell’effetto alla causa, sono congiunti con un similiter che testimonia l’ampiezza della sintesi alla quale l’Angelico è arrivato, e in relazione alla quale espone le indicazioni di Boezio.
Si può anche notare che il primo e terzo significato esulano dal testo e dal problema posto da Boezio, e sono invece una esigenza del problema che si è posto Tommaso, quella del rapporto tra l’ ’ipsum esse’ e tutto ciò che è. Nel commento al testo di Boezio, Tommaso mette da parte il terzo modo di intendere la partecipazione, non perché sia meno importante degli altri due, ma perché non è direttamente implicato nella risoluzione del tema in discussione. L’Aquinate mostra che l’ ‘ipsum esse’, non può partecipare a qualcosa, né nel primo né nel secondo modo, poiché non c’è al di sopra dell’essere una formalità superiore alla luce della quale l’essere può essere detto partecipare; ciò che partecipa è invece l’ ‘ens’ inteso come il concreto che partecipa all’astratto, rappresentato dall’ ‘esse’.
Tommaso inoltre allarga la nozione di partecipazione anche agli stessi astratti (esempio: ‘albedo’ e ‘color’, ‘homo’ e ‘animal’),cosa che non solo è estranea al testo di Boezio, ma ripugnante allo spirito del medesimo, secondo il quale l’astratto ha la proprietà di essere partecipato, ma non può partecipare.
Tenendo conto della etimologia tomista di partecipare: Est autem partecipare quasi partem capere è importante non soffermarsi al significato puramente materiale di questa affermazione; infatti se da un lato nell’ordine della quantità, la partecipazione avviene per una comunicazione di una parte, per il fatto che in quell’ordine si possono avere realmente delle parti di un tutto distinte realmente le une dalle altre, nell’ordine metafisico, cioè della qualità e dell’atto in genere, il partecipare non può avere questo significato troppo materiale. L’atto e la qualità, come tali sono semplici, e pertanto o si hanno o non si hanno; se ad essi si applica il partecipare ciò potrà significare non l’avere una parte, poiché non vi sono parti, ma l’avere in modo particolare, limitato, imperfetto, un atto e una formalità che altrove si trovano in modo totale, illimitato e perfetto[32].
Si potrà avere in definitiva una stessa forma o qualità, realizzata in maniera differente secondo le condizioni del soggetto, e spiegabile alla luce del magis et minus, posizione di chiara origine aristotelica. Il significato pregnante della nozione tomista di partecipazione pertanto, va ricercato, a mio parere, nella relazione di somiglianza e dissomiglianza che si stabilisce tra il partecipato e il partecipante.
San Tommaso, infatti, ritiene che il partecipare sia un partialiter esse, un partialiter habere, che si oppone ad esse, habere, accipere… totaliter. La specie che nella realtà è identica al genere, rappresenta un tipo più particolare, meno universale, della forma generica. Allo stesso modo la bontà delle cose create è simile alla Bontà universale, ma nello stesso tempo differisce da questa, per il fatto che è una bontà per partecipazione, e come tale limitata e parziale.
Da questo punto di vista chi ricevesse tutto quanto ha il donatore, non partecipa del suo atto, ma è consustanziale con il donatore, come avviene nelle processioni ab intra della SS.Trinità[33]. E Tommaso continua nel suo commento, distinguendo l’essere per essenza, che è un essere semplice, e l’essere per partecipazione, che è accidentale, secondo qualcosa[34].
4. MODI DI PARTECIPAZIONE
San Tommaso afferma due modi fondamentali di partecipazione: uno predicamentale-univoco, l’altro trascendentale-analogo. Nel primo caso tutti i partecipanti hanno in sé la stessa formalità secondo tutto il suo contenuto essenziale, ed il partecipato non esiste in sé, ma solo nei partecipanti (esempio: l’umanità non esiste in se, ma esiste l’uomo concreto, espressione particolare dell’umanità).
Nel secondo caso invece, i partecipanti non hanno in sé che una similitudine degradata del partecipato che sussiste in sé, al di fuori di essi (esempio: l’essere dell’uomo deriva dall’Esse subsistens che è Dio). Qui troviamo il significato più forte di partecipazione, presente già nell’ultimo Platone, e che San Tommaso trovava avvalorata dalla speculazione Neoplatonica e di Sant’Agostino in particolare. Questo tipo di partecipazione è definita analoga, ed è quella della creatura al Creatore che, essendo l’essere per l’essenza, in sé riassume tutte le altre perfezioni[35].
Infatti nel De hebdomadibus, a proposito della Bontà divina e di quella creata, si sottolinea che mentre il Primo bene è buono assolutamente, in qualsiasi modo si dia, il bene creato lo è per partecipazione, e in quanto tale risulta essere sempre un’espressione parziale e limitata del Primo. Solo Dio è buono per essenza, le cose creata lo sono per partecipazione, in lui inoltre essere e agire coincidono, motivo per cui Egli è buono e giusto nello stesso tempo, mentre nell’uomo (essere composto), esser buono ed esser giusto non coincidono, con la conseguenza che l’uomo non sempre è giusto nel suo agire[36].
In base a ciò si può concludere che il partecipare è il rapporto metafisico supremo, e sfugge ad una determinazione logica. Partecipare si predica di un soggetto che ha una qualche formalità o atto, ma non in modo esclusivo e in modo totale, o come afferma lo Scheller: Partecipare significa nel partecipante il ricevere in modo essenziale o graduale, qualcosa del partecipato come proprio atto secondo una forma di analogia o di somiglianza. La partecipazione è così una recezione parziale nel partecipante in quanto potenza del partecipato, che è atto, secondo che il partecipato è causa esemplare per l’effetto somigliante[37].
Il partecipato e il partecipante, differiscono per il modo di avere: si dice, infatti che la creatura partecipa l’ ’esse’, non solo nel senso che l’ ’esse’ della creatura non esaurisce la pienezza estensiva dell’esse, come la mia umanità non esaurisce la pienezza estensiva di questa forma, poiché essa può essere in altri e altrove: ma soprattutto nel senso che l’essere creato è formalmente finito sotto l’aspetto intensivo; è ‘esse’ soltanto e non necessariamente vita, sapienza…,come lo è invece l’ ‘Esse per se subsistens’; e se la creatura esercita queste ulteriori formalità non immediatamente per il suo ‘esse’, ma per mezzo di potenze e accidenti aggiunti, radicate nella essenza.
5. PARTECIPAZIONE E CAUSALITÀ NEL TOMISMO
La nozione tomista di partecipazione, assume particolare importanza nell’ambito della storica opposizione tra platonismo e aristotelismo. Da questo punto di vista essa riassume, forse, l’originalità storico-speculativa del tomismo, in quanto Tommaso è riuscito a privare il Platonismo e l’Aristotelismo dell’aspetto caduco che li opponeva, facendoli convivere secondo una mutua complementarità.
La filosofia cristiana del medioevo, sulla scorta di Platone, Agostino, Avicebron, Avicenna e altri[38], aveva badato a salvaguardare i diritti di Dio, con una specie di geloso timore, quasi che concedendo qualcosa alla creature, si sottraesse qualcosa alla perfezione divina.
Tommaso d’Aquino intuì ben presto, grazie anche alla conoscenza del pensiero aristotelico, che questo modo di leggere la realtà creata, e i rapporti di questa con Dio, era sbagliato. Tuttavia la sua risposta non fu quella di negare drasticamente la nozione platonica di partecipazione a favore di quella aristotelica di causalità, ma di sviluppare l’una e l’altra in senso convergente, quasi che il concetto e il modo più puro di causare fosse un puro partecipare.
Tommaso ha tenuto insieme i due concetti, privandoli dell’opposizione che avevano, e si potrebbe dire che la partecipazione tomista è, e insieme non è, la partecipazione platonica, così come la causalità tomista è, e insieme non è, la causalità aristotelica[39]. Non si può dire dunque, che Tommaso abbia soppresso la nozione di partecipazione a favore di quella di causalità, piuttosto si deve dire che il Santo Dottore riuscì a raggiungere un punto di vista privilegiato, che permise di conciliare entrambe le nozioni, in maniera tale da farle risultare armonicamente equilibrate.
E’ lo stesso San Tommaso d’altronde ad affermare questo suo modo di vedere le cose, dicendo Similiter effectus dicitur participare suam causa, et praecipue quando non adaequat virtutem suae causae: si tratta del terzo modo di partecipazione espresso nel De hebdomadibus[40], che per la verità non è molto sviluppato in questo opuscolo, poiché non direttamente coinvolto nella risoluzione del problema in questione. Nel Commento alla Lettera ai Colossesi[41], quel terzo modo di partecipare, lasciato nell’ombra nel De hebdomadibus, viene ampiamente sviluppato.
Il termine partecipare, in Tommaso d’Aquino, ha la proprietà di esprimere nello stesso tempo la dipendenza causale del partecipante dal partecipato, ed insieme l’eccedenza metafisica assoluta del partecipato rispetto al partecipante. Il partecipare viene così a esprimere, in un modo nel quale nessun altro termine filosofico può pretendere di fare, il rapporto che l’ente finito ha con l’essere infinito, la creatura con il Creatore.
Per questo, tutte le opere che Dio mette al di fuori di Sé non sono che partecipazioni, e questo significa sia che la creatura ha ricevuto da Dio tutto quanto ha nell’essere e nell’operare, sia che ogni creatura nelle sue attuazioni non riceve che un aspetto di quella pienezza fontale, presente nella Divinità. Tommaso riesce a esprimere in questo modo l’esatto rapporto tra la creatura e il Creatore.
L’originalità della posizione tomista, dunque, non consiste in una negazione della partecipazione a favore della causalità, ma deve essere cercata nella novità dei principi, grazie ai quali è riuscito a salvare l’una, proprio dando all’altra tutta l’espansione che le conveniva.
[1] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 39-41.
[2] Cfr. RIGUTINI-FANFANI, Dizionario della lingua italiana, U.T.E.T., Torino, v. III, sottp Partecipare, p. 705, col. 3 e p. 706 coll. 1-2.
[3] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 42.
[4] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 42-43.
[5] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 39-122.
[6] Cfr. L.B.GEIGER, La participation dans la philosophie de S. Thomas d’Aquin, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1953, introd. p. 9.
[7] Cfr. P. A. CASTRONOVO, La cogitativa in S. Tommaso, Officium Libri Catholici, Romae 1966.
[8] Cfr. ARISTOTELE, Metafisica. A,5, 987 b, a cura di G. REALE, Rusconi, Milano 1993.
[9] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 75-77.
[10] Cfr. UEBERWEG-GEYGER, Die patristiche und scholastiche Philosphie, Berlin 1928, p. 99.
[11] Cfr. E. GILSON, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris 1929; p. 115 n.
[12] Cfr. D. AUGUSTINI HIPP., 83 Quaestiones, q. 46 De Ideis, P. L., t. 40, col. 29 n. 1. Per una esposizione d’insieme, un po’ troppo letterale, della celebre quaestio, cfr. H. MEYERHOFF, On the Platonism of St. Augustine’s Quaestio de ideis, in The New Scholasticism, XVI (1942), pp. 16-45.
[13] Cfr. S. TOMMASO, Summa theologiae, I, q. 15, a.1 Sed contra; ib., a.2 Sed contra; a.3 Sed contra; q.84, a. 5, ed. Leonina, 1888-1906, con il commento del Gaetano. Tutto l’art. non è che una presa di posizione di fronte alla dottrina della q.46.
[14] Per la storia degli Areopagitica in Occidente, cfr. C. THÉRY, L’entrée du Pseudo-Denys en Occident, Mélanges Mandonnet, II (Paris, Vrin, 1930), p. 23 ss.
[15] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 86-88.
[16] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 88.
[17] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 98-100.
[18] Cfr. C. PANDOLFI, cit., introd. pp. 22-23.
[19] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 105-107.
[20] Cfr. OTTO BARDENHEWER, Die pseudo-aristotelische Schrift: Ueber das reine Gute bekannt unter den Namen Liber de Causis, Freiburg i. Br. 1882; cfr. M. STEINSCHNEIDER, Die europaische Uebersetzungen aus den Arabischen, Wien 1904, p. 40;cfr. M. GRABMANN, Die Proklusubersetzungen des Wilhem von Moerbeke unde ihre verwertung in der lateinische Literatur des Mittelalters, Byzantinische Zeitschrift 30 (1929-1930) riprodotto in Mittelalters Geistesleben, Munchen, II, p. 415. Questo studio è stato ripreso e integrato nella monografia: Guglielmo di Moerbeke O. P., il traduttore delle opere di Aristotele, in Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. IX, Roma 1946, p. 147 ss.
[21] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 107-113.
[22] Cfr. DE VAUX, R., Notes et Textes sur l’Avicennisme latin, Paris 1934, p. 29.
[23] Cfr. C. FABRO, cit., pp.113-117.
[24] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 120-122.
[25] Cfr. C. PANDOLFI, cit., p. 97.
[26] Cfr. C. FABRO, cit., pp.144-186.
[27] Cfr. P. PORRO, cit., pp. 386-387: “Et ideo quando aliquid particulariter recepit id quod ad alterum pertinet universaliter, dicitur participare illud….”.
[28] Cfr. GEIGER, cit., pp.47-83.
[29] Cfr. P. PORRO, cit., pp. 386-387: si dice che ‘uomo’ partecipa di ‘animale’ perché non possiede la ragione di animale secondo la sua intera estensione.
[30] Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, ed. Marietti, cura et studio C. PERA-P.MARC-P.CARAMELLO, 1961-67 (3 volumi; testo della Leonina), Lib. I : Omne quod de pluribus praedicatur univoce secundum partecipationem, cuilibet eorum convenit de quo praedicatur, nam species partecipare dicitur genus et individuum speciem. De Deo autem nihil dicitur per partecipationem, nam omne quod participatur determinatur ad modum participantis, et sic partialiter habetur, et non secundum omnem perfectionis modum.
[31] Cfr. P.PORRO, cit., pp. 398-399.
[32] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 316.
[33] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 317.
[34] Cfr. C. FABRO, cit., pp. 315-327.
[35] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 318.
[36] Cfr. P. PORRO, cit., pp. 418-19.
[37] E. SCHELLER, Das Priestertum Christi, Paderbon 1931, p. 67.
[38] Cfr. C. FABRO, cit., pg. 356.
[39] Cfr. C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, Società Editrice Internazionale, Milano 1958.
[40] Cfr. P. PORRO, cit., pp. 382-383.
[41] Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Expositio et Lectura super Epistolas Pauli Apostoli, ed. Marietti, 2 t.
Tomismo e neo-tomismo nell’Ottocento e nel Novecento
A cura di Andrea Porcarelli
La ricchezza del pensiero di Tommaso e la grande varietà dei temi affrontati hanno fatto di lui un autore molto letto e citato, talora da studiosi che si sono addentrati in profondità nello spirito e nei contenuti del suo pensiero, talora da interpreti più frettolosi che hanno contribuito a diffondere una visione distorta del tomismo. È bene, in ogni caso, accennare anche solo di sfuggita al fatto che quando si parla di “tomismo” non ci si riferisce – ovviamente – al solo S. Tommaso, ma all’insieme di tutti coloro che – nel corso dei secoli – a qualche titolo ne hanno esplicitamente ripreso l’insegnamento, a partire dai grandi commentatori della “tarda scolastica”, di cui ci limitiamo – in questa sede – citare i principali: Giovanni Capreolo (1380-1444), Francesco Silvestri da Ferrara, più noto come “Ferrarese” (1468-1528), Tommaso de Vio, più noto come “Gaetano” (1469-1534), Domenico Bañez (1528-1604), Giovanni di San Tommaso (1589-1644) che hanno prodotto studi monumentali, sia come commento alle opere di Tommaso, sia come veri e propri strumenti per lo studio. Alla linea tomista “domenicana” a cui si è appena fatto riferimento, si affianca la linea “gesuitica”, visto che fin dalla “Ratio studiorum” del 1599 (ma anche prima, nella Ratio del Collegio Romano) l’ordinamento degli studi dei Gesuiti prescrive esplicitamente di attenersi alla dottrina di S. Tommaso; ma tale riferimento comporterà un certo grado di libertà interpretativa, per cui possiamo di fatto distinguere una linea ermeneutica distinta, che si esprime attraverso alcuni grandi autori, tra cui citiamo: Pedro Da Fonseca (1528-1599), Gabriel Vàzquez (1549-1604), Luis de Molina (1536-1600) ed il “doctor eximius” Francisco Suàrez (1548-1627).
La filosofia tomista nell’Italia del XIX secolo
Tra i centri che hanno favorito la rinascita e la diffusione degli studi tomistici nel XIX secolo va ricordato, innanzitutto, il Collegio Alberoni di Piacenza, attivo dal 1751, caratterizzato fin dal suo sorgere da una particolare sensibilità per la filosofia aristotelico-tomista. Nel 1879, qualche mese prima della pubblicazione della stessa enciclica Aeterni Patris, Alberto Barberis fondò – presso il Collegio piacentino – la rivista “Divus Thomas”, la prima al mondo interamente dedicata interamente a san Tommaso, che fu subito bene accolta in molti paesi d’Europa (Belgio, Francia, Spagna, Ungheria, Germania), da dove studiosi insigni mandarono i loro scritti e dove il periodico ebbe notevole diffusione (fatto, peraltro, non comune per la stampa del nostro Paese). Altri centri di diffusione degli studi tomistici in Italia furono strettamente legati all’azione dell’Ordine dei Gesuiti, soprattutto dopo la sua ricostituzione nel 1814. Quando per esempio il Collegio Romano venne nuovamente loro affidato, nel 1824, il rettore (Luigi Taparelli d’Azeglio) si rese conto che le scienze ecclesiali potevano essere risollevate dalle misere condizioni in cui versavano attraverso la riproposizione dell’antica Ratio Studiorum del 1599, che concretamente comportava la ripresa dell’insegnamento della filosofia di Tommaso d’Aquino. Trasferito a Napoli dai suoi superiori, il Taparelli operò per rilanciare gli studi tomistici anche in quella città, finché nel 1846 un altro studioso (Gaetano Sanseverino) fonda l’Accademia di Filosofia Tomista di Napoli. Nel 1850, sempre a Napoli, appare per la prima volta la rivista “La Civiltà Cattolica”, non dedicata specificamente agli studi tomistici, ma che ebbe di fatto una notevole importanza per il loro rilancio contribuendo alla diffusione del pensiero dei filosofi neoscolastici. Altri centri di studi tomistici, legati in particolare all’ordine domenicano, si trovavano a Bologna (1) e a Roma (presso il convento di Santa Maria sopra Minerva). Non va dimenticato nemmeno il centro di Perugia. Nel 1880 fu fondata l’Accademia Romana di S. Tommaso d’Aquino, inaugurata dallo stesso Leone XIII e caratterizzata per il fatto di essere una istituzione pontificia a carattere internazionale.
La filosofia tomista nell’area tedesca nel XIX secolo
Nell’area culturale di lingua tedesca il fenomeno della riscoperta di Tommaso d’Aquino nella seconda metà del XIX secolo si lega da un lato alle divisioni interne all’hegelismo dopo la morte di Hegel e – dall’altro lato – al rafforzarsi della coscienza cattolica dopo il 1848. Di particolare interesse è l’opera di alcuni autori, come Franz Jakob Clemens e Joseph Kleutgen. I principali centri di elaborazione culturale furono il liceo di Eichstätt, l’Accademia di Münster e i licei reali di Baviera, oltre alle istituzioni di alcuni ordini religiosi. I centri culturali cattolici ebbero un ruolo particolare durante gli anni del Kulturkampf, quando molte istituzioni cattoliche furono soppresse e gli studenti di teologia confluivano in quelle che erano state risparmiate. Dopo il fallimento del progetto di istituire un’università cattolica in Germania, nel 1876 – proprio nel cuore del Kulturkampf – i cattolici crearono un organismo di cultura a cui appoggiarsi, vista l’emarginazione che pativano nelle università statali, la Görres-Gesellshaft, la cui sezione filosofica fu largamente influenzata dal pensiero di autori neoscolastici.
L’enciclica Aeterni Patris
Una sottolineatura a parte merita l’enciclica Aeterni Patris (4 agosto 1879) di Leone XIII, al secolo Gioacchino Pecci, che era stato uno degli animatori del Centro di studi tomistici di Perugia. L’enciclica parte dalla considerazione che molti errori del tempo presente derivano dall’adesione a visioni filosofiche false e fuorvianti e rilancia la “mirabile armonia” ed il “misurato rigore” della sintesi di Tommaso d’Aquino come modello di filosofia in grado di garantire quell’armonia tra fede e ragione che il razionalismo laico contemporaneo metteva fortemente in discussione. Il pontefice invita i vescovi a ripristinare pienamente l’insegnamento della filosofia tomista nei seminari e nelle università cattoliche, con l’esortazione ad andare direttamente ai testi di Tommaso e dei suoi immediati commentatori. La linea di Leone XIII fu proseguita ed accentuata dal suo successore – Pio X – che era particolarmente preoccupato per gli esiti infausti della crisi modernista e, nell’enciclica Pascendi (1907), rende più rigorosamente prescrittive le indicazioni dell’Aeterni Patris, probabilmente spingendosi con questo ben oltre le intenzioni del suo predecessore. Il contributo più duraturo dell’enciclica di Leone XIII non va tanto cercato nei riflessi che ha generato negli studi ecclesiastici perché – come si è detto – questi furono ben presto condizionati dalle chiusure che derivarono dalla reazione alla crisi modernista (2), ma piuttosto nell’impulso che fu dato al sorgere di nuovi centri di studi e dal lavoro svolto dalla “Commissione leonina”, costituita nel 1880 con l’incarico di curare l’edizione critica di tutte le opere di Tommaso.
La filosofia tomista in Francia Tra Ottocento e Novecento
Il contributo fondamentale dell’area culturale di lingua francese al neotomismo contemporaneo si lega indubbiamente alla fondazione dell’Istituto Superiore di Filosofia a Lovanio (in Belgio), ad opera del Card. Mercier nel 1882, che di fatto pose le basi per un positivo incontro tra il pensiero di ispirazione tomista ed il pensiero filosofico moderno. Dopo la pubblicazione dell’enciclica Aeterni patris, fu lo stesso pontefice – nel 1880 – a prendere l’iniziativa, incaricando il Card. Dechamps, arcivescovo di Malines, di creare una cattedra speciale di filosofia tomista presso l’Università cattolica di Lovanio che era, all’epoca, l’unica università cattolica completa, che comprendeva – oltre alla facoltà di teologia – la facoltà di diritto, di lettere e filosofia, di medicina e scienze naturali. Nel 1882 i vescovi belgi designarono Désiré Mercier, allora professore di filosofia al seminario di Malines, di istituire a Lovanio un corso “di alta filosofia secondo san Tommaso”. Per il Mercier la filosofia non è tanto una “dottrina” da insegnare, ma è soprattutto ricerca della verità, aperta e libera, accogliendo ogni pensiero saggio ed ogni scoperta utile, da qualunque parte provengano, come faceva ed invitava a fare lo stesso Tommaso. Verso la fine del secolo l’Istituto di Lovanio è già pienamente avviato e i primi discepoli e poi successori del Mercier vi operano con lo zelo dei pionieri, estendendo progressivamente il suo raggio d’azione ed il suo prestigio in tutta Europa.
Interprete acuto del pensiero di Tommaso nella prima metà del XX secolo fu Antonin–Dalmace Sertillanges (1863-1948) che pubblicò nel 1910 la sua opera in due volumi dal titolo Thomas d’Aquin, in cui affronta con originalità sul piano speculativo alcune tematiche che saranno oggetto di acceso dibattito. Ci limitiamo qui ad accennare all’ultimo capitolo di questo testo che – significativamente – si intitola Il futuro del tomismo, in cui l’autore si domande in quale direzione il tomismo debba rivolgere le proprie ricerche, a partire da quella che il Sertillanges individua come la sua caratteristica peculiare, ossia “lo sforzo scrupoloso di soddisfare tutte le condizioni dell’esperienza, di accogliere tutte le idee reali, di raccoglierle in una struttura e limitarle di volta in volta secondo la necessità, ottenendo così il massimo equilibrio e una giusta comprensione per ogni momento di una scienza in continua evoluzione” (3). Caratteristica peculiare del pensiero di Tommaso è la ricerca di una visione d’insieme, in modo vivo e sotto l’influsso di alcune “idee guida”. Tale è, per Sertillanges, la prerogativa che rende il pensiero tomista particolarmente adatto ad affrontare positivamente i problemi del nostro tempo: si offrono principi di unità per un mondo che va alla deriva per i troppi contrasti, lealtà e correttezza come metodo per le relazioni umane in un universo sempre più individualista, capacità di analisi per studiare chi ha opinioni differenti, al fine di cogliere ciò che può esservi di vero nel pensiero di chiunque.
Di grande importanza sono anche le ricerche storiche sulla filosofia medievale che attraggono l’interesse di molti studiosi che estendono alle opere dei grandi autori il metodo storico-critico, che veniva applicato – non senza un dibattito ancora piuttosto vivace – alla stessa interpretazione delle Scritture. Di particolare interesse sono i contributi della scuola francese di Victor Cousin, che si interessò in prima persona del pensiero di Abelardo e stimolò le ricerche di Jean-Barthélémy Hauréau sulla filosofia scolastica (nel 1850 e poi con la grande Histoire de la philosophie scolastique, in 3 volumi, usciti tra il 1872 e il 1880) e di Ernest Renan su Averroé e l’averroismo (del 1852). Sulla stessa linea si collocano le ponderose ricerche di alcuni autori tedeschi, tra i quali possiamo citare la Storia della filosofia del Medioevo di Albert Stökl (1864-1867), i cinque volumi de La scolastica del Tardo Medioevo di Carl Werner (1881-1887) e la sua opera su Tommaso d’Aquino in tre volumi (1889).
Le opere di carattere storico-critico che segnarono una vera svolta nella ricostruzione del pensiero filosofico scolastico in genere e tomista in particolare furono quelle di Clemens Beaumker (1853-1924), Pierre Mandonnet (1858-1936) e Maurice De Wulf (1867-1947). Beaumker fondò, nel 1891, la collana di pubblicazioni chiamata Contributi alla storia della filosofia del Medioevo, che diresse fino alla morte, quando gli successe Martin Grabman (1875-1949), che pubblicò lavori ancora oggi importanti sulla Storia del metodo scolastico (2 voll., 1909-1911), su Tommaso d’Aquino e la scuola tomista. Ancora più illuminanti sono i contributi del domenicano francese Pierre Mandonnet, che coglie – da storico – il significato della reazione conservatrice contro Tommaso d’Aquino: la tradizione agostinista, che costituiva la dottrina tradizionale dei pensatori pre-tomisti fino a Bonaventura, si caratterizza per il fatto di conoscere senza rendere del tutto effettiva la distinzione tra filosofia e teologia tanto cara ad Alberto Magno e Tommaso d’Aquino.
È Mandonnet il primo autore a cogliere la specificità del contesto storico-culturale dell’opera di Tommaso, simultaneamente impegnato su due fronti: nell’attacco contro l’averroismo latino e nella difesa contro l’agostinismo reazionario. Mandonnet inizia nel 1921 la serie di pubblicazioni della Bibliotèque thomiste, con lavori prevalentemente di carattere storico ed avvia, dal 1924, la rivista critica Bulletin thomiste, che si caratterizza sempre per la straordinaria attenzione alla ricostruzione storica del pensiero di Tommaso.
I frutti di tale paziente lavoro di indagine storico-critica confluiscono nella Storia della filosofia medievale di De Wulf (professore a Lovanio), pubblicata in prima edizione nel 1900 e costantemente rieditata, tenendo conto degli sviluppi progressivi della ricerca storica.
Étienne Gilson
Nel periodo fra le due guerre la ricerca storica sull’età medievale riceve un grandissimo impulso dalla fondazione di numerosi istituti di ricerca con questa specifica finalità: si avvia l’edizione critica dell’opera di molti autori (da Alessandro di Hales ad Alberto Magno, per citarne solo due), a Parigi inizia ad operare un altro grandissimo studioso, Étienne Gilson, che avvia nel 1926 la pubblicazione degli Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen-Age e, dal 1930, della serie degli Études de Philosophie Médiévale, raccogliendo attorno a tali organi un cospicuo numero di collaboratori di grande valore. Gli orizzonti degli studi storici specialistici si aprono oltre oceano, con la fondazione della Medieval Academy of America, a Cambridge (Massachussetts) nel 1925 e l’Institute of Medieval Studies, fondato a Toronto nel 1929, con la collaborazione dello stesso Gilson. Egli si muove ancora come storico della filosofia, ma opera ad un livello diverso rispetto ai suoi colleghi e predecessori: non si è mai occupato personalmente di ricerca di manoscritti, ma ha sempre favorito il lavoro erudito e ne ha fatto la base delle sue ricerche, spostando solo l’asse della domanda storica non tanto sulla constatazione di “quello che è stato detto”, quanto sulla ricerca “di che cosa si stesse veramente parlando”, sempre su un piano di ricostruzione storicamente accurata. Il suo testo sul tomismo (Le Thomisme) appare per la prima volta nel 1919, riceve la forma attuale nella IV edizione, del 1941, ma la quinta e la sesta apportarono ulteriori cambiamenti. Lo stesso si dica del suo celebre compendio, La philosophie au moyen-âge (apparso nel 1922 e ripubblicato in diverse edizioni, sempre aggiornate alla luce dei progressi della ricerca storica). Un discorso a parte merita la sua opera, più filosofica che storica, L’être et l’essence, del 1948, mentre nel 1932 era stata pubblicata un’altra opera fondamentale, L’Esprit de la philosophie médiévale. Forse in tale opera – dal titolo particolarmente evocativo – risiede la cifra dell’importanza dell’opera di Gilson e della sua lettura della scolastica in genere e di Tommaso in particolare: la filosofia medievale si caratterizza in quanto filosofia cristiana, non nel senso che la ricerca filosofica sia “condizionata” dalla fede cristiana, ma nel senso che le verità della fede cristiana hanno offerto all’indagine filosofica gli “spunti euristici” (4) per porsi in modo nuovo alcune domande eterne dell’uomo. È attraverso la ricerca storica che è possibile ricostruire il vero volto di Tommaso e dunque essere, autenticamente, “tomisti”.
Nella sua opera esplicitamente dedicata al profilo speculativo di Tommaso (Le thomisme. Introduction au système de saint Thomas d’Aquin) in cui si sottolinea come i temi filosofici ed i temi teologici – nelle opere dell’Aquinate – siano materialmente congiunti e formalmente distinti: quando Tommaso si occupa di filosofia è sempre anche “teologo”, nel senso che non trascura di mettere in luce i riflessi teologici delle proprie riflessioni, mentre nei passaggi del proprio ragionamento che non si basano su premesse desunte dal patrimonio della rivelazione egli non solo argomenta in termini strettamente filosofici, ma si premura di attivare un “dialogo a distanza” con i filosofi di varie impostazioni e correnti, proprio su quelle tematiche. In altre parole Gilson osserva come la teologia di Tommaso sia quella di un filosofo e la sua filosofia sia quella di un santo. Sl libro sul sistema filosofico di Tommaso in generale seguì, nel 1925, un testo sulle dottrine morali dell’Aquinate (il testo fu pubblicato con il titolo Saint Thomas d’Aquin nella collana dedicata ai moralisti cristiani), in cui Gilson sottolinea come la morale di Tommaso non sia separabile dalla sua metafisica, discutendo in particolare la dottrina del Sommo Bene come chiave di volta dell’edificio etico tomista. Oltre alla controversia sulla filosofia cristiana, di cui si è già fatto cenno, Gilson fu coinvolto – negli anni Trenta – in un altro dibattito molto vivace, circa la validità del realismo critico sostenuto da molti neoscolastici. Due sono le opere da lui pubblicate in tale contesto, Le réalisme méthodique (1936) e Réalism Thomiste et critique de la connaissance (1939), in cui prende in esame anche le idee di quanti sostenevano che per portare la riflessione scolastica al livello della discussione filosofica moderna fosse necessario assumere la prospettiva gnoseologica del dubbio cartesiano e del criticismo kantiano. Gilson afferma che se si parte dal cogito cartesiano o dal criticismo kantiano non si potrà mai giungere all’affermazione “le cose esistono in sé”: il realismo scolastico è tutt’altro che “ingenuo” (come asseriscono alcuni suoi detrattori), ma si tratta di “un realismo consapevole, meditato e voluto, che tuttavia non muove dal problema posto dall’idealismo, poiché i presupposti di questo problema implicano necessariamente l’idealismo stesso come sua soluzione. In altre parole: anche se questa tesi di primo acchito può sorprendere, il realismo scolastico non è al servizio del problema gnoseologico – piuttosto sarà vero il contrario -–bensì la realtà viene vista in esso come indipendente dal pensiero, l”esse’ viene posto come distinto dal ‘percipi’, e questo sulla base di una certa rappresentazione di che cosa sia la filosofia e come condizione della sua stessa possibilità. Questo è un realismo metodico” (5).
Le ricerche di Gilson porteranno ad una complessiva revisione della maggior parte dei manuali di filosofia scolastica circolanti nelle università cattoliche e nei seminari, anche per eliminare le numerose ingenuità sul piano della ricostruzione storica che non potevano sfuggire a studiosi che andavano progressivamente maturando una forte sensibilità di tipo storico-critico, pur mantenendo una costante tensione verso la acquisizione degli elementi teoretici di quella philosophia perennis, di cui Tommaso veniva – comunque – considerato maestro (anche da studiosi storicamente attrezzati come Gilson). In tale impostazione emerge una logica per cui da un lato vi sono dei motivi storici per cui è in un’epoca piuttosto che in un’altra e in un ambiente culturale piuttosto che in un altro che i filosofi maturano la convinzione della necessità di appellarsi a determinati principi e giungono – di conseguenza – a determinate conclusioni; dall’altro lato però il valore teoretico di tali principi e la coerenza logica dei ragionamenti che ad essi si appellano, non devono necessariamente venire relegati nel tempo in cui i principi ed i percorsi logici vennero – di fatto – pensati.
Fernand Van Steenberghen
Su posizioni distinte, rispetto a quelle di Gilson, si collocano altri notevolissimi interpreti del pensiero di Tommaso, con particolare riferimento a Fernand Van Steenberghen, successore di De Wulf alla cattedra di Lovanio. Egli, evidentemente, non nega l’ispirazione cristiana della filosofia medievale, ma critica il concetto di “filosofia cristiana” nella forma indicata da Gilson che sarebbe estraneo alla cultura del periodo: autori come Bonaventura – per esempio – sono in primo luogo teologi, che non elaborano una filosofia autonoma, ma ne usano semplicemente alcuni concetti in funzione della trattazione teologica (in tali autori si può cogliere in senso più proprio una visione “ancillare” della filosofia nei confronti della teologia), mentre è prerogativa peculiare di Alberto di Colonia e più ancora di Tommaso d’Aquino l’avere organizzato in modo sistematico questa filosofia autonoma ed averne sottolineato l’importanza in rapporto alla teologia. Per questo motivo – afferma Van Steenberghen, che ha scritto un’opera in due volumi su Sigieri di Brabante attraverso le sue opere inedite – Tommaso è in grado di incontrare sul suo stesso piano (quello di una riflessione filosofica autonoma) sia l’aristotelismo “radicale” di Sigieri, sia i presupposti filosofici utilizzati dai teologi agostiniani, sia una rilettura più attenta della filosofia di Aristotele che passa attraverso l’analisi attenta delle sue opere. È interessante notare come Van Steenberghen da un lato prenda le distanze da alcuni elementi dell’interpretazione storica del pensiero medievale operata da Gilson, ma dall’altro affermi con forza la necessità di un “neotomismo” che sappia “riscrivere” la filosofia di Tommaso nello stile del nostro tempo e tenendo conto delle istanze proprie del nostro tempo.
La filosofia tomista in Italia nella prima metà del Novecento
In Italia un punto di riferimento importante è costituito, nella prima metà del XX secolo, dalla nascita della “Rivista di Filosofia Neoscolastica” (1909) e dalla fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (nel 1921, riconosciuta dallo Stato italiano nel 1924); ricordiamo anche la rivista “Vita e Pensiero” (fondata nel 1914), che si rivolgeva ad un pubblico più ampio, con un largo ventaglio di interessi culturali. Campeggia in questa fioritura di iniziative la figura di Agostino Gemelli (1878-1959) che animò il centro milanese per circa mezzo secolo, muovendo dalla convinzione che una robusta base filosofica fosse il fondamento ineludibile di tutta l’impresa culturale che fioriva attorno al centro milanese. Nel periodo che va dalla fondazione dell’Università al secondo conflitto mondiale la scena filosofica italiana è dominata dal neoidealismo di Croce e Gentile, con cui i docenti della Cattolica intrecciano un fitto dibattito. Di particolare rilievo in questo senso è l’opera di Amato Masnovo (1880-1955) che volse i propri sforzi nella direzione di una ricostruzione rigorosa ed essenziale della metafisica classica, insistendo in modo particolare sul problema del “fondamento” della metafisica stessa, a partire dalla domanda sul fondamento del possibile (il possibile è pensabile da un’intelligenza finita solo conseguentemente alla conoscenza di ciò che è attualmente reale). Interessanti sono le conseguenze di tale posizione nel campo della critica della conoscenza: “nell’ordine ideale, cioè dei principi, non vi può essere certezza riflessa senza la coscienza della possibilità dell’ente. Ora la coscienza della possibilità dell’ente – nozione semplicissima – non può essere conquistata per analisi: deve essere conquistata attraverso l’esperienza esterna o interna, secondo l’effato ‘ab esse ad posse datur illatio’: dalla realtà di una cosa si è autorizzati ad affermare la sua possibilità” (6). Francesco Olgiati (1886-1962), fondatore della Cattolica assieme a Gemelli, difese la purezza della metafisica classica saldamente ancorata al principio dell’immediatezza e trascendentalità del suo principio, l’ente. La tesi di fondo su cui si basa la sua difesa del tomismo parte dall’idea che la negazione del valore della prospettiva realista non era – in realtà – il cuore delle più autentiche acquisizioni del pensiero moderno, ma una conclusione indebita rispetto a premesse di cui era possibile recuperare il valore. I campi in cui la modernità ha portato i frutti migliori sono – secondo Olgiati – quelli della scienza e della storia, che possono trovare una loro fondazione sintetica ad un livello più profondo proprio nella prospettiva realista, attraverso un recupero della dottrina dell’astrazione, in una visione della riflessione filosofica che pone al centro e al culmine la speculazione metafisica.
Panorama complessivo della seconda metà del Novecento
Nella seconda metà del XX secolo, dopo la guerra, la situazione degli studi tomisti presenta un panorama decisamente interessante: sul piano dell’indagine storica la ricerca è proseguita in modo non del tutto uniforme, ma continuativo; giungono a conclusione alcune iniziative a lungo termine che erano state intraprese nel periodo tra le due guerre; le grandi edizioni critiche delle opere si arricchiscono di volumi completi, con ritmo lento, ma con una elevatissima qualità critica. Intorno agli anni ’60 ha inizio un’ondata di ristampe anastatiche di libri ormai rari (soprattutto edizioni della prima età moderna), tra cui numerosi testi di fonti scolastiche che non costituiscono un vero e proprio progresso nel campo della ricerca, ma consentono una maggiore disponibilità di testi utili a quegli studi a cui viene così dato un notevolissimo impulso. Sorgono nuovi centri di studi come il “Thomas Institut” (fondato da Josef Koch presso l’Università di Colonia nel 1950). Sempre nel 1950 iniziano i “congressi medievistici” interdisciplinari, i cui contributi iniziano ad apparire dal 1962 nella collana Miscellanea mediaevalia. Nel 1954 Michael Schmaus fonda – a Monaco – il “Martin Grabmann Institut” e nel 1956 sorge il “Centre De Wulf Mansion” a Lovanio, per la storia della filosofia antica e medievale, dove – nel 1958 – si tiene il primo Congresso Internazionale per la Filosofia Medievale, con la fondazione della SIEPM (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médieévale) che, a partire dall’anno successivo, inizia a pubblicare un Bulletin, diffuso a livello mondiale. Centri analoghi, con compiti specifici che spaziano per tutto l’arco e le correnti della filosofia medievale, nascono in tutto il mondo, ma volendoci concentrare solo sui centri con un particolare interesse per lo studio di Tommaso d’Aquino sorti nella seconda metà del XX secolo, dobbiamo ancora citare perlomeno il “Thomas Institut” di Kyoto (Giappone), sorto nel 1955. Di particolare rilievo anche il fatto che Centri di studi operanti nel Medio Oriente (come quelli del Cairo, Beirut e Gerusalemme), particolarmente attivi nell’area delle ricerche sul pensiero arabo del Medioevo, siano ormai stabilmente entrati “in rete” con i centri operanti in Occidente, partecipando abitualmente ai congressi della SIEPM. Lo stesso Istituto di Lovanio si rinnova e si rafforza: nel 1946 la rivista dell’Istituto fu ribattezzata “Revue Philosophique de Louvain”, a sottolineare la fisionomia specifica assunta dalla “scuola di Lovanio” nel corso degli anni; e nel 1951 il re del Belgio organizza celebrazioni “giubilari” in occasione del centenario della nascita del Card. Mercier, istituendo anche una Cattedra a lui intitolata, nel 1956 nasce presso l’Istituto una nuova sezione, ossia il “Centre De Wulf-Mansion, Recherches de philosophie anciénne et médiévale – De Wulf-Mansion Centrum. Navorsing over antieke en middeleeuwse filosofie”.
Sul piano della ricerca teoretica il panorama muta notevolmente – soprattutto a partire dagli anni del Concilio Vaticano II – rispetto alla prospettiva dell’enciclica Aeterni patris: si registra una generale apertura del pensiero scolastico alla filosofia e più ancora alle scienze moderne e contemporanee, con un progressivo affievolirsi di una prospettiva prevalentemente apologetica che aveva caratterizzato il tomismo del XIX e della prima metà del XX secolo. Il pensiero moderno viene preso sul serio nei suoi intenti più profondi, accettato come qualcosa di positivo (del resto Tommaso stesso affermava che “omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est”), utile per ripensare ed approfondire la riflessione scolastica che non si limita più a “tramandare” una nobile tradizione (nella logica dell’Aeterni patris), ma si pone il problema di portare un proprio contributo per accrescere il patrimonio comune della riflessione umana, interrogandosi sulle grandi questioni del tempo presente.
Erich Przywara
Erich Przywara (1889-1972) può essere considerato – in questo senso – un autore che segna una linea di spartiacque: la sua apertura a problemi e pensatori in certo modo “nuovi” dal punto di vista della tradizione neoscolastica, contribuì a creare un clima culturale diverso, all’interno della cultura cattolica di area tedesca. Emblematiche le parole con cui annunciò il proprio programma teoretico in occasione del congresso della Società Accademica Cattolica a Ulma nel 1923: “Ciò di cui abbiamo bisogno e che quindi oggi ci proponiamo come programma, è una filosofia dell’equlibrio, un equlibrio non ‘oggi per sempre’, ma piuttosto ‘che procede all’infinito’: la filosofia della polarità, equidistante da una filosofia di inquieti capovolgimenti come da una filosofia della statica medietà, la filosofia della polarità dinamica” (7). La polarità, come “unità di tensione”, richiama il senso del mistero, con un’apertura che va oltre una prospettiva riduttivamente immanentistica, senza configurarsi come una fuga immediata in un trascendentalismo ingenuo, ma si caratterizza come ricerca di risposte alle domande che provengono dall’abisso degli opposti. Tra le riflessioni di Przywara che più hanno fatto discutere vi è indubbiamente la sua lettura del tema – tipicamente tomista – dell’analogia entis, a partire dalle due parti che compongono la parola ana-logia. Il termine logia dice riferimento al nesso tra “Logos” e “leghein” e viene interpretato da Przywara come il “raccogliersi a formare un senso nella parola”; il suffisso ana può a sua volta designare un duplice significato. Da un lato può avere il senso di “conforme a”, dall’altro si confonde in tutte le parole composte con anô , nel senso di “sopra, su, di nuovo”. Il mondo può in tal modo manifestarsi secondo un duplice ritmo, sul piano dell’ana (dimensione orizzontale) e sul piano dell’ anô (dimensione verticale) che si incontrano in quello che sarebbe il “proprium” dell’analogia intesa come “incrocio di coordinate” in una lettura dinamica di una realtà che si colloca su una pluralità di piani.
Edith Stein
Interessantissima in questo senso è anche Edith Stein (1891-1942) (8), di famiglia ebrea, prima allieva e assistente di Edmund Husserl, poi avvicinatasi al tomismo dopo la conversione al cattolicesimo, ha operato profondi tentativi di sintesi tra la fenomenologia husserliana e la filosofia di Tommaso. Nel 1933 entra nell’Ordine Carmelitano di Colonia, continua i propri studi filosofici, ma non può pubblicare in quanto ebrea. Viene arrestata dalla Gestapo nel 1942 e condotta ad Auschwitz-Birkenau, dove troverà la morte nella camera a gas. Nel 1950 inizia l’edizione delle sue opere a Bruxelles; nel 1962 viene istruita la causa di beatificazione, il 1° maggio 1987, a Colonia, Giovanni Paolo II ha dichiarato beata la martire Edith Stein. La Stein abbracciò l’impostazione filosofica husserliana in un contesto culturale in cui il dibattito ruotava attorno alla fondazione delle scienze dello spirito di contro alle scienze della natura, ed ella si sentì “corresponsabile” di questa impresa scorgendo il metodo di tali scienze non nella spiegazione causale, ma nella “comprensione che si immedesima” per cui ogni soggetto spirituale afferra “per immedesimazione” gli altri soggetti e si rende presente come “datità” il loro agire. L’incontro con il pensiero scolastico le fece maturare la convinzione che il suo ruolo culturale dovesse proprio collocarsi in questa area di mediazione tra antico e moderno, attraverso la lettura di Tommaso con le chiavi interpretative della fenomenologia husserliana.
Jacques Maritain
Una figura del tutto particolare nel panorama del XX secolo è rappresentata da Jacques Maritain (1882-1973), di cui è davvero interessante seguire le vicende biografiche (9), e il cui pensiero campeggia nel panorama culturale della rinascita del tomismo per tutta la parte centrale del XX secolo. Dopo la “conversione” dalla prospettiva bergsoniana (che pure aveva avuto un ruolo importantissimo nella formazione della sua personalità intellettuale e spirituale) Maritain si proclama “un fedele seguace di S. Tommaso d’Aquino” e non propriamente un “tomista”: la sua attenzione principale non è centrata sull’analisi ed il commento della dottrina di Tommaso, ma si preoccupa di riprendere e ri-esprimere secondo il proprio linguaggio e la propria sensibilità alcuni temi filosofici (talora centrali in Tommaso, talora più marginali) aventi come principale caratteristica la particolare “attualità” nel tempo in cui si svolge l’avventura intellettuale di Maritain. I più significativi punti di incontro tra Tommaso e Maritain riguardano il primato dell’esistente (prendendo le distanze dall’intellettualismo razionalistico che pervadeva anche gli studi tomistici del tempo), il ruolo decisivo dell’intuizione intellettuale, la pluralità dei gradi del sapere in funzione metodologica e per un incontro sapienziale tra le diverse discipline, il rapporto tra individuo e persona, l’elaborazione di un “umanesimo integrale” che possa fungere da modello, da “ideale storico-concreto” per una nuova umanità ed una nuova cristianità. Se leggiamo tali tematiche sullo sfondo delle vicende storiche con cui si è intrecciata la vita di Maritain (le due guerre mondiali, i totalitarismi, l’incontro con il pragmatismo edonistico americano, la speranza per una giustizia internazionale fondata sui Diritti Umani, il Concilio Vaticano II), possiamo capire quanto la sua rilettura di Tommaso fosse effettivamente orientata alla ricerca di risposte profonde alle questioni “epocali” dell’umanità.
Volendo cogliere – a titolo puramente esemplificativo – alcune suggestioni dai numerosi temi affrontati da Maritain, ci soffermiamo sulla sua idea di un Umanesimo integrale (opera pubblicata nel 1936), in cui – di fronte al volto drammatico dei diversi totalitarismi – si propone una visione della società che ha al centro un ideale con due punti di riferimento, espressi dalle parole del titolo: un “umanesimo”, perché l’uomo – la persona umana – deve essre posta al centro dell’organizzazione etico-politica della vita singola e associata; “integrale”, perché integrato (nel senso di completato) da un’apertura alla trascendenza di Dio, contro le varie forme di “umanesimo riduzionistico” che di fatto costituivano il fondamento teorico dei totalitarismi del tempo. Nel testo, pubblicato nel 1932, Distinguer pour unir: ou Les degrés du savoir, Maritain offre in qualche modo i fondamenti della sua rilettura di Tommaso nella cultura del proprio tempo, in dialogo con il sapere scientifico che – a sua volta – si colloca entro un orizzonte sapienziale più ampio: “Il filo conduttore ci è fornito dalla dottrina dei tre gradi di astrazione, o dei tre gradi secondo cui le cose offrono allo spirito la possibilità di cogliere in esse un oggetto più o meno astratto e immateriale, quanto all’intelligibilità stessa che discende dalle premesse alle conclusioni e, in ultima analisi, quanto al modo di definire. Lo spirito può considerare oggetti astratti e purificati solamente dalla materia, in quanto è fondamento della diversità degli individui in seno alla specie, in quanto, cioè, è principio di individuazione; l’oggetto resta, così, e anche in quanto presentato all’intelligenza, impregnato di tutte le note derivanti dalla materia, eccettuate solamente le particolarità contingenti e strettamente individuali che la scienza trascura. (…) Oppure lo spirito può considerare degli oggetti astratti e purificati dalla materia in quanto essa, in generale, fonda le proprietà sensibili, attive e passive, dei corpi. Allora lo spirito considera soltanto una proprietà che isola dai corpi – quella che resta quando tutto il sensibile è caduto – la quantità, numero ed estensione considerati in sé: oggetto di pensiero che non può esistere senza la materia sensibile, ma che può essere concepito senza di essa (…). Infine lo spirito può considerare oggetti astratti e purificati da ogni materia, non conservando nelle cose altro che l’essere stesso di cui sono penetrate, l’essere in quanto tale e le sue leggi: oggetti di pensiero che non soltanto possono essere concepiti senza materia, ma che anche possono esistere senza di essa, sia che non abbiano mai l’esistenza nella materia, come Dio e i puri spiriti, sia che la loro esistenza si dia nelle cose tanto materiali quanto immateriali, come la sostanza, la qualità, l’atto e la potenza, la bellezza, la bontà, ecc. (…) Per precisare, notiamo che, poiché tutti i nostri concetti si risolvono nell’essere, che è il primo oggetto raggiunto (in confuso) dall’apprensione intellettuale, i concetti della METAFISICA si risolvono nell’essere come tale, ens ut sic, quelli della MATEMATICA in quella sorta d’essere (isolato dal reale) che è la quantità ideale, quelli della FISICA nell’essere mobile o sensibile, ens sensibile. Ma per la filosofia della natura, bisognerà, in questa espressione ens sensibile, mettere l’accento su ens: scienza esplicativa, essa rivela la natura e le ragion d’essere del suo oggetto. (…) Per la scienza empirica della natura, invece, quando diciamo ens sensibile, essere sensibile, non sarà su ens, bensì su sensibile che bisognerà porre l’accento” (10). Tra gli altri temi centrali del pensiero di Maritain segnaliamo ancora la distinzione tra individuo e persona, che rappresenta un’originale rielaborazione di temi tomisti e viene espressa con chiarezza nell’opera del 1925 Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau, in un percorso che tende a rinvenire le radici dell’individualismo moderno, in cui si assiste ad un’esaltazione dell’individualità “camuffata da persona” e – conseguentemente – ad un impoverimento della nozione autentica di persona (che, come dice Tommaso, è “nome che esprime una dignità”, porta l’impronta del divino, un mondo di valori spirituali e morali, si configura come una singolarità ineffabile e inviolabile). Il tema forse più caro alla speculazione maritainiana è la proposta di un Umanesimo integrale, capace di reagire alla “tragedia dell’umanesimo contemporaneo” che si configura come un “umanesimo inumano”, avendo perso il riferimento alla dimensione metafisica della persona umana, che la colloca all’interno di un quadro di valori che ha Dio al vertice. Un cenno meritano anche le opere educative di Maritain (11), in cui egli riprende la concezione educativa di Tommaso, sia per quanto esplicitamente scriveva l’Aquinate nel De Magistro, sia rintracciando nell’antropologia tomista i fondamenti di una filosofia dell’educazione capace di resistere alle opposte tentazioni del totalitarismo e del pragmatismo: “Il compito principale dell’educazione è soprattutto quello di formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo del quale l’uomo forma se stesso ad essere un uomo. Questa è la ragione per cui avrei potuto adottare come titolo: l’educazione dell’uomo. (…) L’educazione è un’arte, un’arte particolarmente difficile. Tuttavia essa appartiene per la sua natura stessa alla sfera della morale e della sapienza pratica. L’educazione è un’arte morale (o piuttosto una sapienza pratica in cui è incorporata una determinata arte). Ora ogni arte è una spinta dinamica verso un oggetto da realizzare che è lo scopo dell’arte stessa. Non c’è arte senza finalità; la vitalità stessa dell’arte consiste nell’energia con cui tende al suo fine, senza fermarsi a nessuno stadio intermedio” (12).
L’Università Cattolica di Milano
L’opera dei grandi maestri dell’Università Cattolica di Milano che hanno operato nella prima metà del secolo è stata ereditata da Gustavo Bontadini (1903-1990) e Sofia Vanni Rovighi (1908-1990). Bontadini amava definirsi come “un metafisico radicato nel cuore del pensiero moderno” ed è proprio l’attenta lettura di molte opere di impostazione idealistica che lo porta ad affermare quella che egli considera la “verità metodologica” dell’idealismo: il primato metodologico della coscienza quale orizzonte per poter parlare dell’essere costituisce il guadagno speculativo dell’età cartesiana, ma proprio all’interno di tale guadagno si insinua l’affermazione aporetica che considera l’essere come “altro” dalla coscienza, ciò di cui si dovrebbe “provare” la corrispondenza con quanto è dato nella conoscenza sensibile o intellettiva; l’idealismo sopprime questa aporia (il dilemma del “ponte” per passare dalla coscienza all’essere), rimanendo però nell’orizzonte del “cogito”, riaffermando l’originaria identità del pensiero con l’essere (in una sorta di ritorno a Parmenide). La prospettiva di Bontadini cerca a sua volta di cogliere – come si è detto – la “verità profonda” del superamento idealistico dell’aporia cartesiana, recuperando una prospettiva metafisica che egli chiama “neoclassica”: “la metafisica neoclassica conserva la verità dell’idealismo (l’intrascendibilità del pensiero come organo dell’interno, come orizzonte assoluto…) e la perfezione inserendovi l’impianto problematico, la struttura della mediazione dell’esperienza: in una parola l’esatta – rigorosa! – metodica e non generica posizione dell’antinomia di trascendenza e immanenza, per cui si parlerà di trascendere – se mai sia possibile – l’esperienza nell’orbita del pensiero!” (13). Il principio o “cominciamento” della filosofia è, secondo quanto affermava lo stesso Tommaso, l’ente (ciò che per primo l’intelletto concepisce) a cui Bontadini applica quello che egli stesso chiama “Principio di Parmenide”, riformulato in termini non-monisti: “la constatazione del divenire, da un lato, e la denuncia della sua contraddittorietà, dall’altro. Due protocolli che fanno capo rispettivamente, ai due piloni del fondamento: l’esperienza e il principio di non contraddizione (primo principio). I due protocolli sono tra loro in contraddizione, e tuttavia godono entrambi del titolo di verità … sono verità, però, che in quanto prese nell’antinomia (antinomia dell’esperienza e del logo) si trovano a dover lottare contro un’imputazione di falsità. Giacché l’esperienza oppugna la verità del logo e il logo quella dell’esperienza” (14).
Cornelio Fabro
Da istanze simili muove l’opera di Cornelio Fabro (1911-1995) che ha dedicato gran parte della propria attività al tentativo di riscoprire un tomismo autentico, liberandolo dall’essenzialismo sistematico della tradizione greco-scolastica e dal soggettivismo immanentistico del pensiero moderno, per farne emergere i tratti caratteristici di filosofia dell’essere e della libertà. Principio o “cominciamento” del pensiero è proprio l’ens, l’ente, inteso come “trascendentale fondante” ogni possibile conoscenza concettuale. Oltre ai suoi contributi fondamentali nel campo dei fondamenti della metafisica, ci preme segnalare di Fabro le sue riflessioni sull’uomo e la libertà: all’umanesimo senza fondamento del pensiero moderno, la speculazione tomistica oppone l’idea che l’esse è implicato nella stessa struttura costitutiva della persona ed è questo il modo più alto di celebrare la dignità dell’uomo. Ogni uomo, in quanto essere spirituale, è un soggetto libero e intelligente e lo spirito umano risulta come costituito – nell’ordine etico-esistenziale – da una “libertà assoluta per partecipazione”, la quale, ben lungi dal disperdersi in una cieca indifferenza rispetto agli oggetti da scegliere, si configura come facoltà autenticamente umana proprio in quanto capace di tendere a Dio come Sommo Bene.
Josef Pieper
Il contributo di Josef Pieper (1904 – 1997) muove a partire dalle aspre critiche che gli ambienti esistenzialisti (con particolare riferimento a Heidegger e Jaspers) hanno rivolto contro l’idea di una “filosofia cristiana” che Heidegger dipingeva come una sorta di “ferro di legno”, una contraddizione in termini. Pieper sottolinea – sulla scorta del pensiero di Tommaso – come il domandare proprio della filosofia si configuri come una ricerca reale di una risposta: “Nonostante si sappia che alla fine sta l’incomprensibile, essere alla ricerca di una risposta e tenersi aperti per essa; mentre per Heidegger ‘domandare’ sembra piuttosto significare: rifiutare in linea di principio qualsiasi possibile risposta, e chiudersi di fronte ad essa (perché essa, di fatto, intaccherebbe il carattere di domanda della filosofia)” (15). Nella filosofia di Pieper si può riscontrare un’indubbia centralità del problema antropologico, che si dipana in tre filoni essenziali:
1) l’uomo deve lottare per vivere da uomo;
2) l’uomo deve rapportarsi con la realtà (non è l’uomo la misura dell’essere, ma l’essere è misura dell’uomo);
3) l’uomo ha come fine supremo Dio e realizza pienamente la propria umanità nella misura in cui partecipa di Dio, conosciuto nell’amore.
L’attualità del tomismo, per Pieper, non risiede tanto nel fatto che esso offra alla modernità ciò che essa esplicitamente chiede, ma ciò di cui ha profondamente bisogno, come risposta ai propri problemi irrisolti. Pieper ha costruito una sintesi originale, che assimila in un impianto autenticamente tomistico elmenti platonici, neoplatonici, agostiniani e aristotelici: fossilizzarsi nella pura ripetizione di tesi tomistiche sarebbe decisamente “anti-tomistico”. Il tomismo infatti – secondo Pieper – unisce alla capacità di cogliere i valori trascendentali e i principi metafisici della realtà, la consapevolezza del limite di ogni conoscenza umana, superando tentazioni storiciste o relativistiche; esso esclude altresì prospettive come quelle hegeliana e marxista che pretendono di possedere la chiave di lettura dell’Assoluto che si realizza nella storia. In conclusione di un saggio sulla questione della verità, Pieper scrive che “giammai l’uomo comprenderà – ossia conoscerà fino in fondo – la natura delle cose. E mai saprà misurare la totalità dell’universo. (…) La conoscenza dell’essenza delle cose e la conoscenza della totalità delle cose, è stata concessa all’uomo ‘come speranza futura’. Ciò significa: ogni sforzo conoscitivo sarà sì un positivo progresso, e non sarà per principio inutile; ma avrà anche sempre come risultato un nuovo non-ancora. (…) L’uomo è capax universi (e a tal punto che lo stesso universo, proprio perché non è ‘tutto’, non riesce a saziarlo). (…) Perché l’uomo è situato nel centro di un mondo che al di là di quanto è da noi via via conosciuto tiene sempre pronto l’imprevedibile; perché egli è un essere che vive al cospetto della totalità delle cose esistenti e la cui interiore sconfinatezza non è che la risposta alla inesauribile immensità del suo mondo. Questo mondo a sua volta risponde – questa è la sua natura – al verbo creatore dell’intelligenza divina, nella cui ‘arte’ gli archetipi del mondo sono vita. Poiché l’universo delle cose esistenti ‘è posto fra due intelletti’, il divino e l’umano. E il ciò, come ben sa la tradizione metafisica occidentale, si fonda la verità delle cose” (16).
Note
(1) L’Accademia tomistica di Bologna fu fondata nel 1853 da Marcellino Venturoli, da Francesco Battaglini Ufuturo cardinale di Bologna, da Giambattista Corsoni e Achille Sassoli Tomba, per citare solo i principali.
(2) Possiamo anzi affermare che il “tomismo imposto per decreto” che caratterizza il pontificato di Pio X e si traduce nella pubblicazione, il 27 luglio 1914, delle 24 tesi tomiste, redatte dal p. Guido Mattiussi (successore di Billot alla Gregoriana) per conto della Congregazione degli Studi non ha certamente giovato al progresso dell’autentica riflessione filosofica genuinamente ispirata a Tommaso. Si trattava di un tomismo semplificato, coartato in formule riduttive, ben lontano dall’autentica tensione filosofica che caratterizzava gli scritti dell’Aquinate.
(3) A. D. Sertillanges, Le Thomisme, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 570.
(4) Può essere utile citare un passaggio cruciale dell’opera del nostro autore: “Il contenuto della filosofia cristiana è dunque il corpo delle verità razionali che sono state scoperte, approfondite, o semplicemente salvaguardate, grazie all’aiuto che la rivelazione ha apportato alla ragione. Se questa filosofia sia realmente esistita, o se essa non sia che un mito, è una questione di fatto che noi chiederemo alla storia di risolvere. (…) Il filosofo cristiano si domanda semplicemente, se tra le proposizioni ch’egli crede vere, ce ne sia un certo numero che la sua ragione potrebbe saper vere. Finché il credente fonda le sue asserzioni sulla persuasione intima, che la sua fede gli conferisce, egli rimane un puro credente e non è ancora entrato nel dominio della filosofia; ma dal momento in cui egli trova nel numero delle sue credenze alcune verità che possono divenire oggetto di scienza, egli diventa filosofo, e se deve questi nuovi lumi filosofici alla fede cristiana, diventa un filosofo cristiano” [E. Gilson, Lo spirito della filosofia Medievale, trad. it. ed. Morcelliana, Brescia 1983, pag. 42].
(5) E. Gilson, Le réalisme, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 618.
(6) Amato Masnovo, Gnoseologia e metafisica, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 772.
(7) Cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 660.
(8) Ci siamo permessi di collocare la figura di Edith Stein nella seconda metà del XX secolo, a dispetto delle coordinate anagrafiche in cui appare evidente la prematura morte nel 1942, perché – oltre ad essere contemporanea di altri intellettuali come Przywara (che ella conobbe personalmente e dal cui pensiero fu profondamente stimolata) e Maritain, il fatto che le sue opere non potessero essere pubblicate durante gli anni del totalitarismo nazista, ha portato ad una circolazione delle sue idee (quindi ad un suo influsso reale sulla storia del pensiero) solo nella seconda metà del secolo.
(9) Nato a Parigi nel 1882 in una famiglia di tradizioni repubblicane e di fede protestante, studiò filosofia alla Sorbona (in un clima di relativismo e scetticismo, mentre la cultura era dominata dalla tradizione positivista), visse in modo travagliato la propria esperienza religiosa, frequentò ambienti socialisti (dove conobbe Raissa, sua futura consorte, a sua volta atea, ma figlia di pii ebrei russi), finché non ebbe modo di ascoltare le lezioni di Bergson che fecero rinascere – in lui e molti altri – la fiducia nella verità, nella vita, negli alti ideali. Nel 1904 vi è l’incontro con Léon Bloy, da cui nasce un’intensa amicizia ed un profondo dibattito interiore che porta i coniugi Maritain (nel 1906) al battesimo cattolico. Maritain è ancora vicino al bergsonismo, finché l’incontro con il p. Clérissac lo introduce allo studio di S. Tommaso. La sua riflessione “tomista” inizia negli anni del primo conflitto mondiale (dove perdono la vita molti suoi cari amici) e prosegue nel periodo fra le due guerre, finché – nel 1940 – non è costretto a trasferirsi in America per sfuggire alla persecuzione nazista. Insegna a Princeton ed alla Columbia University. Torna a Parigi nel 1960, anno in cui muore l’amata consorte Raissa. Maritain si stabilisce presso i Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld, a Tolosa, di cui entrerà a far parte nel 1970. Morirà nel 1973, più che novantenne.
(10) Jacques Maritain, Distinguere per unire: i gradi del sapere, tr. it. Morcelliana, Brescia 1974, pp. 58-61.
(11) Si tratta di due opere pubblicate negli anni del secondo conflitto mondiale, durante la permanenza di Maritain negli Stati Uniti: L’educazione al bivio (tit. originale: Education at the Crossroads, Yale University Press, New Haven 1943; ed. francese: L’éducation à la croisée des chemins, Egloff, Paris 1947), ed. it. a cura di A. Agazzi, La Scuola, Brescia 1963; e L’educazione della persona (tit. originale: Pour une philosophie de l’éducation, Librairie Fayard, Paris 1959), tr. it. di P. Viotto, La Scuola, Brescia 1962.
(12) Jacques Maritain, L’educazione al bivio, cit., pp. 14-15.
(13) Gustavo Bontadini, Conversazioni di metafisica, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 805.
(14) Gustavo Bontadini, Metafisica e de-ellenizzazione, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 806.
(15) Josef Pieper, Verteidigungsrede für die Philosophie (Monaco, 1966), cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all’eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 760.
(16) Josef Pieper, Verità delle cose. Un’indagine sull’antropologia del Medio Evo (tit. orig. Wahrheit der Dinge. Eine Untersuchung zur Anthropologhie des Hocmittelaters, Monaco 1944, IV ed. 1966), tr. it. di L. Frattini, Massimo, Milano 1981, pp. 117-123, passim.
SIGIERI di BRABANTE

Le dottrine di Averroè permearono anche nel mondo occidentale , che era entrato in contatto con quello orientale soprattutto grazie alle crociate , e si diffusero ampiamente anche a Parigi . Qui operò Sigieri , nato a Brabante ( Belgio ) fra il 1230 e il 1240 : egli si recò a Parigi per studiare le arti liberali fra il 1255 e il 1260 e successivamente divenne maestro in tale facoltà . Dante lo colloca in Paradiso , definendolo come colui ” che sillogizzò insidiosi veri ” , ossia colui che argomentò verità pericolose per la Chiesa , però pare più logica la lettura ” invidiosi veri ” , ossia verità che lo misero in cattiva luce : altrimenti perchè mai dovrebbe essere in Paradiso uno che andò contro la Chiesa ? Prima del 1270 Sigieri compose le ” Questiones in tertium de anima ” , concernenti il libro dell’ omonimo trattato aristotelico dedicato alla trattazione dell’ intelletto . Con il ” De intellectu ” invece egli replicò al ” De unitate intellectus ” di Tommaso e poco dopo , tra il 1272 e il 1273 scrisse il ” De anima intellectiva ” . Nel 1276 fu citato in tribunale dall’ inquisitore di Francia , Simone du Val , con altri maestri , ma egli aveva già lasciato la Francia per recarsi presso la corte pontificia , dove intendeva difendersi . Qui , a Orvieto , in una data imprecisata prima del 1284 , morì assassinato da un chierico impazzito . Sigieri fu anche autore di commenti ad alcuni libri della Metafisica , alla Fisica e al De generatione e corruptione di Aristotele , nonchè di alcuni opuscoli di contenuto logico , di una ” Quaestio de necessitate et contingentia causarum ” e di un’ altra ” De aeternitate mundi ” . Secondo Sigieri , come già secondo Averroè , Aristotele é il filosofo per eccellenza , simbolo della ragione umana , ma egli ritiene anche che il coronamento della filosofia aristotelica sia dato dalla teologia contenuta nel Liber de causis . Qui si trova enunciata la dottrina che al principio di ogni cosa c’é una causa prima , la quale é unica . Se essa é tale , anche il suo effetto immediato é unico , necessario ed eterno come la causa prima . Essa é la prima delle intelligenze immateriali , dalla quale derivano le altre intelligenze celesti e le sfere celesti stesse e infine il mondo sublunare delle sostanze generabili e corruttibili . In base a queste premesse Sigieri ritiene che si possa affermare che il mondo é creato da Dio , nel senso che tutte le cose dipendono necessariamente dall’ unica causa prima che é Dio , ma non che il mondo abbia avuto inizio nel tempo per un atto di libera volontà da parte di Dio stesso . Si tratta invece di una dipendenza eterna e necessaria di tutte le cose da Dio , che agisce provvidenzialmente attraverso la azione di intermediari e , quindi , anche attraverso l’ influenza degli astri . Quindi il mondo é eterno proprio come lo é Dio . Ed eterne sono anche le specie che popolano il mondo , come già aveva detto Aristotele . Su questa base si fonda la verità di proposizioni universali come ” l’ uomo é un animale ” : tale proposizione é vera perchè sono sempre esistiti uomini , in riferimento ai quali tale proposizione era vera . La tesi dell’ eternità del mondo , tipicamente aristotelica , era già stata ripresa e riformulata da Averroè . Ed anche sul problema dell’ intelletto , Sigieri ritiene , almeno in una prima fase , che la dottrina di Averroè costituisca l’ interpretazione corretta di Aristotele . Ogni individuo umano é una sostanza composta di materia ( il corpo ) e di forma ( l’ anima ) , che svolge le funzioni vegetative e sensitive : ogni essere é , per dirla proprio alla Aristotele , un sinolo di materia e forma . Per quanto riguarda invece le funzioni intellettive , queste dipendono dal suo rapporto con l’ anima intellettiva della specie umana . Questa é unica e puramente spirituale , non collegata a una struttura corporea e si articola , a sua volta , in intelletto agente e intelletto possibile . L’ attività dell’ intelletto si esplica negli individui umani in connessione alle immagini degli oggetti percepiti dai sensi , le quali variano da individuo a individuo : su questa base anche l’ intelletto si diversifica a seconda degli individui . Grande differenza rispetto ad Aristotele , é che per Sigieri l’ anima intellettiva é immortale . Mentre l’ anima intellettiva é immortale , i singoli individui sono perituri ; da ciò scaturisce la conseguenza , attribuita a Sigieri dai suoi avversari , che nella vita futura non ci sono premi o punizioni individuali : la punizione é intrinseca ai cattivi atti commessi . Successivamente , forse in seguito alle argomentazioni di Tommaso e alla condanna del vescovo di Tempier nel 1270 , Sigieri attenuò queste posizioni , avvicinandosi a dottrine psicologiche più compatibili con le verità della fede ; ma egli non fu mai sostenitore della dottrina della doppia verità , furono i suoi avversari ad attribuirgli questa dottrina , stigmatizzata in una successiva condanna del vescovo Tempier del 1277 : ” come se ci fossero due verità contrarie ” ( quasi sint duae contrariae veritates ) . Per Sigieri la verità rivelata é superiore a quella umana e , in caso di contrasto , il cristiano opta per la prima . Ma la ragione non può sviluppare sino in fondo le argomentazioni filosofiche , anche se queste danno luogo a conclusioni che risultano contrastanti con la fede e pertanto erronee . Agli occhi di Sigieri l’ eroe é il filosofo che ricerca la verità senza deflettere : qui si esplica la vera grandezza della natura umana . Non é un caso che Sigieri anteponga la magnanimità , virtù che occupa una posizione rilevante nell’ etica aristotelica , alla virtù più propriamente cristiana dell’ umiltà .
BOEZIO DI DACIA
Il più noto rappresentante dell’aristotelismo “averroistico” nel mondo cristiano fu, accanto a Sigieri di Brabante, il danese Boezio di Dacia, di cui si ignorano sia l’anno di nascita sia quello di morte. In sintonia con Sigieri, Boezio – che fu maestro nella facoltà delle Arti di Parigi – riconosce che la verità è unica e, nel caso in cui la ragione contrasti con la rivelazione, è quest’ultima che il fedele deve seguire: il vero compito che questi pensatori si propongono è tuttavia non tanto quello di rendere in qualche modo compatibili i risultati della riflessione filosofica con la rivelazione, quanto piuttosto quello di analizzare che cosa abbiano pensato e argomentato i filosofi su ogni determinato problema, primo fra tutti Aristotele, concordemente additato – sulle orme di Averroè – come il vertice a cui l’intelletto umano si sia spinto. Sia Boezio di Dacia sia Sigieri di Brabante – come è noto – furono accusati di esser sostenitori della cosiddetta “dottrina della doppia verità”, tale per cui la fede e la ragione portano a due diverse verità: in realtà essi erano convinti – come abbiamo testè detto – che la verità fosse unica, raggiungibile sia dalla fede sia dalla ragione e che, in caso di disaccordo fra le due, la preminenza spettasse in ogni caso alla fede. Prendendo a modello il decimo libro dell’Etica Nicomachea dello Stagirita, sia Sigieri sia Boezio sostengono che la massima felicità per l’uomo risieda nella vita contemplativa e teoretica: per essere davvero felice sulla terra in cui si trova viator, l’uomo deve esercitare il più possibile le proprie doti intellettuali, prima fra tutte la scienza dimostrativa. Dall’esercizio del pensiero scaturisce una felicità irresistibile, superiore ad ogni altra. Ciò non toglie, tuttavia, che talvolta la filosofia, intesa come dimostrazione a partire da premesse, possa pervenire a conclusioni contrastanti con le verità di fede: in questo caso – pur ribadendo l’assoluta egemonia della fede e su quanto da essa attestato – Boezio ritiene che le verità di ragioni debbano comunque essere enunciate, anche se contrastanti con la rivelazione. In questo modo, viene rivendicata l’assoluta libertà di filosofare. Con grande interesse Boezio si sofferma diffusamente sulla tematica dell’etica filosofica, alla luce degli insegnamenti aristotelici dell’Etica Nicomachea: in particolare, nel suo scritto De summo bono sive de vita philosophi (Del sommo bene, ovvero della vita del filosofo): il pensatore danese non nega certamente che il fine ultimo dell’uomo consista nella beatitudine soprannaturale – come asseriscono le Scritture -, ma si chiede quale effettivamente sia il bene massimo accessibile in terra, da un punto di vista meramente razionale. Tale bene è ravvisato da Boezio nella saggezza (la swfrosunh di cui parlava Aristotele) propria della vita filosofica, dedita alla conoscenza della verità e alla pratica del bene. Il culmine di essa è poi rappresentato dalla conoscenza e dall’amore di Dio, il quale è principio e fonte di ogni bene. Su questi presupposti, Boezio di Dacia può rivendicare al filosofo – nello scritto De aeternitate mundi (L’eternità del mondo) – il diritto di indagare la realtà naturale secondo i princìpi propri di essa, anticipando in ciò, entro qualche misura, la spiegazione della natura iuxta propria principia di Telesio. D’accordo con Tommaso, Boezio ritiene che non sia possibile costruire argomenti validi contro la tesi dell’eternità del mondo: ciò – come già notava Tommaso – significa escludere non la creazione del mondo, nel senso della sua necessaria dipendenza da Dio, ma solo il suo inizio nel tempo. Il fisico, ossia il filosofo della natura, in base ai princìpi propri della sua disciplina, non può ammettere l’esistenza di un movimento iniziale del tutto nuovo. In generale, ad avviso di Boezio di Dacia, le dottrine alle quali la fisica perviene in base ai propri princìpi sono vere e pertanto risulta del tutto illegittima ogni interferenza della teologia nel campo della fisica. Per tale via, Boezio riconosce l’autonomia dei vari campi del sapere, ma al contempo ammette che i princìpi delle varie scienze sono solo possibili. Il fisico è cosciente di svolgere le proprie indagini su un insieme finito di cause meramente naturali; egli non può pertanto escludere la possibilità che altre cause (ad esempio i miracoli) intervengano a modificare l’ordine delle cause naturali, benché ciò esuli dall’ambito della fisica. Boezio, dunque, non esclude tout court il dominio del soprannaturale; ciò che egli esclude è piuttosto che esso sia di pertinenza della fisica. Inoltre, al di là della fisica, sono possibili verità alle quali si accede non per via di argomentazioni razionali, bensì grazie a una rivelazione da parte di Dio. Ne segue che sia che il mondo sia eterno sia che esso abbia origine nel tempo dipende solamente dalla volontà di Dio, la quale può essere conosciuta dall’uomo soltanto se è Dio stesso a rivelarla. Le verità della fisica sono vere soltanto relativamente ai princìpi di essa, non in assoluto e, quindi, non contrastano propriamente con le verità della fede, in quanto appartengono ad un piano diverso, anche se il piano della fede conserva intatta la sua indiscutibile superiorità. In tal maniera, risultava comunque frantumata l’unità organica della sapienza cristiana, quale era stata costruita fin dai tempi dei Padri della Chiesa, né veniva più postulata pregiudizialmente la piena compatibilità tra i risultati conseguibili dalla ragione umana e i contenuti della rivelazione.
DUNS SCOTO

Giovanni Duns, detto Scoto perchè nato in Scozia, nacque probabilmente verso il 1265 o il 1266 e fu saprannominato dai suoi contemporanei doctor subtilis, per la sua abilità nel formulare tutte le distinzioni e alternative possibili. Entrato giovane nell’ordine francescano, studiò a Oxford e poi a Parigi, dove, secondo la consuetudine, commentò le Sentenze di Pietro Lombardo. Nel 1303 fu costretto a lasciare Parigi, essendosi schierato tra i sostenitori del papa Bonifacio XIII nel conflitto contro il re di Francia Filippo il Bello, ma già nel 1304 potè rientrare a Parigi ed essere nominato maestro. Nel 1305 tornò ad insegnare a Oxford , dove compose la sua opera più nota , intitolata Opus oxoniense, dedicata al commento alle Sentenze di Pietro Lombardo. Nel 1307 venne chiamato a insegnare teologia nello studio francescano di Colonia, da poco istituito, ma l’anno successivo perì. Altri scritti di Duns Scoto sono il Tractatus de primo principio, le Quaestiones super libros Aristotelis de anima, e i Reportata parisiensia, conservati in due redazioni, anch’essi dedicati al commento delle Sentenze. Un modo di rendere accettabile la filosofia aristotelica in Occidente era consistito nel renderla funzionale al discorso teologico e compatibile, almeno in una certa misura, con i dati della rivelazione: tale era stata la via intrapresa da Tommaso d’Aquino . Con Duns Scoto questa breve “luna di miele” (Gilson) tra fede e filosofia si interrompe. Il termine teologia designa in Duns il sapere necessario all’uomo per raggiungere il suo fine soprannaturale: per agire in vista di un fine occorre desiderarlo, ma per desiderarlo occorre conoscerlo. Con i suoi soli mezzi naturali l’uomo non può, secondo Duns Scoto, pervenire ad una conoscenza adeguata del suo fine. Tale fine, infatti, é stato voluto liberamente da Dio e da lui assegnato all’uomo e non può pertanto essere dedotto e conosciuto partendo dalle sole caratteristiche della natura umana. La scienza é per Duns Scoto scienza dimostrativa: essa deduce da premesse le conseguenze che ne derivano necessariamente, come aveva mostrato Aristotele. Ma di ciò che é deciso e voluto liberamente da Dio e, quindi, non presenta alcuna traccia di necessità, l’uomo non può avere scienza in questo senso. Duns Scoto non nega che i filosofi possano avere avuto qualche conoscenza del vero fine dell’uomo, ma nega che questa conoscenza sia stata sufficiente per garantire la salvezza. La filosofia, infatti, non può scoprire da sola ciò che all’uomo é noto solo grazie alla rivelazione contenuta nel Vangelo: in questo senso, il Dio del Vangelo non é l’oggetto della filosofia e il Dio dei filosofi non si identifica con il Dio dei cristiani. La rivelazione é la comunicazione proveniente da una fonte diversa dalle fonti naturali di conoscenza, di cui l’uomo dispone dopo il peccato originale: essa é concessa liberamente e direttamente da Dio e ci rende noto che il fine ultimo per l’uomo consiste nella visione diretta di Dio e nel godere eternamente della sua beatitudine. Questa rivelazione del fine e dei mezzi per raggiungerlo é contenuta nella Scrittura, che é quindi l’oggetto proprio della teologia. Il suo dominio é quello delle verità accettate per fede. In quanto tale la teologia é un sapere pratico, la cui finalità consiste nel conoscere le verità che Dio ha ritenuto utili per il conseguimento della salvezza e nell’indirizzare l’uomo alla beatitudine. Essa si distingue dunque da ogni scienza, in quanto ricava i propri principi dalla rivelazione e non dalle scienze alle quali l’uomo può pervenire. Queste scienze, a loro volta, non ricevono i loro principi dalla teologia. I due ambiti risultano quindi non solo autonomi, ma sostanzialmente privi di relazioni. L’ambito della scienza comprende tutto ciò che é dimostrabile: tutto ciò che non può essere dimostrato non può essere oggetto di scienza e cade, pertanto, fuori dai suoi limiti. Segno rilevante della dimostrabilità o no di qualcosa é per Duns il fatto che i filosofi, in primo luogo Aristotele, siano o no riusciti a dimostrare tale cosa. La tradizione filosofica circoscrive in qualche modo i limiti entro i quali si può legittimamente muovere la ragione umana. Al di là di essi si apre invece il terreno indipendente della teologia. La scienza suprema é per Duns Scoto – come già per Aristotele – la metafisica: essa é suprema in quanto ha per oggetto ciò che é conosciuto prima di qualsiasi altra cosa e a partire dal quale sono conoscibili le altre cose. Tale oggetto, come si é visto, non é il Dio cristiano della rivelazione, di cui si occupa la teologia. Era stato Tommaso a sostenere che due scienze distinte, la metafisica e la teologia, possono riguardare entrambi Dio. Per Duns Scoto, invece, l’oggetto proprio della metafisica é l’essere in quanto essere. La nozione di essere é la prima che l’uomo può conoscere, e per conoscere qualcosa distintamente occorre conoscere tutto ciò che é incluso nella sua nozione, tenendo conto che nella nozione di tutto ciò che é , é incluso l’essere. Non stupisce il fatto che Heidegger ottenne la libera docenza con un saggio su La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto, vista la centralità della nozione di essere nel pensatore medievale. Mentre gli altri concetti sono riconducibili a quello di essere, quest’ultimo non é riducibile ad altri concetti che siano anteriori ad esso: in quanto tale esso é l’ens commune. Ma in quanto comune a tutte le cose che sono, la nozione di essere in quanto essere é indeterminata e antecedente a qualsiasi altra e pertanto predicabile di tutto ciò che é. Proprietà del termine essere é, infatti, secondo Scoto, la sua univocità. Un termine é univoco quando in tutti i suoi impieghi significa sempre e soltanto la stessa cosa. Quindi il termine essere si dice in un solo senso di tutto ciò che é. Questa dottrina si differenzia nettamente dalla concezione dell’analogicità dell’essere, sostenuta da Tommaso, o da quella della biunivocità sostenuta da Platone a costo di un omicidio, quello simbolico ai danni di Parmenide. Secondo Duns Scoto, un concetto analogo di essere sarebbe un altro concetto e quindi il concetto di essere, riferito alle creature, non potrebbe più essere usato in relazione a Dio. Il termine essere, invece, si predica univocamente, ossia nello stesso significato, sia delle cose create e finite , sia dell’essere increato e infinito, cioè Dio. Ciò non significa che l’essere sia il genere più ampio, includente al suo interno sia Dio sia le cose create: si tratta invece solo della determinazione comune a tutto ciò che é. L’essere é il primo oggetto dell’intelletto e tramite esso é possibile conoscere il resto. L’oggetto di una scienza, infatti, contiene potenzialmente la conoscenza di tutte le verità alle quali tale scienza può arrivare. Compito della metafisica sarà pertanto svolgere per via deduttiva tutto ciò che é contenuto implicitamente nel concetto di essere. Avendo per oggetto la nozione prima e comune di essere, la metafisica é la scienza suprema, presupposto di tutte le altre scienze. La metafisica non ha per oggetto l’essenza di Dio , ma può stabilire l’esistenza dell’essere che la teologia chiama Dio. L’uomo non gode di conoscenza diretta dell’essenza di Dio e pertanto non basta asserire che l’esistenza appartiene all’essenza divina per essere certi che Dio esiste. L’esistenza di Dio, infatti, non é qualcosa di evidente come la nozione che il tutto é maggiore della parte . Alla dimostrazione dell’esistenza di Dio si arriva, secondo Duns Scoto, attraverso la nozione di essere infinito, ma per dimostrare che esiste un essere infinito occorre prima dimostrare che esiste un essere primo e poi che tale essere primo é infinito. La dimostrazione dell’esistenza di un essere primo avviene a posteriori, ossia a partire dall’esperienza, e non a priori, come aveva preteso Anselmo da Aosta. Su questo aspetto, Duns si approssima alla posizione di Tommaso (le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio), ma il suo punto di partenza non é la nozione di movimento, quanto piuttosto quella di essere e di causa. Noi vediamo che possono esistere enti che non sono prodotti nè dal nulla nè da se stessi, bensì da qualche altro ente, e poichè non é possibile risalire all’infinito nella serie delle cause, perchè é impossibile un’infinità di cause ordinate, occorre dunque ammettere la possibilità di un essere primo, causa di tutto il resto e a sua volta non causato da altro, quindi capace di esistere da sè poichè se non esistesse, esso non sarebbe più tale. Non dipendendo da nulla, l’essere primo non é limitato da nulla e pertanto é infinito. La nozione di infinito non é un attributo particolare di Dio, ma esprime un modo intrinseco del suo essere, il grado massimo della perfezione. Sulla base di esso si può procedere a riferire a Dio i vari attributi: così dire che Dio é bene equivale a dire che infinito é bene e così via. Dalla nozione di essere infinito é possibile ricavare quella dell’unicità di tale essere, dalla sua semplicità e immutabilità: tali attributi sono tra loro distinti formalmente, in quanto sono definibili diversamente l’uno dall’altro, ma non realmente, in quanto nessuno di essi é una entità numericamente distinguibile dagli altri. Ciò che non é dimostrabile di Dio, secondo Duns, é la sua onnipotenza. Lo prova il fatto che i filosofi non sono riusciti a dimostrarla: per i filosofi aristotelici, in particolare arabi (in particolare Avicenna), anche Dio é incatenato dalla necessità, sicchè da lui il mondo scaturisce necessariamente. Il fatto che esista il primo essere non comporta necessariamente per Duns Scoto che esso sia il primo motore, come aveva sostenuto Aristotele. Dio é primo motore soltanto perchè ha creato il mondo, ma il fatto di creare il mondo é qualcosa di contingente rispetto all’essenza di Dio, non é qualcosa che compete necessariamente alla sua essenza. Di conseguenza, il mondo che risulta dalla creazione é anch’esso contingente. L’intelletto divino produce le idee, che sono le verità e le ragioni eterne, gli esemplari o forme delle cose create. Dio ha idee di tutto, anche delle cose individuali e dei loro accidenti, nonchè della materia stessa, concepita non come privazione di forma, ma come ciò che riceve la forma. Rispetto a Dio, essere infinito, ogni creatura é finita e quindi infinitamente distante da Dio. Che esistano esseri contingenti, i quali possono essere o non essere, é verità evidente. In che modo spiegare la loro contingenza? Essa non può essere spiegata in base a cause, le quali siano causate necessariamente da altro, perchè in tal caso l’effetto non sarebbe contingente, ma necessario. La contingenza delle cose può essere spiegata solo in base ad una causa che sia prima, cioè non causata da altro, e che a sua volta causi il resto in maniera contingente, ossia senza essere costretta o determinata da altro. Tale é solamente la volontà di Dio, la quale non é vincolata da nulla e opera in maniera totalmente libera, ma proprio in quanto del tutto libera, la volontà divina sfugge a ogni necessità e ad ogni possibilità di conoscerla razionalmente , mediante scienza dimostrativa. L’onnipotenza assoluta di Dio é pertanto articolo di fede: essa consiste nel potere di creare immediatamente, cioè senza agenti intermediari (le cosiddette cause seconde) tutto ciò che é creabile. Creare vuol dire causare liberamente degli esseri possibili, la cui esistenza non é necessaria. Prima della creazione nulla esiste e ciò che esiste in virtù della creazione é contingente, può essere come non essere. Duns Scoto riprende dalla tradizione giuridica la distinzione tra ciò che é possibile secondo la legge e ciò che é possibile di fatto: il primo definisce la potentia ordinata e il secondo la potentia absoluta. Per potenza ordinata, i gravi cadono al suolo; per pitenza assoluta Dio può far sì che ciò non accada. Sia in Dio, sia tra gli uomini, la potentia absoluta é più ampia di quella ordinata, perchè riguarda un ambito più ampio di possibilità: un re, per esempio, può anche graziare un individuo condannato in base alla legge. La legge ha una funzione limitante riguardo al potere assoluto, ma Dio può anche stabilire un’altra legge che, in quanto stabilita da lui, é necessariamente buona. L’unico contrassegno della bontà di un ordine é la sua dipendenza dalla volontà divina. Qui é il nocciolo di quello che é stato definito volontarismo di Duns Scoto: Platone rispondeva che le cose piacciono alla divinità perché sono belle; Scoto, viceversa, risponde che le cose sono belle perché piacciono a Dio. In questa prospettiva, Dio appare come un sovrano assoluto: nulla può limitarne l’azione, se non il principio di contraddizione, nel senso che Dio non vuole contemporaneamente una cosa e la sua contraria; tutto ciò che egli decide di fare ha valore di legge, ma in quanto proviene dalla sua volontà é il meglio. Per Tommaso, invece, Dio trovava un vincolo nella proipria perfezione: Dio può fare tante cose, ma di fatto egli fa il meglio (è moralmente necessitato). Per Duns Scoto dunque l’attuale ordine del mondo non é l’unico possibile. Le cose create da Dio sono entità individuali, le quali tuttavia hanno una natura comune. Socrate, Platone e gli altri individui hanno qualcosa che li distingue da un cavallo o da una pietra: esso é appunto la natura comune, consistente nell’essere uomini. Ma, diversamente dalle posizioni realistiche, le quali sostengono l’esistenza reale della natura comune, per Duns Scoto essa non é un essere numericamente distinto dalle cose individuali e non é pertanto dotato di esistenza a parte da queste cose, ma non é neppure una semplice entità mentale, come gli universali pensati dall’intelletto. Essa non é di per sè nè universale nè singolare , ma indifferente sia all’universalità sia alla singolarità. Da che cosa dipende allora l’individualità delle cose? Ovviamente non può dipendere dalla forma, che coincide con la natura comune; e inoltre il principio di individuazione non può essere dato neppure dalla materia. Secondo Duns Scoto, che su questo punto si stacca dalla tradizione aristotelica, la materia, infatti, non é pura passività, perchè altrimenti non si distinguerebbe dal nulla: quindi anche la materia é dotata di individualità propria. L’ente individuale deve contenere in sè qualcosa che non é contenuto nella nozione di natura comune e che dispone tale natura, la contrae in modo da essere una cosa determinata nella sua individualità (ad esse hanc rem). Nei Reportata parisiensia questa determinazione é detta haecceitas (da haec, che in latino significa “questa cosa singola”). Anche essa non ha esistenza numericamente distinta dalla cosa singola, ma non é neppure dotata di esistenza puramente mentale: essa appartiene a ciascun ente nella sua individualità. La causa dell’individualità é dunque sempre una differenza ultima, in base alla quale ciascuna cosa si distingue da ogni altra. In tal modo, Duns Scoto riconosce a pieno titolo l’originalità e irriducibilità di ogni ente individuale. La natura comune, che si individualizza nelle entità reali, si universalizza invece nell’intelletto. Ciò avviene mediante le specie intelligibili, che sono gli oggetti della conoscenza intellettuale. Mentre le immagini degli oggetti colti dai sensi presentano tali oggetti nella loro singolarità, le specie intelligibili li presentano sotto l’aspetto dell’universalità. La prima conoscenza distinta dell’intelletto é la specie più universale: essa, come si é visto, é la nozione di essere, nella quale sono incluse tutte le nozioni più ristrette. Duns Scoto distingue due forme di conoscenza: intuitiva e astrattiva. La conoscenza intuitiva coglie l’oggetto in quanto é presente nella sua esistenza attuale, é l’analogo della visione diretta di un oggetto: essa é propria non solo dei sensi, ma anche dell’intelletto; infatti anche la natura comune, non solo le cose individuali, é oggetto di conoscenza intuitiva. La conoscenza astrattiva, invece, prescinde dall’esistenza attuale degli oggetti conosciuti intuitivamente, poichè in questi la natura comune, anzichè individualizzarsi, si universalizza. Solo in questo modo si può costituire la scienza, che é appunto conoscenza dell’universale. La scienza può essere stabile e immutabile, soltanto se astrae dall’esistenza degli oggetti che essa considera; in caso contrario resterebbe coinvolta anche essa nel nascere e perire dei suoi oggetti. Prima della caduta nel peccato originale non era necessaria la conoscenza astrattiva, ma tutto era colto intuitivamente in una visione diretta, anche Dio stesso, e così sarà in futuro nella visione beatificata ultraterrena. Ma Duns Scoto ritiene che l’immortalità dell’anima non possa essere dimostrata e sia soltanto verità di fede. L’anima intellettiva é la forma sostanziale dell’uomo, in quanto il pensiero non dipende da organi corporei, ma il corpo é dotato di una forma della corporeità che predispone il corpo alla sua unione con l’anima: in tal modo, Duns Scoto fa propria la dottrina, tradizionalmente ammessa negli ambienti francescani, della pluralità delle forme. Ma l’ uomo é anche dotato di volontà, la quale é superiore all’intelletto stesso: su questo punto Duns si contrappone nettamente al primato dell’intelletto e della vita teoretica, sostenuto da Tommaso e dalla tradizione aristotelica. L’intelletto, infatti, é determinato dai suoi oggetti, dipende da essi, mentre la volontà é libera, non ha altra causa che se stessa e si serve dell’intelletto come di uno strumento. L’assenso della volontà non é causato necessariamente dalla bontà dell’oggetto; essa infatti é libera di sceglierlo come di rifiutarlo. La volontà é buona quando vuole il bene, ma che cosa sia il bene dipende dall’onnipotenza divina. Dio non vuole il bene perchè é bene, come sosteneva Platone; bene é invece ciò che Dio vuole, in quanto lo vuole. La causa del bene é la volontà di Dio e pertanto il bene per l’uomo consisterà nel conformarsi alla volontà di Dio. Se volesse, Dio potrebbe stabilire per gli uomini una legge diversa da quella che ha stabilito; in tal caso sarebbe buona quest’ultima. L’unica eccezione all’arbitrarietà del comando divino é costituita dal fatto che in ogni caso l’uomo deve conformarsi a tale comando. Ciò darà luogo ad un agire veramente buono quando sarà accompagnato dall’amore di Dio , dal quale dipende l’amore per se stessi e per il prossimo: la virtù più alta é per Duns Scoto la carità. Ad essa Dio risponde con la grazia, ossia con il suo amore e con il premio della beatitudine, conferito liberamente per i meriti che gli sembrano degni di essere premiati.
MARSILIO DA PADOVA

INTRODUZIONE
Marsilio da Padova nacque circa nel 1280, fu medico, studiò presso l’università di Parigi, nella quale fu successivamente insegnante, fino a diventarne rettore nel 1313. La morte lo colse nel 1342 (o forse nel 1343). Nel 1324 cominciò a lavorare a quella che sarebbe divenuta la sua opera principale, il “Defensor pacis” (“Il difensore della pace”), che dedicò all’imperatore Ludovico il Bavarese. Anni dopo, egli compose un compendio (intitolato “Defensor minor”) del “Defensor pacis”. A causa dello scontro che vide opposti l’imperatore e Giovanni XXII, Marsilio fu costretto a fuggire da Parigi nel 1236 – insieme con Jean de Jandun, seguace di Sigieri di Brabante – per porsi al seguito dell’imperatore, al fianco del quale egli rimase fino alla morte. In sintonia con Aristotele, Marsilio da Padova concepisce lo Stato come un’istituzione naturale, nata dalla congenita esigenza dell’uomo (“animale politico”, diceva Aristotele) a vivere in associazione coi propri simili. Lo scopo dello Stato – sostiene Marsilio, anche qui d’accordo con Aristotele – consiste nel consentire all’uomo di vivere e, oltre a ciò, di vivere bene: in questo senso, lo Stato permette all’uomo di raggiungere la felicità (che se vivesse da solo, senza il contatto con altri uomini, non potrebbe raggiungere). Perché ciò si realizzi, diventa essenziale la salvaguardia della pace (a cui si richiama il titolo stesso dell’opera marsiliana) e lo strumento di cui lo Stato si avvale per garantirla è la legge. L’intero discorso di Marsilio orbita intorno al problema della pace e l’eliminazione dei conflitti; un tema, questo, già noto ad Aristotele (e da lui trattato nella “Politica”), al quale era però ignoto quello scontro tra la Chiesa e lo Stato, tra il papa e l’imperatore, che andava configurandosi ai tempi di Marsilio e che il concordato di Worms (1122) non era riuscito a risolvere. Perché la pace sia assicurata, è necessaria la legge, il cui fine precipuo consiste nella giustizia civile e nel vantaggio comune. Nessun governante, anche se giusto, può governare senza far ricorso a delle leggi, ma occorre allora chiarire che cosa sia la legge: a ciò Marsilio provvede nel primo dei tre discorsi in cui si articola l’opera “Defensor pacis”; il secondo discorso è orientato a corroborare le sue tesi con l’ausilio delle testimonianze tratte dalla Scrittura e dai suoi “santi interpreti”, mentre il terzo trae le conclusioni e gli insegnamenti utili che si possono ricavare dai discorsi precedenti. Caratteristica del primo discorso è la struttura dimostrativa: si tratta di partire da “proposizioni che sono evidenti di per sé ad ogni mente non corrotta per natura, consuetudine o sentimento perverso” per dedurne le conclusioni. L’esistenza di una regola (o comunque venga chiamata: “statuto” o anche “consuetudine”) come base di qualsiasi governo civile è per Marsilio un principio di per sé evidente: come già aveva messo in luce Aristotele, la strada che porta alla conoscenza di tali princìpi è l’induzione (ossia il procedere dal particolare all’universale); e, nel nostro caso, l’osservazione delle singole comunità perfette mostra che esse sono fondate su norme e leggi, cosicchè se ne evince che ogni comunità perfetta è fondata su norme e leggi. Il termine “legge” si presta però ad una molteplicità di significati: in primis, “significa un’inclinazione naturale sensitiva verso qualche azione o passione” (“Defensor pacis”, Primo Discorso, cap. X), come quando, ad esempio, diciamo che il corpo segue leggi diverse da quelle della mente. In un secondo significato, legge “indica ogni abito produttivo e in generale ogni forma, esistente nella mente, di cosa producibile, dalla quale […] derivano le forme delle cose prodotte dall’arte”, come quando diciamo che questa data legge è la legge della casa. In un terzo significato, il termine legge “indica la regola che contiene i moniti per gli atti umani comandati secondo che essi siano ordinati alla gloria o alla punizione nel mondo futuro”, come quando si dice (S. Paolo, “Lettera agli Ebrei”, VII,12) “perché è trasformato il sacerdozio, è necessario che si muti anche la legge”. Partendo da queste definizione, Marsilio prova a darne una generale, che tenga conto di esse: “la legge è un discorso o espressione che nasce da una certa prudenza o dall’intendimento politico; ossia, un’ordinanza fatta dalla prudenza politica intorno alle cose giuste o vantaggiose ed al loro opposto, e che ha forza coattiva, e cioè per la cui osservanza viene emanato un comando che si è costretti ad osservare, oppure che è emanata per mezzo di tale comando”. Parlando della legge, Marsilio da Padova introduce una delle sue più importanti innovazioni concettuali: nella tradizione del pensiero politico e giuridico, confluita nel diritto romano e poi in età medioevale nel diritto canonico, concetto cardine era quello di legge naturale, ricondotta ad un’origine divina. Marsilio, invece, definisce legge un “precetto coattivo” legato ad una punizione o a una ricompensa da attribuire in questa terra, ossia ad una sanzione. Connettendo il concetto di legge a quello di sanzione e alla sua applicabilità immediata, Marsilio restringe la nozione di legge al solo ambito umano, escludendo quello divino (caso più unico che raro in età medievale). Infatti, la legge divina è anch’essa sanzionata, ma dà premi e castighi non in questa vita, bensì fuori del tempo, in una vita ultraterrena. Una legge è tale in quanto una volontà la emana e ha il potere di farla rispettare, comminando pene nel caso in cui tale legge venga infranta. Il compito di istituire le leggi – considerate dalla ragione umana giuste e utili per la comunità – spetta al popolo, cioè all’intero corpo dei cittadini o alla sua parte prevalente (“pars valentior” dice Marsilio). Tale prevalenza può essere intesa in senso quantitativo, ma specialmente qualitativo: si tratta cioè dei detentori delle qualità migliori. Pertanto, la fonte del potere è il popolo, che può decidere di affidare il compito di governare ad un principe dotato della forza capace di garantire la pace (cioè un principe che sia “defensor pacis”), fondata sul rispetto delle leggi. La miglior forma di governo è quella fondata sull’elezione: al di fuori di tale sfera non esiste alcun potere legittimo, autorizzato a ricorrere alla forza. La funzione della Chiesa e dei sacerdoti è meramente spirituale e consiste nel “conoscere e insegnare ciò che si deve credere, fare o evitare per ottenere la salute esterna”. In casi di contrasti su queste materie di fede, l’autorità suprema è – secondo Marsilio – non il papa, ma il Concilio, il quale rappresenta la comunità dei cristiani. La funzione spirituale non legittima alcun conferimento alla Chiesa e al papa di potere coattivo: essi non potranno comminare pene temporali e scomuniche. Quindi risulta destituita di ogni fondamento la pretesa papale di esercitare il suo potere sull’imperatore e sui governanti. Tale pretesa non può che generare una forma di conflitto – sconosciuta ad Aristotele – tra Chiesa e potere civile, la quale sconvolge e turba pericolosamente la pace, che è e resta l’obiettivo a cui mira la filosofia marsiliana. In realtà, in quanto membri della comunità civile, anche i membri del clero devono essere sottoposti alle leggi civili, né più né meno dei laici: non fa specie che le tesi di Marsilio – che aprono ragguardevoli spiragli verso una prospettiva laica – vennero vigorosamente condannate dalla Chiesa nel 1327.
LA DIFESA DELLO STATO LAICO
E occorre riferirsi qui sùbito, con evidenza, a quello che forse è l’esempio massimo di moderna laicità, nella cultura trecentesca, l’opera di Marsilio da Padova “Defensor pacis”, dedicata all’imperatore Lodovico, che sopravanzava molto quella politica di frate Guglielmo d’Ockam. Il laico Marsilio, averroista italiano, ghibellino, medico e giurista, maestro delle arti e temporaneo rettore dell’università di Parigi, era espressione della civiltà comunale italiana. La sua avversione all’imperialismo papale, catastrofico per l’unità e la pace in Italia, originava – come l’ostilità dantesca – dalla situazione storica italiana. Da qui il titolo “Defensor pacis”, che esprime la preoccupazione politica dominante dell’autore, confermata dall’indicazione tematica dell’esordio dell’opera: la “tranquillità” civile nella città e nello stato. Altrettanto dichiarata dall‘inizio è l’ispirazione diretta alla Politica aristotelica, per cui probabilmente valse la collaborazione all’opera di Jean de Jaudun, maggiore averroista francese. E’ assai strana seppure non insolita la disparità rispetto all’opinione corrente degli studiosi, che si riscontra nel vol.IV e aggiunto dei fratelli Carlyle, così inutilmente insistenti nel negare alle tesi del Defensor pacis un carattere di modernità “rivoluzionaria”, che l’autore non presumeva e nessuno credo gli abbia attribuito. I Carlyle si riferivano in retrospettiva ai notevoli e pure contraddittori aspetti di secolarizzazione desacralizzante, che affioravano nelle discussioni dei giureconsulti franco-inglesi, a difesa dell’autonomia dell’imperium, col ritorno alle fonti del diritto romano. E citavano quell’Egidio Colonna (Romano) autore fra i secoli XIII-XIV delle citate opere come il “De regimine principum” e il “De ecclesiae potestate”, sbilanciate verso il sovra-potere pontificio. Ma più in particolare citavano il “De legibus” dell’inglese Bracton, per la sua valorizzazione della priorità della legge, fondata non solo sulla volontà del principe, coadiuvato dai suoi maggiorenti, ma pure sull’approvazione della comunità, il populus fonte nominale del diritto romano (vol.III, pp.56ss., 89ss.). E’ superfluo dire che gli essenziali aspetti di novità “laica” e “democratica” erano ricondotti (sempre dai Carlyle) allo studio bolognese di giurisprudenza romana, rifondato da Irnerio nell’XI secolo, cioè ai princìpi del diritto romano, che erano espressione eminentissima di benaltra civiltà politica da quella anche tardo-medioevale. Ma che addirittura li esibiscano come “princìpi tradizionali” nella teoria e perfino nella prassi medioevale, cioè nella civiltà feudale e teocratica cristiana, è assurdamente mistificatorio e contraddetto dallo sviluppo della loro stessa opera (vol.III, pp.409ss.; vol.IV, pp.11ss., 45ss.). Se si riferissero al tardo affermarsi della civiltà comunale e del sistema rappresentativo, dovrebbe essere precisato ma non lo è e anzi, con tipica astrazione dalla violenza di contrasto degli eventi storici europei, si tende a fare apparire quelle difficili conquiste come espressione “caratteristica” del Medioevo, mentre ne erano conflittualmente l’uscita liberatoria. Il “Defensor pacis” – legato alla premoderna civiltà cittadina dei comuni –, è apparso in ovvio senso relativo così “moderno” anticipatore della società futura, giacché nessuno dei testi coevi appare così radicalmente “secolare” come il Defensor pacis. Quasi in deliberato contrasto, un altro studioso inglese, Harold J.Laski, professore di scienze politiche a Londra, valutava così altamente l’apporto teorico di Marsilio, “l’esponente di gran lunga più brillante della vera controversia con Roma”, da scrivere: “Le concezioni, che queste tesi gigantesche implicano, adombrano quasi ogni punto della moderna filosofia politica. La sostituzione del popolo al sovrano quale vera fonte del potere, l’insistenza sulla tolleranza religiosa, la riduzione del clero da una gerarchia che domina la vita degli uomini a un ministero al servizio dei medesimi, tutto questo, esposto nei minimi particolari, costituisce una profezia così audace da non avere uguali nella storia del pensiero umano” (“Il pensiero politico del tardo medioevo”, in Storia del mondo medievale, vol.VII, pp.892-93).
L. de Lagarde intitolava il vol.II della sua opera Naissance de l’ésprit etique au declin du Moyen-âge (1934): Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l’État laï-que. E’ al contrario al limite dell’insensato l’interpretazione di un altro francese, Marcel Prélot, che in una sua sintesi opinabile di Storia del pensiero politico (1970), scrive che Marsilio avrebbe teorizzato lo “stato totalitario” (p. 161), il cui modello totalitario, strutturale e metodologico, può scorgersi solo nell’autoritarismo poliziesco dei sacri imperi e delle burocrazie ecclesiastiche. E’ invece apprezzabile che pure lo “spiritualista cristiano” F.Battaglia (già autore di un Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medioevo, Le Monnier 1928) abbia riconosciuto che Marsilio svolse un nuovo “principio laico”, spinto “con tutta la coerenza possibile fino a scuotere le basi della visione della vita propria dei secoli di mezzo” (“Il pensiero politico medievale”, in Nuove questioni di storia medioevale, Marzorati 1964, p.523). In tale prospettiva pure un altro storico americano del pensiero politico, George H.Sabine (Storia delle dottrine politiche, 1937, 1949, tr.it. Comunità 1953, p.232), lo definiva “aristotelico averroista”.
Marsilio teorizzava la fondazione “aristotelica” cioè mondana e razionale, civile e laica dello stato, in cui la religione è inserita come cosa estranea, affidata a una classe speciale, il clero pari a ogni altra classe sociale, la cui funzione è di insegnare le “verità” irrazionali, le cose che secondo la Scrittura si devono credere, fare o non fare, per la salvezza oltremondana, e per evitare il male (Defensor pacis, I, VI,8, mia parafrasi breve dalla antologia di A.Sabetti, Liguori 1966, che integra lo studio su Marsilio da Padova, Liguori 1964; la traduzione integrale dell’opera è di C.Vasoli, 2^ UTET, 1975). E’ un rovesciamento poderoso, non solo rispetto all’intero Medioevo, ma alla intera storia del cristianesimo ecclesiale pontificio alleato dell’impero, dalle origini costantiniane. Diceva bene Sabine che tale separazione drastica, fra l’altro anti-tomistica, fra ragione e fede, è “l’antenata diretta dello scetticismo religioso” e, nelle sue conseguenze, si risolve in un “secolarismo anticristiano e antireligioso insieme” (p.236). Di fatto solo con questa opera si ha una sortita concettuale e culturale dal Medioevo cristiano.
Marsilio era perfettamente conscio della “ardua impresa” che si era assunto, dovendo sfidare e contrastare “la persecuzione del potere violento del vescovo romano e dei suoi complici” (II, II 1). Il Defensor pacis fa distinta analogamente dalla legge “divina” la legge umana, quale prodotto esclusivamente umano e “comandamento” della “totalità dei cittadini” (universitas civium), o della sua parte prevalente elettiva o assembleare: questa legge è “civilmente vantaggiosa”, diretta solo al vantaggio comune, in cui consiste la “giustizia civile” (I, XI,1), che quindi ha una sanzione giuridica, coercitiva e penale, solo umana, legislativa e cioè giuridica. Il centro protagonistico dello stato laico di Marsilio è il legislator, “causa prima efficiente della legge”, che s’identifica sempre con l’universalità dei cittadini o con la sua rappresentanza, che istituisce la pars principans governante, il monarca o comunque l’organo che governa, che comanda e decide, avendo potere coercitivo, ma sempre per mandato dei “popoli” (I, XII,3). Non poteva ancora riferirsi al potere legislativo, ma a quello di governo della comunità politica autonoma – come scriveva Sabine –, “secondo un concetto comune alla città-stato” (p.237): io direi in un’ottica democratica comunale, che d’altra parte implica pure il potere di legiferare. In questo senso è superflua perché scontata la discussione di McIllwain su questo cap.XII del trattato, “probabilmente il più interessante e importante di tutto il libro” (pp.371ss.). Ma è lo stesso studioso che, rigettando le interpretazioni troppo modernizzanti, ne riconosce la “modernità” storica (p.377).
Quanto al secondo Discorso di attacco virulento ai privilegi del potere ecclesiastico, si è accennato come la riduzione sia la più estrema del secolo, nella giusta esigenza di applicare i medesimi princìpi politici, enunciati finora per la comunità civile, alla chiesa cattolica concepita anch’essa, come era in origine, unicamente quale comunità, precisamente come civium fidelium universitas, ovvero “popolo cristiano”, che si identifica con la comunità civile. Se la chiesa nel suo costituirsi come regnum, con governo monarchico, esercita nel suo interno i poteri previsti dal suo ordinamento, è indubitabile che la comunità cristiana, e pure la gerarchia ecclesiastica, fatta da e di uomini, essendo una comunità politica sottostà alle leggi, al governo civile, ai suoi obblighi e alle sue sanzioni penali, assorbendo e vanificando così la legislazione canonica. Marsilio anzi civilizza tutto l’apparato ecclesiastico, dai poteri penali (scomuniche ecc.) alle proprietà in concessione, perfino agli obblighi legali delle funzioni religiose, senza parlare del diritto pubblico di destituire ogni autorità ecclesiastica, incluso il papa. Notava Sabine: “L’idea che la filosofia politica difendesse la libertà religiosa è totalmente errata. I despoti nazionali del periodo della Riforma, nella illegalità della loro posizione, raramente giunsero agli estremi che la sua teoria giustificherebbe, e la cui conclusione sarebbe la soggezione assoluta della religione al potere civile” (p.240). La dottrina del “Defensor pacis” era comunque una destituzione globale della pretesa plenitudo potestatis, di ogni potere ecclesiastico che non sia “spirituale”. Una utopia irrealizzabile, come si è constatato nelle compromissioni politiche dei secoli moderni, proprio perché la costituzione gerarchica risponde puramente a esigenze mondane di potere politico, non a esigenze “spirituali” seriamente sostenibili. Sabine scriveva che questo preparava la Riforma futura, ma per me aveva torto, perché la Riforma protestante comunque sembrava muovere da esigenze mistico-religiose, mentre la destituzione di Marsilio lui stesso la caratterizza come tendenziale agnosticismo laico. In questo senso, dopo avere censurato McIllwain, mi piace riportare sue parole conclusive di ampio riconoscimento della sua opera, che una volta tanto ritengo pienamente condivisibili. “Il grande significato del Defensor pacis sta nel fatto che in esso per la prima volta lo stato secolare pretende una uguaglianza pratica che può essere ottenuta soltanto attraverso una superiorità teorica. I papisti estremi avevano trattato per qualche tempo lo stato come un ufficio subordinato della chiesa: il Defensor pacis è il primo libro che rovesci il procedimento e che consideri la chiesa come un ufficio dello stato, in tutte le questioni di interesse terreno. Il Defensor pacis è il primo libro, in tutta la lunga controversia, che neghi al clero qualsiasi autorità coercitiva, spirituale o temporale, diretta o indiretta. Perciò deve essere considerato come una vera pietra miliare, non soltanto nella storia della lotta tra chiesa e stato, ma nello sviluppo complessivo del pensiero politico” (p.387).
Purtroppo questo era un livello e modello dottrinale, quasi estremo e quindi utopico in epoca, sollecitato e motivato dalle controversie politiche anti-ecclesiastiche, che nella realtà si scontrava con la cultura dogmatica dominante, con l’ordine del mondo imposto nella coercizione teo-politica ecclesiale. Nei cui confronti non l’uomo generico, ma l’intellettuale pensante e scrivente, guadagnava a fatica e spesso con incoerenza e fallimento la propria autonomia di mente e di coscienza, la propria autentica “dignità” umana. Con tipica visione storico-erudita Garin, notoriamente benemerito degli studi su Umanesimo e Rinascimento, su cui ha prodotto molti libri, perlopiù raccolte di studi specifici, constatava e a un tempo sollecitava ancora un apprezzamento “positivo” sia del Medioevo che del Rinascimento, superando la contrapposizione ottocentesca (anche di Burckhardt), protratta fino nel 900. E citava Hauser quasi come modulo di giudizio consensuale: “il Medioevo è probabilmente morto per avere realizzato col Rinascimento la maggior parte dei suoi sogni” (cit. in Umanesimo e Rinascimento, op.cit., p.358). Che è una battuta priva di senso, se non si precisa di quale “medioevo” si parla, pure nell’affermazione bilanciata che “le due età si implicano e si escludono reciprocamente” (ivi). Io concordo nel senso dell’impegno di storicizzare ogni età, fuori o dentro le partizioni artificiose ma irrinunciabili di cui si è indotti a abusare. Lo ripeto, Medioevo Umanesimo e Rinascimento non sono che nomi, come gli dèi tutti, personificazioni sfruttate come indispensabili al discorso storico, ma in sé vuote, cioè da riempire di dati di fatto storici. Nel flusso continuo della storia umana, in perpetuo mutamento, è ovvio che si osservino successioni di fenomeni, in evoluzione o involuzione secondo i punti di vista ideo-culturali assunti dallo storico. Il Medioevo millenario è un lungo scenario di eventi economico-politici, di poteri istituzionali auto-conservativi, di interessi in conflitto con altri che vi si oppongono in competizione incessante, con enorme spargimento di sangue; è una storia di protagonisti diversissimi, di fatti culturali in sviluppo, che modificano ogni momento la fisionomia epocale. Nel Medioevo gli imperi si succedono, la sola spettrale permanenza “divina” è quella imperiale benpiù temibile, possessiva e totalitaria della chiesa romana. Ma nello stesso Medioevo lo sviluppo italiano e poi europeo delle città, l’acquisto contrastato e il difficile mantenimento delle autonomie politiche, è una conquista civile e perciò “umanistica” primaria e prioritaria, che cioè precedette di secoli le poche acquisizioni innovative o espressioni eterodosse di inibiti intellettuali organici della chiesa cattolica, o dei “laici” cittadini controllati sempre dal potere ecclesiastico. Pure il nostro sondaggio rapido, che seguirà, lo conferma: poterono molto più, in senso oppositivo “riformatore”, i vari moti ereticali interni (se così può dirsi) alla chiesa, fino al gioachimismo più fantasioso. E’ bene poi ribadire – V.Rossi aveva ragione – che il vero “umanesimo” si formava e si realizzava fuori, col risveglio della vita reale cittadina, con lo sviluppo delle libertà comunali, in cui l’”umanità” dei rapporti inter-individuali e di gruppo si affermava nel vigore dei suoi stessi conflitti, con la formazione e la crescita economico-politica e giuridica di una nuova “borghesia” laica mercantile e professionale. Che si espandeva dalle campagne nelle città, in senso antifeudale e anti-autoritario, quindi anche anti-ecclesiastico (Pirenne, Le città del Medioevo cit., capp.VII-VIII), con lo sviluppo di una libera economia produttiva proto-capitalistica, di scambio monetario ecc. (v. J.Rossiand, in L’uomo medievale cit., pp.168ss.). E’ questo l’autentico “umanesimo” tardo-medioevale, che coincise con la nascita e la diffusione delle lingue “volgari” e delle letterature profane, poesia erotica stilizzata, ma anche la prosa “realistica” delle “croniche” ecc., in cui la “umanità” della vita cittadina è ritratta e testimoniata quasi al vivo.
Che altro “umanesimo” si vuole oltre questo, che non necessitava di modelli classici, di “ritorni” filosofici, ma prorompeva nella vita reale delle città e delle campagne? Mentre i poeti stilnovizzavano le loro immagini femminili, allegoriche o “reali”, mentre gli intellettuali dotti dissertavano come Dante stesso sull’Amore e sulla Filosofia, la “umanità” della vita reale si agitava fuori e intorno travolgente. Dante stesso, umanissima vittima, travagliata e sconfitta, esiliato e quasi mendicante nelle corti italiane, scrive il suo grande e dis-umano “poema sacro”, sovraccarico del mondo reale in cui vive, ma stipato nelle sue costrittive strutture giudiziali. Strutture radicalmente alienanti rispetto alla propria stessa “umanità”, per la visione mito-teologica che riconsacra poeticamente, idealmente, misticamente, remote dalla “umanità” dell’uomo reale. L’”umanesimo cristiano” è infatti, né altro può essere, che una rappresentazione perpetuata dell’”uomo medioevale”. L’umanesimo “uma-nistico” (“rinascimentale”) trae risalto e significato storico, nella misura in cui se ne pone contro o comunque ne esorbita per “laicità” e radicalità culturale. L’Umanesimo insomma non consiste soltanto delle tecniche filologiche degli studia humanitatis, ma più generalmente, globalmente involge la faticosa riemersione della “cultura dell’uomo”, a tutti i livelli socio-economici e antropo-culturali. In questa prospettiva sono da rifiutare arcate storiche indiscriminanti come quella millenaria “europea” proposta da Paul Renucci, che pure era uno storico “laico”, non confessionale, in L’aventure de l’humanisme européen au Moyen-Age (IV-XIV siècle) (Paris 1953), che identificava proprio con “Le sort de la culture classique au cours du moyen-âge”, e nella seguente pretesa “Renaissance médiévale”. Si noti infatti che una “Renaissance” qui Renucci l’attribuiva già a Teodorico (per Boezio e Cassiodoro, funzionari imperiali), e ovviamente ai gloriosi carolingi, sempre nell’ottica di una “cultura antica” in regressione e declino quasi mortale, che tuttavia “rinascerebbe” sempre, pure nei secoli più oscuri. Ma si consideri che anche l’impegno dichiarato di Renucci era giustamente di contrastare se non sottrarre il tardo monopolio italiano dell’Umanesimo e del Rinascimento, suffragato da Burckhardt, opponendogli un fenomeno europeo (sottinteso in prevalenza francese), di “rinascita” umanistica. E ci piace che ne identifichi i valori con la “cultura antica” (classica), e coi suoi ritorni prima rari e sporadici, poi crescenti e più diffusi nella cultura medioevale. Ci piace che qui dica d’intendere per umanesimo “la volontà di afferrare l’intera storia del pensiero e dell’arte per mobilitarla laicisticamente al servizio dell’uomo, considerato il più perfettibile degli esseri e il solo capace d’intendere, d’improntare l’universo” (p.9). Ma quanto si concilia tale prospettiva dell’uomo, che qui s’iden-tifca con la “cultura antica”, e con le pretese “rinascite” medioevali: che cosa “rina-sce” (e in realtà sopravvive, più o meno) nella corte di Teodorico e in quella di Carlomagno? Ma pure in seguito, proprio in quella prospettiva, è sufficiente la ricognizione dei testi classici, magari solo quelli neoplatonici, già acquisiti e cristianizzati da Agostino, a configurare una “rinascita” definibile umanistica, nel senso antropo-culturale anzidetto? Lo abbiamo visto nel nostro non breve percorso teo-filosofico medioevale: in cui la mistificata “continuità” non è alpiù che una continua o discontinua assimilazione trasformante, una “conversione” stravolgente dei valori umanistici classici. Si va dal Platone patristico, allievo di Mosè e nunzio di Cristo, all’ari-stotelismo cattolicizzato nella teologia sistematica del santo Tomaso: è questo l’umanesimo cristiano che può vantare la cultura medioevale europea? Ma finanche il cosiddetto “averroismo latino” di Sigieri e lo stesso pensiero di Averroè, si è visto come trapeli in contesti teologici pursempre istituzionali, e con quali torsioni, correzioni e ritrattazioni, con quali rischi e conseguenze personali. No, una più rigorosa visione “umanistica” è obbligata al rigetto di tali diffuse dilatazioni prospettiche, dettate da interessi politici diversi confessionali e laici, ma di scarso esito significante. La “rinascita medioevale” è un lento processo fatto di limitati e pure minimi episodi, prodotti fra difficoltà enormi, inibizioni e repressioni ecclesiastiche sempre più tracotanti, sicché anche l’humanitas dei nostri maggiori poeti e dotti trecenteschi va limitata ragionevolmente. Ricordo il trittico coevo di volumi editi da “Belles Lettres” (1952-54), nella collana “Les classiques de l’humanisme”, Dante disciple et juge du mond latin dello stesso Renucci; Dante Minerve et Apollon di I.Batard, e Dante humaniste di Renaudet: complessivamente una amplificazione spropositata di 1500 pagine!
Lo storico Renaudet, nelle sue 550 pp. di Dante humaniste, distingueva un primo e un secondo umanismo di Dante: il breve umanesimo “laico” del Convivio, e quello teologico e mistico dilagante della Commedia, caratterizzato sùbito come “umane-simo cristiano”, che consistette nei limiti ampi della cultura classica di Dante. Renaudet si poneva lui stesso preventivamente il problema del preteso humanisme chrétien, riassunto riduttivamente in una éthique de la noblesse humaine, che sarebbe “rivolta insieme allo studio e all’azione”, e riconoscerebbe, esalterebbe “la grandezza del genio umano, la potenza delle sue creazioni, e opporrebbe la sua forza alla “forza bruta della natura inanimata”. L’essenziale sarebbe “lo sforzo dell’individuo per sviluppare in se stesso, mediante una disciplina severa e metodica, tutte le potenzialità umane, per non lasciare nulla di ciò che accresce e magnifica l’essere umano” (p.17). Questa formulazione, che non a caso si appella sùbito dopo al Faust goethiano, è quantomai ambigua appunto nel suo faustismo individualistico e superomistico della grandeur, nella nostra visione storico-umanistica nella più larga accezione etico-civile, non è l’umanesimo storico nemmeno rinascimentale, come vedremo.
E’ di grande rilievo che lo studio diretto, allora filologicamente possibile, dei testi letterari e filosofici greco-romani permettesse di conoscere la originaria humanitas naturalistica classica, perduta nelle mistificate “trascendenze” ecclesiali cattoliche. Renaudet scriveva cautamente che “essi attribuivano ai testi antichi nei quali si esprime il pensiero greco-romano la virtù di rendere gli uomini più umani conoscendosi meglio”. E però ammetteva lui stesso che “l’antichità” indeterminata, ma da intendersi “classica”, considerata globalmente nella sua cultura storico-filosofica, “non aveva mai cessato di operare nel senso e nello spirito dell’umanesimo”. Gli intellettuali rappresentativi del rinascimento italiano ritennero – continuava Renaudet, che assecondiamo per consenso – di riprendere, dopo la lunga interruzione medioevale, l’impegno della conoscenza del mondo e della natura umana, carentissimi nel Medioevo, sul quale era fondata l’antica “educazione dell’uomo e del cittadino”, e da cui sembra si aspettassero – diceva – “la riforma intellettuale e morale della moderna cristianità” (p.18).
Renaudet sosteneva che questo presuppone “un atto di fede nella potenza dello spirito umano, e più ancora un atto di fede nella bontà e virtù della natura umana”, opposta al tetro pessimismo cristiano ecclesiale dell’uomo peccatore, del mondo diabolico, della natura umana corrotta e dannata, che l’ecclesia divina è preposta a “salvare”, delegata dai suoi numi, nel suo ordine “soprannatuale” necessario al suo potere. Il comico è che per tale infame concezione Renaudet rimandi al citato Esprit de la philosophie médiévale di Gilson, storico militante cattolico, e precisamente al capitolo “L’ottimismo cristiano”, ottimismo ecclesiastico s’intende. Qui si leggeva a chiare lettere che “il pessimismo cristiano sarebbe così la negazione stessa dell’uma-nesimo”. Anche i promotori della Riforma, a cominciare dagli anatemi di Lutero, pursempre cristiani, erano ostili all’umanesimo sospetto di “paganesimo”, per la sua fiducia nella potenza della ragione e nella bontà della natura” (Gilson, tr.cit., p.11). E giustamente citava l’infelice contrasto fra Lutero e Erasmo, di cui diremo più ampiamente poi. Sono i temi fondamentali della nostra costruzione, che vediamo pienamente confermati in questa incipiente “età moderna”, la cui cultura nascente, nongià “rinascente”, si produceva in opposizione e possibile cancellazione delle “so-prannature” omicide ecclesiali, strumentali al suo potere mondano. Quanto e come, con quali sofferenze e rischi personali, quegli intellettuali vi riuscivano, è altro discorso da circostanziare in singoli casi, e non mancheremo di farlo. Senonché qui lo storico della Sorbona, il laico Renaudet, tornava a sfoderare il suo mistificante “umanesimo cristiano” che, per una sorta di prodigio metafisico, di arcana coincidentia oppositorum, già dai primi secoli procederebbe insieme dalla cultura antica, avversata e combattuta come “pagana”, ma riscattata dal vangelo: si eleverebbe così “dalla scienza e dalla saggezza greche”, da quella bassura “alla santità degli apostoli”. Come non esserne edificati? Qui è lo storico corrivo a riasserire, capovolgendo quanto detto prima da un punto di vista laico-umanistico, le falsificanti tesi ecclesiastiche cristiane, da Giustino a Ambrogio e Agostino fino a Tommaso, sostenendo che “la chiesa cristiana si mostrò attenta dalle origini a trarre partito da ciò che l’antichità aveva saputo del mondo e dell’uomo”, che quindi “fra la credenza cristiana e la ragione greca si era compiuta una riconciliazione necessaria” (p.21). Nemmeno sfiorata l’ipotesi di una appropriazione per la propria qualificazione culturale e per la “conversione”, per una cristianizzazione che appare stravolgente, pro-prio nella prospettiva umanistica prima riassunta inequivocabilmente. Si moltiplicano qui a conforto le citazioni più incongrue, sempre facendo fede a Gilson, col massimo semplicismo senza controllo, così mettendo insieme Agostino arcinoto “umanista” trinitario della “Città di Dio”, il monaco Alcuino patrono retorizzato della “rinascita carolingia”, e perfino i due irriducibili nemici Bernardo e Abelardo affratellati, i mistici Riccardo e Ugo da san Vittore, la “scuola di Chartres” e il monaco Giovanni di Salisbury. Con indiscriminazione totale, del tutto acriticamente, lo storico sorbonico su tali esempi celebrava un autentico “trionfo dell’umanesimo cristiano” medioevale (p.22), tra una “Rinascenza” e l’altra di quella orrenda storia ecclesiale. Un Renaudet apologista cattolico poteva scrivere qui che santo Tommaso avrebbe costruito, “a fronte dell’averroismo anticristiano e antiumanista, un aristotelismo insieme umanista e cristiano” (p.23). L’altro sostegno sicuro dello storico militante, dopo e con Gilson, era l’abate H.Bremond, per raccoglierne una esaltazione dell’”umanesimo devoto”, che nei secoli XVI-XVII, rappresentato dai mistici della Controriforma, porterà alla sublimazione il già fulgido “umanesimo cristiano”, con l’esaltazione psichiatrica della “grandezza della creatura umana”, di cui abbiamo fornito larghe prove nella ultima parte del vol.III. Così vediamo che su tali basi equivoche, con tale confusione d’idee, lo storico francese fondava senza fondamento il suo monumento oratorio all’opinabile “umanesi-mo di Dante”, così viziato e in certa misura tradito, col classificarlo nella mistifican-te casella bremondiana dell’”umanesimo devoto”: è questo che avrebbe avuto “una magnifica affermazione già, indistintamente nell’opera filosofico-politica di Dante, nel Convivio e nella Monarchia, triunfando infine nella Commedia. Il laico cristiano Renaudet non si accorgeva di dequalificarlo in quanto “umanesimo”, concorrendo alla tradizionale appropriazione clericale, che mostrificava quei valori “umanistici” classici, stravolgendoli nel loro esatto contrario, e peggio nei soliti mistificati ibridi falsamente conciliativi dell’inconciliabile, e solo compromissori o puramente retorici, con cui si decanta l’anti- e pseudo-umanesimo cattolico.
Si pensi che fra gli obbligati riferimenti cattolici di Renaudet c’è perfino un libro italiano di Rocco Montano (che se ne sarà lusingato), allora giovane allievo di Toffanin a Napoli, difensore e ripetitore, dell’umanesimo medioevale culminante nel-l’arci-umanesimo tomistico (Dante e il Rinascimento, guida 1942). Il libro era tutta una rivendicazione polemica, dichiaratamente anti-laicistica e cattolica, della “pro-fonda coscienza religiosa” (s’intende sempre cattolica) degli umanisti italiani, con un attacco alla tradizione laica degli studi da De Sanctis a Cassirer, a Garin e Russo ecc., a cui opponeva quella ortodossa cattolica di de Wulf, Gilson ecc. Così Dante, dopo la “crisi giovanile”, si porrebbe “al centro fra il pensiero medievale e l’ideolo-gia dell’umanesimo, sintesi impareggiabile del rinascimento duecentesco ed anticipazione, insieme, di quello cinquecentesco” (pp.77ss.). Ecco il quadretto scolastico dell’assurdo storico e antistorico, in cui si profilava retoricamente, quasi caricaturata “l’immensa figura di Dante”, col consenso incredibile dello storico cristiano-sor-bonico. Che su questi pilastri critici dieci anni dopo riaffermava, senza riserve critiche, come “dimostrate la legittimità dottrinale e la realtà storica di un umanesimo cristiano”, dal quale si annuncerebbe paradossalmente l’esprit de la Renaissance – si noti – “nel pieno trionfo della scolastica e della mistica”, in perfetta sintonia storico-culturale (p.31). Così risplende l’umanesimo cristiano più devoto!
IL PENSIERO POLITICO
A cura di Roberta Galli
E’ attuale Marsilio da Padova? Ponendosi in maniera semplicistica questo interrogativo, alcuni storici hanno travisato il contenuto dell’opera marsiliana, il “Defensor pacis”; l’hanno cioè estrapolata dal suo contesto storico e, per giustificare assetti politici successivi, ne hanno isolato arbitrariamente alcune tematiche. Per inquadrare correttamente la genesi e il contenuto della dottrina marsiliana, è invece necessario conoscere l’ambiente politico e culturale in cui sorge. Il professor Franco Alessio, per meglio illustrare la situazione del ‘300, è ricorso ad un’efficace metafora: le istituzioni politiche verticalistiche, dure a morire per la loro istintiva e caparbia tendenza alla conservazione, sono state da lui paragonate ad un solido muro, nei cui interstizi si vada lentamente insediando un’erba, la parietaria; quest’ultima rappresenta le nuove forze sociali e politiche che si vanno imponendo per la loro vitalità e dinamicità. Come l’insediamento della parietaria è un tentativo, così l’affermarsi del nuovo è a lungo minacciato dal verticalismo impositivo dell’istituzione tradizionale della Chiesa, che tuttavia inizia a cedere per un processo quasi di autocorrosione. Questa situazione si manifesta in primo luogo sul piano pratico. La “breve Europa” del tempo appare “a macchie”: il vecchio costituito dall’organizzazione sociale tradizionale e dalle tradizionali istituzioni dell’Impero e del Papato, è intervallato da vaste zone in cui si vanno stabilizzando nuove forme di organizzazione sociale e politica. In Francia il potere effettivo del re, congiunto con la volontà del popolo, ha tolto l’autorità e la supremazia agli istituti universalistici dell’impero e della Chiesa. E Padova, importante comune italiano in cui sono vitali i nuovi ceti artigianali e commerciali, ha sostituito anch’essa alla ormai vecchia e malferma tradizione del “potere discendente” una organizzazione politica autonoma, istituendo un governo repubblicano. Marsilio si fa interprete, teorico, di questa innovazione, schierandosi contro il verticalismo della Chiesa, che costituisce ancora, pur se realmente effettivamente indebolito, una minaccia per le organizzazioni politiche secolari. Ed il testo che costituisce buona parte del presupposto dottrinario del “Defensor pacis” e che mai prima d’ora avrebbe potuto essere davvero compreso, date le sue rispondenze con le esigenze che la nuova realtà sociale suscita nella coscienza degli uomini, e la Politica di Aristotele. La Politica aristotelica è un testo che la tradizione, della Schola medioevale impone a Marsilio come una auctoritas, nel quale tuttavia egli coglie quegli elementi che gli permettono di avviare un discorso per la risoluzione delle problematiche del suo tempo. La Politica di Aristotele descriveva scientificamente varie forme di Stato, tutte ugualmente legittime, in contrapposizione al modello unico di stampo platonico. Naturalmente Aristotele non poteva prevedere un sistema politico di tipo verticale quale quello medioevale, nei quale dall’alto di una verità scendesse per gradi intermedi (papa, imperatore ecc.) l’essenza della vita politica nei fatti. Marsilio, che conosce questa realtà, si serve di Aristotele, integrandolo. Dal testo del filosofo greco, Marsilio trae un mito: quello dell’animale, che è alla base della visione organicistica dello Stato. Lo Stato viene da lui concepito come un essere vivente tendente a perseguire i propri interessi e a procurarsi i mezzi per realizzarli, nella prospettiva del “bene essere”, quindi non più schiavo della verità suprema ed assoluta. Lo Stato inoltre è considerato come un tutto, il cui fine ultimo, cioè il raggiungimento dell’autoconservazione e l’equilibrio, precede gli interessi delle singole parti. E’ interessante notare l’analogia tra le tesi politiche marsiliane e gli studi biologici diffusi a Padova: come il linguaggio politico utilizza termini strettamente biologici, così quello biologico si avvale della terminologia propria della politica. Questi linguaggi sono intercambiabili in quanto esprimono entrambi l’esigenza di autonomia del mondo terreno da quello spirituale. Ritornando alla concezione naturale e organicistica dello Stato, per Marsilio l’armonia dello Stato coincide con la giustizia: è proprio in riferimento a ciò che, secondo il professor Alessio, emerge l’attualità di Marsilio. L’idea dello Stato come organismo è cioè estrapolabile dallo scritto marsiliano e dal suo contesto storico; in forma di schema politico, può essere, ed è stata, applicata a società diverse, anche di tipo industriale.
GUGLIELMO DA OCKHAM

Guglielmo di Ockham (o Occam) nacque a Ockham nel Surrey, a poche miglia da Londra, in una data imprecisata fra il 1280 e il 1290. Entrò nell’ordine francescano e studiò e insegnò ad Oxford sino al 1324. In questo periodo scrisse un commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, l’ Expositio aurea super artem veterem, consistente in un commento alle Categorie, al De interpretatione di Aristotele e all’Introduzione di Porfirio alle Categorie e in un trattato De futuris contingentibus “, un Tractatus de sacramento altaris, vari Quodlibeta e commenti alla Fisica di Aristotele . Verso la fine del suo soggiorno a Oxford iniziò anche la Summa totius logicae. Nel 1324 fu citato ad Avignone, dove risiedeva la corte pontificia di Giovanni XXII, per discolparsi di tesi sospette. Una commissione di teologi nel 1326 condannò 51 proposizioni tratte dai suoi scritti. Ad Avignone Ockham entrò in contatto con Michele da Cesena, anch’egli convocato presso la curia nel 1327. Michele era diventato generale dell’ordine francescano nel 1316 e in un primo tempo aveva cercato di conciliare le tendenze opposte entro l’ordine tra spirituali, fautori di un ritorno alla povertà e alla semplicità, e conventuali, sostenitori della necessità di ancorare l’ordine all’organizzazione ecclesiastica e della liceità della proprietà. Nel 1322 il capitolo provinciale francescano di Perugia stabiliva che Cristo e gli Apostoli non avevano posseduto nulla, nè individualmente nè in comune: a tale esempio doveva rifarsi l’ordine. Una serie di bolle pontificie, emanate fra il 1322 e il 1324, dichiarava eretica questa tesi: poco dopo Michele era convocato ad Avignone, ma nel 1328, insieme a Ockham, fuggiva da questa città e si recava a Pisa presso l’imperatore Ludovico il Bavaro. Ockham seguirà l’imperatore in Germania, a Monaco, dove risiederà fino alla morte avvenuta verso il 1349, durante l’epidemia di peste che colpì l’Europa per tutto il ‘300. Nell’ultimo scorcio della sua vita, a partire dal 1330, egli dedicherà tutte le sue energie a scrivere una serie di opere di polemica ecclesiastica e politica, contro Giovanni XXII e in generale contro le pretese di supremazia del potere papale su quello imperiale. Di esse fanno parte l’ Opus nonaginta dierum, scritto in 3 mesi, il Dialogus inter magistrum et discipulum, incompiuto, il De imperatorum et pontificum potestate. Per Ockham l’ordine francescano é una molteplicità di persone, che hanno in comune l’osservanza della regola di Francesco, approvata dai papi, la quale impone la rinuncia alla proprietà. Tale precetto ha la sua fonte nel Vangelo, dove Cristo dice : “se vuoi essere perfetto , vendi quello che possiedi e dallo ai poveri”. Adamo ed Eva avevano ricevuto da Dio la prerogativa di usare le cose temporali a proprio vantaggio, ma dopo il peccato originale era stata istituita dagli uomini la divisione dei beni terreni, considerata dalla retta ragione umana il modo più opportuno di usarli. La proprietà non ha dunque per Ockham un fondamento naturale, ma non é neppure del tutto arbitraria, dal momento che é originata dalla retta ragione. Su questa base Ockham elabora la nozione di quello che sarà poi chiamato diritto soggettivo, consistente nel potere esercitato su uno o più beni e attribuito a un individuo da una legge stabilita. Lo Stato é istituito allo scopo di consentire e salvaguardare una vita pacifica e ordinata e, quindi, anche l’esercizio di tali diritti, e ha potere legittimo quando esso é accettato dai cittadini. Ciò non significa che Ockham riconosca una sovranità popolare assoluta. Rispetto al potere civile si distingue la Chiesa, che non é altro che la moltitudine di tutti i fedeli dai tempi dei profeti e degli apostoli sino ad oggi. Nel corso dei tempi essa ha riconosciuto e sancito le verità che debbono essere credute per fede: in essa pertanto risiede l’infallibilità in materia religiosa, e non nel papa e neppure nel Concilio, secondo Ockham. Egli ammette la necessità di qualche interferenza fra le due sfere del potere civile e della Chiesa. In particolare, rientra nei compiti dell’imperatore difendere la Chiesa, reprimendo le eresie, anche quelle compiute eventualmente da un papa. Ma in generale Ockham confuta, anche con argomenti di tipo storico, la tesi che il papa abbia ricevuto da Cristo la pienezza del potere anche nelle cose temporali. L’impero infatti esisteva a Roma già prima di Cristo e da Roma era passato a Carlo Magno e poi ai suoi successori. Cristo stesso aveva detto: “date a Cesare ciò che é di Cesare”, riconoscendo in tal modo l’autonomia del potere civile. Da ciò scaturisce l’indipendenza del potere imperiale, che per essere legittimato non ha bisogno di ricevere l’investitura papale. Ma le accuse di Ockham sono anche esplicitamente dirette alla figura stessa del papa: Nel Dialogus, uno dei suoi trattati antipapali per eccellenza, sostiene che il papa non sia la Chiesa, che il papa non sia regula fidei, che al di sopra del papa vi sia il concilio, la Scrittura, l’universale Chiesa invisibile. Tra questi vari motivi addotti a discapito del papato, quello più efficace é senz’altro quello della supremazia del concilio; il problema di fondo di Ockham é quello di smantellare una teocrazia ostile all’impero temporale (che come detto egli sostiene) per la via della contrapposizione della Chiesa al papa o, meglio, del ritorno della Chiesa alla sua primitiva struttura di mera universitas fidelium, di decentrata società di fedeli. Queste tesi, con le quali Ockham interveniva dalla parte di Ludovico il Bavaro contro le pretese del papato, avevano tuttavia minore radicalità di quelle avanzate da Marsilio da Padova. Massima radicalità, invece, era raggiunta da Ockham sul piano delle dottrine logiche e filosofiche, alle quali aveva dedicato le opere scritte nella prima parte della sua vita. Il suo scritto più importante, la Summa totius logicae, segue l’ordine dei trattati logici aristotelici, affrontando in successione il problema dei termini, delle proposizioni e dei ragionamenti o sillogismi. Termine é ciò che entra o può entrare a far parte di una proposizione. Ockham distingue fra termini mentali, orali e scritti. Tutti questi termini designano direttamente le cose, ma quelli orali e scritti sono convenzionali, in quanto possono variare i suoni o le lettere dell’alfabeto con i quali una stessa cosa può essere designata in lingue diverse. Invece, il termine mentale é il segno naturale di una cosa e non ha pertanto alcuna convenzionalità. Le proprietà del termine mentale convengono anche gli altri due tipi di termini, ma non sempre vale l’inverso. I termini si distinguono in categorematici, dotati di significato definito (per esempio il termine “uomo”, che significa tutti i singoli uomini) e sincategorematici , che posseggono significato solo in connessione ai primi. Sono sincategorematici quelli che oggi sono chiamati quantificatori, come “tutto”, “nessuno”, “qualche”, e connettivi proposizionali, come “e”, “o”, “se”, “poichè”, ecc. Questi ultimi termini, infatti, da soli non hanno significato, ma lo assumono in connessione a termini categorematici . Un’ulteriore distinzione é tra termini di prima imposizione, che significano direttamente le cose e non altri termini del linguaggio (orale e scritto) e termini di seconda imposizione, i quali invece designano termini o parti del linguaggio (per esempio i termini “sostantivo” o “coniugazione”). A loro volta i termini di prima imposizione si distinguono in termini di prima intenzione, che designano oggetti esistenti realmente fuori dalla mente, come “uomo”, “cane”, “cavallo” ecc., e i termini di seconda intenzione, i quali designano invece concetti della mente, come “universali”, “specie”, “genere”, e così via. Diversamente dalle parole, che sono suoni convenzionali, i termini mentali o concetti sono segni naturali predicabili di più cose. In questo senso essi sono universali: tale universalità dipende infatti soltanto dal fatto che questi segni possono essere predicati di più cose. Di per sé invece ogni concetto è un’entità individuale: Ockham rifiuta tutte le forme di realismo, che considerano l’universale esistente realmente, anche se solo in potenza, nelle cose stesse. Per descrivere la è posizione di Ockham è stata usata dai moderni l’etichetta di nominalismo, ma occorre avvertire che essa non coincide con il nominalismo di un Roscellino, per il quale gli universali sono solo suoni. Per Ockham gli universali non sono puri suoni, ma segni, e tali segni non sono istituiti arbitrariamente o deliberatamente, ma sono naturali, in quanto sono prodotti nell’anima delle cose stesse di cui essi sono segno. Ciò non significa che i segni siano rappresentazioni o immagini delle cose, ossia che tra i segni e le cose significate esista necessariamente una somiglianza. Se fossero immagini, essi ci farebbero conoscere soltanto ciò che è già noto: così l’immagine di Ercole non fa conoscere Ercole, se già non lo si conosce. Piuttosto l’universale è segno nel modo in cui il fumo è segno del fuoco o il lamento è segno di dolore o di malattia. Esso ha una natura intenzionale, nel senso che “tende verso” (in latino intendit) l’oggetto di cui è segno. Così il termine universale “uomo” è segno non di una presunta entità universale uomo o umanità, bensì di Socrate , Platone e i singoli individui umani. Ciò è reso possibile da una somiglianza che intercorre fra Socrate, Platone ecc. e li distingue, per esempio da un cane o da una pietra. Ma ciò non vuol dire che la somiglianza sia un’ entità dotata di esistenza autonoma, la quale viene ad aggiungersi alle entità singole tra le quali intercorre: la somiglianza tra Socrate e Platone significa soltanto che per esempio, Socrate è bianco e Platone è bianco. Anche i concetti di relazione, quindi, come quello di somiglianza, non sono dotati di esistenza autonoma. Nella dimostrazione dell’inesistenza e inutilità degli universali é operante il principio metodico detto rasoio di Ockham, benchè egli non sia stato il primo a formularlo. Esso é una regola di economia che prescrive di non introdurre nelle spiegazioni delle cose più entità di quante siano necessarie e quindi di non trasformare parole o concetti in cose realmente esistenti. Varie sono le formulazioni di esso: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora o pluralitas non est ponenda sine necessitate o ancora entia non sunt multiplicanda sine necessitate. In ogni caso si tratta di non introdurre principi esplicativi più numerosi di quanto sia necessario. Una sua conseguenza é che, non esistendo universale, viene meno il problema dell’individuazione: infatti, tutti gli enti esistenti sono individuali e ciò non richiede ulteriori spiegazioni. Un termine singolo, in quanto segno di una cosa, ha significatio, la quale si distingue dalla suppositio. Già prima di Ockham i logici avevano identificato la suppositio con la proprietà dei termini, all’interno di una proposizione , di stare al posto di qualcosa, in veste di soggetto o predicato. Il termine latino suppositio deriva appunto da supponere, stare al posto di qualcosa . Ockham distingue vari tipi di suppositio : 1) personale, quando il termine sta soltanto per il suo significato proprio , ossia significa solamente una realtà individuale , come nella proposizione “l’ uomo corre” , dove “l’uomo” può significare solo individui reali (Socrate, Platone, ecc), gli unici in grado di correre ; 2) semplice, quando il termine sta al posto di un concetto che non é il segno naturale di quel termine, come nella proposizione “l’uomo é una specie” , dove “uomo” non sta per individui singoli (ossia per il suo significato vero e proprio), ma per un concetto mentale (quello di specie); 3) materiale, quando il termine sta al posto non di un concetto o termine mentale, ma di un termine scritto o orale, come nella proposizione “uomo é un nome di 4 lettere” , dove “uomo” sta al posto del termine scritto “uomo”. Sulla base della teoria della suppositio é possibile affrontare il problema della verità o falsità delle proposizioni. Intanto, Ockham precisa che la verità non é una entità dotata di esistenza indipendente dalla proposizione: la verità di una proposizione coincide con la proposizione vera; e così é per la falsità. Ma esistono due tipi di proposizione: le proposizioni categoriche sono formate da soggetto , copula e predicato ( per esempio “Socrate é un uomo”) . Nelle proposizioni modali la relazione tra soggetto e predicato é qualificata mediante operatori quali “necessariamente” o introdotta da espressioni come “é necessario che” , “é possibile che” ecc. Esistono poi proposizioni composte da due o più proposizioni collegate da quelle che oggi sono chiamati connettivi proposizionali : “se p, allora q”, “p e q”, “p o q”, ecc . Questo tipo di proposizioni era già stato studiato dagli stoici. Ockham ne studia le condizioni di verità o falsità . La proposizione categorica singolare “Socrate é un uomo” é vera non perchè Socrate possiede l’umanità o l’umanità é in Socrate o appartiene alla sua essenza; essa significa soltanto che Socrate é veramente uomo, ossia che c’é una cosa al posto della quale sta il predicato uomo: tanto il soggetto quanto il predicato stanno (supponunt) per la stessa cosa. Così la congiunzione di due proposizioni é vera , quando sono entrambe vere le proposizioni; la disgiunzione se é vera una delle due; il condizionale (“se p, allora q”) é vero in tutti i casi, tranne quello in cui l’antecedente p é vera e la conseguente q é falsa. In tal modo, Ockham individua condizioni puramente formali della verità logica delle proposizioni, a prescindere dal contenuto delle proposizioni stesse. Il sillogismo é un ragionamento costituito da più proposizioni e precisamente da premesse dalle quali si deduce una conclusione. Le premesse possono anche essere solo probabili, non di per sè evidenti. In tal caso non si ha un sillogismo dimostrativo vero e proprio , che procede invece da premesse necessarie ed evidenti. Come già aveva mostrato Aristotele, il sillogismo scientifico per eccellenza é quello di prima figura: esso si fonda sul presupposto che ciò che vale per un individua si predica di tutti gli altri individui simili ad esso (dictum de omni) e, viceversa, ciò che non vale per uno non vale per nessuno (dictum de nullo). Si può pertanto applicare la seguente regola di trasformazione: la proposizione “ogni uomo é un animale” equivale a “quest’uomo é un animale”, “quest’ altro uomo é un animale” e così via. Ciò consente di eliminare il termine sincategorematico (in linguaggio moderno: quantificatore universale) “ogni” e di ottenere proposizioni che contengono soltanto termini categorematici. In tal modo, una proposizione universale affermativa o negativa é interpretata come una proposizione che afferma o nega un fatto singolo rispetto a cose individuali, senza introdurre presunte entità universali. Se la verità delle proposizioni dipende da oggetti particolari, tale verità non può più essere universale e necessaria. Ockham distingue, come già Duns Scoto, tra conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva . Conoscenza intuitiva é quella in base a cui sappiamo se una cosa esiste o no. Essa dà luogo all’enunciazione di proposizioni contingenti ed é propria dei sensi, dai quali scaturisce la conoscenza dei termini indicanti cose individuali. Ma i sensi da soli non sono sufficienti per arrivare alla formulazione di proposizioni, consistenti nella connessione di tali termini. A costituire la conoscenza intuitiva é dunque essenziale l’intelletto, che può formulare un giudizio di esistenza sull’oggetto conosciuto. La conoscenza intuitiva riguarda quindi un oggetto nella sua esistenza attuale e pertanto é antecedente alla conoscenza astrattiva. Con questa non si può sapere con evidenza se una cosa contingente esiste o no: essa infatti ha come caratteristica quella di conoscere gli stessi termini conosciuti dalla conoscenza intuitiva, ma prescindendo (ossia astraendo) dall’esistenza o non esistenza degli oggetti a cui tali termini si riferiscono. Si ha qui un primo tipo di conoscenza astrattiva, che ha per oggetto il singolare. Per esempio, io ho conoscenza intuitiva di Socrate in carne ed ossa qui davanti a me; quando Socrate non é più davanti a me, non ne ho più conoscenza intuitiva, ma astrattiva. Accanto a questa esiste una seconda forma di astrazione, quella che astrae dalla singolarità della cosa e, attraverso la ripetizione di questa operazione su oggetti simili, perviene a un concetto che significa una molteplicità di oggetti: tale concetto é un universale. Sul piano naturale si ha conoscenza intuitiva, e quindi poi anche astrattiva, solo di oggetti esistenti. Sul piano naturale occorre invece riconoscere che, per l’onnipotenza di Dio , sia possibile avere intuizione anche di oggetti non esistenti, ma Dio non può far sorgere l’assenso alla proposizione secondo cui un oggetto esiste, se esso non esiste; altrimenti Dio produrrebbe una conoscenza falsa. Contrariamente a quanto pensava Duns Scoto, la distinzione tra conoscenza intuitiva ed astrattiva non deve essere intesa nel senso che l’astrattiva colga gli oggetti, sia presenti, sia assenti, ma in maniera indebolita e più povera. In realtà, entrambe le conoscenze colgono l’oggetto in maniera esaustiva e non é necessario ammettere, come faceva Scoto, l’esistenza di specie intermedie. La differenza é piuttosto che l’astrattiva può esserci anche se la cosa conoscitiva é andata distrutta, mentre ciò non é possibile nel caso della conoscenza intuitiva che richiede necessariamente l’esistenza della cosa. Le uniche proposizioni che la conoscenza astrattiva non può formulare sono pertanto i giudizi di esistenza; ma può formulare qualsiasi altra proposizione concernente cose già conosciute per via intuitiva, anche se queste scompaiono. Ma poichè la conoscenza astrattiva dipende da quella intuitiva e questa consente di conoscere soltanto enti ed eventi individuali e contingenti, la dimostrazione costruita mediante proposizioni ottenute per via astrattiva non potrà condurre alla conoscenza di una struttura necessaria della realtà, fondata su relazioni causali necessarie. L’unico sapere possibile diventa quello fondato sull’esperienza di cose ed eventi individuali . In questo senso la posizione di Ockham é stata identificata con una forma di empirismo. Da essa Ockham trae una serie di conseguenze radicali non solo per quanto riguarda la teologia, ma anche la metafisica e la fisica. Le verità teologiche sono quelle necessarie all’uomo, pellegrino in questa terra, per conseguire la beatitudine eterna. Ma di tali verità l’intelletto umano non può avere conoscenza evidente: l’uomo non può avere in questa vita conoscenza intuitiva di Dio e, dunque, neppure astrattiva. Solo la rivelazione consente di chiarire il significato del termine Dio, solo essa ci rende noti i suoi attributi, come l’onnipotenza o l’infinità. Aristotele e i suoi commentatori arabi non sono arrivati a dimostrare tali attributi; essi sono pertanto indimostrabili. Il Dio a cui si può arrivare per via filosofica non é il Dio cristiano, anche se ciò non significa che siano in contrasto. L’uomo può formulare proposizioni riguardanti Dio e averne un qualche concetto partendo dalle caratteristiche delle cose finite, ma solo in quanto queste possono richiamare alla mente una realtà dissimile da esse. Si tratta allora di prescindere dal modo di essere finito in cui certi attributi, come l’unità, la bontà e così via, sono presenti nelle creature. Ma gli articoli di fede non sono nè principi nè conclusioni di dimostrazioni e neppure di argomentazioni probabili, perchè non appaiono veri a tutti o ai più sapienti, ossia a coloro che si valgono della sola ragione naturale. Se fossero oggetto di dimostrazione , allora la rivelazione sarebbe stata inutile. La conseguenza é che la teologia non può essere scienza: ragione e fede sono distinte e non convergono: tra ragione e fede non c’é alcun rapporto e la loro separazione tra fede e ragione può essere dimostrata in vari modi, ma tuttavia la cosa più interessante da notare é che nel momento in cui esse vengono separate, ciascuna é libera di procedere autonomamente per la sua strada, sicchè Guglielmo di Ockham sul piano religioso sosterrà una tesi fideistica: la fede é fede e non ha nulla a che vedere con la ragione. Si tratta chiaramente di una posizione molto conservatrice, tipicamente francescana: i francescani, infatti , sono portati a rifiutare la ragione “intellettualistica” : a loro non importa come é fatto Dio, ma come si comporta, cosicchè la loro é una fede che punta solo sull’amore per Dio. Però separando fede e ragione, così come la fede, anche la ragione resta autonoma: da un lato é un modo di vedere piuttosto retrogrado, però va detto che comporta anche elementi di modernità: la ragione diventa “pur ” , senza avere più nulla a che fare con la fede. Non a caso si usa definire Guglielmo di Ockham l’ ultimo pensatore medioevale e il primo moderno. Come già per Duns Scoto, la teologia riguarda verità pratiche, conoscenze indispensabili alla salvezza, tratte dalla Sacra Scrittura. Secondo Ockham, tuttavia, é possibile dimostrare l’esistenza di un essere primo, ma il punto di partenza non é dato dalla serie delle cause efficienti. In questo ambito, infatti, non si può dimostrare che é impossibile andare all’infinito, come per esempio da un uomo generato a uno che lo genera e così via. Ciò non comporta che esistano in atto infiniti esseri, perchè una causa efficiente può anche corrompersi e scomparire dopo aver prodotto il suo effetto. E’ invece assurdo andare all’infinito nella serie delle cause conservanti, ossia di quelle in virtù delle quali una cosa conserva il suo essere. Noi infatti vediamo nascere continuamente nuove entità, le quali non sono in grado di conservare da sè l’essere che hanno ricevuto da altro. Perchè ciò avvenga occorre che la causa coesista con il suo effetto , altrimenti tale effetto scomparirebbe; ma se si andasse all’infinito nell’ordine delle cause conservanti, la serie di tali cause e dei loro effetti, proprio in quanto coesistenti, sarebbe infinita in atto, ma la nozione di infinito in atto, come aveva mostrato Aristotele, dà luogo ad assurdità. Occorre allora ammettere l’esistenza di una causa prima nell’ordine delle cause conservanti. Tuttavia, se l’esistenza di una causa prima può essere dimostrata, non possono essere dimostrati gli attributi di essa, per esempio l’unicità, l’onnipotenza, la provvidenza. Di questi si possono dare solo argomentazioni persuasive. La rivelazione ci insegna che Dio é libero rispetto alla creazione. Non c’é nulla che vincoli Dio a creare questo mondo, nel quale vige la legge che tutto ciò che é mosso é mosso da altro. La bontà di questa legge dipende soltanto dal fatto che Dio l’ha voluta a preferenza di tutte le altre possibili. Di fatto Dio ha scelto questo mondo, ma sul piano teorico rimane la potenza assoluta di Dio di fare cose diverse da quelle che di fatto avvengono. E’ questo che rende il mondo contingente. La distinzione in Dio tra una potenza assoluta e una potenza ordinata (ossia rispondente a una legge o a un criterio) non é reale: é la ragione umana a tracciarla per mostrare che il mondo esistente é soltanto uno degli ordini possibili che Dio avrebbe potuto creare. Ma ciò non significa che Dio intervenga arbitrariamente nell’ordine da lui creato. Il riconoscimento dell’onnipotenza divina conduce a importanti conseguenze nell’ambito della fisica e della cosmologia. Esso permette, infatti, di costruire ipotesi teoriche alternative alle immagini dell’universo, allora diffuse. In primo luogo diventa ammissibile, contro la tesi aristotelica dell’unicità del mondo, la possibilità che esista una pluralità di mondi. Un ipotetico altro mondo avrebbe infatti un altro centro rispetto al nostro mondo, contrariamente a quanto pensava Aristotele, non necessariamente un centro unico. Inoltre Dio, nella sua onnipotenza , potrebbe produrre altra materia, la quale per Ockham si identifica con l’estensione . L’ipotesi della possibilità di altri mondi conferma la contingenza del mondo che Dio ha di fatto creato. Alla base della conoscenza di questo mondo vi é l’esperienza , le cui conclusioni hanno validità soltanto all’interno di esso. Proprio in tale ambito trova ampia applicazione il principio di economia noto come il “rasoio” di Ockham. Così per spiegare il comportamento dei corpi celesti e dei corpi sublunari non é necessario ammettere che essi siano costituiti di materie diverse. Non si può dimostrare che i corpi celesti siano sostanze incorruttibili e, quindi, composte di etere, come aveva sostenuto Aristotele: infatti nella sua onnipotenza Dio potrebbe distruggerli. In tal modo Ockham poneva la premessa per unificare la fisica dei corpi celesti e quella dei corpi terrestri. Ma soprattutto Ockham colpisce al cuore i due cardini della scienza aristotelica: le nozioni di sostanza e causa. L’esperienza ci fa conoscere soltanto le cose individuali e le loro qualità. E’ inutile e superfluo introdurre o presupporre l’esistenza, al di sotto di tali qualità, di un presunto sostrato, chiamato sostanza. La nozione di mutamento significa soltanto che una cosa individuale possiede qualcosa che prima non aveva; nè movimento nè tempo hanno una realtà distinta dalle cose che si muovono. Se l’esperienza ci fa conoscere solo le cose individuali, anche quelli che chiamiamo causa ed effetto sono due cose diverse, conosciute con due atti diversi di conoscenza, cosicchè dalla conoscenza di una non si può risalire infallibilmente a quella dell’altra. La relazione di causa e effetto é fondata sulla constatazione empirica di una successione costante tra cose o eventi, ma non é possibile dimostrare che tale relazione abbia un carattere di necessità. Perchè ci sia una causa immediata di un effetto, é sufficiente che, quando é presente una causa, ci sia anche l’effetto e, quando essa non é presente, a parità di tutte le altre condizioni, l’effetto non ci sia. Ma non é detto che sia sempre vero l’inverso: infatti, effetti dello stesso tipo possono derivare da cause diverse. L’esperienza non attesta che il comportamento uniforme e regolare degli enti naturali privi di intelligenza e volontà dipenda da una loro tendenza a realizzare fini, nè esistono proposizioni evidenti a partire dalle quali sia possibile dimostrare l’esistenza di un finalismo nella natura. Così anche quest’altro caposaldo della fisica aristotelica risulta espunto da Ockham. Anche ammettendo l’esistenza di un fine come oggetto di desiderio, ciò non significa che tale fine agisca effettivamente. In conclusione, non é possibile dimostrare con assoluta necessità che tutte le cose hanno una causa efficiente o una causa finale. Anche nella concezione dell’anima sono avvertibili gli effetti del principio metodico di economia. Ockham ritiene che intelletto e volontà non siano entità realmente distinte dall’anima. Realmente distinti sono gli atti di intellezione o di volizione, ma ciò non implica una distinzione reale tra le facoltà che li originano. Tali facoltà differiscono tra loro soltanto di nome: ciò che opera é sempre e soltanto l’anima, in quanto capace di intendere e di volere. Puramente verbale é anche la distinzione tra intelletto agente e intelletto possibile. Dal momento che non esistono specie intelligibili intermedie tra le cose individuali e il soggetto che le conosce, per spiegare la formazione dei concetti non é più necessario ammettere l’esistenza di un intelletto agente capace di portare all’atto l’universale presente potenzialmente nelle cose. Nelle cose, infatti, come si é visto, non esistono universali, neppure in potenza. L’anima in quanto volontà non é determinata dall’intelletto, essa é libera non solo di scegliere tra due contrari, ma anche di autodeterminarsi, ossia di volere o no una cosa. L’esistenza della libertà non é dimostrabile, ma l’esperienza attesta ad ognuno che la volontà può rifiutare ciò che la ragione gli comanda. La libertà non é altro che la stessa volontà umana in quanto capace di produrre effetti contrari. L’esperienza ci mostra che esistono uomini che non tendono a un bene infinito e alla felicità, ritenendoli irraggiungibili: ciò significa che non si può dimostrare nè che la tendenza a un bene infinito é costitutiva della natura umana, nè il contrario. E’ possibile tuttavia che Dio, se vuole, si ponga come fine delle creature. Proprio questo ci fa conoscere la rivelazione: sulla sua base si costituisce la morale teologica. Un atto morale é tale, in primo luogo, se é orientato verso il fine, cioè verso Dio, e si configura come amore di Dio. E’ Dio a stabilire ciò che é bene e ciò che é male: nessuno dei 10 comandamenti é valido di per sè, se si prescinde dal comando di Dio stesso. La regola fondamentale consisterà allora nell’agire in conformità al volere di Dio. Per essere moralmente buono, tale agire deve essere libero e non il risultato di una costrizione, neppure da parte di Dio. Con la retta ragione l’uomo decide la conformità dei singoli atti al comando di Dio e in relazione alle circostanze, mentre il destino ultraterreno degli uomini dipende soltanto da Dio: é Dio a concedere liberamente la sua grazia a chi vuole salvare e nulla esclude che egli possa concederla anche a chi vive soltanto secondo la sua retta ragione. Ma se é così, perde ogni centralità la funzione mediatrice della Chiesa nell’economia della salvezza.
Ricapitolando: Ockham é francescano e il francescanesimo é un ordine più mistico che non intellettuale: scarso é l’interesse per la speculazione teologica, forte é invece l’amore per Dio e la mistica. Chiaramente questa concezione ha portato i francescani ad una diversa idea dell’onnipotenza: i domenicani, nella loro visione intellettuale, identificavano di fatto il mondo delle idee con la seconda persona della Trinità, la Sapienza: l’esistenza del mondo per loro dipende dall’essenza divina, l’essenza del mondo dipende invece dalla sapienza divina. Per loro l’onnipotenza era limitata: Dio non può scegliere qualsiasi cosa: io so che 2 + 2 = 4 , per Dio 2 + 2 = 4 perchè lo pensa lui: ma non é che decida che sia così, é limitato dal suo pensiero stesso. Per i francescani, invece, Dio ha onnipotenza totale: tutto dipende da Dio, sia l’essenza sia l’esistenza del mondo; tra quelli che la pensano così vi é appunto Ockham: per loro ciò che é santo lo é perchè piace a Dio; Ockham diceva, riprendendo il primo comandamento che dice di amare Dio, “se Dio avesse decretato che fosse meritevole odiare Dio, allora sarebbe giusto odiarlo” : questa é la cosiddetta prospettiva voluntarista : Dio ha stabilito ogni cosa: se avesse stabilito che 2 + 2 = 5, allora sarebbe così. Dio può scegliere ciò che vuole, é talmente onnipotente da poter cambiare l’essenza delle cose. Questo discorso si riconnette anche con il radicale nominalismo di Ockham: la volontà di Dio é addirittura più potente dell’intelletto: in Ockham si trovano 3 posizioni che in qualche modo si riconnettono tra loro: a) nominalismo , ossia il negare l’esistenza degli universali; b) separatismo, ossia l’inconciliabilità tra fede e ragione; c) voluntarismo, ossia la prospettiva secondo la quale Dio può tutto e ha stabilito tutto secondo il suo volere. Per quel che riguarda gli universali Ockham nega totalmente la loro esistenza: non esistono nè in re, nè post rem, nè ante rem: per lui gli universali sono una inutile moltiplicazione della realtà: questo é un problema già affrontato da Platone nel Parmenide ed era una delle accuse mossegli da Aristotele: tuttavia anche le idee in re di Aristotele sono per Ockham una inutile moltiplicazione della realtà: per Ockham bisogna evitare tutto ciò che é inutile e questa idea é sintetizzata nel cosiddetto e già citato “rasoio di Ockham”, così chiamato perchè con esso si cerca di tagliare via il superfluo: quando si può spiegare una cosa con poco, perchè dilungarsi? Nel Medioevo, poi, ogni minima cosa la si attribuiva ai diavoli o agli angeli, a seconda che fosse positiva o negativa. Chiaramente il “rasoio” Ockham lo applica pure agli universali: se posso spiegare qualcosa con pochi elementi, perchè introdurne di superflui? Ma come si può fare a meno degli universali per spiegare la realtà? Pare assai difficile, ma Ockham ci prova, grazie all’ introduzione di due concetti: 1) intentio e 2) suppositio. La intentio é la caratteristica propria dei segni di possedere un significato: gli universali non ci sono, ci sono solo realtà individuali: la parola “uomo” é una realtà individuale, che, scritta, altro non é che un insieme di macchie di inchiostro e si riferisce alla parola detta: se la si legge suona nell’aria “uomo”: é una realtà individuale che vibra nell’aria e si riferisce ad un concetto, quello di uomo che io ho nella testa: non é un universale, però si riferisce agli uomini: il concetto uomo, di per sè individuale, si può riferire a più persone: non esistono universali, ma funzioni universali con la caratteristica di potersi riferire e tendere ad altre: la parola scritta “uomo” non si riferisce all’idea di uomo (che non esiste), ma alla parola vibrante nell’aria: dopodichè la parola vibrante nell’aria si riferisce a tanti uomini contemporaneamente: ma tuttavia non é un universale. Ma come possono esistere le funzioni universali se gli universali non esistono? Infatti si passa da una macchia di inchiostro ad una parola e poi a più cose: come fanno a richiamarsi tra loro? C’é la suppositio (dal latino subpono = metto al posto di): i segni sono ciò che può stare al posto di qualcosa d’altro; dire “Socrate é uomo” per Platone e Aristotele significava che Socrate partecipava dell’idea di uomo per l’ uno , e che la forma uomo era in lui per l’ altro : una cosa individuale partecipava di una cosa universale. Per Ockham vuol dire che la parola “Socrate” sta al posto di quella particolare cosa che é Socrate in carne e ossa : parlando o scrivendo sostituiamo le realtà di cui parliamo con parole o macchie di inchiostro. Anche per la parola “uomo” é lo stesso: la si usa per sostituire gli uomini in carne e ossa, ossia Socrate più altri: ciò significa semplicemente che esiste una cosa per la quale possono ugualmente stare sia la parola “Socrate” sia la parola “uomo”; alcune cose stanno al posto di altre quando sono un segno o naturale o artificiale di quelle cose; si parla di segni artificiali quando, ad esempio, vediamo un cavallo ed esso ci lascia un “segno” nella nostra testa e questo segno non sarà solo più segno di quel determinato cavallo (segno naturale) , ma anche di tutte le cose simili (gli altri cavalli). E’ una questione sia logica (in quanto si occupa del significato) sia ontologica (gli universali non esistono) che porta a delle conseguenze: dire che esistono solo i casi particolari significa di fatto far venir meno la distinzione essenza-esistenza; l’idea generale del Medioevo era che nella mente di Dio vi fosse ab aeterno l’apparato ideale e che Dio ad un certo momento decidesse di creare il mondo con queste idee insite nella sua mente: era sì Dio a decidere se creare o meno il mondo, ma tuttavia non poteva decidere se pensarlo o meno: l’apparato ideale nella sua mente lo vincolava (Dio può tutto, ma non può non essere Dio); per Ockham, invece gli universali (o idee che dir si voglia) non esistono e quindi Dio non ha l’apparato ideale nella sua mente che lo vincola: creando il mondo, crea essenza ed esistenza: non é che crei Adamo seguendo l’idea di uomo (che per Ockham non esiste): Dio crea dal nulla Adamo e gli dà simultaneamente esistenza ed essenza. Il nominalismo si lega radicalmente al volontarismo: implica una onnipotenza totale, dove Dio non é vincolato neanche più dall’apparato ideale della sua mente e può davvero tutto: tutto dipende esclusivamente dalla sua volontà. E’ vero che in natura ci sono delle forme di regolarità (le leggi fisiche); queste leggi potrebbero essere pensate come essenze della realtà e si potrebbe dire che non é Dio a decidere che vadano così : per esempio , ogni corpo tende a cadere verso il basso , e quindi anche una penna cadrà verso il basso. Ockham era pienamente cosciente di ciò ma tuttavia arrivava a dire: “é vero che ogni corpo cade verso il basso , ma se Dio volesse non sarebbe così” : Dio può cambiare le regole a suo piacimento perchè non ha vincoli; quella che noi chiamiamo “regolarità naturale” non é però tale perchè presente nella mente di Dio come idea , ossia come essenza di Dio. Ockham arriverà a distinguere il modo di operare divino in potentia absoluta e potentia ordinata: Ockham é consapevole che esistano forme di regolarità in natura, ma é convinto che il fatto che esistano non comporti che esse debbano per forza esistere: se Dio volesse cambiare le regole del gioco potrebbe farlo a suo piacimento: potrebbe benissimo non far cadere in basso gli oggetti, ma farli cadere obliquamente. In altre parole, se una penna cade a terra é così perchè Dio ha deciso che sia così, che ci sia un ordine: tuttavia non é vincolato da quest’ordine. Quindi é vero che per potenza ordinata ci sono delle leggi fisiche, ma tuttavia per potenza assoluta Dio può stravolgerle (pensiamo ai miracoli). Una concezione simile a quella teologica di Ockham sarà quella politica del 1600, il secolo dell’assolutismo: ci sarà chi dirà che esistono leggi, ma che esistono solo perchè il sovrano l’ha decretato. Nel Medioevo invece, per quel che concerne la politica, il sovrano era vincolato, per esempio, dalla consuetudine. Tutto questo ha una conseguenza ancora più importante che porterà Ockham a concepire la filosofia e la religione come inconciliabili: ciò che é necessario é prevedibile, ciò che é volontario (ossia arbitrario) non é prevedibile: per esempio, l’atteggiamento di un cane affamato davanti al cibo é prevedibile, quello di un uomo no, perchè é dotato di libero arbitrio: può decidere se mangiare o trattenersi, e quindi il suo atteggiamento non sarà prevedibile. Se ammettiamo le essenze (le idee) divine che da Dio non dipendono e che sono necessarie é un conto, ma se dico che esse non ci sono allora sarà impossibile effettuare ragionamenti che seguano le strutture della realtà : prendiamo il caso della dimostrazione geometrica dove i vari passaggi hanno legami tra loro: da una verità A passo ad un’altra verità B, poi a una C e così via: si tratta di collegamenti necessari che non dipendono da Dio. Se però, ad esempio, qualcuno (per esempio Dio o il triangolo stesso) potesse decidere che la somma degli angoli interni di un triangolo vale 37, gradi ossia se dipendesse dalla volontà di qualcuno, allora non avrebbe più senso e sarebbe impossibile effettuare i passaggi dimostrativi. Lo stesso vale per quel che riguarda Dio secondo Ockham: siccome le essenze (le idee) non ci sono, allora non si può ragionare sulle strutture della realtà divina: quindi le complesse catene di ragionamenti di Tommaso sono agli occhi di Ockham assurde e inutili. L’esistenza di Dio é indimostrabile. Finchè ragiono sulle regolarità in natura che dipendono dalla potenza ordinata allora io posso ragionare e risalire le varie “catene” di ragionamenti: verità A poi B e poi C; ma quando entro nel campo delle realtà soprannaturali allora entro nel campo di Dio e non posso ipotizzare di argomentare ragionando perchè non esistono concatenazioni (da una verità A a una B e così via); sostenendo il volontarismo di Dio é come se spezzassi l’ipotetica “scala” delle dimostrazioni che mi permettono di dimostrare con la ragione perchè il rapporto tra Dio e la natura non é più necessario (tra Dio e le idee) , ma é un rapporto volontario (tra Dio e Dio). Se ammetto le idee nella mente di Dio , come Tommaso , posso dimostrare razionalmente l’ esistenza di Dio e posso risalire la ” scala ” delle verità , ma se nego gli universali , come Ockham , allora ciò non é più possibile perchè Dio agisce solo secondo la sua volontà. Nella matematica, ad esempio, i pioli della scala argomentativa sono fortissimi perchè tutto é regolato, ma più c’é arbitrio e meno si possono usare i pioli. Secondo Ockham più ci si avvicina a Dio e più ci si allontana dalla realtà: ammettendo il nominalismo elimino l’essenza e la scala non può più funzionare in ambito divino: così allora Ockham arriva a spezzare la scolastica, che altro non era che tentare di dimostrare le realtà divine con la ragione e con la filosofia. La filosofia diventa indipendente dalla religione: la fede allora si rafforza perchè é la sola che può portare a Dio (se infatti l’esistenza di Dio fosse dimostrabile razionalmente nessuno avrebbe più fede). La fede arriva a darmi la “certezza di cose non viste”, come diceva san Paolo. Ma senz’altro uno degli aspetti più importanti della filosofia di questo pensatore é l’aver, seppur timidamente, aperto la strada verso la infinitezza dell’universo. Da Aristotele in poi era prevalsa l’idea del mondo visto come finito: partendo dalla presunta constatazione dell’esistenza di luoghi naturali, Aristotele proclamava l’esistenza di alto e basso: una penna cade a terra (il suo luogo naturale), una bottiglia piena d’aria sale in aria (il suo luogo naturale): devono quindi esistere alto e basso nell’universo e quindi quest’ultimo deve essere finito (altrimenti alto e basso non ci sarebbero). Ockham continua a condividere l’idea della finitezza dell’universo (egli é un aristotelico), però con la totale onnipotenza attribuita a Dio mette in crisi questa concezione: egli arriva infatti a dire: “il mondo é finito, ma sarebbe infinito se Dio che può tutto l’avesse voluto infinito”. E’ un’affermazione di fondamentale importanza per il futuro della storia del pensiero: la finitezza dell’universo non é più una realtà inconfutabile e non a caso nel Rinascimento Cusano partirà dalle affermazioni di Ockham per aprire ulteriormente la strada (seppur in modo timido e poco convinto) verso l’infinitezza dell’universo , che sarà poi finalmente proclamata apertamente da Giordano Bruno: il mondo per lui sarà infinito perchè effetto di una causa infinita (Dio) .
IL FILOSOFO E LA POLITICA
Il testo Il filosofo e la politica. Otto questioni circa il potere del papa rappresenta un ottimo accesso al dibattito che ha visto contrapposti il Papato e l’Impero nel corso del Medioevo e in particolare nel XIV secolo. Le prime due questioni sono le più serrate, ma anche le più originali dal punto di vista filosofico perché in esse vengono discussi esaurientemente sia i princìpi della concezione ierocratica che le argomentazioni dei fautori della completa indipendenza ed autonomia del potere secolare. Il pregio delle restanti questioni, invece, consiste nel concentrare la riflessione su tematiche ben precise, ma sempre collegate alle concezioni politiche di fondo delle due massime istituzioni medievali. È significativo che, soprattutto nelle prime due questioni, Ockham riporti tre opinioni: due corrispondenti alle parti in contrapposizione e una terza, condivisa dallo stesso Ockham, secondo la quale le competenze del Papato e quelle dell’Impero dovrebbero essere individuate alla luce del messaggio evangelico e della ragione umana.
In merito alla prima questione, Se una stessa persona può detenere il supremo potere spirituale e il supremo potere temporale, quanti appoggiano la terza opinione affermano che sul piano teorico il sommo potere spirituale e il sommo potere temporale potrebbero coesistere nella stessa persona, ma che nella realtà ciò non debba avvenire. Il sommo potere laicale, infatti, è compatibile sia con l’ordine sacerdotale sia con qualunque funzione amministrativa esercitata da chi detiene il sommo potere spirituale. Se così non fosse, l’individuo divenuto sacerdote, vescovo o papa perderebbe ogni potere temporale su ogni cosa o persona. Inoltre, il sacerdote, in qualità di giudice ecclesiastico, può essere chiamato a giudicare anche i colpevoli di reati secolari. Tuttavia, è preferibile che i due poteri coesistano solo occasionalmente nella stessa persona perché colui che esercita il potere spirituale non dovrebbe occuparsi degli affari secolari, la cui competenza spetta piuttosto a chi detiene il supremo potere temporale. Nella seconda questione, Il supremo potere laicale deriva da Dio, si discute se Dio doni direttamente al rappresentante del sommo potere secolare quanto gli appartiene in modo esclusivo, o si serva invece di mediatori. Ora, dalla Sacra Scrittura si evince che Dio ha affidato a tutti gli uomini il dominio sui beni temporali. Spetta, pertanto, alla volontà dei singoli — e non al papa — accordarsi e scegliere un uomo, a cui assegnare il supremo potere secolare. Ma una volta ricevuto il sommo potere temporale, l’imperatore dipende di fatto solo da Dio. Se cosÏ non fosse, ci sarebbe un uomo o una comunità superiore all’imperatore, il che appunto è impossibile. Le motivazioni portate a sostegno di questa opinione minano le fondamenta della dottrina della plenitudo potestatis papae con la quale il Papato rivendicava la supremazia sul potere secolare e, non a caso, la risposta agli argomenti contrari ribatte ogni assunto della concezione ierocratica. Dai capitoli ad essa dedicati, si possono rilevare i seguenti punti fondamentali: 1) il potere secolare era legittimo anche prima dell’avvento del Cristo; 2) l’esame, l’unzione, la consacrazione e l’incoronazione sono cerimonie per sottolineare l’investitura, ma non dimostrano che l’impero derivi dal papa né che egli debba essere confermato dal pontefice; 3) l’imperatore non è vassallo del papa; semmai il papa, in quanto possessore di beni materiali, è vassallo dell’imperatore e deve prestargli giuramento; 4) il papa non può deporre l’imperatore perché tale potere spetta solo al popolo, che lo ha eletto; 5) il papa non può essere giudice supremo delle cause secolari e non può impugnare entrambe le spade.
Come si può dedurre anche dai titoli, la quarta, la quinta, la sesta e la settima questione riprendono i punti elencati; la discussione, tuttavia, non è più incentrata sui princìpi teorici, ma sugli avvenimenti storici. Infatti, nelle quaestiones menzionate il confronto con i difensori della plenitudo potestatis pontificia e con quanti considerano il popolo mediatore tra Dio e l’imperatore riguarda più in particolare la successione degli eventi che dall’impero romano conducono all’incoronazione di Carlo Magno.
Sulla base della precedente definizione di proprietà, inoltre, nell’ottava questione (Elezione e legittima successione. Il ruolo dei Prìncipi Elettori) Ockham dichiara eretico Giovanni XXII per aver affermato nelle sue bolle (nella questione vengono citati passi della Cum inter nonnullos, della Quia quorundam e della Quia vir) che Cristo ebbe delle proprietà terrene e che Pietro e gli altri apostoli del Cristo possedettero beni materiali.
Tanto nella terza quanto nell’ottava questione, infine, Ockham si propone di delineare come dovrebbero configurarsi, rispettivamente, il sommo potere temporale e il sommo potere spirituale all’interno della società. Dal quarto al dodicesimo capitolo della terza questione (La giurisdizione dei prìncipi e il potere spirituale) il filosofo inglese descrive le caratteristiche del principato regio, ritenuto la forma migliore di governo per la comunità dei fedeli. Collocandosi nell’ambito delle discussioni tradizionali sul buon governo, Ockham ricorda che può detenere il principato quell’uomo che si rivolge alla ricerca di ciò che è utile per la comunità e non per sé. In linea con lo spirito francescano, invece, il maestro inglese individua lo scopo della sovranità regia nel garantire ai sudditi dei rapporti umani equi, fondati sull’amicizia, sulla carità e sulla pace evangelica. Le leggi emanate dall’imperatore sono reputate l’unico strumento valido per perseguire un intento così elevato, a patto che esse custodiscano e difendano i diritti naturali degli uomini (che sono inalienabili perché ricevuti per volontà divina al momento della creazione), e puniscano quanti li violano. Rientra nel diritto naturale di ogni uomo e di ogni popolo poter eleggere (l’elezione è preferita da Ockham alla successione ereditaria) la propria guida politica ed è altrettanto legittimo delegare la scelta all’esercito o ai prìncipi elettori. Dopo aver delineato i princìpi cardine del supremo potere secolare, il Venerabilis Inceptor passa a tratteggiare i capisaldi del supremo potere spirituale, che a maggior ragione dovranno ricalcare lo stile di vita del Cristo. In polemica con lo sfarzo della corte di Avignone, nell’ottava questione Ockham, richiamandosi anche al De consideratione ad Eugenium papam di Bernardo di Chiaravalle, si sofferma sulla povertà evangelica e sullo spirito di servizio con cui andrebbero vissute le cariche istituzionali.
Come si vede, il testo propone molteplici spunti di riflessione e di approfondimento intorno alle diverse tematiche del pensiero politico medievale, e risulta utile anche ai non specialisti, grazie soprattutto agli elementi forniti dal curatore per agevolare e guidare la lettura. Il saggio introduttivo, infatti, offre una buona contestualizzazione storico-filosofica delle otto questioni, mentre i titoli redazionali assegnati alle suddivisioni del testo facilitano la consultazione del volume.
NICOLA DI AUTRECOURT

La vita
Come accade nel caso di molti pensatori medievali, i cenni biografici a proposito di Nicola di Autrecourt sono davvero pochi. Ciò che sappiano della sua vita intellettuale deve essere ricostruito utilizzando le date incluse nei pochi documenti in cui egli è menzionato. Uno di questi è un rapporto di un periodo compreso tra il1333 e il 1336, che indica che ricoprì la carica di priore nel Collège de la Sorbonne. Un altro documento importante è la lettere pontificia del 1338, nella quale Benedetto XII lo insignisce della funzione di canonico presso la cattedrale di Metz, riferendosi a lui come un maestro di arti ed un laureato in teologia e diritto civile. Evidentemente, comunque, Autrecourt non rivendicò la sua prebenda fino a dopo il suo processo nel 1347. Sulla base di tali riferimenti, la data di nascita di Autrecourt può essere collocata intorno al 1295-98. Egli era originario di Autrecourt, nella diocesi di Verdun, e fu probabilmente studente presso la facoltà di discipline umanistiche di Parigi. La sua laurea si colloca all’incirca intorno al 1318-20. Mentre era studente, deve aver incontrato insegnanti famosi come John da Jandun, Marsilio da Padova, Thomas Wilton, Walter Burley, Bartolomeo da Bruges o Siger da Courtrai. Dal momento che la sua laurea di secondo grado in discipline umanistiche era in diritto civile invece che canonico, deve ad un certo punto aver lasciato Parigi per circa cinque anni, probabilmente per studiare a Orléans, Avignone o Montpellier. Il fatto che facesse parte del Collège de la Sorbonne come studente di teologia ci fa capire che Autrecourt doveva essere tornato a Parigi negli anni ’30. Il 21 novembre 1340 papa Benedetto XII lo convocò da Parigi ad Avignone per rispondere di accuse di insegnamento non ortodosso. Nella sua lettera il Papa si riferisce a lui come ad un laureato di teologia, intendendo con questo che Autrecourt era in possesso dei requisiti formali per la laurea in teologia, cioè per e la lettura della Bibbia e delle Sentenze di Pietro Lombardo. Ma ciò significa anche che Autrecourt fosse un esperto maestro di teologia? La questione è controversa. Nel giudizio del suo processo, si stabiliva che egli potesse ottenere “l’onore e la laurea di maestro” soltanto in seguito ad un permesso speciale accordato dalla Santa Sede, fatto che sembra implicare che egli non potesse accedere alla iniziazione in teologia (la cerimonia durante la quale sarebbero stati conferiti gli onori magisteriali) fino a che il Papa non decidesse altrimenti. Inoltre non ci sono documenti che presentino riferimenti ad Autrecourt come maestro in teologia. Questo suggerisce che egli rimase un laureato in teologia quando si trasferì a Metz per ricoprire la carica di canonico ( e più tardi di decano) del capitolo della cattedrale. Morì nel 1369, il 16 o il 17 di luglio.
Il processo e la condanna di Autrecourt
Il processo di Autrecourt ebbe inizio nel 1340, quando fu per la prima volta chiamato a comparire di fronte alla corte papale ad Avignone, e durò fino alla sua condanna nel 1346. Un esteso, seppur incompleto, dossier del processo giudiziario presso la corte avignonese è stato conservato sotto la forma di un instrumentum publicum, che serviva come modello per la preparazione del verbale ufficiale del processo. Il fascicolo papale contiene copie di una quantità di documenti che giocarono un ruolo durante le prime sedute del processo, e dà una descrizione (narratio) dei procedimenti giudiziari a partire dal momento in cui il Cardinale Curti, il giudice, assunse l’incarico dell’indagine. Il documento specifica le accuse e riassume i falsi insegnamenti imputati ad Autrecourt sotto forma di quattro liste, in totale contenenti 66 proposizioni o articoli errati. Gli articoli erano tratti dagli scritti e dagli insegnamenti orali. Sulla base del documento, apparirebbe che le commissioni pontificie di papa Clemente VI ed il cardinal Curti utilizzarono prove di precedenti azioni giudiziarie presso l’Università di Parigi e la risposte fornite da Autrecourt per formulare i proprio verdetti. Se questo contesto è corretto, emergono due domande ovvie: perché il processo ad Autrecourt fu trasferito da Parigi ad Avignone, e, ancor prima, come ebbe inizio? Sfortunatamente le prove storiche rimaste non sono sufficienti per rispondere a nessuna delle due domande. La commissione di prelati e teologi, che presieduta dal Cardinal Curti aveva discusso tutti gli articoli imputati ad Autrecourt, giunse alla conclusione che esse contenevano numerose frasi false, pericolose, presuntuose, sospette, errate ed eretiche. Per questa ragione, venne ordinato che gli scritti di Autrecourt fossero bruciati al Pré-aux-Clercs o al Pré-de-Saint-Germain a Parigi in una non specificata data futura. Inoltre Autrecourt fu condannato a ritrattare pubblicamente molti degli articoli specificati nel resoconto legale. Queste ritrattazioni e dichiarazioni, che Autrecourt fu dapprima costretto a rendere nel palazzo del cardinale ad Avignone, dovettero essere ripetute presso l’Università di Parigi. La ritrattazione di Autrecourt presso la corte pontificia avvenne prima del 9 maggio 1346. La data precisa è sconosciuta perché fu lasciata in bianco nella minuta stilata dal notaio Bernard. Oltre alla ritrattazione, Autrecourt fu dichiarato indegno ad ascendere al rango magisteriale della facoltà di teologia. A chiunque ne avesse l’autorità , fu proibito presentare o promuovere Autrecourt nel magisterio della facoltà di teologia. La parte parigina della sentenza fu completata l’anno seguente. Il 20 novembre 1247 i decenti dell’università si incontrarono presso la chiesa di Saint-Mathurin, dove vennero lette le lettere papali ed il processo “riguardanti certi articoli”. Questo materiale era stato portato da Avignone da Autrecourt stesso. Il 25 novembre, egli ritrattò i quattro volte confessati articoli nella chiesa dei Domenicani, e dichiarò pubblicamente che le proposizioni contenute nelle altre due liste erano errate. Inoltre egli bruciò questi articoli ed un saggio, molto probabilmente l’Exigit ordo. La lettura pubblica dell’instrumentum e la ritrattazione avevano uno scopo molto importante: non solo rendevano effettiva la sentenza, ma informavano anche la comunità degli studiosi degli errori di Autrecourt e delle punizioni stabilite nell’instrumentum, nelle quali gli insegnanti sarebbero incorsi se avessero insegnato gli errori censurati. Anni dopo, studiosi come John Buridan, Marsilio da Inghen e André da Neufchâteau citarono le proposizioni erronee condannate come “articoli cardinalis”.
Le opere
L’opera di Autrecourt non è particolarmente vasta: c’è una corrispondenza col teologo francescano Bernardo di Arezzo e con un certo maestro Giles ed un saggio che è stato tramandato come l’Exigit ordo. Inoltre possediamo una questione teologica riguardante l’intensità e la riduzione dei minimi e dei massimi (utrum visio alicuius rei naturalis possit naturali intendi, cioè “può la visione di una qualunque cosa naturale essere naturalmente intensificata?”). Autrecourt scrisse nove lettere a Bernardo di Arezzo, di cui soltanto due sono sopravvissute. Inoltre c’è una lettera dal maestro Giles indirizzata ad Autrecourt, con una breve risposta di quest’ultimo, che, tuttavia, è spezzettata in mezze frasi. Insieme le lettere formano un piccolo fascicolo, il punto principale del quale è la lettera del Maestro Giles. Apparentemente, la sola ragione per cui le due lettere indirizzate a Bernardo furono copiate era perché esse vengono menzionate nella lettera del Maestro Giles. La corrispondenza tra Autrecourt e Bernardo è di molto anteriore: risale infatti al tempo in cui entrambi erano studenti di teologia, impegnati come avversari l’uno nei Principia dell’altro, cioè nella lezione inaugurale sulle Sentenze all’università. Non vi è alcuna prova che Autrecourt abbia mai davvero scritto un commentario sulle Sentenze, che, in ogni caso, non era uno dei requisiti formali necessari per ottenere la laurea. Il tema del dibattito sui Principia e delle lettere indirizzate a Bernardo di Artezzo è la validità del principio aristotelico di non contraddizione, quale risulta dal IV libro della Metafisica. L’Exigit ordo è il frutto dell’insegnamento di Autrecourt all’interno della facoltà umanistica. Invece di esporre i suoi punti di vista in commentari sui testi arsistotelici, Autrecourt scelse di scrivere un trattato autonomo che discuteva questioni riguardanti la filosofia naturale, la metafisica, l’epistemologia, la psicologia filosofica e l’etica e che si impegnava in un dibattito con contemporanei di cui non veniva riportato il nome. L’opera fu portata a termine negli anni 1333-35, periodo in cui Autrecourt stava mettendo a punto il su commentario delle Sentenze. Per ragioni economiche, Autrecourt insegnò all’interno della facoltà di scienze umane mentre era ancora iscritto come studente di teologia. L’Exigit ordo è anche conosciuto come il Tractatus universalis (Trattato universale). L’ultimo titolo in realtà è frutto di una errata lettura delle prime due parole del trattato: “tractatus utilis” (trattato utile). È stato conservato in un’unica copia manoscritta, che, come la lettera di Giles, si spezzetta in frasi interrotte. È diviso in due prologhi, due trattati e numerosi capitoli, che, sfortunatamente, l’amanuense ha disposto nell’ordine sbagliato. Tanto l’edizione latina quanto la traduzione inglese hanno mantenuto l’ordine del manoscritto medievale senza correzioni. La questione teologica è una relazione (reportatio) di una disputa teologica nella quale Autrecourt ricopriva il ruolo di colui che deve rispondere alle obiezioni. Sebbene il maestro che presiedeva la disputa dovesse essere solitamente considerato come il suo vero autore, la questione potrebbe in questo caso essere differente. Dal momento che si tratta di una relazione – cioè un testo che, diversamente da un’ordinatio, non doveva essere edita in un secondo momento dal maestro stesso – probabilmente i punti di vista di Autrecourt sono esposti nella forma originaria, inalterata. La questione venne dibattuta tra il 1336 e il 1339 ed è stata poco studiata dagli studiosi.
Gnoseologia
Un ruolo centrale nell’insegnamento di Autrecourt ha l’idea che tutta la conoscenza evidente (eccezion fatta per la certezza delle fede) deve essere riducibile al primo principio (primum principium), ovvero al principio di non contraddizione. Un’inferenza produce una conoscenza evidente solo quando l’affermazione della sua antecedente e la negazione della sua conseguente sono contraddittorie. Ciò significa che l’antecedente e la conseguente, o più precisamente, ciò che è espresso dall’antecedente e dalla conseguente, deve essere identico, “perché se così non fosse, non sarebbe immediatamente evidente che l’antecedente e l’opposto della conseguente non possono coesistere senza contraddizione”. E’ nel contesto di questa teoria che Autrecourt sferra un attacco sulla nostra pretesa di possedere una conoscenza certa dell’esistenza di sostanze e relazioni causali. Se A e B sono due entità distinte – egli sostiene – uno può con certezza inferire l’esistenza di A da quella di B e viceversa, perché l’affermazione che l’uno è la negazione dell’altro non produce contraddizione. Sulla base di questo principio, non si potrebbe inferire l’esistenza di effetti a partire dalla conoscenza delle loro cause, e nemmeno l’esistenza di sostanze dalla conoscenza dei loro accidenti. Questa visione contraddice la posizione aristotelica, secondo la quale le relazioni causali esistono realmente e si possono conoscere attraverso l’induzione, cosicché l’esistenza delle sostanze si può inferire dagli accidenti sensibili che le ineriscono. La conseguenza della posizione di Autrecourt è che noi non abbiamo esperienza di relazioni causali o di sostanze, e nemmeno la logica è in grado di fornirne una conoscenza certa. Non ci sono motivazioni logiche per supporre che c’è un’evidente relazione tra una causa ed un effetto, o tra una sostanza ed un accidente. La posizione sopra delineata viene sviluppata nella corrispondenza di Autrecourt. Essa ha indotto gli storici della filosofia a caratterizzarlo come il più importante, se non il solo, “autentico” rappresentante dello scetticismo medievale, come “lo Hume medievale”, per usare l’epiteto di Hastings Rashdall. Ad un’analisi più serrata, comunque, emerge che lo scetticismo di Autrecourt è limitato alle pretese razionalistiche circa la verità del nostro attaccamento alla causalità e alla sostanza, concetti di cui non disponiamo di una prova empirica. Autrecourt non è affatto scettico quando si trova nella condizione di dover difendere l’attendibilità della percezione sensibile. Nella sua Lettera a Bernardo, egli attacca quel Bernardo d’Arezzo che aveva sostenuto che l’intelletto non è sicuro né dell’esistenza di quelle cose di cui ha una chiara conoscenza intuitiva, né delle sue stesse azioni. Autrecourt rivela tutte le implicazioni di questa posizione facendo rilevare a Bernardo che “tu non sei certo di quelle cose che si trovano al di fuori di te. E così tu non sai se sei in cielo o in terra, nel fuoco o nell’acqua…Allo stesso modo, non sai che cosa esista nei tuoi immediati paraggi, ad esempio dove se hai una testa, una barba, dei capelli e così via”. Egli conclude affermando che l’affermazione ei Bernardo è anche peggiore di quella degli “Accademici”, ovvero degli antichi scettici. Per Nicola di Autrecourt, la conoscenza intuitiva è alla base del sapere, non già perché concerne cose esistenti, bensì soltanto per la sua maggiore chiarezza rispetto alla conoscenza astrattiva. Però non si può essere certi che ciò che si manifesta nella conoscenza intuitiva debba anche esistere e che ciò che si manifesta come vero sia realmente tale. La conoscenza degli oggetti sensibili e dei nostri atti interni è evidente, ma non v’è garanzia assoluta che ciò che è evidente sia anche necessariamente vero. L’unica cosa che si può sostenere è la sua probabilità. L’intelletto può solamente riconoscere che il contrario di ciò di cui si può essere certi, cioè dell’evidente, non può essere vero. Il criterio razionale dell’evidenza è dunque dato dal principio di non contraddizione, che tuttavia non consente di dimostrare il principio di causalità. Esso, infatti, ci dice soltanto che una stessa cosa non può essere insieme se stessa e il suo contrario, ma non dice che, se c’è una determinata cosa (A), necessariamente ne esiste un’altra (B), che chiamiamo effetto della prima. Anche l’esperienza può solo accertare che ad A segue B e, sulla base delle conoscenze passate, prevedere che sarà così anche in futuro. Ma da ciò non scaturisce che, dato A, ne consegua necessariamente sempre B: questa è una proposizione soltanto probabile, non certa. Similmente – come già mostrava Guglialmo da Ockham (e come mostrerà John Locke), con l’esperienza conosciamo solamente qualità, dalle quali non si può inferire l’esistenza di una sostanza. Ma, stando così le cose, nessuna delle proposizioni della fisica e della metafisica aristotelica può essere considerata come dimostrata.
Metafisica
Alla sfida scettica di Bernardo, Autrecourt replica che l’esperienza sensibile è attendibile, solida. Questo tema comunque non viene ulteriormente sviluppato nelle lettere indirizzate a Bernardo. Per la discussione di tale questione dobbiamo rifarci all’Exigit ordo. In una sezione di questo trattato, che risente della Metafisica di Aristotele (IV, 5), Autrecourt si dedica ad uno dei problemi centrali della metafisica, vale a dire la relazione tra l’apparenza e la realtà. Si rifà alla posizione di Pitagora secondo la quale tutto ciò che è apparente è vero: An omne illud quod apparet sit? (“Tutto ciò che appare esiste?”). Autrecourt difende la tesi che ciò che appare sia e che ciò che appare vero sia vero. Egli trova questa posizione più plausibile che quella opposta, ovvero che l’intelletto non possa raggiungere la certezza. Il suo concetto di apparenza gioca un ruolo chiave nella sua dottrina della conoscenza certa. Esso è utilizzato in senso fenomenico, per descrivere esperienze sensibili. Secondo Autrecourt, l’intelletto è certo di tutto ciò che risulta evidente nell’analisi finale. Questo è il caso di tutto ciò che appare in senso proprio (apparet proprie), cioè di ciò che appare con chiarezza in un atto dei sensi esterni (in actu sensuum exteriorum). Autrecourt identifica le apparenze con gli oggetti dell’esperienza sensibile immediata, che dono considerati evidenti. In questo modo, egli asserisce che la percezione sensibile sia un’attendibile fonte di verità, ovvero che le proprietà apparenti di un oggetto siano le sue effettive proprietà. Ma una percezione sensibile è attendibile? Gli errori percettivi ed i sogni sembrano indicare che le cose non stanno sempre come sembra. Autrecourt considera vari dubbi scettici (dubia), versioni di ciò che in seguito verrà chiamato l’”argomento dell’illusione” e l’”argomento del sogno”. Questi argomenti procedono dall’assunzione del senso comune che le cose spesso appaiono diverse da quelle che sono: ad esempio un cibo dolce può sembrare amaro, un oggetto bianco può sembrare rosso, nel sonno a qualcuno può sembrare di volare o combattere i Saraceni. Come risponde Autrecourt a questi dubbi scettici? Distinguendo tra apparenza e giudizio. Le apparenze sono sempre veritiere: l’esperienza non può essere diversa da quella che è. Comunque, i giudizi tratti dall’esperienza possono essere fallaci, in particolar modo se sono basati su immagini piuttosto che su quanto viene percepito “in piena luce”. In altre parole, Autrecourt nega ogni conflitto delle apparenze. Quelle “non in piena luce” non sono in se stesse percezioni errate perché le esperienze stesse non sono illusorie. Semplicemente esse non riescono a darci le proprietà reali degli oggetti percepiti. Un potenziale conflitto si insinua a livello del giudizio, dove vengono avanzate pretese ontologiche sulla base delle apparenze. Soltanto quelle apparenze che sono “in piena luce” rivelano le autentiche proprietà degli oggetti percepiti e solo esse possono fornire le basi per giudizi che siano veri. Le apparenze degli oggetti che non giungono a colui che percepisce “in piena luce” sono incomplete o contaminate, come se l’osservatore stesse guardando uno specchio. In altre parole, Autrecourt distingue con attenzione tra “x appare F” da “x è F”, perché anche se x non è realmente F, può ancora apparire F e induce qualcuno a credere che X sia F. In tal modo le illusioni e i sogni si trasformano in credenze errate. Soltanto le apparenze chiare (apparentiae clarae) possono essere alla base di giudizi veritieri. Un ultimo argomento sollevato da Autrecourt in questo contesto è il problema del criterio: come si può discernere tra le apparenze che costituiscono e quelle che non costituiscono il fondamento di giudizi veritieri? Come Aristotele, Autrecourt sostiene che le apparenze di ciò che noi percepiamo in condizioni “normali” sono le cause di ragionamenti veri. Sempre in sintonia con Aristotele, asserisce che non esiste una prova ulteriore che il criterio su cui si fonda la distinzione tra giudizi veridici e falsi sia corretta. Entrambi liquidano le preoccupazioni circa la giustificazione del criterio considerandole assurde. Così dice Autrecourt: “si deve accettare come vero ciò anche appare in piena luce. Ora, come si può essere certi riguardo la premessa minore dell’argomentazione? […] Un modo di rispondere a questa domanda sarebbe dire che non vi è alcun modo di provare la conclusione, ma che il concetto di certezza che è presente arriva come una valida conseguenza naturale, e non come una conclusione. Un esempio, tra gli altri, è che bianco e nero sono diversi. Questo concetto della loro differenza non è ottenuto tramite la conclusione”.
Filosofia della natura
Il punto di partenza della fisica di Autrecourt è una tesi che lo persuade più di ciò che trova nella Fisica aristotelica, cioè che tutte le cose sono eterne. Una delle implicazioni di questa tesi è che non vi è alcun processo di generazione o corruzione nell’universo, cosa che sembra entrare in conflitto con il modo in cui le proprietà iniziano e cessano di esistere nei loro soggetti, ad esempio quando qualcosa di bianco diventa nero, così che la bianchezza cessa di esistere. Secondo Autrecourt, nessuna autentica corruzione ha avuto luogo. Semplicemente la forma naturale non è più visibile, dal momento che essa è stata divisa e dispersa nelle sue più piccole unità. In altre parole, egli attribuisce l’apparente generazione e corruzione delle cose al movimento di atomi. Coerentemente con la sua visione atomistica, egli sostiene anche che lo spazio e il tempo consistano in unità indivisibili, ovvero, rispettivamente in punti ed istanti. Questa spiegazione atomistica della generazione e della corruzione rimane vera – egli afferma – se il movimento non è distinto dall’oggetto mobile. Perché se il movimento fosse un’altra cosa distinta, provocherebbe la generazione di qualcosa di nuovo, mentre la quiete costituirebbe la sua corruzione. Visto da questa prospettiva, il movimento locale confuterebbe l’eternità dell’universo. Per questa ragione, Autrecourt reputa necessario esaminare più da vicino lo statuto ontologico del movimento. Egli argomenta che il movimento non è una cosa distinta dall’oggetto che si muove. Sulla scia di Ockham, rifiuta l’idea che il moto sia un qualche cosa di positivo proprio dell’oggetto in movimento. Pertanto, la perdita di movimento non dovrebbe essere descritta come la distruzione o la corruzione di un’entità e l’eternità viene salvata.
Semantica
Nicola di Autrecourt non ha lasciato nessuno scritto di logica, né ha discusso di logica e semantica nell’Exigit ordo o nella sua corrispondenza. Comunque da alcuni dei suoi articoli censurati è chiaro che egli dovesse essere aggiornato sui dibattiti di logica del suo tempo. Stando ad uno dei suoi articoli, Autrecourt affermava che “L’Uomo è un’animale” non è una proposizione necessaria secondo la fede, perché in quel senso non ci si attiene alla connessione necessaria tra i due termini. Questo articolo dovrebbe essere letto sullo sfondo del sofismo “L’uomo è un animale”, che ricevette una considerevole attenzione nel corso dei secoli XIII e XIV. Serviva a rendere chiara la distinzione tra significato (significatio) e riferimento (suppositio) indagando la verifica di proposizioni riguardanti classi vuote. Sarebbe ancora vera la proposizione “L’uomo è un animale” se non esistesse alcun uomo? Cinque altri articoli che vengono portato alla luce nella condanna di Autrecourt riguardano il complesso significabile, o ciò che è significato da un’intera proposizione. Secondo gli aderenti alla dottrina come Adam Wodeham e Gregorio da Rimini, l’oggetto della conoscenza non è la proposizione, o le cose (res) a cui fa riferimento nel mondo esterno, ma “ciò che è significato” dalla proposizione. Uno dei problemi sollevati da questa teoria riguardava lo status ontologico del complesso significabile: è qualcosa (aliquid) oppure nulla (nihil)?
GIOVANNI BURIDANO
Giovanni Buridano , nato verso il 1290 e morto non prima del 1358 , fu maestro e rettore della facoltà delle Arti dell’ università di Parigi ( nel 1328 e 1340 ) . Sulla scia del ” Filosofo ” , ossia di Aristotele , alle cui opere scrisse parecchi commenti , Buridano riconosce il primato all’ esperienza sensibile : la conoscenza concettuale é l’ equivalente di una conoscenza sensibile confusa , nella quale un oggetto vista da lontano rimane indeterminato . E’ la percezione sensibile diretta che consente di precisare di quale oggetto si tratti . Con Ockham Buridano condivide la tesi che le entità esistenti sono individuali : egli é in altri termini un nominalista , ossia nega l’ esistenza degli universali . Sulle entità esistenti , che sono appunto individuali , si possono fare solo affermazioni contingenti , non necessarie , anche perchè ciò sarebbe in contrasto con l’ onnipotenza divina , che può fare le cose diversamente da come sono . Infatti , negando l’ esistenza degli universali , Buridano , sulle orme di Ockham e degli altri nominalisi , toglie a Dio l’ apparato ideale : in altre parole , se si ammettono gli universali ( o idee che dir si voglia ) , allora Dio ne sarà vincolato : avrà insito nella sua mente tutto l’ apparato ideale : il fatto di creare l’ uomo e il mondo dipende da lui , ma il fatto di pensarlo no : é nella sua stessa natura il pensare agli universali e non può farne a meno ( ” Dio può tutto , ma non può non essere Dio ” ) . Ma se essi non ci sono allora Dio può davvero tutto : può perfino stravolgere le leggi fisiche ( vedi i miracoli ) . Quindi per Buridano nulla é necessario e tutto dipende dall’ infinita onnipotenza divina . Su queste basi , poi , Buridano avanza una serie di ipotesi alternative rispetto alla fisica aristotelica , ritenuta indiscutibile e inconfutabile nel Medioevo , per esempio assumendo l’ ipotesi dell’ esistenza del vuoto per indagare quali conseguenze ne derivino . Il suo contributo più noto alla fisica consiste nella sua riformulazione della dottrina dell’ impetus . Per Aristotele il movimento violento di un corpo avviene per contatto tra ciò che muove e ciò che é mosso . Come si spiega allora che un corpo lanciato da qualcosa persiste nella sua traiettoria anche dopo che si é allontanato dal suo motore ? Esaminiamo meglio il punto di vista aristotelico : Se tiriamo una penna per aria , noi sappiamo che per un pò sale in quanto le diamo un impulso che la fa salire per un pò : per Aristotele non è così . Lui è convinto che ogni cosa che si muove è mossa da altre (da una causa efficiente) : non ammette che una cosa tenda a mantenere lo stato in cui viene posta (principio di inerzia) ; Questo vale sia per i moti naturali sia per quelli violenti . Aristotele dice che se lancio in aria una penna essa trascina movimenti circostanti e composti : viene qui messo in gioco l’ambiente : è l’ambiente che secondo Aristotele porta su per un pò la penna . Facciamo qualche osservazione : se Aristotele ammette quest’idea , vuol dire che nega l’esistenza del vuoto : non esiste neanche come vuoto relativo (come era per Democrito ) : se ci fosse il vuoto salirebbe all’infinito . Il principio di inerzia mi dice che se conferisco movimento ad un corpo , esso tende a tenere quel moto all’infinito : questo significa che sia quiete sia moto sono stati : se un oggetto si muove quindi ciò che va spiegato è perchè si fermi : dovrebbe per il principio di inerzia proseguire in quel moto all’infinito . Bisogna quindi spiegare il mutamento di stato (da moto passa ad inerzia) . Per Aristotele invece non va spiegata la quiete ma il movimento , che è una forma di cambiamento : è un passaggio da potenza ad atto : la penna è qui ma potrebbe essere lì ; la sposto ed ecco che è lì . Il mutamento-movimento per Aristotele richiede una causa . Per noi va invece spiegata l’accelerazione , il cambiamento di velocità . Il lancio della penna mi spiega che acquista un movimento teoricamente infinito ; per Aristotele è normalissimo che la penna dopo un pò cada : essa tende al suo luogo naturale : quello che per lui va spiegato è perchè per un pò essa tenda a salire . Per Aristotele la quiete è uno stato , il movimento un mutamento (ed i mutamenti vanno spiegati) . Per noi sono entrambe stati . In altre parole la risposta che Aristotele dà alla domanda : ” come mai un corpo lanciato da qualcosa persiste nella sua traiettoria anche dopo che si é allontanato da ciò che l’ ha mosso ? ” é che ” tale corpo continua ad essere mosso dall’ aria in contatto con esso ” . Secondo Buridano , invece , molte esperienze mostrano che la causa non può essere l’ aria , come nel caso di un moto rotatorio o di una nave spinta in un fiume . La causa della persistenza del movimento risiede piuttosto in un impulso ( in latino impetus ) impresso dal motore al corpo . Tale impulso é proporzionale alla velocità iniziale e al peso del corpo messo in movimento e consente a quest’ ultimo di proseguire nella direzione iniziale e con velocità costante , finchè lo consente la resistenza del mezzo : in questa teoria gli studiosi hanno voluto scorgere un precorrimento del principio di inerzia . Buridano , poi , avanza l’ ipotesi che la dottrina dell’ impetus possa spiegare anche il moto dei corpi celesti : in questo caso l’ impulso iniziale sarebbe impresso da Dio e si conserverebbe in quanto non sarebbe diminuito o distrutto da una forza opposta . In tal modo diventa del tutto inutile l’ ipotesi , passata da Aristotele ai suoi commentatori arabi , dell’ esistenza di intelligenze motrici , talora identificate con gli angeli della tradizione cristiana . Pensiamo anche a quanto diceva Platone nel suo libro fisico , il Timeo : i pianeti per lui erano esseri viventi , vere e proprie divinità . Essi hanno regolarità di moto , dove c’ é moto c’ é vita , dove c’ é regolarità c’ é intelligenza , quindi i pianeti sono vivi e intelligenti ; non a caso i pianeti li chiamiamo ancora oggi con il nome di divinità . A Buridano é attribuito anche l’ esempio dell’ asino , che posto tra due fasci uguali di fieno , rimarrebbe indeciso e morirebbe di fame . L’ esempio non si trova nelle sue opere , ma é ricavabile dalla sua dottrina secondo cui la volontà nelle sue scelte segue necessariamente il giudizio dell’ intelletto . Nel caso in cui si tratta di scegliere tra beni maggiori e minori , non c’ é problema . La difficoltà nasce quando i beni , tra i quali occorre scegliere , sono equivalenti : in tal caso l’ intelletto non fornisce indicazioni , la volontà resta indecisa , la scelta non ha luogo e si fa la fine dell’ asino .
NICOLA D’ORESME

Nicola d’Oresme (1323 – 1382) si laureò in teologia presso l’università di Parigi intorno al 1355. Dal 1377 fu vescovo di Lisieux.Fu cultore di temi scientifici d’avanguardia e strenuo oppositore dell’astrologia. Come Buridano e altri, manifestò atteggiamenti critici nei confronti della filosofia naturale di Aristotele e fu uno dei principali esponenti della teoria dell’impetus sul moto dei proiettili. Lasciò un “Tractatus de latitudinibus formarum” in cui si ha, per la prima volta, il concetto di rappresetazione grafica ottenuta mediante coordinate ortogonali, anticipando di fatto, almeno nelle linee essenziali, la geometria analitica cartesiana. La sua fama è affidata soprattutto alla sua opera di astronomia, matematica e fisica. Nel suo “Livre du ciel et du monde d’Aristote” sostenne la tesi, molto discussa in quegli anni dalla Scuola parigina, del moto rotatorio della Terra, suffragandola con una serie di prove ed argomenti molto simili a quelli successivamente addotti da Copernico e Galileo. Ad esempio, ha una risposta (anche se ancora inadeguata) a quelli che sostenevano che se la Terra ruotasse, tutti gli oggetti non solidali con essa (frecce lanciate, sassi scagliati verso l’alto, ecc.), sarebbero rimasti indietro, sarebbero cioè ricaduti a ovest del punto in cui erano stati lanciati. Oresme conclude dicendo che “. . . con nessuna esperienza si può dimostrare che il cielo si muova di moto diurno. . .”. Sempre nel suo “Livre du ciel et du monde d’Aristote”, Oresme va sostenendo espressamente che il passaggio dal giorno alla notte (e viceversa) è spiegabile anche ammettendo che non sia il sole a ruotare intorno alla terra, ma la terra intorno al proprio asse. Pur senza rigettare la possibilità di un influsso dei corpi celesti sulle vicende terrestri, Oresme prese posizione contro le pretese dell’astrologia di prevedee il futuro sulla base della considerazione dei moti celesti. Egli, inoltre, anticipò Galileo, oltre che per la negazione del geocentrismo, anche per il fatto che, studiando la velocità di caduta dei corpi, propendeva per l’ipotesi che essa fosse proporzionale al tempo di caduta e non agli spazi percorsi. Con Oresme la lingua francese fa la sua comparsa anche nella trattazione di questioni politiche ed economiche: egli scrisse infatti un trattato sulla moneta e tradusse in francese l’ “Etica Nicomachea”, l’ “Economico” e la “Politica” di Aristotele. Oresme , pur occupandosi di Fisica, esercitò un grande influsso sulla cultura matematica del tempo: infatti (a una data imprecisata, ma prima del 1361) ebbe l’idea di tracciare un grafico per studiare la variazione di un fenomeno, cioè ebbe la prima intuizione di ciò che oggi descriviamo come rappresentazione grafica di una funzione. Qualsiasi cosa misurabile -scriveva Oresme- può essere immaginata nella forma di una quantità continua. Ciò gli permise di tracciare un grafico della velocità e del tempo per un moto uniformemente accelerato. I termini latitudine e longitudine usati da Oresme equivalgono, grossomodo, alle nostre ordinata e ascissa e la rappresentazione grafica da lui utilizzata precorre la nostra Geometria analitica. L’uso delle coordinate non era nuovo. Già Apollonio, ed altri prima di lui, avevano utilizzato sistemi di coordinate simili. La novità consiste ora nella rappresentazione grafica di una quantità variabile. Oresme aveva intuito il principio essenziale che una funzione in una incognita può essere rappresentata da una curva ma utilizzò questa intuizione solo nel caso di una funzione lineare. Era soprattutto interessato all’area che si trova sotto la curva. Mentre noi diciamo che il grafico della velocità di un moto uniformemente accelerato è una linea retta, egli scriveva: “qualsiasi qualità uniformemente difforme che termina con intensità zero viene immaginata come un triangolo rettangolo”. Ossia, si interessava sia del modo in cui variava la funzione (e ciò era un primo problema di carattere differenziale) sia del modo in cui variava l’area compresa sotto la curva (problema di carattere integrale). Per trovare questa area, Oresme effettuava una semplice integrazione con mezzi geometrici ed è probabile che concepisse l’area come formata da moltissime linee verticali o “indivisibili”, ciascuna delle quali rappresentava in questo caso dello studio del moto, una velocità che continuava per un brevissimo intervallo di tempo. La rappresentazione grafica delle funzioni, nota come “latitudo formarum”, rimase un argomento molto studiato per tutto il periodo che va da Oresme a Galileo.
ECKHART

BREVE INTRODUZIONE
(Hochheim 1260 circa – Colonia 1328 circa), mistico tedesco e teologo cristiano, noto soprattutto col nome di Meister (maestro) Eckhart. Nato da una famiglia di cavalieri, Eckhart entrò nell’ordine domenicano all’età di quindici anni e proseguì gli studi teologici presso l’ordine. Si laureò in teologia all’università di Parigi nel 1302, e fu dapprima priore a Erfurt e provinciale domenicano di Boemia, poi professore di teologia a Parigi nel 1311, e tra il 1314 e il 1322 insegnò e predicò a Strasburgo e a Colonia. La teologia di Eckhart si basava sul principio dei una unione mistica dell’anima con Dio, tesi che gli procurò accuse di panteismo. Nel 1327 il papa avignonese Giovanni XXII invitò Eckhart a difendersi contro l’accusa di eresia. Eckhart ritrattò 26 articoli o proposizioni (28 secondo la bolla papale di condanna “In agro Domini”, del 1329). Gli studiosi moderni considerano ortodosso il misticismo di Eckhart, sebbene generalmente si ritenga che i sermoni e i brevi trattati pervenutici siano stati curati da amici e nemici di Eckhart. “Istruzioni spirituali”(1300 circa), “Il libro della divina consolazione” (1308 circa) e altri sermoni sono ritenute le opere più attendibili; esse illustrano le tappe percorse dall’anima nel suo itinerario verso Dio. Scrivendo in tedesco oltre che in latino, Eckhart esercitò una profonda influenza sulla crescita della lingua tedesca. Gli idealisti tedeschi lo considerarono un precursore, mentre gli studiosi contemporanei hanno individuato la sua influenza sul protestantesimo e l’esistenzialismo, svelando persino analogie con il buddhismo Zen. Scrisse in latino molte “Questiones”, parte dell'”Opus tripartitum”, il “Tractatus super oratione dominica”, molti commenti scritturali.
VITA E OPERE
Le considerazioni precedenti sono state ritenute necessarie per una corretta comprensione del pensiero di Meister Eckhart, nel quale si sono ravvisati molti elementi per portare a compimento le risposte ai temi presupposti. Eckhart, il cui nome è stato assorbito dall’ alta considerazione in cui era tenuto dai contemporanei complementare alla scarsa conoscenza odierna dall’ appellativo Meister, nacque probabilmente verso il 126O. Alcuni hanno avanzato l’ ipotesi che appartenesse ad una famiglia di ministeriali di cognome Hochheim, che nel tempo aveva assunto, per motivi non noti il cognome Eckhart. Entrò nel convento di Erfurt, prima di aver raggiunto la maggiore età, immergendosi negli studi teologici, nello spirito domenicano a cui apparteneva, tant’è che sembra certo che la sua formazione avvenisse a Colonia, nella rimeditazione dello “Studium generale” del suo ordine, in cui forte era l’ influenza di Alberto Magno, col quale Eickhart probabilmente dovette avere qualche casuale incontro personale. Certo è che nel 1286 Eickhart si trova a Parigi, una delle più prestigiose università della sua epoca, tradizionalmente “aristotelica” e sede di ardite interpretazioni evangeliche e teologiche. Tra il 1293/94 , come baccallaureus commentava in questa sede le “Sentenze” di Pietro Lombardo. Nello stesso hanno venne nominato priore a Erfurt, dove restò fino al 1298 ricoprendo contemporaneamente l’ incarico di vicario per la Turingia in rappresentanza di Teodorico di Freiberg. Si dice che proprio in questo periodo, tenne per i giovani domenicani le Reden der Unterscheidung (Istruzioni spirituali). Nel 1298, avendo il Capitolo del suo Ordine proibito il cumulo delle cariche, dovette rinunciare alla carica di priore. Nel 13O2 gli fu conferita la “licentia docendi” e il titolo di Magister (Meister), titolo col quale resto nella storia del pensiero. L’ incarico era tanto più prestigioso dal momento che lo stesso incarico di “magister sacrae theologiae” era stato di Tommaso d’Aquino, un trentennio prima,entrambi residenti nel convento de Rue St. Jacques. (Alcuni studiosi pensano che è a questo periodo che debba esser fatta risalire la prima stesura delle due “Quaestiones parisienses”). Nel 13O3, nei primi dell’ estate, Eckhart fu nominato provinciale dell’ appena istituita princia della Sassonia, resa autonoma da quella ormai ampia e ingovernabile della Teutonia. L’ambito culturale in cui si muove Eckhart è dominato dalla filosofia scolastica che si può far risalire al pensiero di Giovanni Scoto Eriugena (vissuto probabilmente nell’800) ma che nel tempo in questione è ormai intrisa di aristotelismo. La filosofia scolastica, che avrà vita lunga, trae le sue radici dal Cristianesimo, nasce e si fonde con la teologia e viene diffusa da ecclesiastici preposti a questo compito, gli scolastici appunto. Uno dei temi più dibattuti è il rapporto tra rivelazione religiosa ed ambito scientifico. La forma è la “distinzione” senza fine ed “esteriore” (Hegel) utilizzando concetti metafisici e le categorie di Aristotele. Con Eckhart si assiste alla rinascita delle posizioni neoplatoniche di Proclo, della teologia negativa di Dionigi Areopagita e di Giovanni Scoto Eriugena.
IL PENSIERO
Eckhart sente troppo angusto il concetto di “essere” per applicarsi a Dio e giunge così, per conservare a Dio la libertà da ogni limitata categoria, ad associargli piuttosto il “non-essere”. Più dell’essere/non-essere Eckhart trova adeguato a Dio il concetto di “intelligere”. E se proprio si volesse predicare dell’essere di Dio, la sua pienezza contemplerebbe ogni creatura e la molteplicità non troverebbe più terreno proprio. Ogni particolare sparirebbe in se stesso e si conserverebbe invece solo come predicato di Dio e sua espressione. Tornano immagini tipicamente neoplatoniche: Dio è una sfera infinita che trova il suo centro ovunque e la sua circonferenza in alcuna parte; Dio è fonte di luce da cui emana la molteplicità, e così via. Tutti temi questi che resteranno distanti e incomprensibili ai polemici ed aristotelici scolastici. La metafisica di Eckhart ha il suo corrispondente nella psicologia e nella mistica: l’anima scopre Dio nella radicale negazione di ogni essere e di se stessa, al di là di ogni discorso, in un contatto immediato che si realizza nell’ “apex mentis “, nella scintilla dell’anima: progressiva deificazione possibile in virtù della mediazione del Cristo. Condizione di questo cammino verso Dio è vedere ” tutte le cose e noi stessi come un puro nulla “; suo esito è la rinascita dell’uomo in Dio, o addirittura, come accade ai mistici e santi, l’unione totale con Dio. In questo culmine della fede, in questo ” sprofondare nel punto centrale dell’anima “, l’uomo diventa quasi letteralmente Dio, separato dall’essenza divina solo da ciò: che l’uomo è Dio “per grazia” e Dio è tale “per natura”. Eckhart così si esprime a proposito dell’atteggiamento distaccato e libero da ogni finalismo, che deriva in chi si sprofonda nel fondo dell’anima:
” Da questo fondo più intimo devi compiere tutte le tue opere ‘senza perchè’. In verità io dico: finchè compi le tue opere per il regno dei cieli, o per Dio, o per la tua eterna felicità, cioè per una ragione esteriore, non sei veramente come dovresti essere. Chi cerca Dio secondo un modo, prende il modo e lascia Dio che è nascosto sotto quel modo. Ma chi cerca Dio senza modo, lo prende così com’è in se stesso. Chi domandasse per mille anni alla vita: perchè vivi? , se essa potesse rispondere, direbbe soltanto così: io vivo perchè vivo. Poichè la vita vive del suo proprio fondo e scaturisce dal suo proprio essere. Se qualcuno domandasse a un vero uomo che agisce dal suo proprio fondo: perchè compi queste opere?, egli, se dovesse rispondere rettamente, dovrebbe dire: io opero per operare “
Colpisce l’attualità del pensiero eckhartiano per il matrimonio che in esso si consuma tra il duro rigore dell’ “intelligere” e la dolcezza della “grazia”. Il mistico ha una esperienza fuori dal tempo e parla fuori dal tempo. Nel mistico si è già chiuso il ciclo cosmico della materia.
” Diciamo dunque che l’uomo dev’essere così povero da non essere e da non avere in sè luogo alcuno in cui Dio possa operare. Finchè egli riserba un luogo, ritiene una distinzione. Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, poichè il mio essere essenziale è al di sopra di Dio in quanto cogliamo Dio come principio delle creature; in questo stesso essere di Dio in cui Dio è al di sopra dell’essere e al di sopra della distinzione, io ero me stesso, volevo me stesso, conoscevo me stesso per fare quest’uomo (che sono). Perciò io sono causa di me stesso secondo il mio essere che è eterno, e non secondo il mio divenire che è temporaneo. Perciò sono non-nato, e secondo il modo non-nato non posso mai morire “. Valutiamo cosa ha inteso indicarci Meister Eckhart nella Predica “Del Distacco”, perché essa è estremamente utile ai fini di determinare il vuoto che ci è necessario definire e colmare. Meister Eckhart vuole individuare ” quale sia la più alta e migliore virtù per cui l’uomo possa meglio e più strettamente unirsi a Dio e divenire per grazia ciò che Dio è per natura, e per cui l’uomo sia maggiormente simile alla propria immagine, quando era in Dio, quando non c’era differenza tra lui e Dio, prima che Dio formasse le creature “. Innanzi tutto, è da notare che il rapporto messo nella prima accezione ,quello uomo-Dio, dipende, non da qualche categorialità, ma ” da una più alta e migliore virtù “: ossia è nella “virtù” che troviamo lo strumento, e , non in altri, per definire la consistenza e la misura della presenza dell’uomo davanti a Dio e viceversa. La virtù non è una disposizione d’animo, né la virtus antica, né tanto meno una predisposizione al bene. La virtù qui è intesa come strumento per far sì che si pongano le condizioni del rapporto stesso tra uomo e Dio. Meister Eckhart la chiama in maniera non equivoca: “Distacco”. Tale termine verrà distesamente descritto, ma esso non è né conoscenza né moralità: esso è un puro fatto energetico che utilizza non solo la razionalità e la moralità, ma tutto ciò che serve ai fini che si propone. Dice, infatti, Eckhart: ” io lodo il distacco più di ogni amore. Prima di tutto per questo motivo: ciò che di migliore ha l’amore, è che esso mi obbliga ad amare Dio, mentre il distacco obbliga Dio ad amare me. ” . ” L’uomo può strettamente unirsi a Dio “, tuttavia quello che Dio è naturalmente, nell’uomo è ” un divenire per grazia “. Il che equivale a dire che l’unità originaria ha un momento che la può dissolvere definitivamente, poiché noi non siamo né necessari né essenziali alla permanenza dell’Assoluto, tenuto conto che l’Assoluto non ha bisogno di permanenza. Dunque, l’unità originaria avviene solo per grazia. Nella più brutale espressione noi siamo salvi solo per una decisione che non ci appartiene. E non poteva essere diversamente, perché ciò avrebbe significato una parodistica eguaglianza con “Chi” è “più” e “oltre” noi, con Colui che non ha bisogno né di essenza né di spazio, né di tempo e che,conseguentemente non cura né spazio né tempo, se non dal punto di vista umano. Il che significa che se il tempo-spazio esiste, esiste per pura sovrabbondanza, dunque “inutilmente”. Ragion per cui l’utilità di conservare un qualcosa nello spazio e nel tempo, è un puro atto gratuito: infatti, ciò che è in esubero non può assolutamente significare “una perdita” dal momento che è ab aeterno consegnato al niente . Il niente è, perciò, l’opposto della grazia e la grazia non ha da riferirsi a nessun obbligo salvifico, se è vero che la prospettiva della Grazia non muove dal mondo ma unicamente dall’anima. Infatti, ciò si specifica inequivocabilmente da quella immagine purissima che ” non c’è differenza tra l’ immagine dell’ uomo e quella di Dio “, giacché il loro porsi è antecedente ad ogni altra creazione. La questione è, perciò, quella di ripristinare lo stato originario e considerare che esso si determina soltanto togliendo la “posterità creazionale”. Come si è detto, è solo e semplicemente questo che Meister Eckhart definisce “distacco”, poiché, quando esso viene caricato di aspetti puramente “nientificanti”, ciò è dovuto al procedimento divulgativo e “predicatorio”. Il Distacco non esclude il mondo in quanto esistenza, il Distacco esclude l’ esistenza per recuperare “una somiglianza” e solo dopo averla recuperata si può comprendere come essa implichi “una visione” diversa dello stesso “niente”. Ma procediamo con ordine. Trascriviamo “la predica” del distacco. Viene detto: ” il puro distacco è al di sopra di tutte le cose, giacché ogni virtù ha in qualche modo in vista la creatura, mentre il distacco è libero da tutte le creature “. In questa enunciazione (escludendo l’ uso di virtù nella comune accezione di “capacità cognitiva”, che è difforme da quello che Meister Eckhart usa, altrove e correttamente, nel suo vero significato di “mezzo per raggiungere l’unità”), il “tema” del Distacco è espresso nella più completa e concisa determinazione. Ma poiché sembra apparirgli non sufficientemente chiaro che il Distacco è prevalentemente vuoto, ecco come divulga: ” è molto più nobile obbligare Dio a venire a me, che non obbligare me ad andare a Dio, perché Dio può inserirsi in me più intimamente ed unirsi meglio di quanto io non possa unirmi a Dio. Che il distacco forzi Dio a venire a me, lo dimostro così: ogni cosa desidera essere nel luogo suo proprio e naturale. Ora il luogo naturale e proprio di Dio è l’ unità e la purezza ed è ciò che il distacco produce “. Per la ragione che Dio è “tanto semplice e sottile ” che ” solo lui” può trovare posto nello spirito distaccato”, nasce l’ esigenza di insistere sulla nientificazione, anche a costo del fraintendimento. Infatti, Meister Eckhart dichiara apertamente di non trovare alcuna significanza nella “sofferenza”( ” perché nella sofferenza l’ uomo ha in qualche modo in vista la creatura che gli causa la sofferenza “); né tanto meno crede nell’ “umiltà” (” la perfetta umiltà si piega al di sotto di tutte le creature e, piegandosi così, l’uomo esce da se stesso per andare verso le creature, mentre il distacco permane in se stesso , […] vuole essere dove si trova , senza considerare l’ amore o la sofferenza. […] Perciò tutte le cose davanti ad esso sono lasciate essere, senza essere importunate “) E questa necessità di “non importunare” per occuparsi del compito di essere aperto a Dio soltanto, che costringe ad asserire:che il distacco deve essere totale e perfetto, che non può essere turbato né uscire da se stesso, poiché ” nessuna uscita, per quanto piccola può essere senza danno “. ” Tacerò e ascolterò quel che mi dirà il mio Signore e mio Dio. E’ come se mi dicesse: se Dio mi vuole parlare, che venga verso di me; io non voglio uscire da me stesso “. Altrettanto negativa è la misericordia ( ” essa costringe l’ uomo ad uscire da se stesso, per andare verso le miserie del suo prossimo, cosicché il suo cuore si turba “): tale asprezza è dovuta al fatto che c’è in palio l’ eternità e questo desiderio di eternità ha da considerare che ” Dio non può donare ad altri che a se stesso ” e solo nella misura in cui si diventa Dio che si ha la necessità di tendere al non- turbamento.( ” Dio è Dio per il suo distacco immutabile “). ” Devi sapere che il vero distacco consiste solo nel fatto che lo spirito permane tanto insensibile a tutte le vicissitudini della gioia e della sofferenza , dell’ onore, del danno e del disprezzo, quanto una montagna di piombo è insensibile ad un vento leggero. […] Io dico inoltre: tutte le preghiere e le buone opere che l’ uomo può compiere nel tempo, turbano tanto poco il distacco di Dio, quanto lo turberebbe il fatto che mai si siano compiute nel tempo preghiere ed opere buone “.
MEDITAZIONI
C’è una potenza nell’anima, l’intelletto, che fin dall’inizio, appena prende coscienza di Dio o lo gusta, ha in sé cinque proprietà. La prima è quella di essere libera dal qui e dall’ora. La seconda è quella di non avere somiglianza con niente. La terza è quella di essere pura e senza commistione. La quarta è quella di essere operante o ricercante in sé stessa. La quinta è quella di essere un’immagine. In primo luogo: è libera dal qui e dall’ora. Qui ed ora significano il tempo e il luogo. “Ora” è la piú piccola parte del tempo, non è frammento o parte del tempo, ma piuttosto un sapore del tempo, una punta ed una estremità del tempo. E tuttavia, per quanto piccolo possa essere, deve andarsene; tutto deve andarsene quel che tocca il tempo, o il sapore del tempo. Dall’altro lato: è libera dal qui. “Qui” significa il luogo. Il luogo in cui io sono è davvero piccolo. Tuttavia, per quanto piccolo possa essere, deve sparire, se si deve vedere Dio. In secondo luogo: non è simile a niente. Un maestro dice: Dio è un’essenza simile a niente, e che non può assomigliare a niente. San Giovanni dice: “Noi saremo chiamati figli di Dio”. Ma se dobbiamo essere figli di Dio, dobbiamo essere simili a lui. Come dunque può dire il maestro: Dio è un’essenza simile a niente? Lo dovete comprendere cosí: in quanto questa potenza è simile a niente, in tanto proprio è simile a Dio. Essa è simile a niente, proprio come Dio è simile a niente. Sapete, tutte le creature per natura stanno in caccia ed operano al fine di diventare simili a Dio. Il cielo mai ruoterebbe, se non andasse in cerca di Dio o di una somiglianza a lui. Se Dio non fosse in tutte le cose, la natura non opererebbe né desidererebbe niente in nessuna cosa, giacché, che tu ne abbia gioia o dolore, che tu lo sappia o no, la natura cerca e tende a Dio nel segreto, nella parte piú intima. Per quanto assetato possa essere un uomo, egli rifiuterebbe la bevanda che gli venisse offerta, se non vi fosse in essa qualcosa di Dio. La natura non desidererebbe né cibo né bevanda, né vesti né alloggio, né alcuna altra cosa, se non vi fosse niente di Dio; essa sempre cerca nel segreto e sta in caccia per trovare Dio in tutte le cose. In terzo luogo: è pura e senza commistione. La natura di Dio è tale che non può soffrire molteplicità o commistione di alcun genere. Cosí anche questa potenza non ha molteplicità o commistione di sorta; niente di estraneo è in essa, e non può introdurvisi. Se io dicessi di un bell’uomo che è pallido e nero gli farei torto. L’anima dev’essere completamente senza molteplicità. Se qualcuno attaccasse qualcosa al mio cappuccio o vi ponesse qualcosa, chi lo tirasse, tirerebbe insieme quel che vi è attaccato. Quando io me ne vado di qui, tutto quel che è su di me se ne va con me. Se si trascina via ciò su cui un uomo ha costruito, si porta via anche lui. Ma se un uomo fosse fondato sul nulla e non aderisse a nulla, rimarrebbe completamente immobile anche se il cielo e la terra fossero capovolti, perché non sarebbe attaccato a niente e niente a lui. In quarto luogo: è sempre interiormente in ricerca e operante. Dio è una tale essenza che sempre abita nel piú profondo. Perciò l’intelletto ricerca sempre nell’interno. Al contrario, la volontà va verso l’esterno, verso quel che ama. Se, ad esempio, venisse da me un amico, il mio volere con il suo amore si effonderebbe verso di lui, e troverebbe in ciò la sua soddisfazione. Dice san Paolo: “conosceremo Dio come siamo conosciuti da lui”. San Giovanni dice: “Conosceremo Dio come egli è”. Se devo essere colorato, devo avere in me quel che appartiene al colore. Non sarò mai colorato, se non ho in me l’essenza del colore. Mai posso vedere Dio, se non là dove egli stesso si vede. Perciò un santo dice: “Dio abita in una luce inaccessibile”. Nessuno si scoraggi per questo: ci si trova sulla strada o nell’entrata, e questo è bene; ma la verità è lontana, perché questo non è Dio. In quinto luogo: è un’immagine. Ebbene, fate attenzione e ricordate bene, perché tutta la predica sta in questo. L’immagine e l’immagine originaria sono cosí completamente uno ed unite l’un l’altra, che non vi si può riconoscere alcuna distinzione. Si può ben pensare il fuoco senza calore e il calore senza fuoco; si può anche pensare il sole senza la luce e la luce senza il sole, ma non si può riconoscere alcuna distinzione tra immagine ed immagine originaria. Dico ancora di piú: Dio, con la sua onnipotenza, non può riconoscere in ciò alcuna distinzione, perché insieme vengono generate e insieme muoiono. Se mio padre muore, non muoio perciò io. Quando muore, non si può dire “è suo figlio”, ma piuttosto si dice “era suo figlio”. Se si fa bianco il muro, in quanto è bianco è uguale ad ogni bianchezza. Se si fa nero, allora è morto ad ogni bianchezza. Vedete, lo stesso è qui. Se sparisse l’immagine formata secondo Dio, se ne andrebbe anche l’immagine di Dio.
[MEISTER ECKHART, “Sermoni tedeschi, Modicum et iam non videbitis me” ]
FRANCESCO D’ASSISI

Santo protettore dell’Italia, figura rivoluzionaria della Chiesa cristiana, messaggero ed ambasciatore di pace in Oriente: tutte descrizioni che si possono attribuire a San Francesco, il “poverello d’Assisi”. E perché non aggiungere, in fondo, anche quella di filosofo? Ha vissuto da anticonformista, ha predicato e messo per iscritto le sue idee, ha avuto numerosi discepoli… La sua concezione della vita va al di là di un semplice atteggiamento religioso, si può tranquillamente definire una vera e propria filosofia.
1. La vita
Nasce ad Assisi nel 1181/1182 col nome di Giovanni, figlio di Pietro di Bernardone e di Giovanna, detta donna Pica. Il padre, ricco mercante di stoffe, al momento della nascita del figlio si trova in Francia, ma, al suo ritorno, deciderà di chiamarlo Francesco.
Di Francesco, si può dire che abbia vissuto due vite, una l’opposto dell’altra. Il giovane Francesco era un ragazzo vivace, amante delle feste, dei banchetti e del lusso: amava mangiare e bere con gli amici, indossare vestiti eleganti e preziosi gioielli. È Francesco stesso a presentarsi, in apertura del suo Testamento, come uno che viveva nei peccati e nella dissoluzione morale. Nel 1202 partecipò, come molti altri suoi coetanei, alla guerra contro Perugina: fatto prigioniero, fu riscattato dopo un anno grazie alle risorse economiche del padre.
Circa due anni più tardi, inizia la sua conversione e la sua trasformazione. Il padre la racconta così: “All’inizio Francesco sembrava uguale a tutti gli altri bambini: era allegro, voleva sempre giocare e gli piaceva cantare. Poi accadde quello che accadde: un giorno incontrò un lebbroso e, invece di fuggire al suono della campanella, scese da cavallo e lo abbracciò. E non basta, un’altra volta si intrufolò nel mio magazzino e si prese tutte le stoffe preziose che c’erano negli scaffali per poi vendersele sottoprezzo, il tutto per pagare i restauri della chiesa di San Damiano”. Per quest’ultimo episodio, Francesco viene denunciato dal padre al tribunale ecclesiastico: qui, davanti al vescovo e al popolo, il giovane rinuncia all’eredità e ai beni paterni, si spoglia anche degli abiti e fa pubblica professione di povertà. Afferma in seguito: D’ora in avanti voglio dire “Padre nostro che sei nei cieli”, non più “padre mio Pietro di Bernardone”.
Da qui in poi, Francesco inizia la sua nuova vita: il colloquio col crocefisso non fa che rassicurarlo della decisione da lui presa. Un giorno, infatti, mentre sta pregando davanti al crocefisso, sente dirsi: Francesco, se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che mondanamente amavi e bramavi possedere. Inizia quindi a predicare l’amore, la pace e la povertà e a poco a poco si uniscono a lui alcuni compagni: Bernardo di Quintavalle, Pietro Cattani, Gaspare di Petrignano e altri ancora. Vivono tutti insieme nella Porziuncola, una chiesetta mezza diroccata che riparano essi stessi. In questo clima viene redatta la Regola del Primo Ordine Francescano, che contiene le norme e le regole di vita della comunità. Francesco, con alcuni compagni, si reca a Roma per incontrare papa Innocenzo III e vedere riconosciuta la sua Regola. Le guardie, però, non lo fanno entrare a palazzo, scambiando lui e i compagni per dei guardiani di porci. Francesco e i suoi aspettano fuori dalle porte del Laterano per tre mesi, dormendo per strada e vivendo di elemosina, finché il papa, pare a causa di un sogno che lo aveva turbato, lo manda a prendere dalle guardie e accetta la Regola senza obiezioni, seppur solo oralmente. Fu il pontefice Onorio III, con la bolla Solet annuere Sedes Apostolica del 1223, a costituire definitivamente ed ufficialmente l’Ordine francescano.
Intorno al 1211 alla piccola comunità di frati si aggiunge Chiara, figlia di Favarone degli Offreducci, una ragazza di ceto aristocratico che condivide la stessa fede ardente di Francesco: Da quando ho conosciuto la grazia del Signore nostro Gesù Cristo per mezzo di quel suo servo Francesco, nessuna pena mi è stata molesta, nessuna penitenza gravosa, nessuna infermità mi è stata dura. Chiara è seguita nella sua scelta di vita da numerose altre ragazze come lei, che insieme fondano l’Ordine delle Clarisse, redigendo con Francesco la Seconda Regola.
Tra il 1217 e il 1221 si svolge la quinta crociata: voluta da Papa Onorio III, è condotta da Andrea II re d’Ungheria e da Giovanni di Brienne. Il piano dei crociati è quello di arrivare in Terrasanta e attaccare gli infedeli sorprendendoli da sud, arrivando cioè dall’Egitto. Ed è proprio in Egitto che si reca nel 1219 Francesco, con intenti apostolici ed evangelici. Dopo la sconfitta cristiana sotto le mura di Damietta, si spinge disarmato tra le linee nemiche e, catturato, è portato dal sultano Malek-el-Kamel. Il sultano è ammirato dalla persona e dalla figura di Francesco, tanto da trattarlo con garbo e rispetto, consentendogli pure di visitare i luoghi sacri.
Al ritorno dal pesante viaggio la sua salute, già precaria, è molto peggiorata. Francesco si dedica alla stesura della Regola del Terzo Ordine e rielabora quella del Primo.
È in questo periodo che si verificano gli episodi miracolosi della vita di Francesco: al 1223 risale l’apparizione del Gesù Bambino nel presepio vivente che era stato allestito da Francesco e compagni a Greccio, presso Rieti; l’anno successivo riceve le stigmate sul monte Verna; si moltiplicano le voci sulla sua abilità di parlare agli animali e si diffonde, in particolare, la storia del lupo di Gubbio.
I confratelli di Francesco, preoccupati per la sua salute che peggiora sempre più, gli consigliano di riposarsi ritirandosi e curandosi presso Siena: è proprio qui che nel 1226 detta il suo Testamento, forse sentendo vicina la morte. Con le ultime forze decide di tornare ad Assisi, dove, dopo aver scritto il Testamento finale, muore nella sua Porziuncola: è il 3 ottobre 1226. Fu fatto santo da Gregorio IX il 16 luglio 1228.
2. Le opere
Il messaggio e l’insegnamento di Francesco stanno forse più nella sua esperienza di vita che nei suoi scritti, tanto più che egli era solito definirsi “semplice e illetterato”. Non si può negare, tuttavia, la sua attenzione per la predicazione e per la parola, strumenti necessari per illuminare la vita e dare senso all’esistenza, per esprimere l’amore per la Natura e la lode a Dio. La distinzione consueta delle sue opere proposta dagli editori moderni è la seguente:
– Regole ed esortazioni
Regola non bollata (comprende scritti fino al 1221)
Regola bollata (approvata da Onorio III nel 1223)
Regola di vita negli eremi
Ammonizioni (raccolta di riflessioni spirituali)
Testamento di Siena (maggio 1226)
Testamento finale (autoritratto e spaccato della sua vita)
– Lettere (Ai fedeli; Ai chierici; Ai reggitori di popoli; A tutto l’Ordine; etc.)
– Laudi e preghiere
Lodi di Dio Altissimo
Cantico di Frate Sole (o delle Creature)
Preghiera davanti al crocefisso
Ufficio della Passione del Signore
Come nota Carlo Paolazzi in Lettura degli “Scritti” di Francesco d’Assisi, queste opere non nascono da motivazioni culturali e letterarie, ma da esigenze di vita comunitaria e personale.
3. La figura e il messaggio
“Vivere secondo la forma del Vangelo” è la grande svolta che trasforma definitivamente la vita del giovane Francesco, un ragazzo che viveva nella ricchezza e sceglie la povertà, che sognava la gloria delle armi e si fa ambasciatore di pace e amore. La sfida di Francesco è quella di mostrare agli uomini del suo tempo come l’insegnamento del Vangelo possa essere vissuto da tutti, sempre, senza mezze misure, come ha detto Gesù: Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi (Gv, 13,15). “Io ho fatto la mia parte; quanto spetta a voi, ve lo insegni Cristo”, diceva Francesco.
Al centro del suo messaggio sta il mistero di Dio e l’amore con cui Francesco lo vive: è proprio Dio, Padre amorevole, sommo bene dal quale proviene ogni altro bene che egli intravede in tutte le cose, in tutte le creature: Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le tue creature (Cantico di Frate Sole). L’amore e la gratitudine di Francesco aumentano di fronte a Gesù, figlio di Dio, nato e morto per noi. L’umiltà dell’incarnazione e la carità della passione di Gesù non soltanto testimoniano il suo amore per noi, ma sollecitano una risposta: seguire le orme di Gesù è rispondere a quest’amore: “Dobbiamo amare molto l’amore di colui che ci ha molto amati”.
Il pensiero e il messaggio di Francesco ebbero rapidissima diffusione e notevole influenza sulla cultura europea. Tra le più importanti figure francescane si ricordano anche parecchi filosofi: tra gli altri Bonaventura, Ruggero Bacone, Duns Scoto, Guglielmo d’Ockham.
In conclusione, soffermiamoci sulla figura di Francesco così come la delinea un suo discepolo, fra Gaspare da Petrignano:
“Conobbi Francesco un giorno mentre stavo tornando dal mercato: lo vedo e ne resto affascinato. Ha come vestito un sacco di iuta e siamo in pieno inverno. […] Lo invito a casa mia: mangiamo insieme e resto tutta la notte in piedi per parlare con lui. Non capisco bene quello che dice ma lo ascolto. Ho l’impressione di vivere per la prima volta. […] Gli chiedo dove abita e mi porta in una chiesetta mezza diroccata chiamata la Porziuncola. Senza pensarci troppo decido di vivere lì anch’io. […] Oggi ci hanno raggiunto altri tre fratelli: si chiamano Bernardo, Pietro ed Egidio. Li abbiamo sistemati tutti e tre dietro l’altare. […] Noi seguiamo Francesco, felici come non lo siamo mai stati nella vita. Le nostre regole sono: l’umiltà, la carità, l’obbedienza, la povertà, la serenità, la pazienza, il lavoro e la gioia. Ieri Francesco ha detto ad un contadino: Non coltivare tutto il tuo terreno. Lasciane un po’ alle erbacce, così vedrai spuntare anche i fratelli fiori. […] La cosa più bella che ho fatto grazie a Francesco è stato il presepio. Eravamo a Greccio, dalle parti di Rieti, quando lui ci parlò di Betlemme e della nascita di Gesù Bambino. Era il giorno di Natale. Francesco andò in paese e si fece prestare un bue e un asinello, poi convinse alcuni paesani a travestirsi da pastori e uno di loro venne con la moglie, una brava donna. Li nominammo subito Giuseppe e Maria. Insomma, mettemmo in piedi un presepe vivente. Il bambino ovviamente non c’era, eppure, roba da non credere, quando scoccò la mezzanotte tutti, ma proprio tutti, lo vedemmo sgambettare nella paglia. Impossibile raccontare fino a che punto siamo stati felici!”
4. Il Cantico delle Creature
Se esiste un componimento o uno scritto di Francesco che possa essere considerato il manifesto del suo pensiero e delle sue idee, è senz’altro il Cantico di Frate Sole, anche noto come Cantico delle Creature. In esso troviamo il grande amore di Francesco per Dio e per tutto il creato: è in tutte le creature che Francesco vede Dio, è amando tutto il creato che Francesco ama Dio. L’uomo è esso stesso una creatura, fratello di tutte le cose che esistono.
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria, l’honore et onne benedizione.
Ad te solo, Altissimo, se konfane,
e nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le Tue creature,
spezialmente messor lo frate Sole,
lo quale è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significazione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le Stelle:
in celu l’ài formate clarite e preziose e belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
E per aere e nubilo e sereno et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile e pretiosa e casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la notte:
et ello è bello e iocundo e robustoso e forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta e governa,
e produce diversi frutti con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
e sostengo infirmitate e tribulazione.
Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue santissime voluntati,
ka la morte seconda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore e rengraziate
e serviateli cum grande humiltate.
5. S. Francesco e Dante
Dante Alighieri dedica non pochi versi alla figura di Francesco: siamo nel Canto XI del Paradiso, Dante si trova nel cerchio degli spiriti sapienti dove, tra gli altri, è presente anche Tommaso d’Aquino. È proprio a quest’ultimo che Dante fa proferire l’elogio di Francesco, elogio profondo, allegorico e ricco di suggestioni (vv. 43-117).
L’elogio non si riduce ad una semplice biografia, né ricalca la ricca aneddotica, colorita ed incantevole, già solida e conosciuta ai tempi di Dante. Anzi, a onor del vero, la biografia si riduce all’essenziale: la nascita è raccontata con una complessa indicazione geografica, è seguita poi da pochi accenni alla conversione, dalla “guerra” col padre, e subito si arriva alle nozze con la Povertà. I versi proseguono narrando del formarsi dell’originario gruppo di discepoli, delle udienze ottenute da Francesco, prima con papa Innocenzo e poi con Onofrio, che diedero sigillo a sua religïone e corona alla sua santa voglia. Il racconto prosegue con cenni al viaggio in Oriente, all’eremitaggio e alle stigmate ricevute sul monte Verna, per chiudersi col ritorno di quest’anima preclara a Dio, con la morte in umiltà e la sepoltura nella nuda terra.
Centrale in questo canto, come nella vita di Francesco, è l’immagine dell’amore tra il giovane e la Povertà, con le loro “nozze mistiche” dinanzi alla spiritual corte et coram patre, l’immagine dell’amore per una tale donna a cui, come a la morte, la porta del piacer nessun diserra. Morte che, in quanto creatura di Dio, Francesco amava e rispettava come fosse sua sorella.
Come nota Auerbach: a questo per l’appunto serve l’allegoria della povertà: essa fa un tutto unico della missione del santo e dell’atmosfera particolare alla sua persona. […] In quanto donna di Francesco, la povertà possiede una realtà concreta, ma poiché Cristo fu il suo primo sposo, così la realtà concreta, di cui si tratta, è nello stesso tempo parte d’una grande concezione storica e dogmatica. Paupertas unisce Francesco con Cristo, stabilisce la posizione del santo quale imitator Christi.
ADAM MARSH
Adam Marsh, in realtà Adam de Marisco, visse tra il 1200 e il 1259: nato a Bath, si formò a Oxford sotto la guida del celebre filosofo Roberto Grossatesta. Nel 1230 entrò nell’ordine francescano e grazie a Grossatesta si appassionò alla filosofia: ben presto venne riconosciuto da tutti come un vero e proprio leader intellettuale oltre che spirituale. Dei suoi scritti ci sono giunte esclusivamente le lettere. Il suo allievo, Ruggero Bacone, decantò a più riprese la sua immensa conoscenza in campo teologico e matematico. A lui e alla sua saggezza si rivolsero non solo Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone, ma perfino la regina, che ben conosceva la sua immensa esperienza anche nell’ambito della giurisprudenza. Arrivando a occupare una cattedra di teologia a Oxford (che tenne dal 1247 al 1250), Marsh non fece che accrescere il peso dell’ordine francescano: in lui convivono, seppur non senza problemi, il messaggio francescano e quello gioachiniano, secondo il quale si è in attesa dell’età nuova intesa come imminente. Marsh è infatti tra coloro che avvertono con ansia la cristianità minacciata, in forza di una caterva di eventi preoccupanti: a partire dal 1236, infatti, i mongoli si sono pericolosamente avvicinati all’Europa, e nel 1241 papa Gregorio IX ha lanciato l’appello per una crociata contro i tartari; inoltre, qualche anno dopo, parte la missione del francescano Giovanni di Pian del Carpine presso i tartari. In forza di questi eventi catastrofici che preludono al peggio, Marsh avverte l’esigenza di un rinnovamento radicale della Chiesa in quanto istituzione: egli trasmetterà questa preoccupazione e questa tensione verso l’“età nuova” al suo allievo Ruggero Bacone, che la declinerà come lotta contro il pericolo rappresentato dall’Anticristo.
PIETRO D’AILLY

Pietro d’Ailly, detto Aquila Franciae et aberrantium a veritate malleus indefessus dai suoi contemporanei, cardinale oltre che filosofo e teologo, nacque nel 1350 a Compiègne e morì intorno al 1420 ad Avignone. Si formò soprattutto all’Università di Parigi. Nel 1375, col suo commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Pietro d’Ailly appoggiò la causa dei nominalisti. Nel 1380 fu insignito del titolo di Dottore in Teologia. In quel periodo compose una nutrita serie di trattati nei quali sostenne apertamente che vescovi e preti ricevono la loro giurisdizione direttamente da Cristo, e non dal papa; quest’ultimo veniva riconosciuto non infallibile e addirittura inferiore rispetto al concilio. Sicché Pietro d’Ailly sostenne la dottrina conciliare. Scrisse: “la fermezza della Chiesa non può poggiare sulla debolezza di Pietro, ma solo su Gesù Cristo”. Il papa è, agli occhi di Pietro d’Ailly, capo solo in quanto ebbe un’autorità delegata in parte dalla Chiesa (ministerialiter exercens) ma non può essere superiore a questa, essendo impossibile che una parte sia superiore al tutto. Se anche tutti i sacerdoti errassero, vi saranno sempre nella Chiesa delle umili persone che salvaguardano il deposito della rivelazione: “è chiaro che il tutto è superiore alla parte e il papa è solo una parte del concilio, come il capo è una parte del corpo”. In un sermone predicato al Concilio di Costanza disse: “solo la Chiesa universale ha il privilegio di non errare”. Si guadagnò una grande fama soprattutto in forza dei suoi sermoni e del suo talento dialettico. Tra i principali allievi di Pietro d’Ailly debbono essere ricordati Giovanni Gerson (che fu il suo successore come cancelliere dell’Università) e Nicola di Clemanges. Nel 1839 fu nominato Cancelliere dell’Università di Parigi e confessore del re. Sulla scia di Guglielmo di Ockham, Pietro d’Ailly è convinto che, propriamente, l’esistenza di Dio non sia razionalmente dimostrabile; che il dogma della Trinità non può essere stabilito a partire dalla Scrittura; che la legge positiva sia la sola base su cui possa poggiare la morale. Anticipando in qualche modo Cartesio, egli si spinse addirittura a sostenere che Dio può ingannarci, esercitando la sua potenza assoluta per corrompere le nostre capacità intellettuali. La conseguenza di questa tesi è, paradossalmente, che la Scrittura può contenere menzogne e che pertanto non dev’essere letta come infallibile fonte di verità. Per questa via, l’indagine razionale pareva sempre più sganciarsi dalla fede. Nei suoi numerosissimi scritti (centocinquantaquattro), molti dei quali non sono ancora stati pubblicati, egli affronta problemi eterogenei, come la filosofia e la scienza, la teologia e l’ascetismo. Pietro d’Ailly crede fermamente nell’astrologia, come si evince dal suo scritto Concordanza di astronomia e storia, in cui cerca di dimostrare come i principali fatti storici siano determinabili astrologicamente. Anche la geografia non esulò dai suoi interessi: nell’opera Imago mundi (che sarà successivamente letta dallo stesso Cristoforo Colombo), egli ipotizzò la possibilità di raggiungere le Indie passando da ovest, corroborando tale tesi col supporto dell’autorità di Aristotele, di Seneca e di Plinio il Vecchio.
RABANO MAURO

Rabano Mauro Magnenzio (in latino Rabanus Maurus Magnentius) (Magonza 780/784 – Magonza 4 febbraio 856), erudito carolingio, abate di Fulda, vescovo di Magonza, nacque a Magonza (da cui l’appellativo Magnentius) in un anno imprecisato – probabilmente tra il 780 e il 784 – da Waluran e Waltrat, membri dell’aristocrazia franca. Hrabanus, Rhabanus, Reabanus sono varianti del nome Rabanus. Quando era ancora bambino, nel 790/791 entrò come oblato nell’abbazia benedettina di Fulda dove condusse i primi studi e nell’801 fu ordinato diacono. Poco dopo venne inviato a completare i suoi studi a Tours, uno dei maggiori centri della rinascita culturale carolingia, sotto la guida di Alcuino di York. Fu proprio Alcuino a conferirgli il soprannome “Mauro”, in ricordo del discepolo prediletto di san Benedetto. Dopo due anni fece ritorno a Fulda per dirigere la scuola annessa all’abbazia. Nell’814 fu ordinato prete. Dopo un pellegrinaggio a Gerusalemme, nell’817 tornò all’abbazia di Fulda della quale nell’822 venne nominato abate. Nel ventennio del suo abbaziato, Rabano scrisse la maggior parte delle sue opere, proseguì la ricostruzione degli edifici monastici iniziata dal suo predecessore, potenziò lo scriptorium dell’abbazia, la cui biblioteca divenne una delle più ricche d’Europa. Nell’842 si dimise dalla carica di abate e si ritirò a Petersberg, presso Fulda, dove continuò la sua attività erudita. Nell’847 fu eletto vescovo di Magonza, carica che detenne fino alla morte, avvenuta il 4 febbraio 856, distinguendosi per la sollecitudine nei confronti dei suoi diocesani, in particolare durante la grave carestia dell’850, ma anche per le rigide prese di posizione nelle controversie teologiche ed ecclesiastiche sottoposte al suo giudizio.
La fama di Rabano Mauro è legata alla sua vastissima produzione letteraria come teologo, commentatore delle Scritture, poeta, enciclopedista. Le sue opere per lo più sono compilazioni tradizionali (Curtius lo definì, forse con eccessiva severità, “monotono compilatore”) che attingono abbondantemente alla letteratura patristica – da Agostino a Beda e Isidoro di Siviglia – o agli autori classici.
Tra le sue opere maggiori ricordiamo: Commentaria in libros veteris et novi testamenti; De institutione clericorum; De computo; De oblatione puerorum; De praescientia et praedestinatione, De gratia et libero arbitrio; De disciplina ecclesiastica; Paenitentialia. De universo (o De rerum naturis; Liber de originibus rerum) libri XXII; Martyrologium; De anima; Carmina; Epistulae.
Più che un pensatore originale, egli fu un organizzatore, sistematizzatore e promotore di cultura, ma forse proprio per questo le sue opere esercitarono una profonda influenza nei secoli centrali del Medioevo, come dimostra l’abbondanza e la diffusione geografica dei manoscritti che le hanno tramandate. Tra i suoi allievi diretti ci furono alcune figure ben note della cultura carolingia, come Lupo di Ferrières, Walafrido Strabone, Otfrido di Weißenburg, Godescalco. La sua attività di educatore gli valse l’attributo di praeceptor Germaniae.
Durante il suo vescovato, Rabano presiedette nell’autunno dell’848 il sinodo di Magonza chiamato a giudicare delle tesi eterodosse del monaco Godescalco sulla predestinazione divina, fortemente influenzate dal tardo pensiero agostiniano. Il processo si concluse con la condanna di Godescalco alla fustigazione e alla reclusione perpetua.
Politicamente, Rabano fiancheggiò l’imperatore Ludovico I nelle controversie con i figli per la successione nell’impero carolingio che segnarono gli ultimi anni del suo regno. In seguito, egli si schierò con il partito favorevole a Lotario I, figlio maggiore e successore di Ludovico I nell’impero, e contro i suoi fratelli Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico. Con quest’ultimo successivamente si riconciliò, come attesta la sua elezione a vescovo di Magonza nell’847, quando ormai Ludovico era stato incoronato re di Germania.
GIOVANNI TAULERO

A cura di Mai Saroh Tassinari
” Il mio spirito è andato errando
in un silenzio solitario
dove non ci sono né parole né modi.
Mi ha circondato un Essere
in cui non c’è alcuna meraviglia.
Il mio spirito è andato errando.
La ragione non può raggiungere ciò,
è al di sopra di ogni senso.
Ed io voglio lasciarne la ricerca.
Il mio spirito è andato errando.
Per un momento immergiti nel fondo,
la beatitudine increata ti sarà palese.
Separati dal nulla,
tu troverai il nulla
che la lingua nega
e resta tuttavia qualcosa.
Ciò comprende solo lo spirito
che non si cura di alcun profitto “.
TAULERODominicano tedesco e divulgatore del misticismo di Giovanni Eckhart in lingua tedesca, Giovanni Taulero fu uno dei più grandi mistici e predicatori del Medio Evo; nacque a Strasburgo intorno al 1300 e vi morì il 16 giugno 1361. Figlio di un signore benestante, sembra che, ancora giovane, sia entrato nell’Ordine Dominicano della sua città perché, secondo la sua propria testimonianza, la vita ascetica di quell’ordine lo affascinava. È possibile che, durante i consueti otto anni di studio nel monastero, abbia ascoltato i sermoni di Eckhart, con il quale strinse una più stretta conoscenza in seguito, quando studiò all’università dell’ordine a Colonia e probabilmente nello stesso modo conobbe anche Enrico Seuse, detto Susone (1295 circa – 1366).
Non è certo che abbia studiato anche a Parigi; si propende piuttosto nel pensare che da Colonia sia ritornato a Strasburgo. All’incirca dal 1339 al 1347 o 1348, Taulero visse a Basilea dove, assieme a Enrico di Nördlingen, era il centro di una grande società chiamata gli “Amici di Dio di Basilea”; essa era composta da persone che prediligevano la vita mistica. In seguito, ritornò a Strasburgo, dove fu predicatore. Christina Ebner loda i suoi discorsi infiammati che accendevano gli spiriti di tutti quelli che lo ascoltavano; Rulman Merswin lo scelse come suo confessore. Successivamente, visse per qualche tempo a Colonia e durante l’ultimo periodo della sua vita si trasferì nuovamente a Strasburgo.
Il “Meisterbuch” degli “Amici di Dio dell’Altopiano” fornisce il ritratto di un maestro delle Scritture che nel 1346 attirò molta attenzione con i suoi sermoni. Un giorno, un laico accusò questo maestro di cercare solo la sua gloria personale piuttosto che quella del Signore, aggiungendo inoltre che probabilmente egli non aveva sopportato i fardelli che aveva imposto agli altri. Senza fare nessun accordo, il maestro si fece guidare dal laico e imparò da lui a dimenticare il mondo e se stesso, a volgere tutti i suoi pensieri verso Dio e a condurre una vita interamente dedicata allo Spirito. Per due anni visse recluso e, quando poi incominciò a predicare di nuovo, la prima volta l’effetto fu talmente grande che quaranta di coloro che lo stavano ascoltando ebbero le convulsioni e dodici poterono essere rianimati soltanto a stento. Dopo nove anni, il maestro si ammalò gravemente e, dopo aver chiamato il laico, gli affidò un resoconto scritto della propria conversione, al quale l’uomo aggiunse cinque sermoni che aveva copiato in precedenza. Una volta, era ovvio identificare Taulero con questo maestro; il “Meisterbuch” era del 1498, incluso nelle edizioni dei sermoni di Taulero. In tempi più recenti anche Preger ha confermato questa opinione, ma nel trattato “Taulers Bekehrung” Denifle ha apportato prove schiaccianti contro questa teoria; questo punto di vista è ora generalmente accettato. La storia raccontata dal cronista di Strasburgo, Speckle (morto nel 1589), è intrisa di falsità e riferisce che Taulero si oppose al papa e al divieto che egli aveva imposto a Strasburgo durante la lotta tra il papato e l’imperatore Luigi il Bavarese.
Gli scritti di Taulero non sono ancora stati oggetto di una approfondita analisi critica; si sa solo che molto di ciò che gli è stato attribuito è dubbio, molto non è autentico. Sicuramente non scrisse il libro del “Nachahmung des armen Lebens Christi” o “Von der geistlichen Armut”; gli “Exercitia super vita et passione Jesu Christi” e le canzoni spirituali attribuitegli sono anch’essi spuri. Nella migliore delle ipotesi, scrisse solo una piccola parte del “Medulla animae” o delle “Institutiones divinae”; quindi, solo i sermoni rimangono quale sua opera effettiva. La prima edizione apparve nel 1498 a Leipzig e includeva 84 sermoni; la seconda (Basilea, 1521-22) ne aggiunse altri 42, alcuni dei quali, ad ogni modo, persino nell’opinione dello stesso editore di quell’edizione, non erano di Taulero; nella terza (Colonia, 1543) ne vennero aggiunti 25, tra i quali ve ne sono altri che sono spuri. Quest’ultima edizione venne tradotta, o meglio parafrasata, in latino da Laurentius Surius (Colonia, 1548) e venne poi impiegata per traduzioni in varie lingue e per ritraduzioni in tedesco, sia cattoliche che protestanti. Le edizioni moderne (Francoforte, 1826, 1864, 1872; Berlino, 1841) sono basate sulle vecchie edizioni tedesche. Ferdinand Vetter ne ha curata una (Berlino, 1910) basata sul manoscritto di Engelberg (l’unico redatto a Colonia e il più antico, che forse può presentare la collazione rivista da Taulero stesso), su quello di Friburgo e su copie di tre manoscritti bruciati a Strasburgo nel 1870; questa edizione contiene 81 sermoni.
I sermoni sono tra i più bei monumenti alla lingua tedesca, al credo fervente di questa cultura, e al suo profondo sentimento spirituale. Il linguaggio usato è pacato e misurato, eppure caldo, animato e ricco di immagini. Taulero non è così congetturale come il suo maestro, Eckhart; al contrario, è più chiaro, più pragmatico e più vicino alla gente comune; a tutto ciò si aggiunge il fervore ereditato da Susone. L’espressione usata da Christina Ebner, secondo cui Taulero aveva incendiato il mondo intero con i suoi discorsi infuocati, non significa che ipnotizzasse il suo pubblico, ma che riscaldava e infiammava i cuori di chi lo ascoltava con la fiamma tranquilla dell’amore puro che bruciava nel suo stesso cuore.
Il centro del misticismo di Taulero è la dottrina della visio essentiae Dei, la beata contemplazione della conoscenza della natura divina. Egli mutua questa dottrina da Tommaso d’Aquino, ma si spinge oltre nel credere che la conoscenza del divino sia raggiungibile in questo mondo da un uomo perfetto e che dovrebbe essere ricercata con ogni mezzo. Dio è presente in ogni essere umano: tuttavia, per far sì che questo Dio trascendente possa apparire nell’uomo come un secondo soggetto, le attività umane, peccaminose, devono cessare; in questo tentativo, un aiuto è fornito dalla luce della grazia che eleva la natura umana al di sopra di essa. La via che conduce a Dio è attraverso l’amore, poiché Dio risponde alla sua più alta espressione mostrando la sua presenza. Taulero dispensa i consigli più svariati per raggiungere la vetta della religione, dove il Divino entra in contatto con i soggetti umani.
È necessario accennare qualcosa riguardo la posizione di Taulero nei confronti della Chiesa. Lutero lo lodò ripetutamente e i protestanti hanno sempre avuto un’opinione molto elevata di lui e lo hanno incluso tra i “riformatori prima della Riforma”; tuttavia, adesso essi ammettono che era “in realtà interamente medievale e non protestante”; in effetti, era un figlio rispettoso della Chiesa e non pensò mai di venire meno alla sua fedeltà. La sua opinione viene espressa molto chiaramente nel suo sermone su san Matteo; si schiera apertamente contro l’eresia, soprattutto quella di Brethren sullo Spirito Libero. Ciò che attrasse Lutero probabilmente non fu la dottrina di Taulero in sé, ma solo qualche pensiero secondario sparso qua e là nei suoi scritti; forse gli piacque che la parola indulgenza apparisse solo una volta nei suoi sermoni, o forse gradì il fatto che Taulero desse meno importanza alle opere, o forse era affascinato dalla profonda onestà di questo uomo impegnato in un’incessante ricerca di Dio.
SUSONE

Conosciuto anche come Amandus, pseudonimo adottato nei suoi scritti, mistico tedesco, nato a Costanza intorno al 1295. Morì a Ulm il 25 gennaio del 1366. Fu santificato nel 1831 da Gregorio XVI, che istituì la sua festa il 2 marzo nell’ordine Domenicano. Il padre di Susone apparteneva ad una nobile famiglia di Berg; sua madre, una santa da cui Enrico prese il nome, apparteneva ad una famiglia di Sus(o Süs) in Baviera. A 13 anni, Susone entrò nel convento domenicano di Costanza, ove intraprese gli studi preparatori oltre che filosofici e teologici. Dal 1324 al 1327 frequentò un corso supplementare di teologia nella Sede di Colonia, dove insegnava Johann Eckhart (“Der Meister”), e probabilmente anche Taulero, entrambi celebri mistici. A Costanza fu nominato precettore, anche se pare che sia stato destituito tra il 1329 ed il 1334, quando cominciò il suo percorso apostolico. Intorno al 1343 fu nominato priore di un convento, probabilmente a Diessenhofen (Svizzera). Cinque anni dopo, Susone fu inviato da Costanza a Ulrn, dove rimase fino alla morte. La carriera mistica di Susone cominciò a 18 anni, quando, rinunciando ai costumi dissoluti dei precedenti cinque anni, si fece “Servo dell’Eterna Saggezza”, che identificava con l’essenza divina e, concretamente, l’Eterna Saggezza fatta uomo. Da allora un amore ardente per l’Eterna Saggezza dominò i suoi pensieri e le sue azioni. Susone ebbe diverse visioni, si impose severe mortificazioni (che moderò prudentemente in età matura), e sopportò con rara pazienza tormenti fisici, feroci persecuzioni e aspre calunnie. Si distinse fra gli Amici di Dio per le sue opere di restaurazione dell’osservanza nei chiostri. La sua influenza fu particolarmente forte nei conventi femminili, specialmente nel convento domenicano di Katarinental (Schleswig-Holstein), famoso centro del misticismo nel XIII e XIV secolo, ed in quello di Toss, dove viveva la famosa mistica Elsbeth Stagel, che conservò il suo vasto epistolario e ne tradusse una parte in tedesco, nonché apprese la storia della vita di Susone, che egli stesso ampliò e pubblicò. Fu visto dai contemporanei come un predicatore, e la sua fama si sparse in Svevia, Svizzera, Alsazia e Paesi Bassi. Il suo apostolato, comunque, non fu solo dalla parte delle masse, ma con tutte le classi sociali, attirate dalla sua personalità accattivante, tanto da diventarne, spiritualmente, un punto di riferimento. Erroneamente si pensa che Susone abbia formato ll’interno degli Amici di Dio una Confraternita dell’Eterna Saggezza. La cosiddetta “Regola dell’Eterna Saggezza” non è altro che una libera traduzione del suo Horologium Sapientiae, e non comparve fino al XV secolo. Il primo scritto di Susone fu il Libello della Verità, composto negli anni di seminario a Colonia. La sua dottrina fu giudicata negativamente in certi ambienti, molto probabilmente a causa dello stretto rapporto di Susone con Eckhart, chiamato ad approvare o respingere alcune frasi. Ma il testo è stato poi riconosciuto ortodosso. In questo, come in altri scritti, Susone tradisce sì l’influenza del “Meister”, ma nello stesso tempo ne evita accuratamente gli errori. Lo scopo del libro fu di argomentare contro gli insegnamenti panteistici dei Beghini e quelli libertini dei Fratelli dello Spirito Libero. Padre Denifle considera l’opera il più difficile tra i “libelli” scritti da mistici tedeschi. Laddove nel Libello della Verità, Susone scrive in toni contemplativi e si rivolge all’intelletto, nel successivo, il Libello dell’Eterna Saggezza, pubblicato all’inizio del 1328, Susone è schiettamente pragmatico e parla di tutto cuore a “uomini semplici con qualche imperfezione da eliminare”. Bihlmeyer accetta il giudizio di Denifle, che lo considera “il frutto più bello della mistica tedesca” e lo pone accanto alle Omelie di S. Bernardo e L’imitazione di Cristo di Thomas Kempis. Nel 1334 Susone tradusse l’opera in latino: così facendo aggiunse nuovi contenuti all’opera, modificandola così profondamente che perfino il titolo cambiò in Horologium Sapientiae. Il testo rinnovato acquisì una nuova completezza spirituale, linguistica, allegorica e ritmica che lo elesse a testo chiave nei chiostri alla fine del Medioevo, non solo in Germania ma anche nei Paesi Bassi, Francia, Italia e Inghilterra. Allo stesso periodo appartiene il Libello amoroso, la cui autenticità è discussa. Dopo essersi ritirato a Ulm, Susone scrisse sulla sua vita interiore (Vita o Leben Seuses), revisionò i due “libelli”, che insieme con il Libello Epistolare, composto di undici lettere, e un prologo, formano l’Exemplar Seuses. Oltre gli scritti menzionati, ci sono pervenuti cinque sermoni di Susone e 25 sue lettere accorpate nel Grande epistolario che si trovano nell’edizione del Bihlmeyer. Wackernagel ed altri definiscono Susone “un Minnesänger [trovatore tedesco] spirituale in prosa”. L’amore ricambiato tra Dio e l’uomo, il suo tema principale, dà calore e colore al suo stile. Susone usava il dialetto Alamanno con destrezza ed elasticità, contribuendo alla nascita della prosa tedesca moderna, in particolar modo nell’impiego di nuove sfumature semantiche e di significato negli argomenti spirituali. Il suo bagaglio culturale era quello di uno Scolastico del suo tempo, eppure la sua dottrina è assolutamente originale.
BIAGIO PELACANI
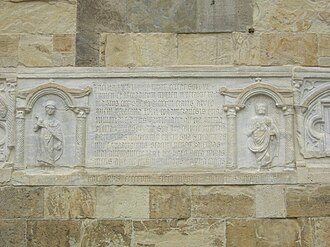
A cura di Gigliana Maestri
Biagio Pelacani (o Biagio Pelicani) da Parma nasce a Costamezzana, vicino Parma, presumibilmente intorno alla metà del XIV secolo. Filosofo e matematico, Pelacani è anche un famoso astrologo, molto stimato da signori e sovrani del suo tempo come, ad esempio, i principi Carraresi di Padova. Insegna filosofia in varie città dell’Italia settentrionale, quali Piacenza, Bologna, Pavia e Padova. All’Università di Padova svolge la sua attività fra il 1382 e il 1387. In seguito, è attestata la sua presenza anche allo Studio Fiorentino. Dopo un periodo trascorso a Parigi, nel 1396 viene condannato dalle autorità ecclesiastiche di Pavia a causa delle sue dottrine materialistiche. Tra il 1407 e il 1411 insegna di nuovo a Padova. A partire dal 1412 è rettore dell’Università di Parma, dove muore nel 1416.
Le sue numerose opere trattano dei più svariati argomenti. Fra i suoi commenti alle dottrine aristoteliche, sono considerate particolarmente rilevanti le Quaestiones de anima. Scrive anche una serie di trattati originali: il Tractatus de ponderibus si occupa di statica, mentre i suoi studi di ottica sono affidati alle Quaestiones de perspectiva; affronta il problema del moto dei pianeti in Theorica planetarum, e quello delle proporzioni nelle Quaestiones de proportionibus, in cui elabora una concezione matematica del vuoto contro le tesi del continuo, tipiche dei fisici aristotelici. Compila poi degli oroscopi mondiali nel 1386 e nel 1411.
Per quanto riguarda la sua speculazione filosofica, Pelacani si rivela critico nei confronti della cosmologia aristotelica e delle interpretazioni teologiche dell’incorruttibilità dei cieli; inoltre, respinge l’idea della necessità di ammettere Dio, quale primo motore immobile, per spiegare il movimento. Contemporaneamente, nega le dimostrazioni a posteriori dell’esistenza divina e dell’immortalità dell’anima individuale. A suo parere soltanto l’universo è eterno, ed è concepito come un animale in costante movimento.
Durante il periodo del suo insegnamento all’Università di Padova, nelle sue lezioni sul De anima di Aristotele, egli sembra anticipare la posizione di Pomponazzi e accentuare la dicotomia ragione-fede. Alle Arti di Padova introduce anche gli sviluppi della fisica aristotelica e della meccanica, elaborati in Francia da Giovanni Buridano e Nicola Oresme, e nei suoi studi si occupa, in maniera particolare, di problemi come la caduta dei gravi e l’accelerazione. La sua attività sembra tracciare le coordinate fondamentali del futuro sviluppo della “scuola padovana”: tendenza a risolvere i problemi metafisici in chiave naturalistica, affermazione orgogliosa della piena autonomia della ragione e profondo interesse per gli argomenti scientifici. In particolare, Pelacani sostiene la tesi della mortalità dell’anima ed è convinto dell’influenza degli astri sull’intelletto umano. Queste posizioni, ben poco allineate con la dottrina cattolica, gli valgono il poco lusinghiero soprannome di doctor diabolicus; ciò non di meno, nonostante i suoi presunti rapporti con le pratiche magiche, egli ottiene la sepoltura nel Duomo di Parma.
Biagio Pelacani è un sostenitore della generazione spontanea e ritiene che, sotto una buona influenza astrale, essa possa dare luogo anche all’anima intellettiva degli uomini. Per quanto riguarda il suo pensiero in materia morale, egli è convinto che la virtù sia premio a se stessa, e che perciò non debba essere perseguita nella speranza di una possibile beatitudine ultraterrena.
Egli deve molta parte della sua fama agli studi di ottica, che influenzeranno artisti rinascimentali come, ad esempio, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti e Filippo Brunelleschi. Pelacani, per il quale l’ottica resta comunque un argomento di carattere filosofico, contesta la distinzione fra la percezione proveniente dall’occhio e quella dovuta al “senso interno”, e sostiene che la facoltà della vista non risiede nell’occhio, ma nel “senso comune”, il quale, dopo aver ricevuto le impressioni visive, le collega, unendole, e le “giudica”. Nella percezione degli oggetti, il colore è sempre inscindibilmente unito alla figura; punti e linee non sono entità fisiche, ma soltanto strumenti della vista, costruzioni dell’immaginazione utili per valutare figure e dimensioni.
TOMMASO DI ERFURT
A cura di Enrico Gori
Tommaso di Erfurt fu uno dei membri più importanti di una gruppo di filosofi tardo-medievali chiamati “grammatici speculativi” e “modisti”, per via del ruolo che assegnavano ai modi sigificandi di una parola nell’analisi logica del discorso. La nozione che una parola, una volta attribuitogli un significato, implica tutti i modi sintattici, o le possibili combinazioni con altre parole, era conosciuta già dal XII secolo. I Modisti tentavano di spiegare le origini dei modi significandi attraverso la teoria del parallelismo tra i modi intelligendi e i modi essendi. Il risultato era un curioso amalgama di filosofia, grammatica e linguistica. L’opera di Tommaso di Erfurt De modi significandi divenne la fonte principale dei Modisti nel XIV secolo, sebbene godrà di maggior fama più tardi, grazie all’erronea attribuzione dell’opera a Duns Scoto. Il testo fu accorpato nell’Opera Omnia di Duns Scoto, dove venne letto e commentato da pensatori recenti quali C. Sanders Peirce e Martin Heidegger, la cui tesi di dottorato del 1916, Die Kathegorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus avrebbe dovuto intitolarsi Die Kathegorien des Duns Scotus und die Bedeutungslehre des Thomas von Erfurt. Heidegger pensa di avere a che fare con Duns Scoto, ma in realtà ha a che fare con Tommaso di Erfurt.
VITA
Quasi nulla si sa della vita di Tommaso da Erfurt, tranne che fu insegnante e filosofo nel primo quarto del XIV secolo. Presumibilmente, egli nacque a Erfurt, nell’odierna Turingia, in Germania. La sua opera tradisce una chiara influenza del Maitre dès Arts parigino Radolfo Brito (ca. 1270-1320) e Sigieri di Courtrai (ca. 1280-1341), il che fa supporre che egli abbia compiuto gli studi, e forse anche insegnato, all’Università di Parigi. Documenti più tardi lo associano alla scuola di S. Severo e allo Schlottenkloster di Sankt Jakob di Erfurt. Il suo testo di grammatica più celebre, il De modi significandi, era già conosciuto nel 1310 e i primi commenti conosciuti risalgono al 1324. Presumibilmente ritornò varie volte a Parigi nel corso della sua carriera accademica, sebbene non vi sia alcuna prova. Alcune copie del De modi significandi attribuiscono l’opera a un religioso inglese del XIV secolo chiamato Tommaso di Occam, ma gli studiosi sono scettici poiché la notizia compare solo in uno sparuto gruppo di manoscritti del XV sec. La stragrande maggioranza dei manoscritti, e delle testimoniane del tempo indicano come autore Tommaso di Erfurt.
SCRITTI
Sei opere sono state attribuite a Tommaso. Oltre al citato trattato di grammatica, il cui titolo completo è Tractatus de modis significandi seu Grammatica speculativa, ci sono pervenuti quattro brevi expositiones (commenti letterali): Isagoge di Porfirio, Categorie di Aristotele, il De interpretatione e il Liber sex principiorum, anonimo. Infine vi è anche un breve scritto di versi mnemonici per l’insegnamento della grammatica ai ragazzi, il Commentarius in carmen fundamentum puerorum, anche se l’editore ritiene che sia una versione anonima ridotta del De modi significandi. In ogni caso, la fama di Tommaso deriva dal De modi significandi, la sola sua opera studiata dettagliatamente. L’opera era così popolare che divenne il testo principe (e più tardi quello che la rappresenterà) della tradizione modista, tanto da essere presente in più di 40 manoscritti del XIV e XV secolo. Un’edizione stampata apparve nel tardo XV secolo. Venne ristampata ben undici volte prima della sua ristampa “definitiva” nell’edizione delle opere complete di Duns Scoto di Luke Wadding (1639).
MODISMO
Come abbiamo già accennato, Tommaso di Erfurt apparteneva a un interessante quanto oscuro gruppo di filosofi del tardo XIII e primi del XIV secolo conosciuti come “Modisti” o “grammatici speculativi”. Il termine “grammatici speculativi” è ambiguo perché è adoperato dagli studiosi di filosofia medievale per indicare i maestri grammatici parigini del XII secolo come Guglielmo di Conches e Pietro Elia, oltre a Ralph di Beauvais, che revisionò sistematicamente le antiche grammatiche di Donato e Prisciano, testi usati nell’insegnamento del latino ai fanciulli per creare un semantica universale. I due gruppi sono collegati, com’è dimostrato, dato che gli ultimi grammatici adotteranno molte teorie e le tendenze universalistiche dei loro predecessori del XII secolo. Predominante fra loro la teoria dei modi significandi, o modo di significato. Il termine Modistae o Modista si riferisce al secondo gruppo. Una concetto grammaticale di modi significandi esisteva già dai tempi di Martino e Boezio di Dacia intorno al 1270. Originariamente, l’idea si riferiva ai diversi modi in cui una parola o espressione può significare qualcosa. Le stesse parole sono il prodotto di un preliminare atto di imposizione attraverso il quale ad un particolare suono corrisponde una determinata cosa o proprietà della stessa: è il suono che definisce l’argomento, che è a sua volta “informato” dall’atto di imposizione. La parola acquista il suo “modo di significare” attraverso un secondo atto di imposizione che codifica tutti i ruoli sintattici che la parola può ricoprire collegata con altre parole ed espressioni ad esempio le parti del discorso che può rappresentare (verbo, sostantivo, avverbio) e le loro forme grammaticali (genere, numero e caso dei sostantivi; il tempo e modo dei verbi). Questi modi influenzerebbero la creazione di forme lessicali della parola nello scritto e nel parlato. Perciò, il latino usa la parola canis per indicare quello che un tedesco indica con Hund, ma gli stessi modi significandi determinano la sua funzione di sostantivo singolare. Metaforicamente si può pensare ai modi significandi come a ganci o cinture di sicurezza della parola poiché riflettono il suo potenziale di combinazione con altre parole nelle proposizioni ed altre costruzioni grammaticali. È facile capire come una tale elaborazione del significato possa portare ad una teoria grammaticale fatta e finita. Senza dubbio, i filosofi speculativi di entrambi i periodi hanno destato interesse sia nei filosofi, sia nei linguisti. Ma la posta in gioco era alta per i modisti, perché l’influsso aristotelico sulla metafisica e la filosofia naturale del tardo XII sec. ed inizio XIII secolo aveva costretto i filosofi a pensare adottando un nuovo paradigma conoscitivo. La grammatica poteva essere concepita come “scienza del linguaggio” (scientia sermocinalis)? La questione era se la grammatica potesse essere considerata a pieno diritto una scienza speculativa aristotelica, ossia se è dimostrativa nel senso di essere un’attività conoscitiva ordinata da un soggetto i cui principi sono universali e necessari. Questioni di questo tipo spiegano chiaramente le lodi della grammatica tradizionale tessute da Boezio di Dacia. Tommaso di Erfurt nelle prime righe del De modis significandi esprime la sua volontà di essere uno di quegli insegnanti:
“La razionalità del metodo. Dato che in tutte le scienze, per comprendere ed acquisire dimestichezza con la conoscenza dei principi, com’è scritto nel 1 capitolo del commento alla Fisica I, chi desiderasse possedere la conoscenza della scienza della grammatica dovrà prima di tutto conoscere i principi primari per sé i cui modi sono modi di significato. Ma prima di cercare la coonoscenza nel particolare, vi sono alcune cose da porre, senza le quali è impossibile avere una corretta conoscenza del particolare”.
Per i Modisti come Booezio e Tommaso, il soggetto della grammatica ha ed è forma corretta, discorso pregnante (sermo congrue significativus), i cui principi sono espressi nel De modi significandi. Ma i Modisti compresero che la teoria del modo di significare includeva anche argomenti sulla natura del pensiero e sulla realtà. Il problema in Prisciano, come i grammatici del XII sec. avevano notato, sta nel fatto che egli aveva taciuto riguardo le parti del discorso. Da qui la necessità di una teoria dei modi significandi. Ma i Modisti capirono che essa poteva costituire solo una parte della risposta, poiché la grammatica è un fenomeno linguistico, e i fenomeni linguistici devono avere una causa all’interno dell’ordine naturale delle cose. Quindi, per completare la spiegazione, dicevano che la struttura formale del modo significare deve la sua esistenza ai modi intelligendi, o “modalità di comprensione”, che sono causati a loro volta dai modi essendi o modalità di essenza presenti un una cosa al di fuori della mente.
Il cuore del progetto Modista è la supposizione che vi sia una relazione di tipo parallelo o triadico tra parola, concetto e cosa. Il significato si basa prossimamente sull’intelletto, ma finalmente sull’essere. Secondo Tommaso:
“Ogni modo di significato deriva da determinate proprietà della cosa. Il ragionamento che porta a questa conclusione è il seguente: Non essendo i modi di significato o le nozioni di essi fittizi, logicamente dovranno derivare dalle cose rappresentate. In sintesi: l’intelletto, per dotarsi di significato pone la voce sotto un modo di significato, e considera la proprietà della cosa da cui ha tratto il modo di significato; questo perché l’intelletto, essendo un potere indeterminato passivo di sé stesso, non progredisce ad atto determinato a meno che non sia determinato da un’altra fonte. Per cui, imponendo la voce per significare in modo determinato, l’intelletto è necessariamente mosso da una proprietà intrinseca della cosa; quindi la proprietrà della cosa, o modus essendi, corrisponde a qualsiasi modus significandi”.
I modi significandi non potrebbero logicamente svolgere alcuna funzione di causalità nelle parti del discorso, né i corrispettivi modi significandi nella determinazione dei modi significandi, né i modi essendi per i modi intelligendi se tutti questi non esistessero. Partendo da questo presupposto, i Modisti ripresero l’idea aristotelica secondo cui, sebbene i simboli usati per indicare suoni e parole siano diversi da luogo a luogo, “ciò che rappresentano – influenze dell’anima – sono lo stesso per tutti; ciò a cui queste influenze assomigliano -cose esistenti – sono anch’esse uguali [per tutti]” (De interpretatione). Allo stesso modo, l’ordine dei modi imitava l’ordine aristotelico delle discipline nella scienza speculativa: come la psicologia, lo studio delle cose mobili animate, è subordinato alla fisica, lo studio delle cose che si muovono, e la fisica è subordinata alla metafisica, studio che esistono, così i principi grammaticali (modi significandi) derivano dagli atti mentali di significato (modi intelligendi), che riflettono il modo in cui le cose esistono (modi essendi). Gli schemi teorici perdono affidabilità davanti ai fatti. I Modisti impiegavano molto tempo a spiegare concetti così oscuri. Dopo aver delineato nei primi capitoli della sua opera le origini dei modi significandi, Tommaso affronta alcune obiezioni: come può “dea” essere significato con un sostantivo femminile che connota passività? Risposta: un modo di significare non deve essere per forza tratto dalla cosa significata, perché può essere talvolta tratto dalla proprietà di “una cosa di suono diverso”. Così, se diciamo “in Dio”, non intendiamo attribuirGli una qualità passiva, ma solo immaginare Lui toccato dalle preghiere. Quando si usa un modus significandi in relazione a Dio, ciò che facciamo realmente è significare la nostra concezione passiva femminile o maschile di un’altra cosa che funge da ricevente, ad esempio qualcosa che corrisponde ad una determinata modalità di essere ricevente, e poi si impone la stessa parola per significare Dio. Allo stesso modo, imponiamo nomi alle cose che non possiamo percepire tramite i sensi o le proprietà delle cose sensibili, attribuendo quindi “modi significandi attivi ai loro nomi”.
E le parole che designano oggetti fittizi come “chimera” o privazioni come “cecità”? Queste non corrispondono ad alcun modus significandi, attivo o passivo, non significando niente (quindi nessuna cosa). Secondo Tommaso, i modi attivi per significare le chimere “sono tratti dalle parti che immaginiamo comporre una chimera, ossia testa leonina, coda di drago etc”. Invece, i nomi di privazioni, “designano i modi intelligendi delle privazioni ossia i loro modi essendi attraverso i propri modi significandi di privazione”. L’idea è che “cecità” corrisponda alla nostra concezione positiva di vista assente, che ha un modus essendi positivo nel nostro intelletto. Perciò: sebbene le privazioni non siano essenze positive fuori dall’anima, esse sono tuttavia positive nell’anima; e dato che la loro comprensione è la loro essenza, quindi, il loro modus intelligendi viene ad essere il loro modus essendi. La cecità fuori dall’anima non può causare alcuna concezione di sé da sé, non esistendo la cecità in sé, e ciò che non esiste non può essere causa di nulla. Quindi, quando diciamo “Omero era cieco”, la parola “cieco” significa attivamente il modo passivo di comprendere qualcosa come essere senza vista, e deve la sua funzione semantica al modo in cui il concetto corrispondente è inteso. Nel caso in cui i concetti non siano né fittizi né privazioni, questi modi intelligendi sono determinati dai corrispettivi modi essendi, ad esempio da sostanze e proprietà effettive esterne all’anima. Per i Modisti, quindi, la parola “chimera” e “cavallo” sono diverse, ma solo in termini di complessità dei loro modi sottostanti. Tommaso segue Sigieri di Courtrai nella sua distinzione tra modi intelligendi/significandi per spiegare la differenza tra l’atto di significare/comprendere (materialmente inteso come proprietà della cosa significata/compresa). Il fatto che niente risponda al nome “chimera” non ha importanza. Il Modismo era una teoria sul significato di una parola in opposizione alla suppositio, che era considerata appannaggio dei logici. Inoltre, se le verità grammaticali sono universali e necessarie o meglio, se esiste una scienza della grammatica allora queste verità non possono essere influenzate dal fatto che le chimere non esistano. L’affermazione-guida di Tommaso nelle ultime pagine del trattato è che alcune cose palpabili debbano avere una corrispondenza con le verità grammaticali. Per questo motivo non vi sono aporie. Tommaso affronta subito dopo argomenti più pratici come le parti del discorso (“Etymologia”) e la sintassi (“Diasynthetica”). In quest’ultima sono inclusi i concetti di constructio (come le parole si colleghino sintatticamente), congruitas (la formazione di tali costruzioni) e di perfectio (la formazione di espressioni complete). Le spiegazioni modiste dei fenomeni semantici erano estremamente complesse. Se si considera i molteplici modi in cui una parola può essere un significante con le sue potenzialità di combinazione con altre parole nelle espressioni, vi potrebbero essere infiniti modi significandi, una proliferazione di modi ripetuti costantemente al livello di modi intelligendi. Il De modis significandi fu l’ultima opera a sviluppare consistentemente la dottrina modista. La sua chiarezza e relativa brevità portarono alla sua adozione a testo standard nelle università medievali, sostituendo il più antico dei modi significandi di Martino di Dacia. Ma dal 1330 per ragioni non ancora chiare, il Modismo era scomparso da Parigi, rimpiazzato dal più esauriente Summulae de dialectica di Buridano. Il Modismo non riuscì mai a superare certe difficoltà, come il suo rifiuto di riconoscere un contesto extra-linguistico, non riuscendo così a spiegare come i significati possano essere trasmessi anche attraverso espressioni imperfette o incongrue. Ma la ragione più probabile del suo abbandono era che le sue spiegazioni non erano più ritenute soddisfacenti. Quello che si proponeva di fare, argomentare sulla sintassi della grammatica latina, poteva essere raggiunto con mezzi meno dispersivi. Inoltre questa teoria divenne assurdamente complicata nel suo intento di salvare i fenomeni dei modi significandi, facendo supporre che i modi furono schiacciati sotto il loro peso, come accadde a molti epicicli tolemaici.
INFLUENZA
L’opera di Tommaso di Erfurt ha goduto di più attenzione di quanto non ne avrebbe potuta meritare, grazie all’erronea attribuzione delle sue opere a Duns Scoto. Fu quindi stampato insieme alle opere scotiste di logica nell’edizione secentesca di Luke Wadding e nel XIX secolo nella ristampa di Wadding da parte di Juan-Luis Vivès. Fino a poco tempo fa, l’edizione Wadding-Vivès fu la fonte più completa delle opere di Duns Scoto, così che consultandola si sarebbe associato il De modis signficandi a lui. A complicare le cose è il fatto che Duns Scoto fu influenzato dal Modismo nella sua prima fase, anche se questo è dovuto probabilmente ai suoi contatti con autori modisti quali Simone di Faversham e Andrea di Cornovaglia. È improbabile che Scoto fosse stato influenzato da Tommaso di Erfurtt, poiché il De modis significandi non iniziò a circolare che molto dopo la morte di Duns Scoto.
Una delle figure più prominenti che hanno dimostrato un’ammirazione incondizionata per Tommaso fu il pragmatista americano Peirce, che considerava Duns Scoto come il compagno di viaggio nella metafisica e la cui teoria semiotica assomiglia sotto certi aspetti a quella modista. Peirce cita i primi sei capitoli del De modis significandi in una lezione del 1869 in cui confronta le tesi di Duns Scoto (così crede lui) con quelle di Guglielmo di Ockham, sui nomi e significati. Ma la lezione è di carattere introduttivo, quindi non è certo se Peirce apprezzasse davvero cos’era in gioco nella grammatica modista piuttosto che considerarla una specie di addendo linguistico alla metafisica scotista.
Un altro importante filosofo che fu influenzato da Tommaso fu Martin Heidegger, il cui Habilitationsschrift fu pubblicato nel 1916 con il titolo Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Questo testo non fu mai studiato molto dagli allievi di Heidegger, il che è un peccato perché tratta più del progetto heideggeriano di ampliare la nozione husserliana di una grammatica aprioristica, invece di essere un’opera di esposizione ed interpretazione filosofica. In quella che sembra essere una sottovalutazione classica, lo storico della filosofia medievale Martin Grabmann scrisse del libro, nel 1926, “Heidegger ha dimostrato la continuità del “Grammatica speculativa” finora attribuita a Duns Scoto con la terminologia e l’aspetto intellettuale generale di Husserl, così che la struttura e particolarità della sua origine medievale è in qualche modo oscurata”. A discolpa di Heidegger, il filosofo tedesco non finge mai di fare della storia della filosofia nel Die Kathegorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotuis. Al contrario, afferma all’inizio della seconda parte che è principalmente interessato alle implicazioni dello scritto di Scoto in funzione della più vasta teoria del significato, e che raccoglie nonostante tutto consensi attribuendola a Duns Scoto.
Nel 1922, tuttavia, Grabmann dimostrò che Tommaso di Erfurt era il vero autore del De modis significandi, e non Duns Scoto. Così, quanto scritto da Heidegger nell”Habilitationsschrift è solo parzialmente vero. La prima metà, la Kathegorienlehre, è dedicata, correttamente, alla teoria scotista delle categorie così come fu sviluppata sulla base dei commenti all’Isagoge di Porfirio, delle Categorie di Aristotele e del De sophisticis elenchis. Ma la seconda metà, la Beedeutrungslehre, è basata quasi interamente su Tommaso di Erfurt.
Influenze più recenti risalgono a Jacques Derrida, che menziona Tommaso collegandolo con l’idea, mutuata da Peirce, che la Logica è una branca della Semiotica: “come in Husserl (ma l’analogia, sebbene dia da riflettere, finisce qui e bisogna applicarla con cautela), il livello più basso, la fondazione della possibilità della logica (o semiotica) corrisponde al progetto del Grammatica speculativa di Tommaso di Erfurt, erroneamente attribuita a Duns Scoto”.
Ciò che colpisce Derrida non è tanto la riduzione della logica a grammatica come il potenziale decostruttivo della fenomenologia dei segni di Husserl. L’idea di decostruire la scienza del linguaggio sarebbe apparsa assurda a Tommaso, naturalmente, anche se avrebbe probabilmente scorto delle affinità con la nozione, altamente variegata, del segno nella semiotica moderna.
TEODORICO DI CHARTRES
Scarse sono le notizie che abbiamo circa Teodorico di Chartres. Fratello minore di quel Bernardo che aveva inteso i moderni come “nani sulle spalle di giganti”, Teodorico insegnò forse a Parigi: verso il 1140 divenne reggente a Chartres e successivamente si ritirò in un monastero. Qui morì all’incirca nel 1150.
Sappiamo con certezza che Teodorico difese strenuamente Abelardo al concilio di Soissons e che scrisse un manuale finalizzato all’insegnamento delle arti liberali. Intitolò questo manuale, secondo l’uso dell’epoca, Heptateuchon, cioè – tradotto alla lettera – “le sette mura”. Il riferimento è, chiaramente, alle sette arti necessarie per la comprensione della Scrittura: non è un caso che, nello stesso secolo, venissero raffigurate tali sette arti sul portale della cattedrale di Chartres.
Teodorico, oltre all’Heptateuchon, compose anche commenti all’opera di Boezio Sulla Trinità e alla Genesi, la quale dev’essere, ad avviso del nostro autore, interpretata anzitutto alla lettera e non in senso allegorico o simbolico.
Entrando nel vivo della sua riflessione filosofica, Teodorico distingue quattro diversi modi d’essere delle cose. Di questi quattro modi in cui sono le cose, due sono modalità della necessità e due della possibilità.
a) La necessità assoluta è la forma in cui si danno le cose come “piegate” (complicatio) nella semplicità tipica di Dio.
b) La necessità dell’ordine è quella secondo la quale si sviluppano (explicatio) le cose. Questa necessità viene dagli uomini chiamata “fato”.
c) La possibilità assoluta è la modalità secondo la quale in cui le cose sussistono come meramente possibili (e dunque non ancora determinate) nella semplicità di Dio.
d) La possibilità determinata è la modalità in cui le cose ci si danno abitualmente nella realtà sensibile: è, di fatto, il mondo che è in atto.
Teodorico si riallaccia poi alla dottrina aristotelica delle quattro cause, interpretandola in maniera compatibile con la verità cristiana: infatti, la causa materiale è rinvenuta nei quattro elementi, che sono stati creati da Dio; la causa efficiente è Dio padre; la causa formale è la Sapienza divina (Cristo), che conferisce ordine alla materia; e infine, la causa finale è lo Spirito Santo, che conferisce alla materia già allestita ordinatamente.
Oltre che ad Aristotele, Teodorico si accosta anche a Platone, secondo l’usanza tipica della Scuola di Chartres, la quale, com’è noto, era caratterizzata dalla riscoperta del mondo naturale interpretato secondo le coordinate fissate dal Timeo platonico.
L’avvicinamento di Teodorico al platonismo risulta evidente nella misura in cui egli identifica lo Spirito Santo con l’anima del mondo su cui s’erano soffermati diffusamente Platone e i Neoplatonici.
Nella concezione fatta valere da Teodorico, la natura è ordinata e disciplinata da Dio e si sviluppa poi autonomamente, in virtù della rotazione dei cieli (da tale rotazione si generano il calore e la vita) e in virtù dell’azione delle cause seconde che Dio stesso ha immesso negli elementi. Teodorico compose anche un’opera intitolata De Sex Dierum Operibus.
GREGORIO DA RIMINI

A cura di Enrico Gori
INTRODUZIONE
Gregorio da Rimini potrebbe essere stato l’ultimo grande Scolastico del Medioevo. Fu il primo pensatore a conciliare gli sviluppi della tradizione post-occamista ad Oxford e la tradizione post-auriolana a Parigi: questa sua sintesi ebbe un impatto duraturo sul pensiero europeo. Attraverso un grave fraintendimento della sua dottrina, Gregario è stato qualificato come tortor infantium (torturatore dei bambini), poiché avrebbe condannato alle pene eterne i bambini che muoiono senza il battesimo: niente di ciò; Gregorio espone le due sentenze e non si pronuncia per nessuna delle due. È, stato detto che egli fu antesignanus nominalistarum (antesignano dei nominalisti). Gregorio da Rimini ( conosciuto anche come de Arimino, Ariminensis, tortor infantum “il torturatore di infanti” e doctor acutus o autenticus) nacque a Rimini intorno al 1300. Entrò nell’ordine mendicante degli Eremiti di S. Agostino, studiò teologia a Parigi dal 1323 circa al 1329, e insegnò in diversi istituti agostiniani italiani, prima a Bologna, poi, dopo il 1338, a Padova e Perugia. Quasi certamente, Gregorio, mentre si trovava in Italia entrò in contatto con le opere degli Scolastici di Oxford degli anni ’20 e ’30, in particolar modo con Guglielmo di Ockham, Adam Wodeham, Richard Fitzralph e Walter Chatton. Gregorio tornò a Parigi nel 1342 per un anno di preparazione alle lezioni sulle Sentenze di Pietro Lombardo, che tenne nel 1343-1344. Gregorio divenne probabilmente “Maestro di Teologia” nel 1345, ma continuò a revisionare il suo commento fino al 1346, eliminando alcuni passaggi. Nel 1347 tornò in Italia per insegnare a Padova, dove rimase fino al 1351. Successivamente insegnò al nascituro istituto di Rimini fino al 1357, dove fu eletto priore generale degli Agostiniani, succedendo a Tommaso di Strasburgo. Gregorio morì a Vienna verso la fine del 1358. L’opera più importante di Gregorio è il commento a primi due libri delle Sentenze. Il primo ci è pervenuto in venti manoscritti completi, mentre del secondo ne rimangono circa dodici. L’opera fu stampata varie volte dal 1482 al 1532, ristampata nel 1955, e finalmente edita nel 1979-1984 in sei volumi. Alcune parti sono state tradotte, o si stanno traducendo, in francese, tedesco e inglese. Oltre ai commenti scritti e alle sue lettere, scritte durante il priorato, gli sono state attribuite anche opere minori, come un trattato sull’usura, il De usura, stampato a Reggio Emilia nel 1508 e a Rimini nel 1622, e un trattato sulle quattro virtù cardinali, De quatuor virtutibus cardinalibus. Il suo trattato sull’intensione e remissione delle forme, De intensione et remissione formarum corporalium, contiene l’incipit Circa secundum partem huius distinctionis ed è, quindi, solo un estratto dal commento delle Sentenze (libro primo, distinzione 17, parte II).
GREGORIO NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA
Sebbene Gregario abbia goduto di particolare attenzione da parte degli storici del pensiero medievale, comprendere la sua posizione nella storia della filosofia non è facile. Gregorio scrisse in un periodo considerato unanimemente decadente, fideistico, in contrasto con il periodo in cui operò, per esempio, Tommaso d’Aquino; questo punto di vista storico rendeva di per sé difficile una valutazione oggettiva del Riminese. Gli storici hanno definito Gregorio un nominalista, un termine, questo, vasto e vago se applicato ai pensatori trecenteschi; un termine che, quando veniva usato, tendeva a confondere e a offuscare le differenze tra di essi, come per esempio tra Ockham e Gregorio. Al contrario di Tommaso d’Aquino, Enrico di Gand e Duns Scoto, Gregorio fu attivo in un periodo che, fino ad ora, è stato ben poco studiato: ciò rende la contestualizzazione di Gregorio difficile e le affermazioni su di lui precarie. Solo attenti studi diacronici di problemi filosofici specifici possono fornire un quadro preciso del ruolo di Gregorio nella storia della filosofia, e finora pochi studi di questo genere sono stati portati avanti. Generalmente, quello che si sa è che Gregario fu il primo ad introdurre nell’Università di Parigi le innovative idee sviluppatesi nelle scuole inglesi tra Ockham e Bradwardine. Da Gregorio in poi, i nomi di Adam Wodeham, Richard Fitzralph, Walter Chatton, William Heytesbury, Thomas Buckingham, Richard Kilvington, Robert Halifax e altri divennero estremamente popolari tra gli studenti parigini. Gregorio fu profondamente influenzato anche dai contemporanei nella sua università, sia in negativo sia in positivo. L’impatto di Pietro Aureolo è stato a lungo considerato il più consistente, ma studi recenti hanno reso noto che altre figure, come Francesco di Marcia, Tommaso di Strasburgo, Gerardo Odone e Michele di Massa, ebbero un’influenza decisiva sul pensiero del nostro autore. Più chiara è l’importanza di Gregorio nel tardo Medioevo e durante la Riforma. Numerosi scolastici, dopo il 1350, copiarono numerosi brani delle sue opere. Tra le figure importanti che plagiarono Gregorio spiccano Giacomo il Cistercense di Eltville, Pietro d’Ailly ed Enrico di Langenstein, ma anche pensatori di rilievo come Ugolino di Orvieto, Marsilio di Inghen e Pietro di Candia (Papa Alessandro V) conoscevano bene l’opera di Gregorio. Sono pochi filosofi del tardo ‘300 a non aver risentito della sua influenza. L’impatto di Gregorio all’interno e all’esterno dell’Ordine Agostiniano continuò nel XIV secolo. Nella celebre disputa sui contingenti futuri nell’Università di Lovanio (1465-1474), numerosi partecipanti citarono la posizione di Gregorio o la fecero propria. Naturalmente, il fatto che solo i primi due libri del commento gregoriano godettero dell’attenzione pubblica, significa che l’impatto diretto di Gregorio è da ricercarsi negli argomenti trattati nei detti volumi piuttosto che quelli trattati nei libri III e IV, come l’Immacolata Concezione e l’Eucaristia, che avevano a loro volta delle discussioni filosofiche intorno a sé. Forse l’elemento più rilevante del pensiero e dell’influenza di Gregorio è la sua adesione al pensiero di Agostino. Gregorio fu tra gli Scolastici il più attento lettore di Agostino, tanto da attaccare Pietro Auriolo per le citazioni errate del pensatore di Tagaste. L’interesse di Gregorio per le opere di Agostino è stato ritenuto centrale per lo sviluppo di un metodo storico-critico nella teologia filosofica, specialmente nell’Ordine Agostiniano, in parte anticipando i metodi moderni. Insieme a tale metodo, Gregorio fece parte di un generale tentativo di “canonizzare” i principali scritti di Agostino e separare le opere autentiche dal corpus pseudo-agostiniano. Inoltre, Gregorio citò svariate volte e con molta perizia il maestro di Ippona nelle sue opere, incluso il commento alle Sentenze, che, quando non fu plagiato, fu spesso usato come fonte per gli studi su Agostino. Non è quindi una sorpresa se le idee di Gregorio coincidono spesso con quelle di Agostino. Il tipo di Agostinismo dottrinale di Gregorio, influenzato dalla tradizione Francescana più che dalla variante domenicana di Giles di Roma, divenne il fulcro del pensiero degli Eremiti Agostiniani. Quindi, nel XVI secolo esistevano scuole di pensiero Egidiste e Gregoriste, ed una via Gregorii era riconosciuta in molte università come quella di Wittenberg, l’università di Martin Lutero. Il fatto che ogni libo del commento alle Sentenze sia stato stampato sei volte tra il 1482 e il 1532, serve a spiegare perché le idee di Gregorio somiglino a quelle luterane e calviniste. Anche durante la Controriforma, il pensiero di Gregorio trovò terreno fertile in Francisco Suarez. Non è difficile fare una lista delle posizioni filosofiche di Gregorio, e non è difficile spiegare il suo rapporto con Ockham. Sulla filosofia naturale, ad esempio, d’accordo con Ockham, Gregorio era un nominalista e sfruttava il principio del “rasoio di Ockham” per negare l’autonomia di variazione, tempo e moto. Gregorio ritiene anche che il mondo potrebbe essere eterno ed è possibile un infinito. Ma in questi casi si preferisce forse conoscere le idee dei predecessori di Gregorio, come Francesco di Marcia, per valutare l’originalità e le fonti del pensiero gregoriano e per evitare che una possibile lista rimanga tale. Di conseguenza, ci si concentrerà su argomenti sui quali le teorie di Gregorio e dei suoi predecessori hanno fatto maggior luce. Più chiara è l’importanza di Gregorio nell’ultimo Medioevo e durante la Riforma. Molti scolastici dopo il 1350 copiarono diversi brani dalle sue opere. Tra le figure più importanti che plagiarono Gregorio o si servirono dei suoi insegnamenti, spiccano il cistercense Giacomo di Eltville, Pietro d’Ailly ed Enrico di Langestein, ma anche altri importanti pensatori quali Ugolino di Orvieto, Marsilio di Inghen e Pietro di Candia conoscevano bene l’opera di Gregorio. Sono pochi i filosofi dell’epoca che non furono influenzati dall’Ariminensis. L’impatto delle idee gregoriane dentro e fuori dall’Ordine Agostiniano fu vivo anche nel XIV sec. Nella celebre disputa sui contingenti futuri all’Università di Lovanio (1465-1474), ad esempio, vari partecipanti citarono passi da Gregorio, o fecero proprie le sue posizioni. Naturalmente, il fatto che solo i libri I e II del commento di Gregorio siano circolati significa che l’impatto diretto del filosofo è da ricercarsi negli argomenti discussi in tali testi piuttosto che in quelli trattati nei libri III e IV, come l’Immacolata Concezione e l’Eucaristia, che ebbero a loro volta i loro argomenti filosofici. Forse l’elemento più centrale del pensiero e dell’influenza di Gregorio è il suo rapporto con Agostino e la natura di questo rapporto. Gregorio fu un attento lettore di Agostino, il che gli permise di contestare Pietro Aureolo e le sue lacunose citazioni da Agostino. L’interesse di Gregorio per l’opera di Agostino è stato spesso considerato centrale nello sviluppo di un metodo storico-critico nella filosofia teologica, specialmente all’interno dell’Ordine Agostiniano, precorrendo in parte i metodi moderni. Coerente con tale metodo, Gregorio fece parte di un movimento volto a “canonizzare” i testi agostiniani e separare il materiale apocrifo. Le citazioni di Agostino venivano riportate con grande precisione nell’opera di Gregorio, tanto che il suo Commento alle Sentenze fu spesso usato come fonte per studi su Agostino.
Ne segue che le idee di Gregorio erano in gran parte agostiniane. Lo speciale agostinismo di Gregorio, influenzato dalla tradizione francescana, dominò ben presto la filosofia e teologia degli Eremiti Agostiniani. Così, già nei primi anni del XVI secolo vi erano scuole di pensiero Egidiste e Gregoriste, e in molte università era presente una “via Gregorii”, specialmente a Wittenberg, l’università dell’agostiniano Martin Lutero. Il fatto che ogni libro del Commento sia stato ristampato 6 volte tra il 1482 e il 1532 aiuta a far luce sull’importanza delle idee di Gregorio per lo sviluppo successivo di quelle di Lutero e di Calvino. Il pensiero di Gregorio potrebbe essere sopravvissuto in Suarez in epoca post-riformista.
PRESCIENZA E CONOSCENZA
Per molti versi Gregorio fu più un teologo che un filosofo, poiché abbondava con i passi dalle Scritture nelle sue premesse e procedeva per deduzione. Nella sua teologia deduttiva, Gregorio dedicava molte pagine a definire i suoi termini e ad esplorare esaustivamente le implicazioni di possibili soluzioni, una pratica che rende le sue Sentenze piacevoli da leggere e gli valgono un posto tra i classici della filosofia. Nelle distinzioni 38-41 del Libro I, Gregorio affronta il problema della prescienza divina e i contingenti futuri e il dilemma della predestinazione e del libero arbitrio. Le posizioni di Gregorio a riguardo sono state oggetto di studio per decenni, e recentemente gli storici hanno tentato di porre Gregorio nel suo contesto parigino e Ossoniano. Inoltre, il soprannome di Gregorio, “torturatore di infanti”, deriva in parte dalle sue posizioni riguardo la predestinazione. Di conseguenza, discutere su questi argomenti fornirebbe un’esauriente introduzione alla noetica gregoriana e alla posizione nella storia del filosofo.
Gli argomenti di Gregorio sono diretti soprattutto a Pietro Aureolo e ai teologi di Oxford. Per conservare la contingenza degli eventi derivanti dalla volontà umana, Aureolo afferma che le proposizioni su avvenimenti futuri non sono né false né vere, ma neutrali, quindi Dio non sa se l’Anticristo verrà, poiché l’asserto “L’Anticristo verrà” non è né vero né falso. Gregorio, tuttavia, preferì concentrarsi sugli elementi summenzionati. Gregorio comprese che la teoria di Aureolo sulle proposizioni sui contingenti futuri era quella esposta da Aristotele nel De interpretatione, capitolo IX. Gregorio non aveva difficoltà ad ammettere che Aristotele avesse sbagliato. “[Ciò] è in apparenza una buona scusa, ma è in verità un’accusa, per il fatto che le assurdità che derivano [da questa affermazione] non ci convincono che [Aristotele] non lo pensasse, ma ci convince che non deve averlo pensato… Inoltre, teologi moderni [come Aureolo], grandi maestri, hanno detto che la conclusione [negare la verità determinata alle proposizioni sui contingenti futuri] non solo era nelle intenzioni del Filosofo, ma anche che è verissimo e dimostrato….” Per Gregorio, dunque, Aureolo aveva ragione a dire che Aristotele negava il Principio di Bivalenza per le preposizioni sui contingenti futuri. Aureolo pose due regole base per tali preposizioni:
1) se una proposizione sul futuro quale “Socrate correrà” è vera, sarà vera immutabilmente e inevitabilmente, poiché non potrebbe essere falsa.
2) Il significato di tale preposizione sarà necessariamente e volta in essere.
La base delle affermazioni di Aureolo è la teoria modale: l’immutabilità e la necessità sono la stessa cosa. Se qualcosa è immutabile, non potrà essere diverso da ciò che è, e di conseguenza è necessario. Gregorio rispose con una vigorosa ed esauriente difesa della bivalenza e con un’altra teoria modale. La sua difesa della Bivalenza comprendeva una lista dettagliata di regole sulle proposizioni. In breve, Gregorio riteneva che il principio di Bivalenza fosse universalmente applicabile, e Aristotele aveva sbagliato ad ammettere un’eccezione riguardo alle proposizione. Aureolo poneva l’accento sulla semplicità divina e la necessità piuttosto che sulla libertà divina e la contingenza, affrontando uno dei problemi fondamentali della teologia cristiana: se Dio è assolutamente semplice e necessario, qual è la fonte della contingenza? La spiegazione di Aureolo è da cercarsi nel rapporto di Dio con gli eventi nel tempo, ma tale affermazione non soddisfaceva Gregorio, che era convinto dalla profezia biblica che Dio conosce il futuro, e dalla logica che il Principio di Bivalenza è universale. Il problema diventa: se Dio sa se Socrate correrà, e la frase “Socrate correrà” è vera, forse che Socrate non correrà necessariamente? La risposta di Gregorio è una versione della “opinio communis”, una posizione radicata nel pensiero scotista e nella tradizione parigina, perfezionata più tardi da Ockham e gli oxfordiani posteriori spostandola sulle proposizioni. È possibile che Ockham fosse influenzato da Aureolo nella sua concentrazione sulle proposizioni contingenti futuri, come alcuni pensano, ma non c’è nulla che faccia supporre che Ockham conoscesse le posizioni di Aureolo, e comunque, dopo Scoto, era naturale pensare che le proposizioni contingenti future erano di primaria importanza. L’opinio communis si basa sulla libertà divina di preservare la contingenza nel mondo: ogni cosa, oltre Dio, è contingente, poiché Dio vuole e agisce liberamente e contingentemente quando crea, perciò è logicamente impossibile per le cose non essere state o essere state. Allo stesso tempo, la posizione comune afferma l’immutabilità divina e la conoscenza determinata delle cose. Il fatto è che le proposizioni vere sul futuro sono sempre state vere e lo sono immutabilmente, anche in maniera determinata, ma sono solo contingentemente vere e non in maniera necessaria. Così dicendo, Gregorio nega l’equazione aureoliana di necessità e immutabilità. La posizione di Gregorio si basa su un utilizzo interessante dei comuni mezzi e distinzioni logici sviluppati a Parigi e Oxford nel corso del secolo precedente, come la distinzione tra i sensi di proposizione divisi e composti, e quella tra contingenza assoluta e condizionale. Lo scopo di queste distinzioni era fornire un modo di spiegare la contingenza degli eventi, ma così facendo si ammetteva la contingenza ultima di tutto tranne Dio. In ogni caso, lungi dall’essere un’affermazione della “contingenza radicale” del mondo, come alcuni storici hanno supposto, era il solo modo che avevano i teologi di salvare un po’ di contingenza dalla minaccia del determinismo logico e divino assoluto. In effetti, Gregorio ed altri ammettevano che, se Dio conosce il futuro, il futuro era necessariamente “ex suppositione”, sebbene non in modo assoluto poiché è logoicamente possibile per Dio, ente immutabile, di conoscere altro. Aureolo, Pietro da Rivo, Pomponazzi e Lutero avrebbero considerato tali sforzi deboli e inutili. Le posizioni di Gregorio, pur non essendo originali, sono straordinariamente chiare e precise. Egli evidenziava perfino problemi nelle discussioni che approvava del tutto, come quelle occamistiche. Tutto ciò che Gregorio sostiene si trova in Francesco di Marchia, Michele di Massa, Landolfo Caracciolo, Adam Wodenham e altri, ma nessuno di questi teologi l’ha mai esposto in maniera così precisa e organizzata. Un altro elemento della teoria modale gregoriana che merita attenzione è la contingenza o necessità del passato. La “opinio communis” riteneva che il passato è in qualche modo necessario in senso forte, anche se non è assolutamente necessario. Pare che Gregorio non si sia spinto così lontano da dire che il passato è necessario (oltre la normale necessità “ex suppositione”), ma fa una sorta di distinzione modale tra il passato e il futuro. Quindi si può affermare che Gregorio non pensava che Dio potesse cambiare il passato.
PREDESTINAZIONE
La predestinazone era l’argomento principale delle distinzioni 40-41 dei commenti alle Sentenze, libro I. La predestinazione può essere considerata una branca più prettamente teologica della prescienza e dei contingenti futuri, argomenti di natura più filosofica, che erano stati esaminati nelle distinzioni 38-39. Come per la prescienza, Gregorio procede con cautela, definendone i termini e considerando le possibili posizioni. L’inclinazione agostiniana di Gregorio si manifesta qui più che altrove. Dalla Lettera ai Romani, 9.13, dove Paolo commenta il passo di Malachia, 1.2 (“Giacobbe ho amato ma Esaù ho odiato”), Gregorio desume che Dio sceglie attivamente chi salvare e chi dannare, teoria, questa, chiamata della “doppia predestinazione”, o “doppia elezione particolare”. La questione principale è definire il collegamento tra la volontà e le azioni umane e la loro salvezza o dannazione, predestinazione e reprobazione: gli uomini sono attivamente responsabili della loro salvezza o dannazione, o tutto è a discrezione della volontà divina? La risposta tradizionale è che gli uomini sono responsabili della loro meritata dannazione, mentre la salvezza dipende unicamente da Dio. Sebbene vi fossero numerose interpretazioni e aggiunte a riguardo, Pietro Aureolo sembra essere stato il primo scolastico a proporre una alternativa seria. Aureolo aveva già tentato di allontanare Dio dall’esistenza terrena, per preservare la necessità divina e la contingentia rerum. Aureolo applica la sua teoria alla scienza della salvezza e afferma che Dio stabilisce delle regole secondo cui certi gruppi di persone saranno salvati e altri verranno dannati, senza una scelta nel dettaglio da parte di Dio. Tale affermazione conservava l’immutabilità divina e ammetteva la simmetria nella reprobazione e nella predestinazione: il fattore determinante è la presenza o assenza di un’ ostacolo alla grazia. Per Aureolo, la presenza di un ostacolo è una causa positiva di reprobazione, mentre l’assenza è una causa negativa o privativa di predestinazione. Aureolo credeva di evitare accuse di pelagianesimo negando la causa positiva di predestinazione nell’eletto. Sembra che Ockham si sia appropriato dei suoi argomenti principali, mentre Walter Chatton di Oxford e Gerardo Odone e Tommaso di Strasburgo di Parigi ammettevano una causa positiva di predestinazione nell’eletto, cosa che li avvicinava alla tanto biasimata dottrina pelagiana. Gregorio reagì affermando che entrambe le cause nell’eletto sono tacciabili di pelagianesimo. Gregorio si mantenne su posizioni tradizionali per quanto riguarda la predestinazione: essa è a discrezione della benigna volontà divina. Tuttavia, la critica di Aureolo della asimmetria dell’opinione tradizionale portò Gregorio ad affermare che non solo gli eletti non partecipano attivamente alla loro predestinazione, ma neanche la reprobazione contribuisce alla dannazione. In breve, non c’è altra ragione per la salvezza o la dannazione dell’uomo, tutto parte dal volere imperscrutabile di Dio: non siamo in grado di sapere perché alcuni sono salvati ed altri dannati. Questa, dopotutto, secondo Gregorio, era la teoria autentica di Paolo e Agostino. La coerenza di Gregorio è ammirevole, così come quella di Aureolo. Aureolo, vista la fallacità della tradizionale teoria dei contingenti, proponeva una alternativa Così facendo conservava il ruolo causale degli uomini nella reprobazione, forse a detrimento della partecipazione alla predestinazione, abbracciando posizioni pericolosamente vicine al pelagianesimo. La teoria di Auriolo non era perfetta ma era coerente. Gregorio invece concordava con l’opinio communis sulla prescienza, ma sulla salvezza forniva una conclusione logica condivisa anche da Aureolo. Posto che l’azione e la volontà divina sono l’unica fonte di salvezza e dannazione, lo saranno anche della contingenza. La salvezza e la dannazione sono naturalmente contingenti, ma non al libero arbitrio umano, ma alla volontà divina. Secondo Gregorio, chiunque fosse d’accordo avrebbe dovuto necessariamente concordare con la teoria della Doppia Predestinazione. Lutero e Calvino concorderanno con Gregorio, ma non vedranno l’utilità della opinio communis, che, per loro come per Auriolo, non preserva la contingenza del volere umano.
ISACCO DELLA STELLA
A cura di Marco Machiorletti
Nato in Inghilterra agli inizi del secolo XII, Isacco si fece monaco nell’abbazia cirstercense dell’Ètoile (in Francia), della quale divenne abate nel 1147. Pochi anni prima della morte, avvenuta nel 1169, fondò un’abbazia nell’isola di Rè, nell’Atlantico, vicino alla costa francese.
Isacco ci ha lasciato, come altri cistercensi che hanno seguito l’esempio di san Bernardo, una serie di Sermoni sul Cantico dei cantici, ma egli cerca Dio meno attraverso l’estasi che attraverso la metafisica. Questo è sicuramente il caso di otto di questi sermoni (XIX-XXVI), coi quali Isacco eleva il pensiero fino a Dio con un’analisi dialettica a un tempo solida e sottile della nozione di sostanza. Vi si sono scoperte diverse influenze, ad esempio quella dello Pseudo-Dionigi e di Anselmo da Aosta, ma si può aggiungere, volendo, l’influenza di Boezio e di Gilberto de la Porre (il Porretano), senza che l’originalità di Isacco ne sia sminuita. Queste pagine sono una testimonianza notevole della profonda penetrazione della spiritualità da parte della metafisica in quest’epoca. Ma l’opera più celebre e più influente di Isacco è la sua Epistola ad quemdam familiarem suum de anima, scritta su richiesta di Alchiero di Chiaravalle. Questa epistola è un vero trattato sull’anima, che dovette il suo successo alla minuziosa classificazione delle facoltà che essa contiene. Vi sono tre realtà: il corpo, l’anima, e Dio; di nessuna di esse noi conosciamo l’essenza, ma conosciamo l’anima meno del corpo, e il corpo meno di Dio. L’anima, posta tra Dio e il corpo, conviene in qualcosa sia con l’uno che con l’altro, e, per la sua stessa posizione intermedia, ha una parte bassa, un centro e una sommità. La parte bassa dell’anima, o immaginazione, è imparentata con la parte più elevata del corpo che è la sensibilità; la parte più elevata dell’anima, l’intelligenza, è imparentata con Dio. Tra queste due facoltà estreme si dispongono tutte le altre secondo un ordine ascendente partendo dal corpo: senso corporale, immaginazione, intelletto, intelligenza.
MARSILIO DI INGHEN

A cura di Enrico Gori
Marsilio di Inghen, magister all’Università di Parigi (1362-1378) e di Heidelberg (1386-1396), scrisse una serie di trattati di logica, filosofia naturale e teologia diffusi in molte università tardo medievali e della prima età moderna. Marsilio adottò l’approccio logico-semantico di Ockham e Buridano, difendendo contemporaneamente le posizioni tradizionali di Tommaso e Bonaventura. Il suo pensiero fa luce sul dibattito tra nominalisti e realisti e consente di rendersi conto dei nuovi interessi della teologia e della filosofia, dall’atteggiamento critico di molti autori del Trecento alla ricerca della tradizione caratteristica del Quattrocento.
VITA E OPERE
Marsilio nasce intorno al 1340 a Nijmegen, nei Paesi Bassi orientali. Nelle fonti più antiche è spesso scritto che proveniva da Inghen, villaggio alle porte di Nijmegen, ma il dato è errato. Ciò deriva da una lettura frettolosa dell’oratio funebris pronunciata da Nicholas Prowin nel 1396 al funerale di Marsilio e pubblicata a Magonza nel 1499. Dal 1362, Marsilio fu magister alla Facoltà delle Arti all’Università di Parigini, dove fu anche rettore (1367 e 1371) e studente di teologia. Insegnante a Parigi, Marsilio fu molto stimato e le sue lezioni avevano un grande pubblico. Tra gli studenti c’erano molti suoi compatrioti, alcuni dei quali provenienti da Nijmegen e dintorni. Nel 1378 venne delegato dell’Università alla corte di Papa Urbano VI a Tivoli. Nel 1379 chiese a un collega, Ugo di Hervort, di occuparsi dei suoi affari a Parigi. Dopo il 1379, Marsilio non è più menzionato negli atti dell’università parigina. La causa della rottura con Parigi fu probabilmente il clima di corruzione venutosi a creare intorno al Grande Scisma del 1378. Intanto Marsilio mantenne i contatti con Nijmegen. Nel 1382 il consiglio cittadino diede un banchetto in suo onore. Dal 1386 Marsilio fu magister all’Università di Heidelberg, di cui fu rettore non meno di nove volte, negli anni 1386-1392 e nel 1396. Nel 1389-90, nuntius con Corrado di Soltau, fece trasferire i registri dell’università a Roma, dove era Papa Bonifacio IX. All’inizio degli anni ’90 Marsilio riprese gli studi di teologia. I maestri erano allora i Corrado di Soltau (dal 1378) e Matteo di Cracovia (dal 1394, entrambi dell’Università di Praga). Nel 1395/96 Marsilio concluse le lezioni sulle Sentenze e fu così il primo teologo ad ottenere il dottorato a Heidelberg. Morì poco tempo dopo, il 20 agosto 1396.
Marsilio fu scrittore prolifico, le sue opere sono il frutto dei suoi insegnamenti a Parigi e Heidelberg. Molti dei suoi scritti sono conservati in numerosi manoscritti e qualche edizione stampata quattrocentesca, sebbene alcune opere siano state pubblicate recentemente con apparati critici.
Le sue opere più importanti si suddividono in:
Logica ed epistemologia:
Esposizione della Vecchia Logica, Questioni sulla Vecchia e Nuova Logica, Sommario della Vecchia e Nuova Logica.
Trattati sulle proprietà dei termini: Della supposizione, ampliamento, restrizione, obbligo, appello, insolubili e conseguenze
Filosofia naturale e metafisica:
Sommario della Fisica aristotelica, Questioni sul ‘De generatione et corruptione’, Questioni sul ‘De anima’, Questioni sulla ‘Metafisica’.
Etica
Questioni sull’’Etica nicomachea’.
Teologia
Questioni sulle ‘Sentenze’ di Pietro Lombardo.
PENSIERO
Logica ed epistemologia
Seguace del nominalismo trecentesco sulla scia di Ockham e Buridano, Marsilio non si considerò, tuttavia, mai nominalista o seguace di Ockham. Era un pensatore indipendente che attingeva dalla tradizione del XIII secolo, ad esempio da Pietro Ispano, o da teorie più vicine al sentire comune in opposizione al linguaggio eccessivamente tecnico dei contemporanei. Marsilio trattò questioni logiche ed epistemologiche in quasi tutte le sue opere, come le Questioni sulle Sentenze di Pietro Lombardo, che furono utilizzate anche nei trattati di logica della prima età moderna. Il nominalismo di Marsilio si evidenzia nella trattazione di quale sia l’oggetto della conoscenza scientifica, la natura degli universali e la dottrina logica della supposizione. Il suo assunto di base è che vi sono solo individuali fuori della mente umana.
L’oggetto della conoscenza scientifica
Secondo l’aristotelismo accettato da Marsilio, l’oggetto della conoscenza scientifica deve essere universale e necessariamente vero. Ciò non accade con gli oggetti individuali nel mondo esterno, essendo questi soggetti al mutamento. Solo la conclusione di un sillogismo vero e necessario può essere accettato. Per Marsilio, quindi, l’oggetto della conoscenza scientifica non è fuori della mente ma la proposizione mentale che si riferisce agli oggetti individuali e alle loro qualità. In altre parole, il vero oggetto della conoscenza scientifica è una proposizione in forma di conclusione dedotta da premesse necessarie.
Gli universali
Marsilio sosteneva che i concetti universali come umanità non si riferiscono a corrispondenti reali fuori dalla mente umana. Di conseguenza, negli individui non c’è l’essenza universale. Gli individui di un genere o specie si assomigliano, e questa somiglianza è il fondamento dei concetti universali nella mente umana La generazione di concetti universali è un processo naturale, descritto da Marsilio nel modo seguente: L’individuo A della specie S evoca il concetto X nella mente umana. Tale concetto è simile al concetto Y evocato da B appartenente ad S. Astraendo dalle differenze tra X e Y, la mente umana può produrre un altro concetto Z, che vale per A e B. L’universalità è dunque una qualità di Z, il prodotto dell’operazione epistemologica di astrazione su X e Y.
La supposizione
Coerentemente, Marsilio rifiuta la supposizione semplice. I logici come Pietro Ispano avevano usato la nozione per indicare che un termine indicava non un individuo ma una natura universale o comune nel mondo esterno, come il termine uomo nella proposizione L’uomo è una specie. Rifiutando l’idea di universali esterni alla mente, Marsilio eliminava la supposizione semplice dalla lista dei diversi tipi di supposizione. Marsilio era critico nei confronti di contemporanei come Alberto di Sassonia, che rifiutavano sì gli universali reali, ma riconoscevano la supposizione semplice. Secondo Marsilio, avevano cambiato il significato del termine sostenendo che un termine scritto o parlato aveva in sé la supposizione semplice se usato per riferirsi a un concetto nella mente umana. Marsilio si chiedeva se gli studenti più giovani sarebbero stati in grado di capire il significato di supposizione semplice pur non capendo bene cosa fossero i concetti. Per evitare confusione, Marsilio decise di trascurare la supposizione semplice. Esempio della singolarità della logica di Marsilio è la sua analisi della proposizione Socrate è una chimera, frase che altri consideravano vera. Secondo il metodo parigino, invece, la frase è falsa perché, non esistendo chimere, il riferimento è nullo. Altrimenti la scuola parigina (scola Parisiensis) è abbandonata e si preferisce la prospettiva del linguaggio comune (communis modus loquendi); ad esempio, nella frase ‘l’Anticristo non è ma sarà’, il riferimento è nullo perché l’Anticristo non è. Ma nel linguaggio comune il riferimento sussiste perché è al futuro Anticristo. Marsilio, nonostante l’autorità di cui godeva la prima soluzione, preferì sempre la seconda.
Filosofia naturale e metafisica
Marsilio era un empirista nel campo della filosofia naturale e della metafisica, ossia credeva che ogni conoscenza scientifica si basa o sul senso o sulle proposizioni auto-evidenti, ossia proposizioni in cui il significato del predicato è nel soggetto. Chiunque conosca il significato dei termini di tali proposizioni, le giudica evidentemente vere. Ciò ha conseguenze piuttosto importanti sulla relazione tra filosofia e teologia. Dato che il filosofo usa solo i dati sensati e le proposizioni auto-evidenti, la sua ricerca può portare a conclusioni diverse di quelle del teologo, che ha in più la conoscenza datagli dalle Scritture. Il filosofo giudica il mondo da una prospettiva umana e perciò limitata, il teologo è aiutato dalla Rivelazione. Tuttavia Marsilio si occupò della visione filosofica con impegno, poiché secondo lui la mente umana ha una naturale tendenza a cercare la verità, soddisfatta (sebbene non del tutto) dalla filosofia naturale e dalla metafisica.
La Creazione
Secondo i principi della filosofia naturale, la creazione dal nulla è impossibile. I sensi ci mostrano che tutto deriva da qualcosa. Poiché non c’è motivo di dubitare dei sensi, la mente umana giunge al principio universale del nihil ex nihilo, spinta dalla sua tendenza alla ricerca della verità. Di conseguenza la creazione dal nulla è impossibile per la mente umana, poiché contraddice nihil ex nihilo. Il fatto che Dio abbia creato il mondo dal nulla è un dogma (sola fide est creditum). La Rivelazione mostra che la conoscenza umana della creazione è limitata e non può avere aiuto sufficiente dalla filosofia naturale o dalla metafisica.
Teoria dell’anima umana
Nel tardo Medioevo, lo studio dell’anima divenne parte della filosofia naturale. Marsilio affrontò l’anima umana nel suo commento al De anima aristotelico, in cui seguiva Buridano e Oresme. Come Buridano, sosteneva che non vi sono prove a sostegno dell’immortalità dell’anima. Per la mente umana, senza l’aiuto della Rivelazione, la teoria di Alessandro di Afrodisia per cui l’anima è corruttibile è plausibile. Solo la Rivelazione può farci ammettere la falsità di tale teoria e quindi l’immortalità dell’anima. La Fede è più autorevole della Ragione, e vi si deve dare credito ogniqualvolta le due entrino in conflitto, poiché ciò che si crede per fede viene da Dio, il quale non può sbagliare
Metafisica
Sebbene la metafisica non possa oltrepassare i limiti della conoscenza umana, Marsilio la considerava la via d’accesso alla teologia. La ragione naturale può formare concetti veri e adeguati di Dio, e anche proposizioni vere sullo stesso soggetto, oltre a dimostrare che Dio esiste e possiede conoscenza e volontà. Ma non può dimostrare il libero arbitrio o il potere infinito. Questo, sosteneva Marsilio, era vero anche per filosofi come Aristotele, i cui insegnamenti sono pari a quelli della ragione naturale. Da Buridano Marsilio riprese l’idea che Dio secondo Aristotele e Averroé non è solo la causa finale dei cieli e delle sostanze separate, ma anche la loro causa efficiente. Su questo punto, Buridano e Marsilio seguivano Scoto e Ockham contro Giovanni di Jandun e Gregorio da Rimini. E’ bene notare, a riguardo, che nei Punca super libros Metaphysicae, riassunti dell’opera aristotelica a scopo didattico attribuiti a Giovanni de Slupcza e scritti a Cracovia nel 1433, alcune opinioni di Buridano riprese da Marsilio, come quella appena esposta, sono attribuite allo stesso Marsilio, nonostante il fatto che l’autore conoscesse entrambi gli autori e i loro Commenti. Questo dimostra la grande influenza di Marsilio sulla metafisica quattrocentesca. Tuttavia, Marsilio non concordava con Buridano su alcune dottrine. Ad esempio, Marsilio considerava la soluzione di Buridano del problema della possibile separazione degli accidenti dalla loro sostanza in disaccordo con gli insegnamenti aristotelici, e quindi non propriamente metafisici, ma piuttosto teologici. Solo in modo miracoloso Dio avrebbe potuto vincere il potere di sostegno della sostanza, separando così l’accidente dal suo custode naturale. Secondo Marsilio, comunque, tale intervento divino non va preso in considerazione in sede di metafisica, dove il filosofo deve usare la sola ragione.
Attributi e idee
Secondo la lezione appresa da Wodeham, Dio è perfettamente uno. La saggezza divina e tutte le altre perfezioni attribuite a Dio sono in realtà tanto identiche all’essenza divina quanto questa lo è a se stessa. Nell’essenza divina non vi è distinzione o non-identità tra gli attributi di Dio. Ogni distinzione tra attributi divini è necessariamente di natura razionale e fabbricata dall’uomo. Una posizione ugualmente radicale è contemplata a proposito delle idee divine. Le idee non sono distinte formalmente in Dio, come qualche scotista sostiene, ma oggettivamente ed estrinsecamente distinte. La loro distinzione è la conseguenza della varietà delle creature di Dio (ecco il perché dell’estrinsecità) e del fatto che Dio le considera diverse (distinzione oggettiva). Dio sa di essere la causa di infinite differenze tra le creature. Ecco perché la Sua mente contiene idee infinitamente differenti. Marsilio criticò l’idea di Occam per cui l’idea di Dio coincide con la creazione. Se fosse vero, sosteneva Marsilio, l’idea di creare una pietra deve essere identica alla stessa pietra o alla pietra come è conosciuta da Dio. Nel primo caso, Dio deve guardare al di fuori di sé nella sua idea, il che contraddice Agostino, citato da Ockham. Nel secondo caso, l’idea di creazione della pietra non è la pietra stessa, ma la prescienza divina della stessa.
Teologia e logica
Marsilio progredì nella sua critica all’uso della logia in teologia nella sua disputa sulle dottrine di Robert Holcot. Holcot aveva sostenuto che logicamente Dio può essere chiamato causa del male. Se Dio è la causa di tutte le entità, e il male morale è un’entità, allora Dio è causa del male. Marsilio riconosceva che l’argomento poggiava su premesse vere, ma la conclusione non può essere ritenuta vera poiché contraddice la fede e potrebbe creare confusione ai fedeli. I teologi non dovrebbero esagerare nell’esibire i propri talenti logici, ma esprimersi tenendo conto della divinità. Le loro opere non dovrebbero minare le credenze della gente comune, non esperta della logica, ma rafforzarne la devozione e la spiritualità. Marsilio tuttavia teneva ad evitare la dipendenza della prescienza divina dagli esseri umani. Nella sua discussione delle idee di Wodeham sulla casualità della volontà umana, lamentava che Wodeham non aveva enfatizzato il fatto, dato che permetteva il seguente argomento: se un evento E accadrà, Dio conoscerà E dall’eternità; ma se non-E accade, Dio conoscerà non-E dall’eternità; dato che l’uomo è libero, egli può scegliere tra E e non-E, quindi può cambiare la prescienza divina. Per Marsilio l’argomento è logicamente corretto, ma porta a concludere che la prescienza divina dipende dalla volontà umana, il che è assurdo: l’eterno non può sottomettersi al creato. Quindi tale dottrina non è valida. Meglio, dunque, ammettere che Dio è onnisciente delle attività umane senza esserne dipendente.
I sacramenti
L’ultima parte del Commento alle Sentenze è dedicato ai sacramenti: seguendo Tommaso e Bonaventura, Marsilio sosteneva che Cristo, dicendo ‘questo è il mio corpo’ (Mc 14:22) durante l’Ultima Cena, si riferiva a ciò che il pane e il vino hanno in comune. Tommaso di Strasburgo aveva criticato tale idea, ma Marsilio dimostrò che all’inizio Tommaso aveva ragione, più tardi ebbe torto. Nella disputa sulla causalità dei sacramenti, Marsilio seguiva Bonaventura, secondo cui i sacramenti non hanno causalità propria. E’ Dio che agisce quando questi sono amministrati correttamente. Solo in senso ampio è corretto dire che i sacramenti hanno il potere di agire.
L’influenza di Marsilio è stata notevole, specie grazie alle sue opere logiche e ai suoi commenti d Aristotele. Ciò si deduce non solo dal numero dei manoscritti conservati, ma anche da altre considerazioni. Il commento agli Analitici primi fu usato a Praga negli anni 80 del 1300. Le sue opere logiche, come le Obligationes e le Consequentiae, furono usate come libri di testo a Vienna nella decade successiva. I commenti alla Metafisica e alla Fisica furono letti a Cracovia nei primi sessanta anni del Quattrocento. All’università di Heidelberg, Erfurt, Basilea e Friburgo le sue opere furono studiate per tutto il XV secolo, specie nell’ambito curricolare dell’università. Nel 1499 i dottori e maestri della Via moderna all’Università di Heidelberg pubblicarono un volume che conteneva epigrammi su Marsilio scritti da noti umanisti come Jakob Wimpfeling, e una difesa del nominalismo sulla scia di Marsilio (Via Marsiliana). Lodi in forma di epigrammi si trovano anche nell’edizione strasburghese del 1501 del commento alle Sentenze. Le Obbligazioni, stampate nel 1489 con il nome di Pietro d’Ailly, furono usate da Thomas Bricot, John Major e Domingo de Soto. Il commento agli Analitici primi fu citato d Agostino Nifo, Jodocus Trutvetter e Bartolomeo di Usingen, che consolidarono il nominalismo a Erfurt citarono spesso Marsilio nelle loro opere. Sia Leonardo da Vinci che Galileo fecero riferimento al commento al De generatione et corruptione. Le dottrine teologiche di Marsilio ebbero altrettanto successo: il commento alle Sentenze divenne noto a Cracovia nella prima metà del Quattrocento, e fu usato da Tommaso de Strampino nei suoi Principia (1441-1442). L’Università di Salamanca aveva una cattedra per il commento alle opere di Marsilio e Gabriel Biel. Il commento alle Sentenze venne citato da teologi spagnoli come Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina e Francisco Suàrez, spesso a proposito di questioni inerenti la grazia e la prescienza divina.
ALCUINO DI YORK

Tratto dal “Manuale di storia della filosofia medievale” dell’Università di Siena
Alcuino nacque in Northumbria intorno al 735. Il suo nome – Alcuino – significa “amico del tempio”. La sua famiglia d’origine era benestante, e ad essa appartenne anche s. Willibrord (Bonifacio). Fu ben presto spedito a York per studiare (greco, ebraico, grammatica, retorica) sotto la guida di Egberto e di Aelberto. Nel 767 venne ordinato diacono proprio da quest’ultimo, al quale succedette alla guida della scuola di York, fino al 786, anno in cui fu chiamato da Carlomagno a dirigere la schola palatina, e ad occuparsi della ri-organizzazione dell’insegnamento in Francia e nell’impero. Trasferitosi a corte nel 782, prese parte attivamente al dibattito intorno a questioni inerenti alla teologia e svolse anche incarichi politici. Nel 796, venne nominato abate di S. Martino presso Tours. Trascorrerà là gli ultimi otto anni della sua esistenza, nel tentativo di rianimare lo zelo della locale comunità monastica, caratterizzata da costumi fin troppo rilassati. Morì a York nell’804. L’intero corpus di opere alcuiniane, tradizionalmente considerato dalla critica di scarsa originalità, può essere schematicamente suddiviso in una mezza dozzina di grandi categorie: opere pedagogiche (De grammatica, De dialectica, De rhetorica, un frammento proveniente dal De musica, l’opuscolo De Orthographia, la Disputatio Pippini cum Albino scholastico), teologico-filosofiche (De animae ratione ad Eulaliam virginem, De virtutibus et vitiis ad Widonem comitem, Liber adversus Haeresim Felicis, Adversus Felicem libri VII, Adversus Elipandum libri IV, De fide sanctae et individuae Trinitatis, XXVIII quaestiones de Trinitate), poetiche (Oratio in nocte, De cuculo, Certamen Veris et Hiemis, De clade lindisfarnensis monasterii), storico-agiografiche (De sanctis Eboracensis Ecclesiae, Vita sancti Willibrordi), liturgiche ed ascetiche (Liber Sacramentorum, De Psalmorum usu, Officia per ferias, De baptismi caeremoniis, De confessione peccatorum ad pueros s. Martini). A queste opere devono essere aggiunte le importanti revisioni alcuiniane dei testi sacri (Interpretationes et responsiones in Genesim, Compendium in Canticum Canticorum, Commentaria super Ecclesiastem, Commentaria in s. Iohannis Evangelium, Tractatus super tres s. Pauli ad Titum, Ad Philem et ad Hebraeos Epistolas, Commentarium in Apocalypsim libri V) ed il suo ricco Epistolario, dalla lettura del quale si apprende molto circa il suo impegno per la ripresa degli studi nei centri monastici dell’impero ed i suoi numerosi interessi. La figura di Alcuino si colloca nel contesto della cosiddetta rinascenza carolingia: egli fu infatti il grande esecutore del progetto politico elaborato da Carlomagno e il prototipo di una nuova classe dirigenziale di stampo imperiale. La sua attività si svolse prevalentemente in ambito pedagogico: introdusse infatti un sistema di studi ordinato secondo le sette discipline (trivio e quadrivio), che rappresentavano le sette colonne del palazzo della sapienza. Scrisse inoltre manuali per l’insegnamento, che debbono essere considerati veri compendi del sapere classico tramandato nelle opere di Prisciano, Donato, Isidoro e Beda (per la grammatica), Cicerone (per la retorica), Agostino (per la dialettica). Promosse il rinnovamento della didattica, e favorì un ritorno all’uso del latino corretto, polemizzò (specie nel Dialogus de rethorica et virtutibus, in cui l’interlocutore è Carlomagno) contro l’uso sofistico della dialettica, ritenuta d’altro canto importante strumento per la vita civile e politica. Per la prima volta dopo molti secoli, infatti, una cerchia di intellettuali, riunitisi attorno alla corte di Carlomagno, si pose un obiettivo che non fosse il mero consolidamento del sapere già acquisito, dibattendo importanti problemi filosofici e teologici. In questo contesto si manifesta una concezione del bello e dell’arte sostanzialmente autonoma. Carlomagno, anche al fine di porsi come legittimo erede degli imperatori romani, fu un sostenitore del canone artistico classico, ma dovette sempre tenere conto della forte specificità germanica dei popoli che governava: per questo la sua politica oscillò spesso fra i poli del neoclassicismo (elemento romano) e dell’anticlassicismo (matrice germanica). La politica estetica neoclassica di Carlo si impose, tuttavia, più facilmente a livello teorico piuttosto che pratico: se, infatti, la nozione agostiniana di “ordo” (ordine) costituì uno dei pilastri dell’estetica carolingia, nella produzione artistica rimase ben evidente l’elemento germanico, caratterizzato da un maggiore astrattismo rispetto alla romanità classica. Nell’estetica carolingia, della cui specificità Alcuino fu ampiamente responsabile, si trovarono a convivere un tratto ascetico ed uno maggiormente terreno: alla bellezza eterna (pulchritudo aeterna), la cui contemplazione è fonte di felicità eterna, si contrappongono la bellezza della forma (pulchra species) e il gusto per il decoro (amor ornamenti), che procurano piacere all’occhio, ancorché effimero. Anche in questo contesto, come in gran parte della cultura carolingia, siamo di fronte ad una commistione di motivi platonici e fede cristiana. Come si evince dalle discussioni tenute nell’ambito dei sinodi di Aquisgrana (811) e Tours (813) gli autori carolingi considerano autonoma l’arte in quanto a forma, ma non in quanto a contenuto: giacché l’arte non è di per sé né pia né empia, ma il suo valore (dignitas) è determinato da un fattore formale e da uno contenutistico: del primo decide l’artista, del secondo il teologo. In ambito filosofico e teologico, Alcuino riprende numerosi temi tipici dell’agostinismo, come l’inconoscibilità dell’essenza divina, e la spiegazione del dogma trinitario a partire dalla triplice natura dell’anima umana. Fu un esegeta e un teologo non particolarmente originale, ed uno dei sui meriti consiste nella ripresa di temi psicologistici: in particolare nel De animae ratione, che può essere considerato il primo trattato di psicologia medievale, si delinea una teoria della sensazione fondata sull’attività del soggetto senziente, secondo la quale le sensazioni e le immagini sensibili sono plasmate dall’anima. La sensazione intesa come atto dell’anima recupera, attraverso temi tipici dell’agostinismo, il fulcro della concezione platonica dell’individuo: l’anima come “principium individuationis” della personalità umana, incorporea, immortale e teleologicamente rivolta alla contemplazione del bene sommo. Anche la gnoseologia alcuiniana è caratterizzata dalla presenza di elementi della tradizione patristica venati di platonismo: la figura di Cristo rappresenta di fatto l’intelletto del padre, una sorta di luogo platonico delle forme universali della creazione. Il compito degli inventori delle arti (i filosofi) è quello di rintracciare questa razionalità sotto la scorza dell’accidentalità sensibile, elaborando una teoria della conoscenza che possa essere applicata all’intera realtà, come riflesso delle leggi divine che la governano. Strumento privilegiato di questa analisi è il metodo dialettico, considerato da Alcuino il fondamento stesso della ricerca filosofica: nel dialogo Disputatio de vera philosophia, il maestro esorta un discepolo alla conoscenza dell’ordine cosmico attraverso la propria anima ed all’adeguamento ad essa, fine ultimo della natura umana.
Il metodo dialogico fu utilizzato da Alcuino anche nel tentativo di chiarificazione razionale della verità teologica: sia per quanto concerne questioni riguardanti il dogma trinitario e l’esistenza di Dio, sia nell’ambito della lotta contro gli argomenti propugnati dagli adozionisti. Nel De fide sanctae trinitatis attraverso un processo dimostrativo di carattere sillogistico, si perviene ad una parziale chiarificazione razionale del dogma, secondo il modello agostiniano e tramite l’utilizzo della distinzione aristotelica fra sostanza-accidente e l’analisi basata sulle categorie.
La mediazione fra la cultura pagana e la nuova esigenza, dettata dalla politica di Carlomagno, di conciliare l’ideologia cristiana e quella imperiale, fu il grande risultato dell’opera di Acuino, che fu inoltre capace di proporre un’alternativa alla strategia monastica benedettina – che riteneva come condizione primaria l’isolamento dal mondo – fondando e garantendo dignità ad un modello ascetico fondato sulla scuola e sull’importanza della cultura e riconquistando lo spazio storico, spesso trascurato a favore di quello ascetico e metastorico.
BERTOLDO DI MOOSBURG
Tratto dal “Manuale di storia della filosofia medievale” dell’Università di Siena
Scarse sono le informazioni che disponiamo sulla vita di Bertoldo di Moosburg, la cui vita può però essere approssimativamente collocata tra il 1316 e il 1361. Egli occupò un posto di primo piano fra i lettori domenicani che insegnarono in Germania nel XIV secolo. La sua carriera fu quella tipica di un intellettuale dell’ordine: studi all’estero (Oxford 1316), lettorato presso cattedre prestigiose (Ratisbona 1327), attività (certamente dopo il 1335) presso lo Studio generale di Colonia come lector principalis, ricoprendo la prestigiosa cattedra che era stata occupata in precedenza da personaggi come Alberto Magno e Eckhart. Più o meno contemporaneo di Taulero e di Suso, Bertoldo faceva parte di quel gruppo di giovani intellettuali che vissero direttamente le discussioni e la delusione provocati dall’affare Eckhart, che culminò nel 1329 con la promulgazione della bolla In agro dominico. Mediante il suo progetto filosofico di commentare non Aristotele ma un testo neoplatonico, gli Elementi di teologia di Proclo, che la tradizione universitaria, soprattutto la scolastica parigina, aveva ignorato, Bertoldo contribuì a risolvere la crisi post-eckhartiana riannodando il filo interrotto della tradizione filosofica dei domenicani tedeschi, facente capo, attraverso Ulrico di Strasburgo e Teodorico di Freiberg, ad Alberto Magno. Fu probabilmente nel periodo coloniense (1327-1361) che compose il suo monumentale commento, la Exposito super Elementationem theologicam Procli, una vera e propria summa del neoplatonismo medievale, l’unica opera di Bertoldo giunta fino a noi, ad eccezione di alcune glosse ad un testo di Teodorico di Friburgo riguardanti la questione della determinazione dei poli dell’arcobaleno. Il commento di Bertoldo era letto ancora nel Quattrocento e fra i suoi estimatori ci fu anche Nicola Cusano che nell’Apologia della dotta ignoranza (1449) lo citava, insieme ai rappresentanti del neoplatonismo cristiano in polemica contro la scuola aristotelica. L’Expositio, solo in parte edita, è un intarsio potente e esteso di testi filosofici neoplatonici mediante i quali Bertoldo affronta tutti i problemi della metafisica neoplatonica e riassume, attorno alle tesi degli Elementi di teologia, l’intero pensiero platonico greco, arabo e latino, trasformando in un sistema unitario i vari momenti della continuità della sua tradizione, dallo Pseudo-Dionigi fino ai contemporanei domenicani tedeschi.
Bertoldo riteneva Proclo non soltanto il filosofo sottile che espose la metafisica più penetrante dell’antichità – perché aperta, al di là dell’essere, alla contemplazione dell’Uno, e quindi superiore alla metafisica aristotelica che era, secondo Bertoldo, scienza di un settore soltanto della realtà –, ma soprattutto egli lo considerava il pagano che aveva raggiunto la sommità della contemplazione di Dio mediante l’esercizio assiduo della filosofia, e che testimoniava personalmente, nei suoi scritti, delle sorprendenti potenzialità nascoste nell’uomo o, più precisamente, nell’uno dell’anima (il fiore dell’intelletto della tradizione mistica), in quel principio, cioè, capace di divinizzare ogni uomo dedito alla pratica della filosofia. Proprio l’uno dell’anima che per molti aspetti sembra riecheggiare il fondo dell’anima (grunt der sele) eckhartiano è uno dei motivi che dimostrano la volontà di Bertoldo di prolungare, seppur evitando accuratamente ogni riferimento esplicito, le istanze speculative di Eckhart.
CASSIODORO

A cura di Paola Bernardini
Nato a Aquillace verso il 490, Flavio Magno Aurelio Cassiodoro fu uno dei funzionari, oltre che segretario particolare, di Teodorico. Alla morte del re goto (526), restò alla corte del nipote e successore, Alarico, per distaccarsene poi, ormai stanco, nel 537. Dopo un periodo a Roma e a Costantinopoli, si ritirò a Squillace, dove si dedicò agli studi e fondò un monastero, Vivarium, che diverrà celebre per la sua opera di trascrizione e conservazione dei codici. Morì nel 583, dopo un’intensa attività intellettuale che continuò a caratterizzare anche i suoi ultimi anni (a novanta anni scrisse un trattato De orthographia). Al primo periodo della sua vita risalgono testi storici: i Chronica, che, sul modello di Girolamo, ripercorrono le tappe della storia umana da Adamo fino al suo tempo, e il De Gaetarum sive Gothorum origine et rebus gestis, dedicato alla storia dei Goti. A Roma compose invece il trattato De anima, che dal punto di vista speculativo rappresenta forse l’opera più significativa, per l’influsso che ebbe sui pensatori dei secoli successivi: in questa si affrontano le questioni tipiche dell’epoca concernenti l’origine dell’anima e la sua natura spirituale e incorporea, la sua localizzazione, e il rapporto che essa intrattiene con il corpo. Cassiodoro si fa sostenitore di una concezione dualistica che, tuttavia, tende a mitigare l’elemento di conflittualità tra le due componenti dell’essere umano, anima e corpo, insistendo invece sull’armonia che caratterizzerebbe questa unione. La rinnovata attenzione per la spiritualità lo spinse a comporre un lungo commento sui Salmi, Expositio in Psalterium, a cui dedicò una decina d’anni di lavoro. Le Institutiones divinarum et humanarum litterarum, opera a carattere enciclopedico tra le più celebri dell’alto medioevo, furono composte nel monastero di Vivarium. L’opera è pervasa da una tensione che mira alla conciliazione tra l’eredità della cultura classica e il messaggio cristiano: lo studio delle arti liberali, che Cassiodoro cerca di rilanciare, deve avere come fine ultimo la corretta esegesi dei testi sacri. Questo atteggiamento non sminuisce l’autentico interesse per gli oggetti delle discipline, che vengono studiati in relazione a singole tematiche, per ognuna delle quali l’autore riporta una stringata bibliografia, ovvero i testi più importanti che le discutono. L’opera è divisa in 2 libri; il primo, articolato in 33 capitoli (tanti quanti gli anni di Cristo), riguarda le divinae litterae: fondando la riflessione sulla Bibbia, insegna in che modo si devono imparare le discipline ecclesiastiche e fornisce notizie sugli storici cristiani; il secondo, suddiviso in 7 capitoli, riguarda le saeculares litterae e propone un programma d’insegnamento delle arti liberali del trivio e del quadrivio, presentando come modelli Elio Donato per la grammatica, Cicerone e Quintiliano per la retorica e Aristotele per la dialettica. In questo quadro la cultura pagana è considerata necessario fondamento per quella sacra. Il secondo libro, in particolare, ha circolato in ambiente monastico come una sorta di manuale di arti liberali, sotto il titolo di De artibus ac disciplinis liberalium litterarium.
CHRISTINE DE PIZAN

A cura di Cinzia Pieraccini
Suo padre fu Tommaso di Benvenuto da Pizzano, medico e astrologo all’università di Bologna; sua madre era la figlia di Tommaso Mondini, consigliere della Repubblica di Venezia. Il padre lasciò Bologna per Venezia nel 1357, e proprio nella città veneta nacque Christine nel 1365. Poco tempo dopo la sua nascita, Tommaso da Pizzano passò al servizio del re Carlo V, per questo, nel 1368, l’intera famiglia si trasferì a Parigi. Bologna e Parigi erano al tempo i due centri maggiori della cultura. Il padre ha goduto, per parecchi anni, di molta considerazione e di notevole benessere. Christine sposò a quindici anni il piccardo Etienne Castel, che le diede due figli maschi e una femmina. Morto il re Carlo V nel 1380, e poco dopo anche il padre, Christine rimase vedova nel 1390. Iniziò così per lei un periodo molto duro durante il quale dovette far fronte ad innumerevoli problemi per sovvenire alle necessità della sua famiglia. Iniziò così a guadagnare con la penna. A partire dai primissimi anni del Quattrocento si impegnò in tutte le lotte sociali e culturali del tempo. Non è chiaro il percorso educativo e culturale che Christine ha seguito; sappiamo però che la sua posizione sociale le ha permesso un eccezionale vicinanza con una delle maggiori biblioteche d’Europa: quella, appunto, di Carlo V. Sappiamo anche che essa fu seguita nell’educazione dal padre, contro il volere della madre, la quale avrebbe preferito che la figlia seguisse il percorso di vita già segnato per ogni femmina. Molti sono infatti gli accenni nelle opere di Christine a questo strano gioco delle parti fra un padre che, seppur maschio, desidera un’istruzione per la figlia, e una madre che la preferirebbe moglie e madre alla stregua delle sue contemporanee. Christine muore nel 1430. Tra il 1390-1410 si può individuare la parte essenziale della sua imponente produzione letteraria. La sua produzione poetica è di carattere lirico, morale e allegorico-didattico e comprende: le Cent ballades, i Virelais, le Ballades d’estrage façon, i Lais, Rondeaux, Jeux a vendre, le Autres ballades, le Complaintes amoureuses, l’Espistre au dieu d’amours (1399), il Dit de la Rose (1402), il Debat de deux amans (1400), il Livre de trois jugemens, il Livre du dit de Poissy (1400), il Dit de la pastoure (1403), l’Epistre a Eustache Morel (1404), le Oroysons a Nostre Dame ed a Nostre Seigneur, gli Enseignemens e Proverbes moraux, il Livre du duc des vrais amans (1405), le Cent ballades d’amant et de dame, Livre du chemin de long estude, il Livre de la mutation de Fortune. Uno dei motivi dominanti della sua opera poetica è la lamentazione per il suo stato vedovile accompagnato dal rimpianto per la felice gioventù. Le opere in prosa comprendono: le Epistres du Debat sur le Roman de la Rose, il Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, il Livre de la Citè des dames, il Livre de trois Vertus, l’Avision Christine, Livre du corp de Policie. Strettamente legate alle vicissitudini del tempo la Lamentation , il Livre de Paix. La monumentalità della sua produzione, ci fa intuire che Christine riesce ad imporsi come un’importante figura del XV sec.; non bisogna però dimenticare che essa, a differenza di un qualsiasi scrittore uomo del suo tempo, ha dovuto, proprio tramite la scrittura, costruirsi un’identità di donna in un contesto sociale e culturale affatto pronto ad accoglierla. Essa fu la prima ad affermare solennemente l’ingresso nel campo delle lettere, osando ”un nuovo punto di vista dal quale scrivere, quello delle donne”. Un punto di vista e una voce che si sono fatti sentire in un’opera diversificata che, come abbiamo evidenziato poco sopra, va dagli scritti filosofici, a quelli politici, religiosi, senza contare la lirica. Christine de Pizan è una “donna virile” che non antepone a se stessa alcuna maschera, ma che, al contrario, fa della sua femminilità una causa da difendere. Accusa e tenta di correggere la fragilità delle donne ne Le livre des trois vertus (1405), all’interno del quale fa una vera e propria classificazione dei ruoli delle donne nella società contemporanea, assumendo quello di pedagoga nei confronti delle altre rappresentanti del suo sesso, le quali ancora devono prendere consapevolezza della loro condizione e della eventuale possibilità di modificarla. Si tratta forse della prima femminista della letteratura francese, visto anche il tentativo di conquistare lo spazio pubblico. All’interno del suo lavoro più celebre, Le livre de la Citè des Dames, troviamo, appunto, una “città in un libro” che contemporaneamente include e trascende le città storiche. Christine introduce le reali comunità femminili storiche nell’allegoria di una città immaginaria, intendendo così creare uno spazio di autonomia e libertà per donne virtuose; spazio che lei non riesce a trovare altrove, neppure fra le mura dei conventi; spazio, inoltre, all’interno del quale le donne saranno protette dalla misoginia. Dai dialoghi che Christine instaura con le tre Dame che incontra, Ragione, Rettitudine e Giustizia, si ricava sia il pensiero dell’autrice rispetto alla svilente condizione della donna, sia la sua profonda riflessione sulle posizioni che la scolastica assume riguardo all’unità della Creazione, alla natura della virtù, alla libertà. Esemplificativa di tutto questo è una delle prime domande che Christine rivolge a Ragione: “Dio ha concesso alle donne una grande intelligenza e un sapere profondo. Ma la loro mente ne è capace?” Domanda che deriva dalla consapevolezza che gli uomini non riconoscono alle donne che delle deboli capacità intellettuali; Christine, con la sua opera, intende dimostrare il contrario. L’autrice espone problemi che risuonano anche nelle pagine nei libri contemporanei: l’accesso all’educazione per le donne, il disappunto che talvolta provano le donne alla nascita di un figlio, l’idea che le donne possano essere carine e ben vestite senza venire meno al loro “voto di castità”, la violenza nel matriomonio. Christine cerca di esplorare i motivi dell’oppressione delle donne discutendo le ragioni della misoginia maschile con Dama Ragione. Quest’ultima intende mostrare che molte donne hanno portato importanti contributi alla civilizzazione e per farlo produce una lista di donne famose, mitologiche, donne dell’antichità e contemporanee, nei vari campi della giurisprudenza, della scienza e della filosofia. Nella seconda parte, con Dama Rettitudine, si fanno molti esempi di donne che hanno o hanno avuto un altissimo senso morale accompagnato da sentimenti di pietà, saggia devozione, integrità, generosità. Usando soltanto i migliori materiali da costruzione, Dama Rettitudine costruisce la città, le strade, i negozi, e tutti i luoghi pubblici e privati. Una volta completata l’opera, Dama Giustizia procede nel popolarla con le donne migliori, cominciando dalla Vergine Maria, con Maria Maddalena e una lunga lista di Sante e Martiri. E’ abbastanza evidente, in quest’opera, l’intento di Christine de Pizan di andare alla ricerca di una genealogia al femminile che unisca in un unico percorso il suo pensiero con quello delle donne del passato e ponga le basi per quelle del futuro. Christine de Pizan fu la prima scrittrice di professione nel senso moderno del termine, che visse del suo lavoro e scrisse per committenti, in un contesto sociale e politico molto preciso, al di fuori delle mura del convento. Forse proprio per questo la sua scrittura è fortemente segnata dal proprio vissuto personale, storico e reale. Se La Citè des Dames è il libro più noto, Christine, come abbiamo evidenziato poco sopra, ha anche al suo attivo molte opere politiche (il Livre du Corps de Policie, Le livre de la Paix, la Epistre à la Reine) tra le quali ricordiamo l’ultima Le Ditié de Jehanne d’Arc (si tratta di una breve poemetto in onore di Giovanna d’Arco). Quello che Christine sembra voler far risaltare in quest’opera ma anche all’interno dell’intera sua produzione letteraria, è il contrasto fra un femminile civilizzatore, proteso alla vita, e un maschile che nella dimensione mitica come in quella quotidiana predilige lo scontro, la distruzione, la morte. Tutto questo in opposizione alla sua reale esperienza personale: Christine ha imparato dal padre mentre la madre ha cercato di ostacolarla nell’acquisizione della strumentazione intellettuale. Scaturisce forse da qui il sentire di Christine come una donna e la consapevolezza di esserlo, mentre nelle sue mani è presente una cultura che è maschile e il cui portato ha bisogno di essere ribaltato.
DAVIDE DI DINANT
A cura di Paola Bernardini
Filosofo naturale e medico, morto intorno al 1208. Visse probabilmente per un periodo alla corte di Innocenzo III, come cappellano, ma più nota è la sua attività di magister a Parigi. Ci sono pervenuti solo alcuni frammenti delle sue opere, tra cui i Quaternuli o Tractatus naturalis e gli scritti di medicina De iuvamento anhelitus (inserito nel corpus di scritti di Galeno) e De anatomia venarum. La lettura dei suoi Quaternuli fu vietata nel 1210 e successivamente nel 1215, insieme a quella della Metafisica e delle opere naturali di Aristotele nell’Università, agli scritti di Amalrico di Bène e Maurizio Ispano. Dai riferimenti della Summa theologiae e del commento alle Sentenze di Tommaso d’Aquino e della Summa theologiae di Alberto Magno è possibile ricostruire alcuni elementi della dottrina di Davide: egli sosteneva che l’essere fosse costituito da tre indivisibili, sostrato di tutte le realtà: la materia, che dà origine ai corpi, la mente, che è il sostrato delle anime e Dio, da cui prendono origine le sostanze separate. Visto che per Davide l’essere è uno e trino, corpi, menti e Dio danno luogo ad un’identità: da ciò l’accusa di panteismo e materialismo formulata dall’autorità ecclesiastica, secondo la quale tale posizione implicherebbe che una concezione di Dio come identico alla materia prima, sostrato di tutte le cose.
GUGLIELMO DI SHERWOOD
A cura di Eleonora Buonocore
Della vita di Guglielmo di Sherwood (o Shyreswood), logico inglese del tredicesimo secolo, poco è noto: fra il 1235 e il 1250 lo troviamo attivo come magister artium a Parigi, dove insegnò logica, successivamente, dal 1252, ricoprì il ruolo di insegnante ad Oxford, e da allora rimase in Inghilterra dove detenne l’incarico di cancelliere di Lincoln fino al momento della sua morte che avvenne fra il 1266 e il 1272. Guglielmo è noto principalmente come autore di alcuni importanti trattati di logica: le Introductiones in logicam, i Syncategoremata, il De insolubilibus e le Obligationes (sulla cui autenticità sono stati recentemente sollevati alcuni dubbi). Le Introductiones, scritte probabilmente intorno al 1250, costituiscono uno dei manuali di logica terministica più usati nel medioevo, insieme alle Summulae logicales di Pietro Ispano: questi trattati sono pervasi da una forte preoccupazione verso l’insegnamento della logica nelle Scuole che si riflette in una sistematizzazione precisa del materiale presentato e nella tendenza ad analizzare approfonditamente le regole formali del discorso che presiedono alla formulazione di propositiones e di argumentationes. Le Introductiones si strutturano infatti come un trattato introduttivo alla logica distinto in sette parti che si occupano rispettivamente della proposizione e delle sue parti, della dottrina dei predicabili, del sillogismo, della topica, cioè dei luoghi logici su cui basare un’argomentazione, dei termini e delle loro proprietà, dei sofismi e dei syncategoremata, ovvero di quei termini, come le costanti logiche, che assumono senso solo in rapporto ad altri termini. Mentre le prime quattro parti riprendono le idee alla base dell’Organon aristotelico che formavano la Logica Vetus, la quinta introduce la dottrina delle proprietà dei termini, intesi come soggetto o predicato di un enunciato: la significatio, cioè la rappresentazione concettuale di un termine (connotazione), i vari tipi di supposititio (denotazione), materialis, simplex, naturalis, che spiegano le modalità con cui un termine può “stare per” un suppositum, ed infine l’appellatio e la copulatio, che rappresentano le altre funzioni semantiche della significatio di un termine; proprio per l’importanza di queste problematiche legate alle proprietà dei termini all’interno dell’opera questo tipo di logica verrà chiamata terministica. Il sesto capitolo si occupa invece delle fallacie, ovvero dei sillogismi falsi, seguendo la trattazione aristotelica del De Sophisticis Elenchis, mentre il settimo analizza l’uso dei termini sincategorematici. I Syncategoremata rappresentano invece un’opera intesa per un pubblico già progredito negli studi di logica: in essa si indaga il significato logico e semantico di quelle parole, ad esempio le costanti logiche, che da sole non forniscono alcuna determinazione di contenuto ma sono funtori logici che prendono significato solo in unione con un nome od un verbo, determinando così un intero enunciato. Guglielmo distingue dunque fra termini descrittivi (categorematici) e logici (sincategorematici), ponendo l’attenzione sulla possibilità di un uso categorematico di alcuni termini in certi contesti e sincategorematico in altri. Il De Insolubilibus si occupa infine dei paradossi logici, come quelli legati ai problemi di autoreferenzialità, ad esempio il paradosso del mentitore, e dei modi possibili di risolverli. Per concludere la logica di Guglielmo di Sherwood esercitò una grande influenza non soltanto sugli altri trattati di logica terministica immediatamente successivi al suo, come quelli di Lamberto di Auxerre e Pietro Ispano, ma anche su tutta la Logica modernorum, fino ad arrivare a Guglielmo di Ockham.
HERRADE DI HOHENBURG (O DI LANDSBERG)

Dal “Manuale di storia della filosofia medievale” dell’Università di Siena
Sappiamo assai poco delle origini di questa monaca colta, che a partire forse dal 1167 fu la badessa dell’antica abbazia di Hohenburg in Alsazia, recentemente rifondata da Federico Barbarossa; di lei abbiamo però un ritratto, l’ultima miniatura del manoscritto che contiene la sua opera, l’Hortus deliciarum (Giardino delle delizie), e vari documenti che ne testimoniano l’attività di organizzatrice vigorosa e intelligente della vita monastica. Partecipò al rinnovamento della vita spirituale del suo secolo, nel quale le donne ebbero un ruolo rilevante, sia attraverso l’attività di direzione della comunità che guidò ispirandosi al nuovo ordine monastico dei Premostratensi; sia con la redazione del già ricordato Hortus deliciarum, che testimonia il suo impegno per promuovere la vita spirituale e intellettuale delle monache a lei affidate. La data di composizione di quest’opera si colloca verosimilmente nel decennio 1175-1185, ovvero quasi contemporaneamente agli anni in cui nel monastero di Rupertsberg veniva redatto il grande manoscritto miniato del Liber Scivias di Ildegarda di Bingen. Benché il manoscritto dell’Hortus deliciarum sia andato perduto, si conservano di esso riproduzioni e testimonianze che ne hanno permesso una virtuale ricostruzione: si tratta di una raccolta organica di testi sulle arti liberali, ampiamente illustrata da miniature non puramente esornative, ma chiaramente coordinate sulla base di un piano didattico e storico: il materiale enciclopedico viene articolato come un grande disegno che ha al suo centro la vita di Cristo. I testi raccolti e l’ordine loro conferito mostrano che si trattava di un libro utilizzato per l’insegnamento, ed esso costituisce quindi un esempio concreto della cultura monastica ancora protagonista nel panorama del XII secolo.
LAMBERTO DI AUXERRE
A cura di Eleonora Buonocore
La biografia di Lamberto d’Auxerre, conosciuto anche come Lamberto di Lagny, è ancora in gran parte ignota: di lui sappiamo soltanto che divenne frate domenicano ad Auxerre ed insegnò a Parigi, dove intorno al 1250 fu Maestro delle Arti insieme a Guglielmo di Sherwood. La sua opera più importante è una Summa di logica, scritta probabilmente nei primi decenni del XIII secolo, che rappresenta insieme ai trattati dello stesso Guglielmo di Sherwood e di Pietro Ispano uno dei manuali più importanti della tradizione parigina (continentale) della nuova logica terministica o logica modernorum. La tradizione parigina della logica si distingueva da quella inglese (o meglio di Oxford) soprattutto per quanto riguarda la teoria della referenza: Lamberto, come gli altri maestri parigini, poneva l’accento sulla suppositio, cioè quella proprietà interna ai termini che si modifica ogni volta che un termine è usato all’interno di una proposizione, e sosteneva l’esistenza di una distinzione fra supposizione naturale (tutti gli individui a cui naturalmente il termine si riferirebbe) e supposizione accidentale (gli individui a cui il termine si riferisce una volta che è soggetto di una proposizione, sotto la restrizione del tempo di un verbo). Lamberto d’Auxerre si distingue inoltre perché, come Ruggero Bacone a Oxford, si interessa degli impieghi auto-referenziali di un termine all’interno della supposizione semplice, anticipando alcuni sviluppi della logica successiva ed in particolare del pensiero di Ockham.
LANFRANCO DI PAVIA
A cura di Eleonora Buonocore Il filosofo e teologo italiano Lanfranco nacque a Pavia intorno al 1005. Nel 1042 si recò in Francia per entrare nel monastero di Le Bec, del quale divenne priore nel 1045 e dove assunse la direzione della scuola monastica: ebbe grande notorietà come maestro e furono suoi allievi il canonista Ivo di Chartres, il futuro papa Alessandro II e il filosofo Anselmo d’Aosta. Nel 1063 grazie ai suoi personali contatti con Guglielmo il Conquistatore divenne abate nell’Abbazia di Santo Stefano a Caen e nel 1070, sempre grazie ai buoni uffici di Guglielmo, venne chiamato a ricoprire la carica di Arcivescovo di Canterbury che occuperà fino alla sua morte, nel 1089. Uomo di grande cultura, fu autore fra l’altro di un trattato di dialettica oggi perduto, di commenti ai Salmi e alle lettere di san Paolo, ma la sua opera più famosa è il Liber de corpore et sanguine Domini adversus Berengarium, scritta intorno agli anni 1065/66 con la quale Lanfranco si inserisce nella ripresa del dibattito sul significato dell’eucarestia, polemizzando con le tesi sostenute da Berengario di Tours e denunciandone la mancanza di ortodossia. Berengario, utilizzando argomentazioni logico- dialettiche, sosteneva che la presenza del Cristo nell’eucarestia era soltanto simbolica e di conseguenza che la formula e l’atto della consacrazione compiute dal sacerdote sull’altare non avevano il potere di mutare la natura del pane eucaristico, come invece voleva la dottrina della transustanziazione. Lanfranco, che pure all’interno della cosiddetta disputa fra dialettici e antidialettici dell’XI sec. può essere considerato un antidialettico, risponde a Berengario rivolgendo contro di lui le stesse armi della dialettica, della quale si dichiara conoscitore: per difendere la transustanziazione e controbattere le argomentazioni logiche di Berengario, egli fa uso della tecnica cosiddetta delle propositiones aequipollentes (proposizioni equivalenti: una nozione probabilmente di origine medio- platonica) che consiste nel costruire argomentazioni non attraverso sillogismi ma tramite una serie di definizioni, allargamenti di significato e precisazioni, che permettono di giungere alla fine a dimostrare l’originaria equivalenza di due proposizioni. Secondo Lanfranco durante la messa, con la formula di consacrazione del sacerdote, avviene un mutamento reale nella sostanza del pane e del vino che diventano il corpo e sangue del Cristo: è questa una conversione di essenza, che coinvolge la sostanza interna della materia ma non le sue qualità esteriori, che mantengono in apparenza la stessa forma. L’opera e gli insegnamenti di Lanfranco, che affiancava ad una strenua difesa dell’ortodossia cristiana l’utilizzo consapevole di argomentazioni logico- dialettiche nelle dispute teologiche, esercitò una notevole influenza sui filosofi a lui immediatamente successivi ed in particolar modo sul pensiero di Anselmo d’Aosta.
GUIDO TERRENA
Il carmelitano Guido Terrena (Guido Terreni, morto nel 1342) fu autore di diversi scritti: tra cui vari commenti ad Aristotele (alla Fisica, al De anima, alla Metafisica, all’Etica, alla Politica), di un Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e di Quaestiones disputatae. Egli nega l’esistenza di una “natura comune” e lo fa prendendo le mosse da un testo di Giovanni Damasceno (il De fide orthodoxa, I. 8): i singoli soggetti empirici Socrate e Aristotele non soltanto hanno ciascuno le proprie differenze individuanti, ma pure la propria specifica umanità. Guido Terrans i trova dunque d’accordo, in questo, con Enrico di Harclay e con la sua tesi per cui “Socrates et Plato distinguuntur per humanitatem in re sicut per socrateitatem et platonitatem”. Guido Terrena estende questa tesi pure ai “generi”: “animal” non è una cosa in quanto attribuito a un asino e un’altra cosa in quanto attribuito a un uomo; e non lo è per un motivo semplicissimo: in un caso, la cosa predicata è un asino, mentre nell’altro caso è un uomo. In una simile teoria – affine, per molti versi, a quella di Ockham – proposizioni del tipo “Socrate è un uomo”, “Socrate è un animale”, “Socrate è sostanza”, e così via, vogliono banalmente dire che “Socrate è Socrate”. Tuttavia, Guido si distingue da Ockham su un punto decisivo: ciò che nel reale corrisponde agli universali è una certa somiglianza tra sostanze che, proprio perché reali, sono però distinte individualmente le une dalle altre; tale somiglianza non è una cosa, ma una “relatio realis” che si basa sulla natura stessa delle cose. Guido Terrena incentra la sua concezione del genere su una sorta di conformità delle sensazioni. Richiamandosi al De anima di Temistio, egli sostiene che un uomo e un asino sono due sostanze senzienti e che in questo risiede la loro somiglianza. Predicare il genere della specie per Guido Terrena non vuol dire predicare il più generale del meno generale, ma il particolare inteso più confusamente dello stesso particolare inteso meno confusamente. In questa ottica, la scienza del genere viene a fondarsi sul singolare: “scientia est de re eadem cum singulari, sub conceptu tamen confuso et universali”. Significativamente, la posizione filosofica di Guido Terrena è stata anche qualificata come una specie di “semi-nominalismo”.
ROBERTO HOLKOT
Il domenicano di Cambridge Roberto Holkot (morto nel 1349) segna uno snodo decisivo nell’elaborazione – di marca occamista – tra la fede e la ragione, tra la teologia e la filosofia: soprattutto il suo Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo è, sotto questo profilo, dirompente. A suo avviso, il mistero della Trinità non può essere conciliato con i dettami della ragione e della logica. Da ciò egli inferisce l’esistenza di una logica di altro tipo, propria della teologia e rimasta sconosciuta ai filosofi. Così, ad avviso di Roberto, Aristotele non è stato in grado di capire che la stessa cosa può essere contemporaneamente una e tre. Ciò non significa comunque che la teologia rinunci alla logica: “oportet ponere unam logicam fidei”, scrive Roberto. E tale “logica della fede” è in qualche modo razionale, ancorché siano differenti i suoi principi rispetto a quelli della logica abituale (“rationalis logica alia debet esse a logica naturali”). Sembra dunque che Roberto ammetta l’esistenza di una logica extra-aristotelica, valida su un piano di intelligibilità superiore rispetto a quello della “ragione filosofica”. È di grande importanza, a questo proposito, il fatto che Roberto recuperi il concetto di “potentia Dei absoluta”, ossia di potenza di Dio sciolta da ogni vincolo: la volontà e la causalità di Dio non hanno limiti, cosicché Egli non approva il peccato e non ne è l’autore, ma ciò non di meno Egli è la causa immediata della volizione che è il peccato. Ne deriva che, se Egli non ne è l’autore responsabile, ne è comunque la causa: “sequitur necessario quod Deus sit immediata causa peccati” (“ne segue di necessità che Dio è la causa immediata del peccato”). La conseguenza che Roberto ne trae è la seguente: Dio vuole l’esistenza del peccato “voluntate beneplaciti” ed Egli può pure “de potentia absoluta” imporre all’uomo di odiarLo. Per questa via, in modo forse ancora più radicale rispetto a Ockham, Roberto distrugge la “teologia naturale”.
ADAMO WOODHAM
Adamo Woodham (Goddam), francescano inglese, fu uno degli scolari di Guglielmo da Ockham a Oxford: città nella quale egli stesso insegnò teologia nel 1340, dopo averla insegnata a Londra. Il suo Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo sarà pubblicato, rivisto, nel 1512. Per la Logica di Ockham, Adamo ha scritto un interessante Prologo: nel quale, tra le altre cose, si lagna del fatto che i suoi contemporanei attribuiscono scarsa importanza alla logica, trascurandola; si trattava, indubbiamente, di un fatto nuovo, se si considera che in quell’Università la logica era stata studiata ininterrottamente per quasi due secoli. Scrive Adamo: “Ne vediamo infatti parecchi che, mettendo da parte questa scienza (haec scientia praetermissa) e volendo però occuparsi di scienze e di insegnamento, si sbagliano in molti modi, disseminando numerosi errori nei loro cuori, e svolgono, senza misura e senza ordine, discorsi prolissi e del tutto inintelligibili”. Tra tutti i pensatori che hanno praticato la logica dopo il sommo Aristotele, Adamo pone al primo posto il venerabile e inimitabile Dottore “tanto eminente per l’umana natura e il genio, quanto può esserlo, in questa vita, l’uomo grazie alle luci divine dall’alto, fratello Guglielmo da Ockham, Minore per il suo ordine, ma sublime per la perspicacia del suo pensiero e la verità del suo insegnamento”. Nonostante egli sia stato “sotto la ferula” di Ockham e l’abbia ammirato, Adamo pare aver ristretto il campo della critica filosofica del suo maestro e forse pure averla ridotta all’impossibilità di provare in modo assolto l’unicità della causa prima.
EGIDIO ROMANO

A cura di Andrea Pesce
Egidio Romano, in latino: Ægidius Romanus, indicato anche come Egidio Colonna (Roma, tra il 1243 e il 1247 – Avignone, 22 dicembre 1316), è stato un arcivescovo cattolico, teologo e filosofo italiano, generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Dopo la sua morte, gli furono tributati i titoli onorifici di Doctor fundatissimus e Theologorum princeps. Fu discepolo di San Tommaso d’Aquino all’Università di Parigi, dove più tardi insegnò, prima di diventare generale degli agostiniani e arcivescovo di Bourges (1295). Fu inoltre il precettore di Filippo il Bello per il quale scrisse il trattato De regimine principum, sostenendo l’efficacia della monarchia come forma di governo. Egidio Romano è considerato tra i più autorevoli teologi di ispirazione agostiniana, attivo anche nella vita intellettuale e politica in un contesto culturale ed istituzionale travagliato da frequenti ed aspre polemiche sul problema del rapporto tra potere temporale e potere spirituale. Questo filosofo è generalmente ricordato, insieme al prediletto allievo Giacomo da Viterbo, per il contributo nella redazione della celebre bolla Unam Sanctam del 1302 di Papa Bonifacio VIII e per il ruolo significativo che assunse il Maestro degli Eremitani di Sant’Agostino quale autore del De Ecclesiastica potestate e, dunque, quale teorico famoso e autorevole della plenitudo potestatis pontificia. In Egidio Romano rileviamo subito una compresenza del duplice atteggiamento dottrinale e politico; infatti è possibile rintracciare, fra le opere giovanili, il De regimine principum, opera scritta per Filippo il Bello e di ispirazione aristotelico-tomista inerente alla naturalità dello Stato, erigendola a difensore della potestas regale. Nel De Ecclesiastica potestate, invece, Egidio Romano afferma la superiorità del sacerdotium rispetto al regnum, distinguendosi quale rappresentante della teocrazia papale. In seguito alle condanne di Étienne Tempier del 1277, Egidio difende la tesi di Tommaso, per la sua qualifica di Baccalaureus formatus, ma, proprio a causa delle condanne stesse, viene sospeso dall’insegnamento. In quegli anni, gli avversari del papato trovano nel pensiero di Aristotele gli strumenti per svolgere un’analisi politica che metta in discussione la sacralità del potere. Dall’altra parte troviamo l’influenza della corrente speculativa dell’agostinismo politico (ossia quel fenomeno, tipicamente medioevale, di compenetrazione fra Stato e Chiesa, all’interno del quale Agostino viene a giocare un ruolo fondamentale dal momento che l’apporto teorico del suo De Civitate Dei conduce a confusioni inevitabili fra il piano spirituale della Civitas Dei Caelestis e il piano temporale della vita terrena che è Civitas Peregrina), che ripropone la teoria delle “due città” e riafferma la superiorità del sacerdotium rispetto al regnum, costituendo un vero e proprio “partito del Papa”. Egidio rivendica la Plenitudo potestatis come proprietà costitutiva dell’auctoritas del Papa in quanto homo spiritualis. Egidio sostituisce al concetto agostiniano di ecclesia, quello di regnum al fine di estendere gli ambiti del potere del sovrano ecclesiastico. Il sovrano ecclesiastico (il Papa) dovrebbe esercitare la sua sovranità anche sul potere temporale al fine di garantire l’ordine mediante una forma di dominium che coincida con la sua stessa missione spirituale.
