FILOSOFIA DEL 1900 – PARTE 1
“Il pensiero stesso è un cammino. Corrispondiamo a questo cammino soltanto restando in cammino” (M. Heidegger, Che cosa significa pensare?)
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO
LO SPIRITUALISMO FRANCESE
Lo “spiritualismo” francese è una filosofia maturata a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento che tende a dare grande importanza alla vita spirituale dell’uomo, cercando di sottolinearne la specificità rispetto a quella materiale; ci sarà perfino chi, come Bergson (nell’ Evoluzione creatrice ), negherà ogni autonomia alla sfera materiale, riconducendola interamente a manifestazione di quella spirituale, sulla scia di quanto aveva già fatto Leibniz secoli prima. Lo spiritualismo nasce e si sviluppa soprattutto in Francia perché si tratta di una filosofia di derivazione essenzialmente cartesiana: proprio Cartesio, infatti, aveva prospettato con l’idea del “ cogito ” la ricerca della verità nell’interiorità spirituale, riducendo la materia ( “ res extensa ”) a pura e semplice estensione nello spazio priva di ogni forma di spiritualismo e vitalità. La contraddizione del pensiero cartesiano, come senz’altro si ricorderà, scaturiva dal fatto che, in definitiva, il pensatore francese non era stato in grado di spiegare in maniera convincente il rapporto tra lo spirito ( “res cogitans”) e la materia (“res extensa”), tra l’anima e il corpo, con l’inevitabile conseguenza che tutti i pensatori a lui successivi si erano sbizzarriti nel tentativo di risolvere il problema in modo migliore: c’era chi, come La Mettrie, si era sbarazzato dell’ingombrante idea di anima e dalla concezione cartesiano dell’ “animale-macchina” era direttamente passato a quello dell’ “uomo-macchina”, e chi, invece, aveva esasperato la sfera spirituale e l’indagine interiore del “cogito”. Proprio dall’attenzione per le istanze spirituali muove i suoi passi lo spiritualismo francese, che si colloca pertanto in modo critico nei confronti del meccanicismo e si inserisce bene nel contesto di quelle filosofie vitalistiche (prima fra tutte quella nietzscheana) che si opponevano al Positivismo e al suo culto acritico della ragione. Tra i numerosi pensatori che hanno aderito al nuovo movimento francese merita senz’altro di essere ricordato Émile Boutroux, che con la sua filosofia ha inciso in modo rilevante sul pensiero di Bergson: alla teoria da lui elaborata egli stesso dà il nome di “contingentismo”; alla base di essa vi è il riconoscimento di una certa contingenza all’interno dei fenomeni che avvengono nel mondo e, come sarà senz’altro noto, una cosa è contingente quando c’è ma potrebbe tranquillamente non esserci. Il nucleo dell’argomentazione di Boutroux è piuttosto semplice e fa perno su quel concetto che da sempre sta alla base del determinismo: il principio di causalità. Esso prescrive che ogni fatto sia causato in modo necessario da un altro fatto, ma Boutroux riesce a scoprire una specie di indeterminazione nella causalità: accettando il concetto di causa, infatti, siamo costretti a riconoscere causa ed effetto non siano la stessa cosa, il che vuol dire, detto in maniera molto schematica, che l’effetto non è tutto già contenuto nella causa, ma presenta qualcosa di nuovo e di differente rispetto ad essa. Il risultato di questo ragionamento è prevedibile: nel mondo, dice Boutroux, devono per forza esistere elementi di contingenza per cui gli effetti han sempre qualcosa di nuovo, che non c’era nella causa. E se Comte diceva che le leggi di una disciplina (ad esempio, la fisica) non sono riconducibili in tutto e per tutto a quelle di un’altra (ad esempio, la matematica), Boutroux ci spiega il perché, facendo notare, appunto, come l’effetto non derivi in maniera così necessaria dalla causa, ma come anzi presenti un qualcosa di contingente. Così, se è vero che diciamo che 2+3 è uguale a 5, quasi come se lo causasse in modo del tutto necessario, non ci sogneremmo mai di dire che lo sfregamento del fiammifero sia uguale all’accensione della fiamma, sebbene in effetti la fiamma venga accesa dallo sfregamento del fiammifero: questo perché l’effetto non si identifica pienamente con la causa, checchè ne pensasse Schopenhauer nella “Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente”. Non è un caso che negli anni in cui Boutroux sviluppa il suo pensiero, Heisenberg elabori il principio di indeterminazione, secondo cui è impossibile determinare con rigore al tempo stesso il moto e la posizione di una particella: né Heisenberg né Boutroux mettono in dubbio l’esistenza di regolarità nel mondo e, per questo motivo, continuano a ritenere valido il principio di causalità, ma avanzano l’ipotesi che sia scorretto ridurre ogni cosa al meccanicismo, facendo considerazioni piuttosto simili, nella sostanza, a quelle fatte duemila anni prima, circa, da Epicuro con la sua teoria del “clinamen”. E del resto il rifiuto di Boutroux e di Bergson e, più in generale, degli spiritualisti francesi, non nasce da una loro ignoranza delle problematiche scientifiche, ma anzi da un’ottima conoscenza di esse, di cui colgono i limiti e le contraddizioni: si tratta, potremmo dire, di un superamento della scienza da parte di chi la conosce a fondo. Il poeta italiano Eugenio Montale si dichiarerà apertamente sostenitore della filosofia di Boutroux e, non a caso, la sua poetica cerca qua e là delle vie di fuga dall’ordine oppressivo della realtà e può essere ben rappresentata dall’immagine, tipicamente montaliana, del muro coperto da cocci di vetro (che rappresenta il limite che impedisce di attingere l’essenza più intima della realtà) che presenta qualche fessura, ovvero qualche tenue possibilità di cogliere l’essenza della realtà; in Montale è, infatti, costante l’idea di una “ maglia che non tiene ”, del muro dalle cui fessure si può sbirciare e cogliere, in modo extra-meccanicistico, la realtà più profonda, anche nei momenti più banali (quando, ad esempio, si sente l’odore dei limoni, dice Montale), che possono rivelarsi invece momenti di fuga dall’ordine soffocante.
LA FENOMENOLOGIA
La “fenomenologia” costituisce una delle principali fonti dell’esistenzialismo, tant’è che molti dei grandi pensatori esistenzialisti (Sarte e Heidegger, ad esempio) sono prima stati fenomenologici: in particolare, Heidegger è stato discepolo dell’eroe della fenomenologia, Edmund Husserl. La tesi fenomenologica formulata da Husserl parte dal recupero di alcune nozioni della tarda-scolastica, prima fra tutti l’ “intenzione”: per Ockham l’intenzione era l’atto con cui la mente si riferisce a qualcosa, per cui se penso ad un oggetto, l’atto con cui la mente si riferisce ad esso è un’intenzione, proprio come un segnale stradale si riferisce a quella precauzione che suggerisce con un’intenzione. Inoltre Husserl riprende la tradizione cartesiana (nel 1931 scrive un’opera intitolata “Meditazioni cartesiane”): fondamentalmente egli mutua dal filosofo francese l’esigenza di arrivare a costruire un sapere assolutamente certo, una filosofia come scienza. E, sotto questo profilo, Husserl ha la pretesa di costruire una filosofia che non si limiti a concetti elaborati in passato, ma che parta dai dati della realtà così come essi si manifestano e proprio per questo motivo la sua filosofia prende il nome di “fenomenologia” ( fainomenon indica appunto il manifestarsi). In questa ricerca di un’assoluta certezza, Husserl si domanda, cartesianamente, se quando ho in mano un oggetto, supponiamo una penna, vi sia qualcosa di certo. E finisce per dire che del fatto che esiste un mondo a me esterno non posso averne certezza e per questo motivo decide di sospendere il giudizio sul mondo ricorrendo al concetto di epoch , elaborato dagli antichi Scettici, che significa appunto “sospensione di giudizio”: con tale atto, Husserl, com’egli stesso afferma, mette il mondo “ tra parentesi ” perché problematico, in quanto non certo. C’è una cosa, però, dice Husserl, di cui ho certezza ed è il fatto di pensare e di avere percezioni (tattili, visive, ecc) di quel mondo messo tra parentesi, sicchè posso costruire una scienza di idee che metta fra parentesi la corrispondenza tra le idee presenti in me e il presunto mondo a me esterno. E, in un certo senso, Husserl vuole ricollocare tutta la filosofia all’interno della coscienza perché ciò gli permette di attribuire alla filosofia stessa una veste di assoluta certezza. Ma questo non toglie che nell’ambito della coscienza sussista un rapporto di intenzionalità: il soggetto percepisce idee, ma che ad esse corrisponda qualcosa in un mondo esterno viene messo tra parentesi; ma, compiuta quest’operazione e quindi escluso l’oggetto come esistente fuori di me, si crea un rapporto soggetto/oggetto nella coscienza. Infatti, quando percepisco il nero, sto percependo, in qualità di soggetto, un oggetto e non è vero, dice Husserl, che i princìpi logici e matematici sono il riflesso del funzionamento della nostra mente, come sosteneva lo “psicologismo”, secondo il quale 2 + 2 = 4 solo perché la nostra testa funziona così: non è possibile, in altri termini, che le leggi logiche e matematiche siano fondate dalla psiche umana. Un po’ come era per Platone, anche per Husserl 2 + 2 = 4 è un oggetto del pensiero ma, a differenza di Platone, per Husserl non è un oggetto esistente in modo indipendente: viceversa, l’esistenza della verità 2 + 2 = 4 risiede nel fatto che all’interno della coscienza esiste un rapporto di intenzionalità per cui quando dico 2 + 2 = 4 non mi sto muovendo fuori dall’alveo della coscienza, ma è un gioco tutto interno alla mia mente. Ma anche se tutto avviene nella mia mente, ciononostante, distinguo tra atto del pensare ( noesiV ) qualcosa dall’idea che viene pensata (noema ), nel nostro caso2+2=4. In altri termini, nel pensare sono sempre compresenti e distinti l’atto del pensare e l’oggetto di tale atto: l’uno si riferisce all’altro con un rapporto intenzionale.
L’ESISTENZIALISMO
Quando l’esistenzialismo nasce, nel Novecento, è un atteggiamento culturale a tal punto di ampia portata da investire, proprio in quanto filosofia dell’esistenza, ogni ambito della cultura del tempo e tende spesso a sfuggire alla trattazione filosofica e, talvolta, ad assumere l’aspetto di una moda letteraria. Senz’altro la fonte principale dell’esistenzialismo è il pensiero di Kierkegaard e il suo interesse per l’io come singolo, ovvero per l’io concreto, sganciato dalla nebulosa astrattezza in cui l’aveva avvolto Hegel. Del resto, osservava molto acutamente Kierkegaard, checchè ne pensi Hegel, noi siamo nel mondo come singoli, ancor prima che come umanità e spirito. L’indagine esistenzialista, pertanto, viene proiettata sull’esistenza dell’io come singolo e sul significato della vita e non è un caso che spesso tenda a slittare verso forme che esulano dal pensiero filosofico, quali la filosofia o la letteratura: del resto già Aristotele aveva fatto notare che la scienza è, per definizione, sempre scienza dell’universale, cosicchè lo studio del singolo uomo e della sua esistenza non è rigorosamente definibile, ma anzi sfugge ad ogni inquadramento intellettuale, con la conseguenza che per indagare l’esistenza del singolo occorre percorrere strade alternative. E così l’esistenzialismo di Kierkegaard, di Lutero e di Pascal provava la via religiosa, mentre quello del Novecento prova, con Sartre e Camus, quella del teatro e della letteratura, poiché il teatro, la letteratura e la religione consentono di presentare situazioni concrete ed individuali. La categoria fondamentale è, dunque, l’esistenza e non l’essenza, sicchè a contare non è ciò che l’uomo è in sé, ma ciò che l’uomo può fare di sé progettando il proprio destino: non vi è nell’uomo un’essenza che determini deterministicamente ciò che egli sarà; viceversa, l’esistenza è una navigazione nel vuoto: si è gettati nel mondo e si deve cercare di dare un senso ad un’esistenza che, priva di senso, ne è sprovvista. Altri grandi esistenzialisti del passato erano stati Pascal e Lutero, i quali si erano interessati non tanto se Dio esistesse, quanto piuttosto che senso avesse per l’esistenza dell’uomo credere in Dio. Nel Novecento, accanto agli esistenzialisti credenti e a quelli difficili da catalogare, come Heidegger (Vattimo dà di lui un’interpretazione non-religiosa), vi saranno anche esistenzialisti atei che riprenderanno le riflessioni di Kierkegaard, rimproverando però al filosofo danese e, in generale, all’esistenzialismo religioso di aver tradito l’istanza esistenzialistica originaria ricorrendo a Dio: infatti, l’esistenzialismo è tutto incentrato sulla possibilità ed essa, per essere tale, non può agganciarsi a Dio, perchè così facendo si approda al porto sicuro della fede e si tappa l’enorme falla del nulla, tipica della ricerca esistenzialista. Camus, ad esempio, insisterà vivamente sul concetto di assurdo e sull’accettazione da parte dell’uomo dell’assurdità dell’esistenza; l’uomo di Camus saprà dunque vivere fino in fondo la condizione di ineliminabile assurdità dell’esistenza, paragonata ad un’inutile fatica di Sisifo. Tuttavia, contro la critica mossa dall’esistenzialismo ateo, si può spezzare una lancia in favore di Kierkegaard, facendo notare come per lui la fede non rinneghi la matrice esistenzialista: infatti, egli non la concepisce in modo tranquillo e sereno, come un porto in cui trovar riparo; al contrario, la vive in modo drammatico e problematico (l’immagine della fede è per lui Abramo), come l’avevano vissuta Tertulliano, san Paolo, Lutero e Pascal, non in modo tranquillo e sereno come Erasmo e Tommaso. Il pensiero kierkegaardiano e, con esso, l’esistenzialismo rinasce, dopo più di mezzo secolo di oblìo, negli anni della prima guerra mondiale e non è un caso che abbia i suoi momenti d’oro subito dopo le due guerre mondiali, quando gli eventi bellici, con tutta la loro drammaticità, tendono a far nascere un vivissimo senso dell’insensatezza dell’esistenza (già peraltro sottolineato dal Dadaismo in campo artistico). Le due guerre mondiali, però, hanno lasciato un senso diverso nella coscienza della gente: la fine della prima guerra mondiale suggerisce l’idea di un crollo dei sistemi tradizionali tanto nei Paesi vincitori quanto in quelli vinti (atteggiamento che traspare benissimo da “Il tramonto dell’Occidente” di Splenger); con il secondo conflitto mondiale, invece, si assiste a genocidi sconvolgenti, mai verificatisi in passato, ma ciononostante si aprono maggiori spiragli di speranza poiché, se la prima guerra mondiale aveva chiuso tragicamente un’epoca in fin dei conti felice (la “bella époque”), con la seconda è crollato un mondo, ma il mondo in questione è quello dominato dai nazisti. All’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, alberga la speranza e la voglia di rivivere nell’animo di tutti e la stessa Resistenza, che aveva valorosamente saputo opporsi alle dittature, non aspirava solo a liberare il mondo dai fascismi, ma anche a creare una società nuova e più vivibile. E così si può dire che tra l’esistenzialismo fiorito all’indomani della prima guerra mondiale e quello sviluppatosi dopo la seconda intercorre una differenza accostabile a quella prospettata da Nietzsche tra nichilismo passivo e nichilismo attivo: come abbiam detto, l’esistenzialismo prevede la mancanza di un’essenza rigorosamente determinata nell’uomo e questo rievoca, per molti versi, l’assenza di essere prospettata da Nietzsche; dallo sgomento che nasce dal sentirsi mancare la terra sotto i piedi si origina un nichilismo passivo, che fa sì che si provi nostalgia per il passato, in cui vi erano valori saldi a cui far riferimento. Al nichilismo passivo, però, subentra quello attivo: cessato lo sgomento scaturito dall’assenza di punti di riferimento, ci si accorge che non resta che crearne di nuovi. Qualcosa di analogo vale anche per l’esistenzialismo novecentesco: è come se nel primo nichilismo, che va dalla prima guerra mondiale alla seconda, prevalesse il nichilismo passivo e pessimista, che intende l’esistenza come smarrimento dell’uomo, come “ amhcania ” ineliminabile; l’uomo è, leopardianamente, gettato nel mondo a condurre un’esistenza priva di senso e la libertà di cui egli gode è vista più come una condanna che non come un privilegio: Sartre dice, a tal proposito, che “ l’uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa” , sottolineando come si sia liberi di tutto fuorchè di scegliere se venire al mondo. Dopo la seconda guerra mondiale, invece, l’esistenzialismo si colora di ottimismo e tende sempre più a leggere la possibilità come facoltà di progettare liberamente il proprio futuro. A tal proposito può essere interessante l’itinerario filosofico di Sartre fra le due guerre mondiali: negli anni successivi alla prima guerra mondiale egli scrive (nel 1938) il celebre romanzo “La nausea”, con cui esprime quel senso di disagio quasi fisico nei confronti del mondo e della sua insensatezza: in uno dei passaggi forse più famosi del libro, il protagonista, seduto in una panchina nel parco, osserva le radici contorte di un albero che si spingono nella terra senza senso alcuno e ciò gli fa cogliere tutto d’un colpo l’insensatezza dell’esistenza e gli provoca un forte senso di nausea; in un’altra parte del libro, ha un incubo ad occhi aperti: immagina delle trasformazioni anatomiche stravolgenti (un terzo occhio o la lingua che si trasforma in un insetto ripugnante). Con ciò, Sartre vuole sottolineare come siamo tutti abituati a vedere l’uomo in una sola maniera, perché ha una sua essenza che determina ciò che è; ma nel momento in cui perdiamo il senso delle cose, tutto diventa possibile e in questo periodo Sartre legge la possibilità come altamente negativa, quasi come una condanna che implica l’insensatezza del mondo: come a dire che il mondo, quando può diventare ciò che vuole, diventa una mostruosità. Negli anni della seconda guerra mondiale, più precisamente nel 1943, Sartre pubblica invece “L’essere e il nulla”, un trattato filosofico in cui compare un’immagine che chiarisce il nuovo atteggiamento sartreano nei confronti dell’insensatezza dell’esistenza: egli afferma come in un mondo e in un’esistenza privi di senso sia l’uomo a poter conferire un significato ad essi; proprio come parliamo, convenzionalmente, di “mezza luna” ma potremmo tranquillamente definirla “luna” e chiamare invece “doppia luna” quella che abitualmente chiamiamo “luna”, così possiamo dare un significato a tutte le cose del mondo, visto che esse, di per sé, non ce l’hanno. Se Sartre negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, sull’onda dei drammi bellici, non guardava con simpatia alla libertà di dare un senso al mondo, ora che la guerra sta del tutto volgendo al termine dà una svolta ottimistica al suo pensiero. A guerra ultimata, nel 1946, compone un opuscolo (al quale risponderà lo stesso Heidegger) intitolato “L’esistenzialismo è un umanismo”, con cui guarda in modo attivo alla filosofia dell’esistenza: se il mondo è caratterizzato dall’assenza di un significato e di un’essenza predeterminata, allora mi trovo a scegliere liberamente cosa diventare e quando scelgo, nota Sartre, scelgo anche per coloro che verranno al mondo dopo di me, dal momento che si sceglie sempre facendo riferimento a valori consolidati da secoli e da una miriade di persone. Ne consegue che sono quel che decido di essere, ovvero attraverso l’esistenza determino l’essenza mia, ma anche degli altri. Ecco perché se l’umanesimo ha messo, nel Cinquecento, al centro del mondo l’uomo, inteso, secondo la felice espressione sallustiana, “faber fortunae suae”, l’esistenzialismo ora rappresenta il culmine della tradizione umanistica, in quanto è l’uomo a dare un senso alla propria esistenza e al mondo stesso. Naturalmente questa nuova prospettiva sartreana è altamente ottimista, in quanto il filosofo francese è alimentato dalla speranza, tipica del dopoguerra, di ricostruire un nuovo mondo e non a caso questo è il periodo in cui Sartre è impegnatissimo politicamente nel Partito Comunista: affiora nella sua filosofia il concetto di “impegno” esistenziale e politico, che farà sì che Sartre tenti un’ibridazione tra il marxismo e l’esistenzialismo, in virtù del fatto che l’esistenzialismo, in quanto filosofia dell’esistenza, può essere innestato un po’ ovunque. Nel 1947 Heidegger pubblica la “Lettera sull’umanismo”, con la quale capovolge la prospettiva sartreana emersa in “L’esistenzialismo è un umanismo” e interpreta il compito del pensiero come impegno non per l’uomo, ma per l’essere. In questo modo, il pensatore tedesco prende le distanze dall’esistenzialismo, a cui rinfaccia di assegnare il primato a quell’ente che è l’uomo, dimenticandosi dell’essere. Ma l’uomo, dice Heidegger, è solo il “ pastore dell’essere ”, colui al quale è affidato il compito di salvaguardare e custodire nel pensiero la verità dell’essere. L’esistenzialismo risente, come abbiamo visto, dell’influenza della filosofia fenomenologica: in particolare, in Heidegger resta l’idea husserliana che la coscienza sia sempre costitutivamente intenzionale; la coscienza, in altri termini, si riferisce sempre a qualcos’altro, qualsiasi atto umano è un riferirsi a qualcosa, cosicchè pensiamo, facciamo, vogliamo sempre qualcosa. L’atteggiamento di Husserl, però, è iperclassico, porta all’esasperazione la tendenza teoretica riservata da Aristotele alla filosofia, quasi sganciandosi dal mondo (che non a caso veniva da Husserl messo tra parentesi). L’esistenzialismo, però, si trova agli antipodi rispetto alla concezione aristotelica e husserliana della filosofia come “sapere per il sapere”: infatti, la sua indagine verte sull’esistenza e quest’ultima implica l’essere immersi in quel mondo sul quale Husserl sospendeva il giudizio. Dunque Heidegger eredità la nozione husserliana di “intenzionalità”, ma respinge nettamente l’ipotesi che essa resti interna solo all’orizzonte della coscienza: ne consegue che per Heidegger il carattere intenzionale non implica tanto il tendere alle idee, quanto il tendere e il riferirsi al mondo; questo atteggiamento, proprio di Heidegger, rispecchia in realtà buona parte delle posizioni esistenzialistiche, che per lo più vedono come marginale l’aspetto teoretico, tanto caro ad Husserl, perché l’esistenza è, in primo luogo, essere nel mondo.
IL CIRCOLO DI VIENNA E IL NEOPOSITIVISMO
Il Circolo di Vienna (in tedesco “Wiener Kreis”) si propose come obiettivo l’elaborazione di una concezione scientifica del mondo: il primo nucleo del circolo si costituì a partire dal 1923, dopo l’arrivo di Moritz Schlick a Vienna in veste di professore universitario; tra i suoi membri princioali vanno ricordati Herbert Feigl, Friedrich Waismann e vari scienziati, come il matematico Hans Hahn, il fisico Philip Frank, il sociologo Otto Neurath. Nuovo impulso alla vita del Circolo fu poi dato dall’arrivo a Vienna di Rudolf Carnap e dall’iniziativa di discutere insieme il “Tractatus logico-philosophicus” di Wittgenstein, che partecipò qualche volta ad alcune sedute del Circolo. Nel 1928 esso assunse il nome di “Associazione Ernst Mach”, mentre nello stesso anno veniva fondata a Berlino una parallela “Società per la filosofia scientifica”, di cui erano membri Hans Reichenbach, Richard von Mises, Carl Gustav Hempel e Hilbert. Tra i due gruppi vebnnero intrecciate relazioni che culminarono nell’organizzazione di una serie di congressi, nella fondazione della rivista “Erkenntnis” (Conoscenza), pubblicata dal 1930 al 1938 sotto la direzione congiunta di Carnap e Reichenbach, e di una collana di volumi, in cui uscirono anche opere di Carnap e di Popper. Le riunioni del Circolo a Vienna continuarono fino al 1936 e ad esse presero parte anche visitatori stranieri come Ayer (da Oxford) e Quine (dagli USA), ma fra il 1932 e il 1938, anno dell’annessione dell’Austria da parte di Hitler, quasi tutti i suoi membri emigrarono all’estero, in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti. Qui entrarono in rapporto con filosofi americani, tra i quali Dewey e Charles W. Morris, e insieme diedero vita al progetto di una “Enciclopedia della scienza unificata”. La posizione filosofica di quanti parteciparono alle iniziative del Circolo è influenzata dalla tradizione empiristica, da Mach e dal “Tractatus” di Wittgenstein ed è stata variamente denominata: “neopositivismo” o “positivismo logico” o anche “empirismo critico” o “empirismo critico”. I caratteri generali di essa emergono nel manifesto del Circolo, che fu pubblicato nel 1929 con il titolo “La concezione scientifica del mondo”, dedicato a Schlick e sottoscritto da Hahn, Carnap e Neurath, ma redatto essenzialmente da Neurath. L’obiettivo è reagire contro la svalutazione del sapere scientifico, mostrando che la nuova immagine del mondo, costruita dalla scienza, è in grado di fornire una migliore spiegazione dei dati forniti dall’esperienza. A ciò è possibile provvedere coordinando i risultati raggiunti dalle varie scienze in modo da elaborare la scienza unificata , attraverso la ricerca di un linguaggio quotidiano. Il presupposto è che la scienza è un linguaggio ed è l’unico linguaggio dotato propriamente di significato dal punto di vista della conoscenza. In sintonia con il primo Wittgenstein, le proposizioni scientifiche sono distinte in tautologiche, proprie della matematica e della logica, e in enunciati empirici: questi ultimi sono significanti, soltanto se sono riducibili ad asserzioni elementari riguardanti i dati immediati della sensazione. Le teorie scientifiche si fondano quindi su una base empirica e vengono costruite mediante l’elaborazione di questo materiale grazie agli strumenti forniti dalla logica matematica, che per i neopositivisti è sostanzialmente quella dei “Principia mathematica” di Russell e Whitehead. Il significato di una proposizione consiste, secondo una formula introdotta da Waismann, nel metodo della sua verificazione : Schlick dice che “ la gioia di conoscere è la gioia della verificazione, l’entusiasmo di aver colto nel segno ”. Sul senso da attribuire a questa nozione di verificazione si aprirà un dibattito, soprattutto sulla rivista “Erkenntnis”, che vedrà differenziarsi le varie posizione, mentre rimarrà sostanzialmente uniforme l’accettazione di una delle conseguenze di questa impostazione generale, ovvero la dimostrazione dell’ insignificanza della metafisica tradizionale, mediante l’analisi logica delle sue proposizioni. Questa analisi, infatti, mette in luce l’inverificabilità delle proposizioni della metafisica, le quali pretendono di parlare di entità che vanno al di là di ogni esperienza possibile: tali proposizioni sono dunque prive di significato. Sotto questo profilo, dice Carnap, il linguaggio della metafisica appare soltanto come un’espressione di sentimenti e i metafisici vengono da lui paragonati a “ musicisti senza talento ”.
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
Nel febbraio del 1923 viene aperto ufficialmente a Francoforte, grazie ad una donazione privata, l’ “Institut für Sozialforschung” (Istituto per la ricerca sociale), sotto la direzione dello storico marxista Karl Grünberg. Di esso fece parte anche Max Horkheimer (Stoccarda 1895 – Norimberga 1973), che nel 1931 ne diventa a sua volta direttore. Nato nei pressi di Stoccarda da ricca famiglia ebrea, dopo aver lavorato presso l’impresa paterna, si laurea con una tesi su Kant nel 1922 a Francoforte, dove nel 1929 diventa professore di Filosofia sociale. Nel 1932 iniziano le pubblicazioni della rivista dell’Istituto, la “Zeitschrift für Sozialforschung”, alla quale collaborano anche altri filosofi del calibro di Adorno, Fromm, Marcuse e sulla quale Horkheimer pubblica diversi articoli, che saranno successivamente raccolti dopo la guerra sotto il titolo di “Teoria critica” (1968). Nel 1933, con l’avvento del nazismo, Horkheimer è espulso dall’università, l’Istituto viene chiuso e trasferisce la propria sede in Svizzera e poi, nel 1934, a New York, mentre la rivista continua le sue pubblicazioni a Parigi, fino al 1940, e successivamente negli Stati Uniti. Horkheimer stesso si trasferisce a New York e dal 1941 in California, acquistando la cittadinanza americana. Durante il soggiorno statunitense, egli pubblica in inglese l’ “Eclisse della ragione” (1947) e in tedesco la “Dialettica dell’illuminismo”, composta in collaborazione con Adorno. Nel 1950 escono, sempre negli Stati Uniti, i risultati di una ricerca collettiva dell’Istituto, sotto il titolo “Studi sulla personalità autoritaria”, ma nel frattempo Horkheimer torna in Germania per insegnare Sociologia e Filosofia all’università di Francoforte, anche se conserva la cittadinanza americana; con lui torna anche l’Istituto, soprannominato dagli studenti “Caffè Max”. Nel 1951 è nominato rettore dell’università e nel 1954 si stabilisce sul lago di Lugano, dove conclude la propria esistenza nel 1973. In primo luogo, l’Istituto si propone il ripristino del marxismo , ma tenendo conto dei profondi mutamenti della situazione storico-sociale: soprattutto, dopo la grande crisi economica divampata nel 1929, il capitalismo sembra assumere un nuovo aspetto e trasformarsi, sia nelle democrazie occidentali, sia nelle dittature di Destra, sia nell’Unione Sovietica, in capitalismo di Stato. Ciò implica che non è più possibile parlare di una struttura economica autonoma rispetto alla politica: contrariamente alla teoria di Marx, lo Stato sembra riassumere il primato rispetto alla società civile e impedire, col suo intervento diretto nella sfera economica, l’impoverimento crescente del proletariato. In questa situazione, si assiste ad una graduale perdita di impulso rivoluzionario nella classe operaia, con la conseguente sfiducia, comune agli autori della Scuola di Francoforte, nel fatto che essa possa ancora essere il motore di una trasformazione radicale della società. Ostili alla socialdemocrazia, poiché traditrice degli obiettivi rivoluzionari, ma anche alla burocratizzazione e alla bancarotta, verificatasi anche sul piano teorico, del comunismo sovietico, essi si tengono per lo più lontani dall’attività politica diretta: l’organizzazione totale della società, comune ai paesi occidentali come a quelli orientali, non è spiegabile solo attraverso la coercizione materiale a cui sarebbero sottoposti gli individui. Si tratta, invece, di individuare anche le mediazioni psicologiche e culturali che rendono possibile la costituzione del dominio sociale e, dall’altra, l’accettazione passiva di esso. A questo scopo sono dedicate le ricerche collettive dell’Istituto sul problema dell’autorità. Non scorgendo più all’orizzonte un agente sociale della rivoluzione e ritenendo ormai impossibile su questa base una previsione scientifica del crollo del capitalismo, i pensatori della Scuola di Francoforte ritornano, in qualche modo, ad un’impostazione simile a quella della sinistra hegeliana dopo la scomparsa di Hegel: infatti, essi riconoscono la discrepanza tra la realtà storica e la razionalità e, quindi, il carattere irrazionale della società esistente, rispetto alla quale il compito primario da esercitare è la critica; si tratta pertanto, attraverso un lavoro di critica, di far diventare reale ciò che è razionale. Ecco perché i pensatori della Scuola di Francoforte vogliono elaborare una teoria critica della società , in cui occupa una posizione assolutamente centrale la dialettica , concepita (sulla scia del primo Lukàcs) come metodo per la trasformazione della realtà. A differenza di Lukàcs, però, la teoria critica non viene intesa come semplice espressione della coscienza di classe, senza per questo scivolare nell’illusione opposta che l’intellettuale sia al di sopra della mischia e della lotta di classe. L’intellettuale critico non è un ripetitore delle tendenze conformistiche del proletariato e la dialettica, di cui egli si serve, è orientata ad accertare le contraddizioni esistenti, ma senza la certezza di un superamento di esse in una sintesi finale. E poi, se Marx considerava la scienza, acquisibile mediante il metodo dialettico, diversa sia dall’ideologia, sia dall’utopia, per i pensatori della Scuola di Francoforte la scienza e la tecnica sono anch’esse causa ed espressione, al tempo stesso, del dominio totale della società e quindi forme di ideologia, non nel senso di essere semplici riflessi di interessi di classe, ma in quanto esprimono le contraddizioni della società. In questa prospettiva torna dunque ad aprirsi un nuovo spazio per l’ utopia , la quale però consiste, più che nella delineazione di un programma dai contenuti positivi da perseguire e nella definizione dei caratteri della società libera del futuro, nella denuncia di ciò che è falso nel presente e nel rifiuto di esso: e così nel pensiero dialettico assume grandissimo rilievo il momento della negazione.
IL NEO-CRITICISMO TEDESCO
Già nella seconda metà dell’Ottocento si andò sviluppando negli ambienti culturali tedeschi un ritorno a Kant in funzione antipositivistica. A cavallo tra Ottocento e Novecento si andò formando un movimento d’ispirazione kantiana, definito Neocriticismo, rappresentato principalmente dalla Scuola di Marburgo, e dai grandi nomi di Cohen, Natorp, Cassirer. Contemporaneamente al Neocriticismo, e sempre ispirandosi alla filosofia di Kant, fiorì lo Storicismo tedesco, ad opera di Windelband e Rickert, massimi esponenti della Scuola di Baden. Riconducibile tanto alla Scuola di Baden, per l’attenzione alla problema ermeneutico della Storia, quanto alla Scuola di Marburgo, per l’interesse rivolto alla teoria dei valori di marca kantiana, è la filosofia di Dilthey, che, proprio per il progetto di creare una metodica delle “Scienze dello Spirito”, rappresenta un passo avanti verso la nascita del pensiero ermeneutico novecentesco, oltre ad essere importante in sé, come modello di riferimento d’ogni matura metodologia delle scienze umane e sociali che non voglia rinunciare alla mediazione filosofica. Il pensiero filosofico tra Ottocento e Novecento è caratterizzato (soprattutto in Germania, ma anche in Francia) da una serrata polemica antipositivistica, portata avanti soprattutto da due correnti filosofiche abbastanza diverse tra loro: lo spiritualismo di Lotze, Eucken, Spir, Hartmann, che adotta il metodo della riflessione interiore e non quello della costruzione dialettica, approdando verso forme di misticismo religioso, pessimismo cosmico, irrazionalismo inconscio; l’altra corrente è il neo-criticismo delle due scuole di Marburgo (Cohen, Natorp e soprattutto Cassirer) e del Baden, nelle due Università di Heidelberg e Friburgo (Windelband e Rickert). In entrambe le correnti il tentativo era quello di recuperare quei valori spirituali trascurati dal positivismo e di ribadire l’esigenza di attribuire alla filosofia un compito diverso da quello di una semplice coordinazione unitaria del sapere scientifico ammessa dal positivismo. Ma delle due correnti quella che diede i risultati più fecondi fu la seconda. Il neo-criticismo rappresenta la sistematica ripresa della filosofia kantiana, nel senso di una riflessione sui fondamenti, metodi e limiti della scienza (in seguito gli ambiti si amplieranno a storia, morale, arte, religione, linguaggio). Mentre per i positivisti l’oggettivo sono i fatti e l’apriori è sinonimo di soggettività/arbitrarietà, per i neo-criticisti l’apriori è il fondamento dell’oggettività scientifica . La scienza, cioè, non sarebbe progredita tramite l’accumulazione pura e semplice dei fatti, ma piuttosto con l’unificazione di questi fatti in ipotesi, leggi, teorie (gli elementi apriori). Compito della filosofia è appunto quello di studiare criticamente gli elementi apriori (filosofia=logica/metodologia scientifica). Il neo-criticismo non è solo contrario all’affermazione del carattere assoluto o metafisico della verità scientifica, ma è anche contrario a ogni tipo di metafisica o di integrazione metafisico-religiosa del sapere scientifico , secondo l’indirizzo dell’idealismo e dello spiritualismo. Il neo-criticismo contesta sia la metafisica della materia (positivismo e naturalismo) sia quello dello spirito (idealismo e spiritualismo). Per i neo-criticisti, Kant si è proposto anzitutto di criticare il sistema scientifico newtoniano (questo viene detto per superare l’interpretazione psicologistica allora dominante del pensiero kantiano). La filosofia critica vuole diventare la scienza delle determinazioni necessarie e universali di valore (della verità, del bene, del bello). La preoccupazione di questi neo-kantiani è quella di ridimensionare l’assoluta oggettività di ogni scienza o filosofia, valorizzando l’apporto dell’individuo concreto (storicamente determinato) alla conoscenza complessiva delle cose (della cui validità teoretica vanno poste le fondamenta gnoseologiche). In due punti il neo-criticismo di Marburgo ha corretto l’impostazione kantiana: ha eliminato il riferimento al noumeno (che lo sviluppo delle scienze esatte aveva reso obsoleto) e ha eliminato la distinzione tra sensibilità (facoltà passiva) e intelletto (facoltà attiva) . L’oggetto dell’attività scientifica è frutto dell’attività produttiva del pensiero (ad esempio, nel calcolo infinitesimale si fa nascere un ente geometrico senza alcun riferimento a dati intuitivi, ma solo attraverso operazioni logiche). Tuttavia, l’oggetto di studio della filosofia (il pensiero) non è l’attività pensante soggettiva, ma il pensato (non è possibile cogliere l’attività della coscienza, tanto è vero che i marburghesi metteranno la psicologia tra le scienze “generalizzanti”, al pari della fisica, chimica, biologia…). Il processo conoscitivo non è più l’analisi di un dato iniziale, ma l’analisi del passaggio da un oggetto indeterminato (per esempio un colore) a uno più determinato (per esempio l’onda luminosa di cui parla la fisica), attraverso un processo di sintesi che non giunge mai a compimento. Il processo/metodo è tutto, mentre l’oggetto/fatto è solo in fieri. In pratica, il neo-criticismo accetta le esigenze del positivismo di eliminare un noumeno pensabile ma non conoscibile, rifiutandone nel contempo la pretesa di determinare l’essenza delle cose mediante la scienza: l’essenza sta nel rapporto che le collega. Il neo-criticismo della Scuola di Marburgo cade però nel limite del funzionalismo o relativismo nei nessi relazionali che collegano le cose. Qualunque organizzazione sociale o qualunque enunciato teorico può essere giustificato se se ne trovano i nessi logico-coerenti. Il neo-criticismo si preoccupa soltanto di fissare i criteri di legittimità di una teoria, ma l’unico vero criterio che pone è il rifiuto di considerare possibile la conoscenza vera, esatta, sostanziale della realtà in sé (naturalmente a livello di approssimazioni sempre più vicine alla verità assoluta). Esso ammette unicamente la conoscenza della realtà che ci appare, cioè di quella che in ultima istanza siamo noi stessi a costruire. In tal modo, viene meno la possibilità di contraddire in modo assoluto una determinata teoria sulla base dei fatti. Le teorie per il neo-criticismo si contraddicono da sole quando assolutizzano i fatti, mentre restano coerenti quando mantengono i fatti nella loro relatività (rispetto ad altri fatti). La contraddizione non diventa mai per il neo-criticismo così oggettiva da determinare un ripensamento dei criteri generali di organizzazione della società o della conoscenza. Cassirer dice che “l’uomo non può sottrarsi alle condizioni di esistenza che lui stesso si è creato”, cioè l’esistenza può solo essere accettata, non può essere trasformata. “I contrari non si escludono a vicenda ma dipendono l’uno dall’altro”. L’uomo insomma, per il neo-criticismo, non può più tornare ad essere un ente di natura, che vive rapporti umani naturali, perché è costretto a pagare il prezzo della sua pretesa manipolativa del reale. L’uomo non può più comprendere la verità delle cose, perché ha di fronte a sé solo le proprie verità. “La” verità non esiste, esistono solo “le” molte verità che l’uomo si dà. Cassirer dice che l’uomo si è circondato di forme linguistiche, di immagini artistiche, di simboli mitici e di riti religiosi a tal punto da non poter vedere e conoscere più nulla se non per il tramite di questa artificiale mediazione. Il rapporto colla natura quindi si è irrimediabilmente perso in questa mediazione culturale artificiale creata dall’uomo. Cassirer esclude categoricamente che da una trasformazione della mediazione culturale si possa tornare a un rapporto più equilibrato dell’uomo con la natura. Gli esponenti più significativi della Scuola del Baden sono Windelband e Rickert. Ciò che accomuna le due scuole è sia il rifiuto della concezione positivistica della conoscenza come “riproduzione della realtà”, sia l’esigenza kantiana di considerare la validità della conoscenza indipendentemente dalle condizioni soggettive/psicologiche in cui la conoscenza si verifica. Tuttavia, diversamente dai marburghesi, l’attenzione di questi neo-kantiani non è volta all’indagine/formulazione di un “metodo” che spieghi l’origine del processo conoscitivo e la funzione logica del pensiero in ogni sua espressione, ma alla ricerca di una “norma/criterio” che determini la verità/falsità di un oggetto conoscitivo. Tale criterio è visto nel “valore” (donde “filosofia dei valori”), considerato indipendente dal soggetto che lo formula (Windelband p.es. è stato il primo a trattare la storia della filosofia per problemi, considerando i problemi stessi nel loro sviluppo come relativamente indipendenti dai filosofi che li pongono). WINDELBAND si pone come obiettivo quello di creare una “filosofia critica” che sia scienza delle determinazioni “necessarie e universali” del valore della “verità”, del “bene” e del “bello”. La filosofia cioè non ha per oggetto dei “giudizi di fatto” -come le scienze naturali- ma dei “giudizi di valore”, che hanno validità normativa. Come la legge naturale non è mai un principio di valutazione, così la norma non è mai un principio di spiegazione. Windelband parte da Kant, sottolineando di questi la scoperta che i principi a priori garantiscono la validità della conoscenza, il che ha distrutto definitivamente la concezione greca che credeva esterna all’uomo la realtà che permette di determinare la verità delle cose. Le categorie kantiane -dice Windelband, chiamandole col termine “valori”- sono valori necessari e universali, aventi carattere normativo indipendente dalla loro effettiva realizzazione. A differenza però dai marburghesi, Windelband e Rickert cercano di applicare questa scoperta kantiana (Kant aveva parlato di valore solo nei confronti del “bene”) non solo alla gnoseologia o al sapere fisico-matematico, ma anche all’estetica e all’etica, ovvero a tutto il mondo storico, senza contraddizione tra “scienze della natura” e “scienze dello spirito”, che Windelband chiama, rispettivamente, “scienze generalizzanti” o “nomotetiche” (cioè legate alle leggi, e sono la biologia, la fisica, la chimica, la matematica, ecc.) e “scienze individualizzanti” o “idiografiche” (cioè legate alla singolarità, come la filosofia e la storia). Windelband e Rickert propongono una spiegazione della storia a partire dall’interpretazione del fatto singolo e individuale, che abbia naturalmente un valore universale. Il valore quindi si configura come un a-priori, un “dover essere” (la rappresentazione “vera” come quella che deve essere pensata, l’azione “buona” come quella che deve essere compiuta, la cosa “bella” come quella che deve piacere), indipendente dall’oggetto, in relazione al soggetto, in grado di determinare la validità di qualsiasi tipo di giudizio e che la filosofia deve portare alla coscienza del soggetto. In polemica con Dilthey, Windelband e Rickert affermano l’unità del sapere umano, ovvero il rifiuto di distinguere (se non a livello metodologico) le scienze della natura da quelle della cultura/spirito. La realtà indagabile è sempre la stessa, anche se cambia il punto di vista (scientifico o storico) dal quale viene considerata. Rickert accentua però la differenza “oggettiva” dei due tipi di scienza, facendo del valore un’entità trascendente, come un essere per sé, trascendente l’attività umana. Il neo-criticismo si è diffuso in tutti i paesi, ma le manifestazioni più significative le ha trovate in Francia e soprattutto in Germania. In Italia l’esponente più importante è stato Antonio Banfi (1886-1957), che ha elaborato il “razionalismo critico”. HERMANN COHEN (1842-1918), nel suo “Sistema di filosofia”, sviluppò i presupposti metafisici del criticismo kantiano, soprattutto il concetto del noumeno, o “cosa in sé”, che avanzava una frattura tra ciò che è in se stesso e ciò che si conosce. Inoltre, la dicotomia tra “estetica” e “analitica”, che postulava una distanza non di minore momento tra ciò che si conosce mediante l’intuizione e ciò che si conosce attraverso l’intelletto, limitando successivamente l’oggetto d’intuizione a substrato materiale della conoscenza intellettiva. Nell’interpretazione di Cohen, il pensiero e l’essere sono due concetti coincidenti, tuttavia non nella maniera idealistica, che li unifica nell’Io, ma in quanto essi costituiscono l’oggettività pensabile. Strettamente collegate a quella che Cohen ha definito “logica della conoscenza pura” sono altre due scienze filosofiche teorizzate dal filosofo neokantiano: un’etica della volontà pura e un’ estetica del sentimento puro . Dal punto di vista etico, Cohen riprende il kantiano “dover essere” aggiungendo che senza “dover essere” c’è solo desiderio, negatore di ogni volontà autentica. Da Kant egli desume anche il principio etico di scorgere nell’umanità, in sé e negli altri, un fine e non un mezzo, concezione che per Cohen trova un corrispettivo filosofico-politico all’interno della “Weltanschauung” socialista. Nel Socialismo, asserisce il filosofo tedesco, l’uomo è un fine in sé, per cui è un dovere morale rispettarne la libertà personale e la dignità sociale. Tale principio egli vede a fondamento della concezione socialista: per il socialismo, egli dice, l’uomo è fine in sé, e pertanto bisogna rispettarne la libertà e la dignità. Tuttavia Cohen non accetta il socialismo d’ispirazione marxista, in quanto in contraddizione con il kantiano “regno dei fini”, cioè verso un valore etico a cui sembra tendere il mondo moderno nella sua evoluzione storica. L’esplicitazione etica del socialismo fu poi delineata ed approfondita anche da Paul Natorp (1854-1924), tra l’altro noto come esperto della filosofia di Platone e dei suoi sviluppi. Tuttavia, se la critica dei valori di Cohen e Natorp rischia di apparire anacronistica nel momento in cui rimane ancorata alla tavola di categorie etico-sociali di stretta ortodossia kantiana, ha una sua importanza decisiva se si considerano gli sviluppi di Cassirer, che fa una brillante ed originale ripresa dell’a priori del filosofo di Köenigsberg, nel senso di una presa di coscienza sull’importanza della realtà simbolica ai fini della gnoseologia, o teoria psichica della conoscenza umana. ERNST CASSIRER (1874-1945), noto come uno dei più importanti storici delle idee, va annoverato tra i principali filosofi del Novecento soprattutto grazie alle brillanti intuizioni esposte in due opere: “Concetto di sostanza e concetto di funzione” e in “Filosofia delle forme simboliche”. La scienza, dice il grande filosofo tedesco, non è capace di mostrarci l’immagine di oggettive entità di natura. Le strutture che sottostanno ai contenuti della conoscenza sono “funzioni”. In questa filosofia il linguaggio assume una sua peculiare “funzione costitutiva” degli enti della conoscenza. La dimensione linguistica non rappresenta solo una modalità di approccio comunicativo, ma organizza l’esperienza tipicamente umana della conoscenza, è anzi la stessa organizzazione del pensiero a dover fare continuamente i conti con l’attivo uso del linguaggio e delle sue dinamiche. È la dimensione linguistica che fa da tramite tra le nostre impressioni dettate dal momento e il livello dell’oggettività razionale. Questa operazione è mediata dal simbolo che svolge un suo ruolo specifico come un mezzo necessario e imprescindibile del pensiero per realizzarsi come tale. Non è un semplice agente formale che permette di veicolare, comunicandolo, un contenuto di pensiero preformato nella nostra mente, ma è lo strumento che rende possibile determinare concettualmente lo stesso contenuto. Per Cassirer l’atto di determinare concettualmente un contenuto di pensiero va di pari passo con l’atto del suo riconnotarsi in un non meglio precisato simbolo caratteristico. Dal momento che spetta al simbolo di costituire i concetti, esso determina anche l'”oggetto” della realtà spirituale. Quando con Aristotele si afferma che “l’uomo è un animale razionale”, si è certamente nel giusto. Ma l’aggettivo “razionale” richiama il sostantivo corrispondente, “ragione”, che a Cassirer sembra una parola inadeguata. L’uomo, infatti, si realizza in moltissime forme nella sua vita spirituale, nella sua cultura. La cultura non dà vita soltanto al mondo scientifico, informa di sé una civiltà multiforme, poliedrica e complessa, che crea arti, religioni, istituzioni, etc. Parimenti alla dimensione conoscitiva umana, anche qualsiasi altra forma della sua creazione spirituale è una “forma simbolica”. Per il filosofo tedesco l’uomo andrebbe a ragione definito “animale simbolico”, in tal modo correggendo l’impostazione filosofica tradizionale, sia di marca empiristica che razionalistica, che poneva principalmente l’accento sulla razionalità umana, almeno da Socrate e Platone in poi. Da questo principio si ricava che la comprensione della storia umana non può essere se non ermeneutica dei simboli, quei simboli che rendono possibile la realizzazione e l’oggettivazione della vita culturale, che costituisce una parte essenziale della più ampia vita umana. La filosofia di Cassirer, che rivaluta il simbolo anche in senso linguistico come garanzia della conoscenza, sembra anticipare il cognitivismo e la filosofia della mente che, in corrispondenza analogia con l’indagine sui sistemi informatici, viene a determinare i processi conoscitivi della mente umana tramite l’uso inconscio dei codici simbolici, in questo riconoscendo una qualche corrispondenza tra la mente e il computer, il cui funzionamento richiede un linguaggio peculiare fondato su una rete di simboli alfanumerici. L’interesse per la teoria della conoscenza, d’altra parte, si lega in Cassirer ad un forte interesse per la storia delle idee e dei fatti umani, che, se non concorre direttamente alla costruzione di una propria filosofia della storia, si intreccia con altre coeve teorie della storia, con due filosofi importanti anche per gli sviluppi successivi che ne daranno gli ermeneuti successivi: Windelband e Rickert.
DIETRICH BONHOEFFER

Con l’avvento del nazismo al potere, la Chiesa protestante si adattava a convivere con esso, seguendo l’insegnamento impartito da Lutero stesso, secondo cui il vero cristiano deve essere fedele al potere temporale. Tuttavia, la vita e la personalità eroica di Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) testimoniarono l’assoluta incompatibilità fra il dettato evangelico e il torbido e fosco paganesimo del regime hitleriano. Bonhoeffer fu infatti tra i principali promotori della cosiddetta ” Chiesa confessante che rappresentò in Germania la resistenza cristiana al nazismo e, coinvolto nel fallito attentato a Hitler compiuto dal gruppo di Von Stauffenberg e Canaris, venne impiccato nel campo di concentramento di Flossenburg. La meditazione teologica di Bonhoeffer appare intimamente coerente con la sua vita in quanto, mentre s’innesta in modo conseguente sul filone barthiano e sulla nozione dell’assoluta alterità di Dio, svolge un tema lasciato da Barth in posizione secondaria: quello dell’ impegno concreto dell’uomo nella storia . In una situazione in cui tutto, nel mondo moderno, porta l’uomo a non riconoscersi più nel messaggio cristiano, la riflessione di Bonhoeffer muove dalla domanda su come sia ancora possibile professare il Vangelo. Di qui il suo sforzo, da un lato, di accettare sino in fondo l’autonomia dell’umana, la sua “maggiore età”, cioè il retaggio della cultura moderna dall’illuminismo in poi e, dall’altro, di prospettare la possibilità di un cristianesimo “non religioso”, che richieda di vivere il Vangelo in un mondo totalmente secolarizzato e lontano da Dio. ” Vivere in nome di Dio e di fronte a Dio senza Dio ” è la formula in cui si condensa questo tentativo di accogliere senza mezzi termini le istanze dell’umanesimo ateo e di scorgere la presenza di Dio non nella debolezza, ma nella pienezza e nella forza dell’umano. Nelle sue opere (fra le quali le più note sono certamente l’ “Etica”, il capolavoro incompiuto, e la densa raccolta di lettere degli ultimi anni, pubblicata postuma nel 1951 dal titolo “Resistenza e resa”) tutto ruota intorno alla domanda di fondo: chi è Cristo oggi per noi, abitatori di un mondo che ha imparato a fare a meno dell’ipotesi Dio poiché è finalmente diventato “adulto? Oppure, detto in altri termini, come e perché volgerci ancora a Dio, quando la nostra attuale condizione è di poterne fare a benissimo a meno? Non vi è infatti alcun dubbio, per Bonhoeffer, che non vi sia più alcun bisogno di un Dio “tappabuchi” cui l’uomo ricorra per darsi sicurezza nelle sue crisi e nelle sue debolezze. ” Io vorrei parlare di Dio non ai confini ma nel centro, non nella debolezza ma nella forza, non nella morte e nella colpa ma nella vita e nella bontà dell’uomo. Giunto ai limiti, mi pare meglio tacere e lasciare irrisolto l’irrisolubile. La fede nella risurrezione non è la soluzione del problema della morte. L’aldilà di Dio non è l’aldilà delle nostre possibilità di conoscenza. La trascendenza della gnoseologia non ha nulla a che fare con la trascendenza di Dio. Egli è al di là in mezzo alla nostra vita. La chiesa non risiede là dove la capacità dell’uomo non ce la fa più, ai confini, ma in mezzo al villaggio ” (“Resistenza e resa”, lettera 16.7 del 1944). Ora, questa operazione che rassicura l’uomo nelle sue incertezze era propria della religione, la quale, su questo piano, non ha più nulla da dire. E’ dunque necessario abbandonare la religione come via d’accesso a Dio; ma ciò non vuol dire abbandonare la fede , che può essere davvero ritrovata solo sganciandola dal suo rapporto religioso. Bonhoeffer procede così ad una radicale distinzione tra religione e fede . Se la religione aveva fatto leva sulla debolezza dell’uomo per convincerlo della necessità dell’ipotesi Dio, la fede ricorderà invece che Gesù Cristo ci ha chiamati alla vita e non ha inteso fondare una religione (ipotesi radicalmente opposta a quella di Nietzsche, per cui la fede cristiana ammazza la vita). Si tratta, insomma, di scoprire il nuovo (o il vero) volto di Dio in un quadro di riferimento dove la rinuncia cosciente del “Deus ex machina”, che è un residuo pagano, conduce a vedere nella vicenda cristica la presenza concreta e storica di un Dio che si è abbandonato al potere degli uomini, salvandoli con la sua morte e con la sua sofferenza. E’ dunque per seguire l’esempio di Cristo che gli uomini hanno non solo il diritto ma il dovere di assumere sino in fondo la loro umanità, di realizzare in pieno quella vita che Cristo ha riscattato per loro con la morte: è per questo che un’ etica cristiana non deve respingere la vita, ma affermarla ed esserle fedele. E’ questo il tema che percorre l’ “Etica” di Bonhoeffer il quale, nel rifiutare ogni forma di morale astratta e di legalismo etico, muove (anche sulla scorta di un’operazione d’innesto del pensiero di Nietzsche sul tronco del Vangelo) a richiamare l’uomo all’amore per la vita e alla responsabilità che esso comporta. Nel suo amore per il mondo, Cristo lo riconduce al Padre, ma proprio così ne fonda la libertà e la responsabilità, chiamando l’uomo a un impegno che in ogni scelta concreta riaffermi e rinforzi l’amore per tutta la realtà. L’uomo, dunque, non può e non deve rifiutare le realtà “penultime” (o umane e naturali) in nome di quelle “ultime” (o sovrannaturali) ma, pur con l’occhio rivolte alle seconde, deve agire completamente all’interno delle prime. L’atteggiamento contrario non è che un autoinganno o menzogna, poiché è falso promettere il regno di Dio laddove non siano stati soddisfatti i bisogni primari dell’uomo, sia fisici sia morali sia sociali, e non ci si sia impegnati fino in fondo per correggere le storture del mondo. Compito dell’etica cristiana sarà allora non di distogliere l’uomo da questo impegno, ma di ricordargli che soltanto esercitandolo egli potrà aprirsi la strada verso la comprensione e la conquista delle realtà “ultime”; ma, al tempo stesso, di rammentargli che il rischio dell’agire nella storia sta nella permanente tentazione di farsi fine a se stesso, escludendo le realtà ultime e affermando semplicemente l’ideologia dell’umanesimo ateo. Insomma, per trovare Dio non è necessario espungere l’uomo, ma per trovar l’uomo non bisogna espungere Dio: lo sforzo dell’etica di Bonhoeffer sta tutto nel tentativo di affermare insieme Dio e l’uomo , e proprio per questo essa può dirsi un’ etica cristologica , il che ne rende illegittime le ricorrenti letture in chiave unilateralmente mondana e immanentistica.
WILHELM DILTHEY

A cura di Domenico Turco
L’inizio del movimento storicistico tedesco è si fa solitamente risalire alla pubblicazione, avvenuta nel 1883, della Introduzione alle scienze dello spirito di Dilthey, che era pervenuto ad affrontare questioni di metodologia delle scienze storiche in connessione con la sua principale attività di storico della filosofia. Wilhelm Dilthey nacque a Biebrich, in Renania, nel 1833 e, dopo aver studiato ad Heidelberg e a Berlino, dove fu allievo di alcuni fra i maggiori esponenti della scuola storica, divenne professore di filosofia a Basilea nel 1867; successivamente insegnò in altre università tedesche. Dal 1882 succedette a Lotze all’università di Berlino dove ultimò il suo insegnamento nel 1906. Morì a Siusi, nel Tirolo allora austriaco, nel 1911. I suoi primi interessi di storico si rivolsero in primis alle manifestazioni letterarie, religiose e filosofiche del romanticismo tedesco e trovarono la loro massima espressione nella pubblicazione di un’ampia biografia di Schleiermacher rimasta incompiuta e iniziata nel 1867. In seguito Dilthey ampliò il proprio campo di indagine alla cultura del Rinascimento e della Riforma, all’illuminismo e all’idealismo: frutto di quest’interesse sono Introduzione del mondo e analisi dell’uomo nel Rinascimento e nella Riforma (1891-1894), Il secolo XVIII e il mondo storico (1901), Esperienza vissuta e poesia (1906), La storia generale di Hegel (1905-1906). Nel 1883 era apparso, come accennato, Introduzione alle scienze dello spirito , il primo grande studio teorico di fondamentale importanza, considerato il fondamento del movimento storicistico tedesco, in cui Dilthey cercava di giustificare l’autonomia delle scienze dello spirito nei confronti di quelle naturali. La ricerca elaborata in quest’opera è ripresa e ampliata in una sfilza di opere successive; nelle Idee di una psicologia descrittiva e analitica (1894), Dilthey attribuisce alla psicologia una funzione fondatrice nei confronti delle altre scienze dello spirito. Questa sua presa di posizione verrà abbandonata, però, nelle sue ultime opere, che rappresentano il traguardo delle sue ricerche: si tratta di Studi sulla fondazione delle scienze dello spirito (1905-1910) e La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito (1910). Va poi ricordata la raccolta di saggi sull’ Essenza della filosofia (1907) e I tipi di intuizione del mondo (1911), in cui la filosofia stessa, intesa come una forma particolare di intuizione del mondo, è ricondotta alla sua relatività storica. Dilthey si propone di restituire autonomia allo studio del sapere storico, luogo di svolgimento del mondo umano. Dilthey crede che lo scopo fondamentale dei filosofi e della filosofia sia quello di proseguire il criticismo kantiano, volgendone i presupposti alla creazione di una scienza dello spirito che si avvalga anche dei risultati di altre discipline che abbiano come loro oggetto d’indagine i fenomeni etici, sociali, psicologici e gnoseologici. Il rinvenimento delle leggi che regolano questi fenomeni deve avere come sua precondizione l'”intuizione dello sviluppo storico come processo in cui sorgono tutti i fatti spirituali”; intuizione che si è espressa, per Dilthey, nella filosofia della storia contemporanea, da Winckelmann, attraverso l’Idealismo Ottocentesco, fino a Boeckh. Il filosofo di riconosce i gravi limiti della scuola storica, che derivano dal non aver approfondito i fatti singolari, dopo aver circoscritto la loro peculiarità ai legami relazionali oggettivi, relativamente alla realtà storica e storicamente sociale. È necessario che questi fatti singolari siano compresi dall’interno, dal momento che “noi li possiamo riprodurre, fino a un certo punto, in noi, in base all’osservazione dei nostri stessi stati”. Possiamo giungere a una conoscenza di base intuendo i singoli eventi rappresentati con il concorso attivo e fattivo della nostra esperienza vissuta (Erlebnis). C’è una corrispondenza di tipo analogico tra l’esperienza vissuta individuale e l’esperienza vissuta altrui, che ci consente di interpretare, a livello di consapevolezza storica, le varie espressioni della realtà umana d’ogni tempo come un’esperienza vissuta collettiva che risulta dalla generalizzazione di un’Erlebnis individualmente connotata. Gli stessi fatti acquistano la fisionomia di segni, che, relativamente all’esperienza vissuta dal singolo, gli consentono di aderire all’Erlebnis di chi li ha prodotti. La scienza storiografica deve quindi correlarsi alle altre Geisteswissenschaften, psicologia compresa, data la preminenza che assume l’esperienza vissuta individuale nella presa di coscienza storica. Tuttavia questa correlazione tra la storiografia e le altre scienze dello spirito non può non riconoscerne l’autonomia speculativa a fronte delle Naturwissenschaften, cioè l’insieme delle scienze naturali: Fisica, Biologia, Matematica, Chimica, etc… Nell’interpretazione di Dilthey le scienze dello spirito sono distinte e separate dalle scienze della natura in quanto queste studiano fatti che si mostrano alla coscienza estrinsecamente, quali fenomeni dati singolarmente, invece nelle Scienze dello Spirito i fatti si mostrano subito in maniera intrinseca, come una realtà autonoma ed una correlazione vivente. Nelle Scienze della Natura la correlazione con quest’ultima deriva da una concettualizzazione chiamata ad integrare i fenomeni, attraverso una connessione congetturale basata su ipotesi sperimentali, mentre le Scienze dello Spirito trovano un principio regolatore nella correlazione elementare dell’esistenza psicologica. Come Dilthey scrive nell’opera Idee su una psicologia descrittiva e analitica, “noi spieghiamo la natura, mentre intendiamo la vita psichica […]. La connessione vissuta è qui l’elemento primo, la distinzione dei suoi singoli membri sopravviene in seguito”. Il fondamento delle Naturwissenschaften, o scienze naturali, è la concettualizzazione, basata sull’equivalenza tra causa/effetto, e la loro modalità d’espressione è nel ragionare mediante equazioni. Il fondamento delle scienze dello spirito è l’ermeneutica comprendente della prospettiva storica e sociale umana sulla base della correlazione e della condivisione comunitaria insita in ogni vita psichicamente connotata. Dilthey distingue tra le scienze dello spirito, da un lato, quelle che si pongono come obiettivo intrinseco le generalizzazioni, quelle che in sostanza mirano a trovare le uniformità della realtà umana, e, dall’altro, la storia. La scienza storica infatti studia i fenomeni umani nella loro peculiarità singolare. sulle manifestazioni umane nella loro specificità individuale. Delle scienze generalizzanti fanno parte: psicologia, antropologia, arte religione, filosofia, scienza, economia e diritto. Ogni scienza particolare dello spirito conosce la realtà storico-sociale solo relativamente, in quanto ha coscienza della propria relazione con le altre scienze dello spirito. Ma come comprendiamo il mondo storico nella sua globalità? Anzitutto mediante l’idea della “oggettivazione della vita”. La vita si esprime in una molteplicità di oggettivazioni relazionate. La comprensione del mondo storico è la comprensione di esse, in quanto tali oggettivazioni sono prodotti storicamente determinati della vita dell’uomo, sono fenomeni obiettivi del processo di produzione della vita. E ciò che si trova come oggettivazione storica della vita degli uomini del passato, è comprensibile in quanto oggettivazione della nostra stessa vita. Per questa ragione, argomenta Dilthey, la storia non è nulla di separato dalla vita, nulla di staccato dal presente a causa della sua distanza nel tempo. Ogni prospettiva filosofica, come ogni manifestazione culturale, è del tutto storicizzata e condizionata anche quando si mostra come un sistema isolato. Essa si caratterizza per una propria intuizione del mondo, che, travestita in panni concettuali, si fa metafisica. Le varie metafisiche, pur avanzando la pretesa di risolvere una volta per tutte i misteri del mondo sono molte e diversificate. È impossibile trovare una filosofia totale che riunisca concettualmente tutti le forme delle diverse metafisiche, in quanto ognuna di esse rispecchia il contesto storico in cui nasce, si sviluppa e conclude il suo ciclo vitale.
ERNST CASSIRER

INTRODUZIONE GENERALE
Con l’insegnamento di Cohen e di Natorp si crea una scuola che tra i due secoli esercita una vasta influenza sulla cultura filosofica tedesca; tale influenza si propaga anche attraverso pensatori che daranno vita ad orientamenti di pensiero innovativi, come Husserl, Hartmann e, in parte, lo stesso Heidegger. E’ però nell’opera di Ernst Cassirer che il legame con l’impostazione neocriticistica rimane più stretto. Esponente del Neokantismo, egli nasce nel 1874 a Breslau (Breslavia). Nel 1886 la sua famiglia si trasferisce a Berlino, dove in seguito potrà seguire le lezioni su Kant prima di Paulsen poi di Simmel. A Marburgo studia filosofia e segue i corsi di Cohen e Natorp. Nel 1898 scrive la prima stesura del Leibniz System . Nel 1902 va a Berlino insieme alla moglie, Toni Cassirer. Nel 1919 ottiene la cattedra all’università di Amburgo e nel 1929 ne diviene rettore. Nel 1933, con l’avvento al potere di Hitler, lascia la Germania perché ebreo e fino al 1935 insegna ad Oxford; perfino in Italia Giovanni Gentile si era battuto per censurare le sue opere. Si trasferisce all’università di Goteborg per qualche anno e dal 1941, negli Stati Uniti, insegna come visiting professor all’università di Yale. Tra le sue opere meritano di essere ricordate: Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza dell’età moderna (in quattro tomi, dal 1906 al 1920), Vita e dottrina di Kant (1918), Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento (1927), La filosofia dell’illuminismo (1932), Concetto di sostanza e concetto di funzione (1910), Filosofia delle forme simboliche (in tre volumi, dal 1923 al 1929), Saggio sull’uomo (1944). Negli Stati Uniti muore il 13 aprile del 1945, a Princeton. Il punto di partenza neocriticistico di Cassirer è evidente soprattutto nelle opere di carattere storico, in cui egli si mantiene sostanzialmente fedele al privilegiamento del problema filosofico della conoscenza. Però, se l’interpretazione kantiana di Cassirer deve molto a Cohen, essa rappresenta una novità laddove, pur ribadendo la normatività della struttura logica dell’esperienza scientifica, ammette la possibilità di più forme che rendono possibile non soltanto la scienza, ma anche la morale, l’arte e la religione. E in luogo della preferenza per la Critica della ragion pura si ritrova in Cassirer una considerazione privilegiata per la Critica del Giudizio in quanto approdo problematico del criticismo ad una filosofia della cultura in generale. Anche nel suo lavoro storiografico di maggior rilievo, quello sulla storia del problema della conoscenza (tradotto in italiano con il titolo fuorviante di Storia della filosofia moderna ), l’impostazione si era venuta evolvendo da un iniziale interesse (nei primi due volumi) volto quasi esclusivamente alla trattazione dei problemi gnoseologici riferiti alle scienze esatte, ad una più ampia considerazione delle diverse forme culturali. E nello studio sul concetto di funzione, che nella scienza moderna si è venuto sostituendo a quello di sostanza, Cassirer mette in luce l’importanza del linguaggio , e quindi del segno, nella costituzione degli oggetti di cui si occupa la scienza. Veniva in questo modo aperta la via ad un ampliamento della rivoluzione copernicana a tutte le forme della cultura, riconosciute nella loro irriducibile autonomia, cioè alla filosofia delle forme simboliche . Non soltanto di ampliamento si tratta, ma anche di un autentico mutamento di prospettiva. Nella Filosofia delle forme simboliche permane, infatti, l’esigenza sistematica caratteristica del neocriticismo marburghese, ma essa si realizza in una “critica della cultura” in cui si considera ogni attività spirituale nella sua forma caratteristica, nel suo manifestarsi peculiare, nel suo (come dice Cassirer) ” esser così “, in una ricchezza di forme che rispecchiano la stessa ricchezza della vita. Ciò che accomuna le diverse sfere della cultura (linguaggio, mito, religione, arte, ecc) è la loro natura di ” forme simboliche ” in quanto rappresentano mediante segni simbolici il contenuto dello spirito: ” il simbolo non è il rivestimento meramente accidentale del pensiero ma il suo organo necessario ed essenziale […]. L’atto della determinazione concettuale di un contenuto procede di pari passo con l’atto del suo fissarsi in qualche simbolo caratteristico “. Il compito della filosofia sarà allora quello di mostrare come attraverso l’espressione simbolica si generino le varie forme della realtà spirituale; e a questo compito è preliminare la considerazione del linguaggio, inteso come l’attività specificamente umana attraverso la quale si organizza l’esperienza, che dalla sua espressione immediata e grezza si trasforma in un mondo di simboli. Il mito, l’arte, la religione, la storia fanno parte dell’universo simbolico, sono ” i fili che costituiscono l’aggrovigliata trama dell’esperienza umana “. Se tutte le forme della vita culturale dell’uomo sono forme simboliche, allora anche l’uomo potrà ormai essere definito animal symbolicum : ” in tal modo si indicherà ciò che lo caratterizza e che lo differenzia rispetto a tutte le altre specie, e si potrà capire la speciale via che l’uomo ha preso: la via verso la civiltà “.
IL PENSIERO
Il simbolo per Cassirer è lo strumento che permette all’uomo d’operare una mediazione attiva tra il concreto e il concetto; la forma simbolica è ogni energia dello spirito mediante la quale un contenuto spirituale dotato di significato viene collegato a un segno sensibile e viene ad esso intimamente attribuito. In altre parole, la forma simbolica è un codice attraverso cui si oggettiva lo spirito, mediante cui si esprime lo spirito umano. Passiamo alla conoscenza scientifica in Cassirer: essa s’inquadra a pieno titolo nell’ambito della filosofia delle forme simboliche. La scienza si configurerebbe, anzi, come la realizzazione della più alta forma di cultura umana, basata naturalmente sulla complessa funzione spirituale, che in questo grado di sviluppo approderebbe al livello pienamente razionale e – al tempo stesso – sul terreno dell’astrazione pura. La conoscenza scientifica darebbe “compiutezza” al cammino umano indirizzato alla razionalità dell’esistenza. La filosofia matematica di Cassirer è detta “costruttivismo”; si oppone all’intuizionismo e al formalismo. Cassirer propone una matematica fondata sulla costruzione nell’ambito delle forme pure di spazio e tempo. Per questa ragione, tutte le riflessioni svolte da Cassirer intorno alla conoscenza scientifica prendono le distanze dal progetto positivistico (empiriocriticista) di Mach. Secondo Cassirer lo spirito (cioè il pensiero) si struttura trascendentalmente ( e kantianamente) per mezzo di categorie (vale a dire forme invarianti del pensiero) come l’io, lo spazio, il tempo, la causalità, ecc. Queste strutture fondamentali dello spirito sono presenti in tutte le forme simboliche, sebbene tale loro fissità implichi di volta in volta configurazioni differenti: si tratta, perciò, di diversi modi di darsi una struttura invariante. Per fare un esempio, lo spazio estetico ha caratteri eterogenei rispetto allo spazio scientifico e anche rispetto allo spazio mitico, così come differiscono spazio scientifico e spazio mitico; in particolare, l’intuizione mitica dello spazio è uno spazio mitico, concreto: si configura come una distinzione tra sacro e profano che dà vita a uno spazio, tendente all’universalità (e in ciò differisce dallo spazio geometrico), che è una forma di organizzazione, è insomma una sorta di “spazio strutturale”. Sulla base di queste sue convinzioni, Cassirer è alla ricerca di uno schema che sia in grado di ordinare le cose attraverso le categorie. Mito e scienza per Cassirer sono modalità di comprensione del mondo dotate di specifica e irriducibile identità; esisterebbe tuttavia un rapporto gerarchico tra mito e scienza, e il mito sarebbe inferiore in quanto valutato da Cassirer meno razionale della scienza. Secondo Cassirer il mito rappresenta la forma spirituale che porta a conoscere il senso dell’io e del tu e il senso dell’io e del mondo. Il mito ha quindi un proprio significato preciso, da non confondere con quello delle altre forme spirituali. Per Cassirer sarebbero individuabili due filosofie della mitologia: 1) quella di Schelling; 2) quella positivistico-psicologico-sociologica. Cassirer, elogiando Schelling, sostiene che suo merito grande fu quello di porsi per primo il problema del mito, nel quale vide l’espressione dello spirito. Cassirer critica invece lo studio positivistico della mitologia, riscontrandovi una giustificazione della forma culturale mitica a partire unicamente dalla storia e dall’organizzazione sociale. Cassirer oppone all’interpretazione positivistica del problema mitico una riflessione trascendentale che si sforza di non dipendere dall’esterno, dalla società e dalle influenze storiche. Questo è il cuore, l’essenza della filosofia delle forme simboliche Cassirer: la ricerca delle condizioni di possibilità del fatto culturale. In altre parole, Cassirer effettua una critica della coscienza mitica; ed è una critica in senso lato, non negativo. Il mito per lui è un modo di conferire significato alla realtà, essendo il mito a suo avviso una produzione spirituale, e non un coacervo di elementi privi di senso intrinseco e relazioni reciproche. Si è visto che Cassirer considera il mito dotato di una propria logica, nonostante esso si configuri ancora come una forma pre-scientifica del pensiero. E il mito è una forma pre-scientifica, e non pre-logica, di pensiero dal momento che possiede una legalità trascendentale fondamentalmente affine alla strutturazione essenziale tipica del pensiero scientifico. Cassirer si occupa del mito nel secondo dei suoi quattro volumi dedicati alle forme simboliche. La sua maggior preoccupazione critica consiste nello studiare le strutture logiche portanti del mito, vale a dire le forme di elaborazione mitica del mondo, ma senza riscontrare sostanziali differenze fra la concettualizzazione scientifica e la concettualizzazione mitica, considerate semplici tappe di un processo di razionalizzazione e di astrazione dei linguaggi umani e, più in generale, del mondo. Cassirer trascura l’analisi del prodotto mitico per dedicarsi all’indagine delle forme in cui il mito sorge, valorizzando quindi, in primis, le condizioni che permettono la sua nascita. E’ convizione di Cassirer che i numeri razionali abbiano valore perché posti in serie e, dunque, in relazione gli uni con gli altri. Nel 1922 egli si chiede se anche il mito sia da considerarsi un concetto seriale oppure se si tratti di un concetto-genere. La risposta è perentoria: il discorso mitico è da intendersi come concetto seriale, in quanto diretto a ordinare il molteplice; in altre parole, il mito non ricopia la realtà, ma piuttosto la struttura. Anche nello studio del mito, perciò, Cassirer palesa un’impostazione trascendentale diretta a studiare le condizioni che permettono la nascita di determinati “fenomeni” nella storia e nelle diverse culture, anziché limitarsi a enumerarne acriticamente e disordinatamente le variopinte forme via via assunte. A parere di Cassirer, inoltre, il mito non può che essere una forma pratica, visto il suo intimo legame con la vita dell’uomo, col suo operare, oltre che col suo pensare e strutturare il mondo. Il mito è, in senso forte, una modalità (la modalità “antica”, di comprensione del mondo). Rileva Cassirer che la prima strutturazione del mito è data dallo spazio, dal tempo e dal numero visti miticamente. Grazie al mito l’uomo antico pervenne a comprendere il senso mitico dell’io e dell’intersoggettività (io e non-io, regole comuni di vita accanto agli altri e con gli altri in comunità). In Cassirer è riscontrabile una dialettica della coscienza mitica; esistono rapporti tra religione e mito, anche se – a dire il vero – quando viene a predominare il momento religioso il superamento della visione mitica è ormai inesorabimente in atto. Nel mito i simboli sono essenziali per la comprensione, mentre nella religione si fa maggiormente largo la razionalità a scapito del simbolo: il numero meno cospicuo di simboli utilizzati dalla religione non impedisce però che essi siano usati con più consapevolezza e per supportare una certa idea di divinità, così come questa immagine emerge dai testi sacri (si tenga presente che nelle considerazioni di Cassirer la religione contemplata di preferenza è quella ebraica). Secondo Cassirer lo spirito, possedendo una forte propensione naturale a strutturare la realtà, dà vita a forme simboliche, quale ad esempio il mito, che è da considerarsi a pieno titolo una forma di oggettivazione dello spirito. Per il Cassirer del 1922 la funzione mitica, vale a dire l’operare con concetti, è spontanea, dal momento che lo spirito tenderebbe a suo avviso a informare di sé la realtà, strutturandola, alla stregua di quanto avviene nel campo scientifico. Per questa ragione, Cassirer indaga le strutture (trascendentali) del pensiero mitico. A giudizio di Cassirer, le forme simboliche nascono per dar risposta alle scienze dello spirito, le quali corrispondono propriamente alle scienze del mondo umano. Sullo sfondo c’è chiaro in Cassirer l’intento di pervenire a un’ unità delle scienze , tanto delle scienze della natura quanto delle scienze dello spirito: già nel 1910, in Sostanza e funzione , egli aveva infatti confutato le tesi di Richer, il quale riteneva che le scienze storiche sarebbero in grado di cogliere soltanto l’individuale, in contrasto netto con le scienze della natura che parlerebbero dell’universale; per Cassirer il concetto, lungi dall’essere “genere”, è piuttosto “seriale”, concetto “funzione”, e dunque, potendo cogliere l’individuale, priva di senso la distinzione di Richer. Il mondo umano e il mondo naturale possono allora trovare un loro dialogo nella filosofia proposta da Cassirer, perché nelle sue concezioni si riconosce nello spirito la capacità attiva di strutturare la realtà in ogni campo, conferendo così significato alla realtà stessa. In Cassirer riscontriamo quindi una teoria del concetto che anela ad unificare il mondo della natura e il mondo della storia. In quanto sensibile rappresentato nello spazio e nel tempo, l’ intuizione si colloca come tappa intermedia fra sensibile e intelligibile. Per Cassirer l’intuizione sfrutta la corporeità, attraverso la quale sarebbe possibile introdursi alla conoscenza il mondo. Mentre lo spazio permette immediatamente di collegare l’Io e il mondo, la determinazione di tempo fatica ad essera appresa con la stessa rapidità, come dimostra con tutta evidenza il bambino, da subito in grado di capire il riferimento all’oggetto indicato, ma in difficoltà di fronte a collocazioni cronologiche di eventi. Negli ultimi (e più maturi) stadi di sviluppo dei codici linguistici, la parola e il numero prendono il sopravvento grazie alla loro fondamentale capacità d’identificare una cosa che può anche non essere presente in quell’istante (ammesso, ovviamente, i riceventi del messaggio abbiano accesso al codice utilizzato: ogni lingua, infatti, simbolizza con vocaboli diversi la stessa realtà; è il principale inconveniente legato alla sempre maggior astrattezza del linguaggio). Humboldt fornisce a Cassirer l’idea che il linguaggio non sarebbe un’opera compiuta, ma piuttosto un’attività. Entrambi ritengono che compito prioritario del filosofo sia la ricerca di un metodo adeguato per studiare il linguaggio (problema epistemologico). Come abbiamo già notato più volte, osservare le cose in un’ottica di processo e l’indagine dell’attività dello spirito attraverso lo studio del linguaggio sono i pilastri della filosofia delle forme simboliche di Cassirer. Guardiamo più a fondo la questione. Cassirer parla di tre fasi di maturazione del linguaggio :
1) fase “sensibile”;
2) fase “intuitiva”;
3) fase del “pensiero concettuale”.
Quest’ordine di sviluppo, fisso, si deve intendere valevole tanto per il terreno ontogenetico quanto per quello filogenetico. Nello studio della fase sensibile del linguaggio, Cassirer si serve sovente di analogie col linguaggio dei bambini e degli animali, fondati sulla gestualità. Nel caso specifico dei bambini, si tratta di una gestualità che indica e imita quella dell’uomo adulto; l’animale, invece, pur essendo assolutamente incapace di indicare, impara presto a imitare, ma in forme proprie e affatto diverse dalle forme tipicamente umane di imitazione, fondate sulla comprensione del complesso e dinamico contesto culturale vigente. Cassirer suddivide l'”espressione” dall'”impressione”: la prima equivarrebbe all’impronta creativa dello spirito, mentre la seconda rimanderebbe più direttamente a una concezione sensistica della realtà. Il concetto di espressione è molto importante nel lavoro di Cassirer e, per quanto concerne la prima fase di maturazione del linguaggio, egli ritiene di dover discernere tre tappe del linguaggio parlato: ” espressione mimica “, costituita da onomatopee (i sentimenti, però, sono espressi in forme diverse: ogni popolo, ad esempio, esterna diversamente il dolore); ” espressione analogica “, che comincia a staccarsi dal sensibile (come quando si dice, ad esempio, “il tran tran della vita”); ” espressione simbolica “, grazie alla quale compaiono i simboli, in larga parte slegati dal sensibile e quindi incapaci di richiamare im-mediatamente l’oggetto concreto che si vuol significare (se, ad esempio, non conosco un determinato codice linguistico i vocaboli che leggo o sento pronunciare in quella lingua non mi indicano alcunché). Secondo Cassirer i simboli (cioè, in senso lato, il linguaggio) non sono il riflesso, la riproduzione delle cose. La sua filosofia delle forme simboliche contrasta, quindi, le pretese della diffusissima Abbildtheorie, inaugurata di fatto da Democrito e dagli Stoici, e rielaborata poi nel Medioevo da Tommaso e nell’Età moderna da Berkeley. In questo seguace ideale di Kant, Cassirer non intende la conoscenza come copia, in quanto non crede che l’uomo possa arrivare all’in-sé delle cose. Il segno, anziché rimandare alla cosa pura, sarebbe la costruzione delle cose. Secondo Cassirer per illustrare icasticamente il processo della conoscenza, l’abusata metafora dello specchio quindi non calzerebbe, almeno nella forma consueta: la si può tuttavia ribaltare ad hoc, asserendo che il linguaggio è lo specchio di noi stessi, della coscienza delle cose, e non lo specchio delle cose stesse. Compito del filosofo è perciò quello di esaminare il linguaggio allo scopo di rinvenire in esso tracce dei meccanismi del pensiero che hanno reso possibile e generato i simboli così come si presentano. Ritenendo che i nostri modi di pensare permangano in tracce nel linguaggio, Cassirer studia dunque il linguaggio per attuare la morfologia dello spirito; tuttavia, non si comprende bene se il linguaggio a suo avviso debba essere considerata come la forma privilegiata per l’esplicitazione dello spirito. Già dai primi anni di studio delle forme simboliche, Cassirer afferma che con “espressione simbolica” si deve intendere espressione di una realtà spirituale compiuta attraverso segni o forme simboliche (come, ad esempio, il linguaggio), laddove una “forma simbolica” è intesa come ogni forma che si va oggettivando per mezzo segni sensibili. Maturando le sue concezioni, Cassirer indica la “forma simbolica” come ogni energia spirituale legata a un simbolo (arte, linguaggio, ecc.). A suo avviso – e sulla scorta di una lunga tradizione filosofica in materia -, qualsiasi rapporto umano con la realtà non può che essere mediato; da questa convinzione trae la sua condizione di possibilità la filosofia delle forme simboliche, e cadono invece le istanze vitalistiche che considerano la vita coincidente con la forma: riprendendo Hegel, Cassirer ritiene che l’uomo possa soltanto ritradurre la realtà nel linguaggio dello spirito. E il simbolo non sarebbe altro che il mezzo di cui lo spirito si serve per mantenere il suo rapporto mediato con la realtà. Il rapporto simbolico è dinamico: arte, scienza, linguaggio, mito, ecc. sono stadi dello sviluppo dell’espressione simbolica: la conoscenza scientifica è la forma più astratta, mentre il mito è ricollegabile direttamente all’intuizione, alla sensibilità. A questo riguardo, mediante la sua filosofia delle forme simboliche, Cassirer vanta una finalità precisa, assiologica, quella di liberare il simbolo dalla sensibilità, come a dire che il linguaggio scientifico appartiene a una fase più evoluta, “moderna”, della storia dell’umanità. In questo, Cassirer si dimostra più “ottimista” di Warburg, il quale, dichiarando che non esiste una tal connessione teleologica fra i diversi codici simbolici, sottolinea che la storia vede continuamente uno scontro serrato fra simboli mitici e simboli scientifici. A una realtà dove il predominio della ragione non è mai scontato non crede tuttavia Cassirer, che anche nell’astrologia riscontra un (prematuro) tentativo di scoprire i nessi causali tra i fenomeni, quasi fosse l’astrologia la progenitrice diretta della concezione scientifica della realtà emersa poi con forza a partire dall’Età moderna. A partire dal secondo decennio del Novecento, nell’elaborazione di taluni concetti inerenti alla sua filosofia, Cassirer sembra risentire non poco del magistero goethiano, ad esempio quando egli definisce morfologia dello spirito le forme simboliche. Nel 1916 Cassirer contrappone Goethe a Hegel , rimproverando a quest’ultimo di aver partorito un universo assoluto, strettamente vincolato ai limiti fissati alle possibilità del pensiero soltanto per chiudere, con estrema arroganza intellettuale, il proprio sistema filosofico. Negli stessi anni, come appare in Libertà e forma , all’avvicinamento di Cassirer a Goethe si affianca il recupero del Kant della Critica del Giudizio . In Vita e dottrina di Kant (1918) Cassirer conferma una prossimità ideale con la seconda parte della Critica del Giudizio , in cui Kant si occupa di forme viventi, dell’individuo e dell’organismo (lungi dal risultare alla stregua di una mera somma di parti, si configurerebbe come il tutto che sovrasta le parti), in particolare di quegli organismi complessi che sono le culture. Rafforzando certe tesi kantiane, Cassirer intende impostare uno studio filosofico della cultura, di cui tutto farebbe parte, dal linguaggio al mito, dalla scienza all’arte, ecc. Se pensiamo che per Cassirer la cultura non è altro che l’oggettivazione dello spirito – in senso lato – in forme simboliche, sarà più agevole comprendere le ragioni del suo spiccato interesse per i codici attraverso cui si esprimono le oggettivazioni dello spirito, appunto il mito, il linguaggio, la tecnica, ecc. Tuttavia, l’elenco di questi codici non trova una sua sistemazione ultima, definitiva, negli studi di Cassirer, tanto che in opere diverse compaiono di frequente elenchi in parte eterogenei. Esiste una continuità di fondo tra neokantismo di Marburgo e filosofia delle forme simboliche di Cassirer, in quanto il metodo di approccio alla realtà si rivela il medesimo. Studiando la filosofia delle forme simboliche è quindi necessario far riferimento agli esordi accademici di Cassirer sotto la guida dei celebri Cohen e Natorp. Di filosofia della cultura si parlava già alla fine dell’Ottocento, epoca in cui si andò formando il giovane Cassirer: l’obiettivo era quello – come si affermava – di aprire all’indagine e alla speculazione la “totalità dello spirito oggettivo”, approfondendo non solo gli aspetti razionali, interesse esclusivo di Kant, ma criticando la cultura tutta, compreso aspetti eterogenei e “superati” come il mito. Il primo Novecento tedesco prestando particolare attenzione alla “totalità dello spirito oggettivo” testimoniava la coeva rinascita dell’Hegelismo, tanto che lo stesso Cassirer avrebbe presto rivalutato testi come la Fenomenologia dello spirito , aperto a temi diversi e ricco di prospettive giudicate feconde dal punto di vista filosofico. Pur stimolata dal pensiero di Hegel, la scuola di Marburgo accusava tuttavia la sua dialettica di uccidere lo spirito oggettivo. Il neokantismo pensava che la filosofia fosse in grado di dare unità alla cultura; Cassirer si spinse oltre e cercò, tra il 1910 e il 1920 circa, di approfondire i fondamenti storici della “sua” filosofia delle forma simboliche, prendendo però le distanze dai suoi maestri già a partire dalle loro posizioni intorno a una presunta superiorità culturale della Germania contemporanea, e quindi di una missione teutonica da esplicarsi su scala universale. La riforma del neokantismo di Marburgo attuata da Cassirer s’incentrò sulla rilettura di Goethe, che egli giudicò superiore a Kant e che in breve tempo divenne quasi il patrono e il nume tutelare della costituenda filosofia delle forme simboliche.
CHARLES SANDERS PEIRCE

“La parola o il segno che l’uomo usa è l’uomo stesso. Perché il fatto che ogni pensiero è un segno, insieme al fatto che la vita è un seguito di pensieri, prova che l’uomo è un segno. Cosí, il fatto che ogni pensiero è un segno esterno, prova che l’uomo è un segno esterno. In altri termini, l’uomo e il segno esterno sono la stessa cosa, nello stesso senso in cui la parola homo e man sono identiche. Cosí il mio linguaggio è la somma totale di me stesso; poiché l’uomo è il pensiero“.
Quasi nello stesso tempo in cui si stava sviluppando l’idealismo con Royce, negli Stati Uniti si assistette alla nascita della corrente del pragmatismo, che costituisce il più originale contributo americano alla filosofia novecentesca ed esercita una vasta influenza anche sulla cultura europea: il termine pragmatismo mette in rilievo la tesi fondamentale secondo cui il significato di qualsiasi cosa è determinato dalla sua rilevanza pratica. L’iniziatore di questa nuova corrente, destinata a grande successo, é Charles Sanders Peirce, anche se egli non tarderà a prendere le distanze dal movimento. Nato a Cambridge nel Massachussetts nell’anno 1839, figlio di un famoso matematico che insegnò fisica e astronomia ad Harvard, tentò con insistenza, senza riuscire, di ripercorrere la carriera accademica paterna. Non ottenne successo neanche nella pubblicazione delle sue opere che, fatta eccezione per alcuni importantissimi articoli, rimasero inedite e uscirono solo quando Peirce era già morto (morì nel 1914 a Milford, in condizione di miseria). Una prima antologia dei suoi scritti apparve, postuma, nel 1923 con il titolo di Caso, amore e logica . Le sue opere sono ora raccolte nei sei volumi della Raccolta di scritti di Ch. S. Peirce (Collected Papers of Ch. S. Peirce), edite negli anni 1931-1935. Benché sia uno dei più grandi filosofi americani, Peirce in vita non pubblicò nemmeno un libro. Pubblicò solo articoli apparsi su giornali e riviste e molti dei suoi scritti rimasero inediti fino a dopo la sua morte. La prima edizione di tutti i suoi scritti sono i Collected Papers pubblicati tra il 1931 e il 1958 dall’Università di Harvard: tutte le citazioni appresso riportate sono tratte da quest’opera e sono indicate con C.P., il numero di volume, un punto e il numero di paragrafo. Dal 1982 sono in pubblicazione i Writings of Charles Sanders Peirce. A chronological edition, a cura del Peirce Edition Project, presso l’Università dell’Indiana. Charles Sanders Peirce (1839–1914) è con De Saussure uno dei padri della «semiotica» moderna. Ma Peirce è anche il fondatore del «pragmatismo», a cui cambierà poi il nome in «pragmaticismo» per differenziarsi da William James. Infatti Peirce rimproverava James di aver impoverito il pragmatismo attraverso l’esclusione del suo fondamento logico–semiotico, che per Peirce è parte integrante di una teoria della conoscenza. Peirce afferma: “Il concetto di essere contiene la mera unione del predicato con il soggetto, unione nell’esprimere la quale le due accezioni della copula («è effettivamente» e «sarebbe») concordano. Il concetto di essere, insomma non ha contenuto”. (C.P. 1.547) Questa affermazione si spiega attraverso il concetto di conoscenza di Peirce: non esiste una conoscenza che non sia segnica. Il segno è sempre frutto di una mediazione interpretativa inferenziale. Il concetto di “essere” viene quindi definito da Peirce come: “Un concetto che riguarda un segno, cioè un pensiero o una parola, e dal momento che non è applicabile a ogni segno, non è originariamente universale, sebbene lo sia nella sua applicazione mediata alle cose” (C.P. 5.292). Per Peirce solo ciò che è pensabile è reale: il pensiero non può essere altro che pensiero di segni e il concetto di essere è appunto un concetto che diviene attribuibile solo attraverso una relazione inferenziale, in quanto i segni sono essi stessi prodotto dell’attività inferenziale. Questa posizione è da Peirce chiamata Realtà Logica. Quindi il concetto di essere, in assoluto, sciolto cioè dalle relazioni segniche, non ha contenuto, né significato e neppure senso, come del resto qualunque altro concetto. L’essere di un segno insomma è proprio il suo sviluppo semiosico, il suo essere in relazione con gli altri segni. Non esiste al di fuori della semiosi altro modo di concepire la realtà Si può conoscere, e quindi si considera reale, solo una relazione segnica e non un supposto oggetto assoluto, in sé irrelato. Ma perché per Peirce il pensiero è solo pensiero di segni? Peirce rifiuta l’intuizione. Col termine “intuizione” si indica “Una cognizione non determinata da una cognizione precedente dello stesso oggetto, e perciò determinata da qualcosa fuori dalla coscienza. […] Intuizione sarà qui quasi la stessa cosa che «premessa, che non è a sua volta conclusione». […] Proprio come una conclusione (giusta o sbagliata) è determinata nella mente di chi ragiona dalla sua premessa, cosi anche cognizioni che non sono giudizi possono essere determinate da cognizioni precedenti; e una cognizione non determinata in questo modo, e quindi determinata direttamente dall’oggetto trascendentale, dovrà essere chiamata una «intuizione»”. (C.P. 5.213) Nel saggio “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man” pubblicato sul Journal of Speculative Philosophy nel 1868 (C.P. 5.213 – 263) Peirce, dimostra che sia la conoscenza del mondo esterno al soggetto sia quella del mondo interiore del soggetto, come la propria autocoscienza e la conoscenza dei propri moti interiori, dipendono da mediazioni inferenziali di fatti esterni. Egli ritiene che tutta la nostra conoscenza della mente e dei processi mentali – della nostra mente e di quella degli altri – deriva dalla conoscenza di certi fatti fisici “esterni”: E alla domanda “se possiamo pensare senza segni” risponde in C.P. 5.250 “Se ci basiamo sui fatti esterni, i soli casi di pensiero che possiamo trovare sono quelli di pensiero in segni. È chiaro che nessun altro pensiero può essere evidenziato da fatti esterni. Ma abbiamo visto che il pensiero si può conoscere solamente attraverso i fatti esterni, dunque, il solo pensiero che è possibile conoscere è, senza eccezione, il pensiero in segni. Ma il pensiero che non può essere conosciuto non esiste. Perciò ogni pensiero deve necessariamente essere pensiero di segni”. (C.P. 5.260) “L’unico modo in cui si può conoscere […] è per inferenza ipotetica da fatti osservati. Ma citare la cognizione dalla quale una cognizione è stata determinata, significa spiegare le determinazioni della cognizione in causa. Ed è il solo modo di spiegarle. Poiché qualche cosa completamente fuori dalla coscienza, che si può supporre che la determini, può, come tale, essere riconosciuta e citata solo nella determinata cognizione in questione. [,..] Inoltre le facoltà cognitive di cui siamo a conoscenza sono relative, e conseguentemente i loro prodotti sono relazioni. Ma la cognizione di una relazione è determinata da cognizioni precedenti. Dunque, nessuna cognizione non determinata da una cognizione precedente può essere conosciuta. Essa, allora, non esiste, primo, perché è assolutamente inconoscibile, secondo, perché una cognizione esiste solo in quanto è conosciuta”. (C.P. 5.262). Non esiste per Peirce un termine primo, una causa prima, un fondamento su cui si basa la conoscenza. Essa è un processo autoalimentantesi: il pensiero è una serie continua ed infinita di termini. In questo orizzonte, conoscere è inteso come dare significato ad un evento, applicando ad esso regole e criteri di classificazione appresi precedentemente. Non esiste un punto di partenza, nel modello della conoscenza peirciana, ma per ogni singolo individuo, la nascita è l’inizio del suo processo mentale di conoscenza, con l’ingresso nella Realtà Logica, costituita dall’insieme di segni in uso alla comunità degli interpretanti, di cui l’individuo viene a fare parte. Si è detto sopra che il segno, e quindi la conoscenza, è il risultato di un processo inferenziale. Si analizzerà ora quali sono le tipologie di inferenza attraverso cui si costruisce la conoscenza: Peirce distingue tre specie di inferenza: Deduzione, Induzione ed Abduzione. Non sono però riducibili l’una all’altra, perché sono governate da diversi principi logici, ma tuttavia appartenenti ad un unico genere. L’abduzione è un’ipotesi probabile che si formula della causa di un effetto osservato. L’induzione fornisce, con la scelta corretta dei campioni, regole per formulare notizie corrette su essi, fino a prova contraria. La deduzione rimane analitica, ma l’analisi dipende ora dalle ipotesi scelte, per cui non è rigidamente necessaria. L’Abduzione o Ipotesi permette di ipotizzare quindi una regola che dia spiegazione di un evento o di un fatto. Essa “Procede come se si conoscessero tutti i caratteri richiesti per la determinazione di un dato oggetto o di una data classe”. C.P. 5.272 In pratica, osservati alcuni caratteri di un dato oggetto, gli si attribuiscono ipoteticamente ulteriori caratteri che lo fanno riconoscere come occorrenza di una legge. Questo modo di procedere implica la possibile fallibilità della conoscenza, ma anche che i ragionamenti fallaci si adeguano alla forma dell’inferenza valida. Peirce afferma: ” Nessun pensiero, nessun sentimento, in sé considerati, contengono altri pensieri o altri sentimenti, ma sono assolutamente semplici e non analizzabili. […] Ogni pensiero […] in quanto immediatamente presente, è un sentire puro, senza parti, e quindi, in sé, senza similarità con nessun altro, anzi, non comparabile e assolutamente sui generis”. (C.P. 5.284) Se consideriamo il pensiero in sé, irrelato, non facciamo altro che prendere in considerazione la sua peculiare qualità che lo distingue da tutti gli altri pensieri precedenti e successivi e che scomparirà irrimediabilmente con lo scomparire di quello specifico pensiero. Questa qualità, essendo qualcosa di unico ed irripetibile, non è in sé e per sé esprimibile come caso di una regola più generale e quindi risulterà inesprimibile. Continua però Peirce: Nessun pensiero presente in atto (che è un mero sentimento) ha alcun significato, né valore intellettuale; perché il significato non sta in ciò che è pensato nell’atto in cui è pensato, ma in ciò a cui questo pensiero può essere connesso da pensieri successivi nella rappresentazione; cosicché il significato di un pensiero è qualcosa di virtuale. […] In nessun istante, nel mio stato mentale, vi è cognizione o rappresentazione, ma essa consiste nella relazione dei miei stati mentali in istanti diversi. (C.P. 5.284) Aggiunge poi in nota: Di conseguenza, esattamente come si dice che un corpo è in movimento e non che il movimento è in un corpo, si dovrebbe dire che siamo in pensiero e non che i pensieri sono in noi. La virtualità del significato di un pensiero, cui accenna Peirce nel passo precedente, è relativa alla sua idea di semiosi; infatti un pensiero segno ha una sua vita, un suo sviluppo che altro non è che il percorso della costruzione della conoscenza; questo processo ha uno sviluppo certo intersoggettivo, ma anche intrasoggettivo. Infattti: “Non vi è […] cognizione che non sia determinata da cognizioni precedenti [quindi] l’irruzione di una nuova esperienza non è mai un fatto istantaneo, ma è un evento che occupa del tempo e che passa attraverso un processo continuo. Perciò il suo emergere nella coscienza deve probabilmente essere il coronamento di un processo di crescita. [invece] se un filo di pensiero si spegne gradualmente, con ciò nella sua durata segue liberamente la propria legge di associazione e non vi è nessun momento in cui, a un pensiero appartenente a questo filo, non succeda un pensiero che lo interpreti o lo ripeta”. (C.P. 5.284) Tutta la conoscenza per Peirce è dunque conoscenza di segni; a partire dalla sensazione, non esiste altra modalità conoscitiva che quella inferenziale. E’ attraverso serie intersecantesi di inferenze che gradualmente si sviluppa in maniera sempre più precisa l’interpretante di un segno. Peirce così definisce un segno: “[qualcosa che] sta per qualcuno al posto di qualcos’altro sotto certi aspetti o capacità” (C.P. 2.228). Questa definizione sottolinea il rapporto triadico tra il segno, l’oggetto che questo segno sta ad indicare e la concezione che ne ha colui che interpreta, detta interpretante. Possiamo però prendere in considerazione almeno due tipi di oggetti: 1. la cosa bruta, la cui presenza hic et nunc scatena la semiosi, che è L’Oggetto Immediato; 2. la relazione segnica da cui parte l’elaborazione cognitiva, che è l’Oggetto Dinamico. La conoscenza si sviluppa a partire dall’oggetto immediato che non sarà mai toccato dal processo inferenziale, ma che ne è la molla che ne provoca l’inizio. L’oggetto reale del segno, che è comunque segno a sua volta perché non possiamo pensare altro che segni, è l’oggetto dinamico. Questo si trasformerà nella concezione della comunità degli interpretanti man mano che il suo interpretante logico acquisterà sempre maggiori e nuovi significati grazie al processo di semiosi che è poi il processo stesso della conoscenza. Questo è il significato per Peirce del concetto di Semiosi Illimitata. E solo alla luce di questi chiarimenti si comprende il significato delle seguenti parole di Peirce: In ogni momento siamo in possesso di certe informazioni, cioè di cognizioni che sono state logicamente derivate per induzione e ipotesi da cognizioni precedenti che sono meno generali, meno distinte, e delle quali abbiamo una conoscenza meno viva. Queste a loro volta sono state derivate da altre ancora meno generali, meno distinte, e meno vivaci; e così via a ritroso fino a quel primo ideale, che è assolutamente singolare, e assolutamente fuori dalla coscienza.( C.P. 5.311) Ma perché conoscere? Charles Sanders Peirce è il fondatore del Pragmatismo. Egli elabora questa massima pragmatica: Consideriamo quali effetti, che possano avere concepibilmente conseguenze pratiche, pensiamo abbia l’oggetto della nostra concezione. Allora la nostra concezione di questi effetti è l’intera nostra concezione dell’oggetto. (C.P. 5.2) Lo sviluppo semiosico di un segno lo porta ad avere come Interpretante Logico Finale un abito di comportamento. Questo è una legge che permette di regolare il comportamento, appunto, in base alle concepibili conseguenze pratiche determinate dagli effetti che nell’inferire si attribuiscono all’oggetto-segno. Ad esempio è possibile fare una torta di mele perché le concepibili conseguenze pratiche degli effetti del segno-ricetta sono proprio la realizzazione di quel dolce. La prova di tutto questo è l’induzione sperimentale, cioè la realizzazione della torta di mele. Il segno-ricetta è così il segno dell’idea di torta, che è una legge. La torta ottenuta sperimentalmente è così un’occorrenza di quella legge. Ovvero, se a parità di conoscenze e di condizioni di attrezzature sperimentali, la ripetizione di un esperimento porterà i medesimi risultati, la legge ipotizzata come quella regolante l’esperimento è considerata certa dalla Comunità degli Interpretanti. Questa comunità è il garante intersoggettivo di una nozione di verità non intuitiva, non ingenuamente realistica, bensì congetturale. Questa concezione dinamica della verità permette l’elaborazione di strategie comportamentali creative in risposta agli stimoli dell’ambiente ed è portatrice di una concezione non teleologica e non necessaria del mondo e del destino umano.
WILLIAM JAMES

A promuovere la diffusione del pragmatismo – la più originale tra le filosofie americane – sul piano internazionale fu William James, frequentatore come Peirce del ‘Club metafisico’ di Chauncey Wright. James, nato a New York nel 1842, proveniva da una ricca e colta famiglia americana: il padre, Henry James, era esponente di rilievo della filosofia trascendentale e il fratello maggiore era invece famosissimo scrittore. Dopo aver viaggiato a lungo in Europa, William James insegnò psicologia e filosofia ad Harvard. Morì a Chocorua (New Hampshire) nel 1910. Di fondamentale importanza, infatti, sono i suoi Princìpi di psicologia (1890). Tra le opere filosofiche più importanti vanno senz’altro ricordati La volontà di credere e altri saggi di filosofia popolare (1897), La varietà dell’esperienza religiosa (1902), Pragmatismo: un nome nuovo per vecchi modi di pensare (1907), Il significato della verità (1909), nonchè i postumi Saggi sull’empirismo radicale (1912). I Princìpi di psicologia , sebbene non abbiano un oggetto specificamente filosofico, già contengono alcuni assunti che prefigurano la successiva teorizzazione del pragmatismo da parte di James. Dopo essersi laureato in medicina nel 1869 prosegue gli studi da autodidatta indirizzandosi verso la psicologia. Nel 1872 prende avvio la sua carriera universitaria che si svolge interamente all’università di Harvard dapprima come semplice istruttore e divenendo poi nel 1876 professore assistente di fisiologia. Nel 1885 ha l’incarico di professore di filosofia e nel 1890 assume l’incarico di professore di psicologia. Qui all’università di Harvard creerà uno dei primi laboratori di psicologia sperimentale degli Stati Uniti. Sempre nel 1890 anticipando il funzionalismo pubblica una delle sue opere maggiori, “Principi di Psicologia”, in due volumi. I “Principi” sono universalmente considerati come uno dei testi più influenti e rilevanti dell’intera storia della psicologia, e sono stati per decenni uno dei manuali di base nella formazione accademica degli psicologi nordamericani. Nel 1907 si ritira definitivamente dall’insegnamento accademico. I suoi lavori di psicologia influenzarono Henri Bergson, di cui fu a sua volta un grande ammiratore. wiliam James,padre del funzionalismo ci lascia il concetto di pragmatismo e funzionalismo.Il pragmatismo per il quale le idee e i concetti sono veri solo se consentono all’individuo di operare sulla realtà e il funzionalismo, l’idea di una psicologia funzionale ovvero delle funzioni adattive per l’organismo-uomo in relaione all’ambiente. Con la sua opera monumentale Principles of psycology,contrasta fortemente la psicologia tedesca del tempo sostenendo che non esiste una sensazione semplice ma la coscienza è un continuo pullulare di oggetti e relazioni la parte più importante dei Principles è quella relativa a the stream of thought nella quale descrive le caratteristiche del pensiero che associa alla quelle della corrente e dice: ogni pensiero appartiene ad una coscienza personale grazie al concetto di esperienza personale il pensiero è in continuo movimento qiundi il nostro stato mentale varia continuamente, di conseguenza non lo posso studiare. Nei Princìpi di psicologia la vita psichica dell’individuo viene descritta nei termini di un flusso di sensazioni ( stream of feelings ), che si succedono ininterrottamente, compenetrandosi le une con le altre: in questo modo James si contrappone alla scuola associazionistica, che presuppone una giustapposizione successiva e meccanica di sensazioni distinte e indipendenti. La mente umana non é comunque una realtà distinta rispetto al mondo naturale: piuttosto, l’una e l’altro sono i due aspetti diversi di un’unica realtà o, perlomeno, di un unico complesso di realtà integranti. Trova così una spiegazione la celebre teoria jamesiana dell’ azione riflessa , in base alla quale ogni atto psichico non é che la risposta a uno stimolo proveniente dal mondo esterno, senza che si possa separare la prima dal secondo. L’ambiente esterno influenza la vita psichica, la quale a sua volta, tramite l’azione maturata in risposta alla sollecitazione ricevuta, trasforma l’ambiente. Questa interazione non va però concepita in chiave deterministica, dal momento che la risposta dell’individuo all’ambiente contiene sempre una componente di spontaneità che é espressa da quello che James definisce il ‘ dipartimento della volontà ‘, al quale sono sottoposti in funzione strumentale sia il ‘ dipartimento della sensibilità ‘, preposto alla ricezione dello stimolo, sia il ‘ dipartimento del pensiero cogitativo ‘, che interpreta le impressioni esterne in vista della risposta motoria. Dopo aver letto Materia e memoria di Bergson, nell’ultima fase del suo pensiero, James riprenderà la concezione psicologica di una completa integrazione tra mondo psichico e mondo naturale, dandone una riformulazione filosofica sotto la denominazione di empirismo radicale . Nei saggi postumi dedicati a questa prospettiva egli parla infatti di un’unica sostanza reale, che di per sè non é nè spirituale nè materiale: questa sostanza si rifrange in una miriade di elementi, anch’essi nè pura coscienza soggettiva nè puro oggetto di coscienza, i quali prendono il nome di esperienza pura . Il processo della conoscenza é dato esclusivamente dal fatto che i diversi elementi dell’esperienza pura si determinano secondo rapporti reciproci diversi, configurandosi ora come ‘conoscente’ ora come ‘conosciuto’. La teoria psicologica dell’azione riflessa aveva altri due aspetti filosoficamente importanti: l’esito pratico di ogni processo mentale e il suo orientamento verso il futuro. Questi due elementi fanno ritorno, filosoficamente rivalutati, anche nella concezione jamesiana del pragmatismo. Per James come per Peirce, il significato di un’idea o di una teoria è dato dalle sue conseguenze pratiche future. Ma, se per Peirce quest’affermazione implica solamente una teoria del significato, per James essa si trasforma in una teoria della verità . Le conseguenze di cui parla Peirce sono sempre conseguenze generali e oggettivabili, per cui il metodo pragmatistico viene pensato specialmente in vista della sua utilizzabilità in campo scientifico, rendendo possibile la distinzione tra le diverse teorie sulla base dei loro diversi effetti pratici. Per James, al contrario, le conseguenze in questione sono individuali, per cui la validità di un’idea o di una teoria è misurata dalla sua capacità di sortire l’effetto che l’individuo soggettivamente si attende, senza pretendere riscontri sul piano oggettivo. In altre parole, la verità di un’idea viene a coincidere con la sua efficacia pratica : questo Peirce lo negava in modo esplicito. Si spiega così perchè il pragmatismo di James assuma una coloritura differente da quello di Peirce e sia strettamente connesso con la sua teoria più famosa, quella della volontà di credere . In base a questa teoria James sostiene che vi sono casi in cui l’uomo non ha bisogno di aspettare una verifica empirica della sua credenza, ma può credere esclusivamente in base ad una disposizione emotiva o passionale. Perchè questo sia legittimo, però, bisogna che vi siano alcune condizioni. In primis, bisogna che la questione non sia immediatamente verificabile tramite l’esperienza scientifica o storica: non posso credere che un asino possa volare o che Lincoln non sia esistito. Inoltre, occorre che l’opzione, cioè la scelta di credere o di non credere, sia viva (cioè stimoli il mio interesse), importante (cioè non banale) e obbligata (cioè non rinviabile senza che ciò comporti una scelta negativa). E’ questo il caso delle questioni etiche (si può promuovere un miglioramento morale del mondo?) o religiose (esiste Dio?). In questi casi non solo si ha il diritto di credere, ma la credenza può creare essa stessa la propria verifica. Un alpinista che, per superare un precipizio, deve compiere un salto al limite delle proprie capacità, avrà maggiori probabilità di riuscire nell’impresa se, credendo di avere energie sufficienti, le userà tutte nel salto: nello stesso modo il mondo può diventare davvero migliore se noi crediamo in questa possibilità e lavoriamo in questa direzione. Il pragmatismo si configura dunque in James come filosofia dell’ottimismo e dell’intrapresa , come filosofia che risponde pienamente alle esigenze culturali e sociali degli USA che, smarriti gli ideali del pionerismo e della frontiera ed accingendosi a diventare la prima potenza mondiale, aveva un grande bisogno di nuovi contenuti spirituali e di nuove sollecitazioni ideali. A questa esigenza americana risponde anche l’ etica di James, che vuol essere allo stesso tempo una morale del sacrificio e dell’ottimismo. Ogni esigenza umana ( in inglese claim )ha per lui il diritto di essere realizzata, essendo di per sè priva di connotazioni morali. Ma, dato che le esigenze non sono tutte compatibili tra loro, acquisteranno valenza etica (e dovranno essere realizzate) solo quelle che, promuovendo ‘ un ordine sempre più inclusivo ‘, cioè una sempre maggiore armonia tra le esigenze umane, contribuendo alla realizzazione del maggior numero possibile di esse. Con questa teoria James formulava una prospettiva morale in cui l’esito positivo non era assicurato da nessuna teoria del progresso necessario, ma dipendeva dalla volontà e dall’impegno dei singoli uomini. Una filosofia morale per esseri finiti, come sono gli uomini; perchè in questa sfida non entrasse alcuna forza assoluta, che predeterminasse la sua ricerca, James non esita a raccogliere un suggerimento di John Stuart Mill e a parlare di un Dio finito , che collabora con gli uomini nella produzione dell’ordine morale senza poter fornire, però, neppure lui la garanzia del successo: se Dio fosse onnipotente, del resto, si chiede James, come si spiegherebbe il male? Ecco allora che affiora il ‘ migliorismo ‘ di James, la teoria secondo la quale la salvezza dell’universo é attuabile solo con la collaborazione di tutte le sue componenti, Dio compreso (secondo un tema già emerso dall’opera di Mill).
JOHN DEWEY

L’educazione è ricostruzione e riorganizzazione dell’esperienza che accresce il significato dell’esperienza stessa e aumenta l’abilità di dirigere il corso dell’esperienza stessa.
LA VITA, LE OPERE E LA FORMAZIONE CULTURALE
John Dewey nacque a Burlington, nel Vermont nel 1859, studiò alla John Hopkins University e all’università del Michigan, ad Ann Arbor, dove seguì corsi di psicologia. Dal 1894 al al 1904 insegnò nell’università di Chicago, dove fondò la Laboratory School, una scuola sperimentale per bambini, e dal 1904 al 1929 nella Columbia University di New York, dove morì nel 1952. Si interessò sia alla filosofia che alla pedagogia e la sua influenza in questo campo è ancora notevole, sia negli Stati Uniti che nel mondo anglosassone. Dopo un primo periodo di adesione all’idealismo neohegeliano, dovuto all’influenza di G S Morris, il giovane Dewey si accostò al pragmatismo di William James. Giova ricordare che nella formazione intellettuale del giovane Dewey svolse un ruolo fondamentale la sue educazione “cristiana” pratica ed, in particolare, il pensiero di Coleridge, che aveva completamente rigettato la religione come “corpo dottrinario”, per intenderla soprattutto come “volontà di azione” ed esperienza di vita. Le idee religiose di Dewey sono peraltro sempre rimaste un fatto “privato”, a parte il volumetto “A Common Faith” (Una fede comune, La Nuova Italia, Firenze 1959). Nel periodo degli studi universitari aveva vissuto una sorta di crisi spirituale attraverso la quale era giunto ad emanciparsi alla tendenza della personalità di isolarsi “da sè e dal corpo” e questo lo aveva portato a considerare un errore anche il dualismo Dio-natura, spirito e carne. Cercò in Hegel il superamento filosofico del “dualismo” ( e non crediamo che l’abbia trovato, visto che abbandonò ben presto l’idealismo), ma soprattutto cercò in Darwin il senso, non solo filosofico, dell’evoluzionismo. Elaborò quindi una interpretazione progressista e non reazionaria (tipica del cosiddetto “darwinismo sociale”) dell’evoluzionismo. Per capire subito la qualità della filosofia di Dewey dobbiamo intendere che questo superamento del dualismo diventò il leit motiv di tutta la sua ricerca filosofica e pedagogica e venne già a delinearsi nel saggio “Is logic a dualistic science?” (Open Court,III, 1890, pag 2040-2043) Qui Dewey si opponeva chiaramente alla statica dicotomia tra pensiero e realtà esterna, insistendo piuttosto sulla relazione dinamica e reciprocamente condizionante tra mondo dei fatti e realtà del pensiero.
Lo strumentalismo
La filosofia di Dewey venne da lui stesso definita “strumentalismo” in quanto egli interpretò la facoltà di “ragionare” come uno strumento per elaborare l’esperienza. Ciò suppone che il soggetto non sia riducibile alla sola ragione, ma si dia, appunto, un soggetto protagonista attivo, che usa la ragione, indagando, per colmare gli squilibri tra sè e l’ambiente circostante a partire dai propri bisogni. Scrisse in “How we think”:
“Il pensiero non è un caso di combustione spontanea: non accade punto secondo “principi generali”. Vi è qualcosa che lo occasiona e lo evoca.>>
Ed ancora:
<<[…] il pensiero non è un separato processo mentale: è una faccenda che riguarda il modo in cui una gran quantità di fatti osservati e suggeriti nel corso dell’esperienza viene impiegata, il modo in cui essi concorrono insieme e sono fatti concorrere assieme, il modo in cui sono trattati. Di conseguenza tutte le materie, gli argomenti, le questioni, sono intellettuali non per se stessi, ma in ragione del ruolo che, nella vita di una determinata persona, viene fatto loro giocare nella direzione del pensiero” (idem)
Nella “Logica come teoria dell’indagine” egli scrisse:
“Indagare e dubitare sono, fino ad un certo punto, termini sinonimi. Noi indaghiamo quando dubitiamo; ed indaghiamo quando cerchiamo qualcosa che fornisca una risposta alla formulazione del nostro dubbio. Pertanto è peculiare della natura stessa della situazione determinata che suscita l’indagine, di essere fonte di dubbio; o, in termini attuali anzichè potenziali, di essere incerta, disordinata, disturbata. La qualità peculiare di ciò che investe i materiali dati, costituendoli in situazione, non è esattamente un’incertezza generica; è una dubbiosità unica nel suo genere che fa si che la situazione sia appunto e soltanto quella che è. E’ quest’unica qualità che non soltanto suscita la particolare indagine intrapresa ma esercita anche il controllo sopra i suoi speciali procedimenti. Altrimenti nell’indagine un qualunque processo potrebbe aver luogo e riuscirvi fecondo con altrettanta probabiltà che qualunque altro. Ove una situazione non sia univocamente qualificata nella sua propria indeterminatezza, si da uno stato di completo panico: la risposta ad esso assume la forma di attività palesi cieche e selvagge. Enunciando la cosa da un punto di vista personale, noi abbiamo “perso la testa”. Una grande varietà di parole serve a caratterizzare le situazioni indeterminate. Esse sono disturbate, penose, ambigue, confuse, piene di tendenze contrastanti, oscure, ecc… E’ la situazione che ha questi caratteri. Noi siamo dubbiosi perchè la situazione è nella sua essenza dubbiosa.>>
Ancora:
“E’ un errore credere che la situazione sia dubbiosa solo in senso “soggettivo”. La nozione che nell’esistenza reale ogni cosa sia completamente determinata è stata posta in discussione dai progressi della stessa scienza fisica. Anche se ciò non fosse avvenuto, la completa determinazione non avrebbe potuto valere per le cose esistenti in quanto costituenti un ambiente. Infatti la Natura è un ambiente soltanto in quanto si trovi ad essere in interazione con un organismo, o io, o che altro nome si voglia usare.>>
Per Dewey dunque l’individuo vive un processo nel quale la civiltà e la cultura lo differenziano dalla natura. Ogni individuo come organismo vivente incorpora l’ambiente nelle sue funzioni biologiche e, in qualche modo, lo modifica dopo averlo incorporato. Questa distinzione tra sfera soggettiva ed oggettiva comincia a presentarsi coscientemente quando l’equilibrio tra organismo ed ambiente vien meno e si determina la necessità di un adattamento diverso. Dewey fa l’esempio dell’animale che deve cercarsi il cibo: questi è in una situazione diversa dall’animale ben pasciuto, e sente la differenza tra sè ed il mondo proprio in quanto ha un problema da risolvere. Per Dewey la vita è un’altalena di di squilibri e ristabilimenti di equilibri, cioè di bisogni e di soddisfazione degli stessi. La reintegrazione dell’equilibrio non è un semplice ritorno alla situazione precedente, ma comporta delle modificazioni sia nell’organismo che nell’ambiente. Tra l’evoluzione delle specie animali e lo sviluppo della cultura umana c’è tuttavia uno scarto. Il livello della cultura differenzia l’uomo da tutti gli animali perchè non consente una risposta istintiva ed automatica alle difficoltà ed alle privazioni. Il compito del pensiero, ovvero della logica, è di chiarire ed ordinare, organizzare l’insieme confuso ed oscuro delle esperienze fatte e perciò il pensiero si avvale strumentalmente di concetti, ragionamenti e teorie. Queste però non sono che operazioni mentali, cioè strumenti che consentono di rendicontare ciò che sappiamo in modo intellegibile e secondo un senso. Per Dewey il sapere ha dunque un carattere essenzialmente pratico ed operativo. Tuttavia la ricchezza peculiare dell’uomo consiste nel linguaggio; esso consente la comunicazione tra i propri simili e quindi il confronto di esperienze ed una elaborazione comune. Ma il linguaggio non è qualcosa di soprannaturale, è un comportamento biologico particolare, derivante da una naturale continuità con le precedenti esperienze organiche dell’umanità. Dewey definisce la propria teoria della logica come una teoria naturalistica della logica e sostiene che vi è continuità tra i processi più semplici e i processi più complessi dell’attività umana. Pertanto anche la ricerca scientifica è la prosecuzione naturale del comportamento organico con il quale l’uomo affronta le difficoltà primordiali dell’esistenza. Lo scarto tra la vita mentale e culturale e quella fisica, secondo Dewey, risale alla rottura cartesiana tra razionale e fisico (res cogitans e res extensa), ma non è altro che un pregiudizio filosofico che deve essere rimosso per poter finalmente comprendere che è l’esperienza biologica il fondamento della ragione e dunque dello stesso pensiero astratto e simbolico. Nella “Logica dell’indagine” Dewey definisce il modello dell’indagine secondo un modello costante a qualsiasi livello si svolga. Essa parte sempre da una situazione reale problematica, anche drammatica, e quindi indeterminata. Attraverso l’osservazione si raccolgono dati e si intuiscono-vedono dei collegamenti e delle relazioni tra i dati.
“Donde la domanda: come può controllarsi la formazione di un problema genuino in modo che le ulteriori indagini muovano verso una soluzione? Il primo passo da fare per rispondervi è riconoscere che nessuna situazione completamente indeterminata può essere convertita in un problema fornito di elementi definiti. Il primo passo è dunque la ricerca degli elementi di una data situazione che, come elementi, siano ordinati. Quando un segnale d’incendio risuoni in una sala d’adunanza affollata, v’è la più grande indeterminatezza circa ciò che può portare a un risultato favorevole. Uno può finire sano e salvo o può finire calpestato o bruciato. Tuttavia il fuoco è caratterizzato da alcuni tratti ben definiti. E’, per esempio, localizzato in qualche posto. Inoltre i passaggi e le uscite sono in posizioni fisse. Poichè sono definiti o determinati nella realtà, il primo passo nella posizione del problema è di definirli nell’osservazione. Vi sono altri fattori che, mentre non sono temporalmente e spazialmente fissati, costituiscono tuttavia fattori osservabili; per esempio, il comportamento ed i movimenti degli altri membri dell’adunanza. Tutte queste condizioni osservate, ove vengano riunite, costituiscono “i fatti del caso”. Essi sono i termini del problema, in quanto condizioni delle quali occorre tener conto o prendere atto quando ci si voglia proporre una soluzione adeguata. Una possibile soluzione adeguata è allora suggerita dalla determinazione delle condizioni di fatto accertate mediante l’osservazione. La possibile soluzione si presenta perciò come un’idea, proprio come i termini del problema (che sono fatti) vengono stabiliti con l’osservazione. Le idee sono conseguenze anticipate (previsioni) di ciò che capiterà, ove certe operazioni vengano eseguite in preciso rapporto con le condizioni osservate. L’osservazione dei fatti e le significazioni o idee suggerite hanno origine e sviluppo strettamente corrispondenti. Quanto più chiari si profilano i fatti del caso per essere stati assoggettati a osservazione, tanto più chiare e rispondenti si fanno le concezioni circa i modi di trattare il problema costituito da tali fatti.” (idem)
Le idee come fattori operazionali Avendo dunque chiaro come vengono le “idee” intese come fattori operazionali si può dunque convenire sul fatto che esse ci consentono di dirigere ulteriori azioni per migliorare le osservazioni e far venire in luce nuovi fatti ed elementi nella ricerca. Gli scienziati usano un sistema di simboli concettuali più astratto e riflettono su informazioni più elaborate di quelle di cui dispone l’uomo comune, ma anch’essi tendono a riordinare le esperienze e le condizioni ambientali per discernere e contestualizzare il campo delle possibilità. Nella logica di Dewey, che è viva e non esasperatamente formale, si evidenzia una visione inedita tra mezzi e risultati e, per certi aspetti i principi “primi” vengono apparentemente messi da parte. La logica fondata su principi a priori, come quella di Kant, si fonda per Dewey su un modello storicamente determinato, quello della geometria euclidea. Teoreticamente invece, nemmeno nella matematica, i principi sono in sè a priori, ma solo il frutto di criteri direttivi e convenzioni, principi guida che hanno una loro eterna validità in quanto rendono possibile un campo deduttivo coerente. Ma è la base biologica della logica a fare la logica, anche quella matematica.
Le radici sociali dell’intelligenza
Ciò che consente il passaggio da un comportamento organico semplice ad un comportamento “umano” in senso anche intellettuale, contraddistinto da logica e razionalità, è dunque la socializzazione. Anche per Dewey, come per Aristotele, la società, la polis, è la dimensione naturale dell’uomo, è scritto nelle sue informazioni genetiche, è il suo destino. E’ quindi del tutto inutile, secondo Dewey, che la psicologia sociale si ponga problemi intorno all’origine della società. Il passaggio dal branco, alla tribù, alla formazione sociale più evoluta è determinato, Marx direbbe, dal sistema di produzione. Per Dewey dall’intelligenza e dal sentimento che la cooperazione è meglio del solipsismo, perchè è nella cooperazione che l’individuo trova risposte ai suoi problemi. Ciò che va, per così dire, studiato è come dalle abitudini, dai costumi, dalle tradizioni, cioè dai sistemi di interazione, nascano le diversità delle menti e dei caratteri individuali. La riflessione capace di smuovere una persona dal tran tran sociale e dai modelli circostanti non si fa da sè, secondo Dewey, e nemmeno è un dono degli dei. Nasce da circostanze eccezionali che pongono problemi inediti e richiedono nuove risposte e nuovi adattamenti. Dunque anche se il prodotto del genio è indubbiamente un prodotto delle capacità intellettive individuali, esso ha dietro di sè una storia, mediazioni e conflitti, insufficienze e privazioni, a volte anche “contraddizioni”.
Progettazione operativa e ideologia politica
Per Dewey l’opposizione tra riformatori e conservatori ha una dimensione del tutto americana ed anglosassone (se vogliamo) nella quale l’opposizione tra destra e sinistra non è totalmente ideologica, e quindi artificiosa, come nei paesi europei, latini (e cattolici) in generale. A noi resta difficile capire come e perchè, date le caratteristiche della storia recente del nostro paese dove le contrapposizioni ideologiche hanno sempre avuto la meglio su quelle reali. Eppure è vero: in America la destra è “destra” e la sinistra è “sinistra”! E questo perchè, probabilmente, la sinistra non è mai stata complice di quella banda a delinquere contrabbandata come stato sociale (delle tangenti e delle clientele politiche). I riformatori puntano sull’efficacia delle abitudini e delle istituzioni per formare la natura umana secondo un modello evolutivo. I conservatori parlano invece di immutabilità degli istinti come “costanti” della natura umana. Dewey riconosce che l’inerzia, la pigrizia mentale delle masse è enorme e difficilmente modificabile. Tuttavia nega recisamente che la natura umana sia immodificabile, anche perchè in questa idea alligna sempre l’eterno ritornello del conservatore che giustifica così il ricorso ad atti repressivi e selettivi. Per Dewey non esiste nemmeno un naturale istinto umano che predisponga alla guerra ed alla bellicosità. Sono sempre le condizioni sociali a determinare i conflitti ed è perchè le situazioni vengono strumentalizzate, spesso con argomenti irrazionali, che gli impulsi umani vengono convogliati verso la guerra.
Critica al capitalismo
La critica al capitalismo comincia, in modo non del tutto scontato, con una critica indiretta del marxismo. Dewey soggiornò molti anni in Unione Sovietica per studiare i modelli scolastici e la pedagogia marxista. Molte delle sue riflessioni in questo campo sono dunque dovute ad esperienze dirette. Egli vide, giustamente, che non è vero che lo sfruttamento della classe operaia da parte dei capitalisti sia reso necessario da una sorta di legge naturale, di logica intrinseca alla proprietà privata dei mezzi di produzione. Sono le forme e le modalità del lavoro, che dipendono dalle abitudini sociali dominanti a rendere costrittivo e penoso il lavoro stesso. Su questo piano Dewey rimprovera al marxismo soprattutto la mancanza di un piano della ragione operativa e l’astrattezza della dialettica storica in quanto la lotta di classe non è l’elemento determinante e risolutivo dei conflitti sociali, ma un dato di fatto su cui bisogna agire razionalmente. La critica di Dewey al capitalismo non è una critica astratta al modello metastorico di un capitalismo ottocentesco che sfrutta spregiudicatamente tisici, vecchi e bambini per creare “plusvalore”, ma si indirizza ad una critica del capitalismo concreto, ad esempio del “taylorismo” come modello organizzativo che di fatto inibisce la crescita culturale del lavoratore, lo costringe ad un lavoro “senza pensiero”, consentendo così il riproporsi di una opposizione alla vita intellettuale del “pensiero senza lavoro” cara ai filosofi “contemplativi”. Per Dewey la filosofia di Bergson che separa la vita di routine dallo slancio vitale, considerato come esperienza eccezionale, è una posizione reazionaria volta alla conservazione di pochi privilegiati (siano essi borghesi o intellettuali). In questo giudizio su Bergson Dewey si avvicinò molto ai marxisti francesi degli anni trenta. In questo progetto di ricomposizione dell’uomo che deve rimanere se stesso in tutti i momenti della sua vita ne va della stessa filosofia. A che diavolo serve, altrimenti, la filosofia?
La crisi della società
Dewey legge correttamente i processi sociali e denuncia con chiarezza che quando le istituzioni invecchiano e si sclerotizzano portano al soffocamento delle spinte evolutive e quindi alla necrosi delle società. Il tramonto dell’Occidente non è dovuto a fattori mistici di declino dello spirito ma, all’incapacità di pensare razionalmente ed operativamente e nel progettare soluzioni ai problemi. La crisi è sempre dovuta al decremento dell’intelligenza sociale, alla caduta del dibattito e della ricerca, al prevalere di comportamenti irrazionalistici e misticheggianti. (oggi diremmo alle stupidaggini del pensiero positivo e della new age) Dewey, darwiniano, non condivide il darwinismo razzista e romantico che vedeva la civiltà come un luogo di confronto tra razze vecchie e nuove, tra popoli biologicamente sani ed altri deteriorati. Non sono i popoli giovani che possono salvare le vecchie razze. Bisogna ringiovanire la società, deburocratizzarla, liberarla dal vecchiume ideologico.
La polemica antiprimitivistica
Anche per questo Dewey irride ovviamente tutte le idealizzazioni del “buon selvaggio” e dello spirito vitalistico dei popoli primitivi. Vede con chiarezza nella stessa epopea degli Indiani d’America la prova del loro stretto legame al ritualismo, spesso ingiustificato, e tipico delle società che non si evolvono mai. Critica una delle massime sciocchezze dello stupidario filosofico e culturale, quella che solo la società primitiva consenta la spontaneità dei sentimenti e la purezza del cuore. Del resto basta pensare che il commercio delle mogli, ad esempio, in cambio di un cavallo o due, è l’esatto contrario di quanto teorizzano i “primitivisti” sognatori. Spontaneità e libertà appartengono al futuro di una società evoluta e non al passato primitivo.
Il “New Deal”
Dewey fu dunque uno dei filosofi del “New Deal”, se non il filosofo per eccellenza di questo tentativo vigoroso di rinnovare culturalmente la società americana ed il vecchiume moralistico del New England, stanco erede della filosofia dei pellegrini del Mayflower. Furono queste idee guida a portare gli Stati Uniti a superare la terribile crisi del 29, e poi a scendere decisamente in campo contro il nazismo nella seconda guerra mondiale.
VLADIMIR LENIN

VITA E STORIA DI UN EROE
Lenin (pseudonimo di Vladimir Ilic Uianov) era nato nel 1870 a Simbirsk (oggi Uianovks) e suo padre era un ispettore scolastico. Gli anni di studio e di adolescenza coincisero con uno dei periodi più travagliati della storia sociale e politica della Russia. Il governo zarista dopo l’uccisione dello zar Alessandro II nel 1881, da parte dei populisti, si era affrettato ad annullare quelle limitate riforme che erano state introdotte durante il decennio precedente. In questo clima con Lenin ancora 17enne, il fratello Alessandro con più anni di lui e a cui era molto affezionato, viene arrestato e condannato a morte sotto l’accusa di aver partecipato alla preparazione di un attentato allo zar. Anche Lenin viene espulso dall’Università di Kazan per la sua adesione a un circolo studentesco di tendenze rivoluzionarie. Si avvicina allo studio del marxismo, e in particolare al Capitale di Marx, poi nel 1893 si trasferisce a Pietroburgo entrando in contatto con il movimento fondato da Plechanov, “Emancipazione nel lavoro”. Movimento che confluisce nel 1898 al Congresso di Minsk, nel partito operaio socialdemocratico di Russia (POSDR). Lenin sempre sotto stretta sorveglianza politica, viene alla fine arrestato e condannato a tre anni con la deportazione in Siberia. E qui che nel 1899, porta a compimento il suo primo saggio: Lo sviluppo del capitalismo in Russia; ed è un’altra polemica contro i populisti. Polemica già iniziata nel 1894 a Pietroburgo con l’articolo “ Che cosa sono “Gli amici del Popolo” e come lottano contro i socialdemocratici “. La questione controversa era -sostenevano i populisti- che la Russia a differenza dell’Europa, sarebbe passata dal feudalesimo al socialismo, senza attraversare la fase dello sviluppo capitalistico. La replica di Lenin, fu nel dimostrare con una minuziosa analisi economica e statistica, che l’agricoltura russa era già entrata nella fase del suo sviluppo capitalistico; e che l’idea populista di una rivoluzione contadina, senza la guida della moderna classe operaia (più sveglia, determinata, consapevole politicamente, unita, e forte, pur non essendo ancora numerosa) era quindi un’utopia. Per molti intellettuali radicali, dalla metà dell’Ottocento, il problema centrale era ” ma la Russia è Europa? “, questo orientamento dei radicali era chiamato narodnik , da narod popolo; e s’intendevano le masse rurali in cui si scorgeva la base di una società socialista con una versione rivoluzionaria di tipo marxista. Invece per altri intellettuali (con Lenin in prima fila) la Russia faceva parte già dell’Europa o almeno era in via di europeizzazione, ed era già presente il capitalismo e quindi già presente quella classe operaia che doveva prendere la guida della rivoluzione (e fu questo secondo orientamento rivoluzionario che poi si trasformò in bolscevismo). La prima domanda posta dai radicali, divise i pensatori russi per tutto l’Ottocento e continua a dividerli ancora oggi. Ed anche Marx quella domanda se la pose, e nel 1877 rispose a un saggio di un noto radicale della linea narod secondo il quale la sua teoria Marxista presupponeva ” lo scioglimento delle comunità agricole e l’avvento del capitalismo come condizione preliminare all’affermarsi del socialismo “. Poi Marx dissentì da questa impostazione enunciando altre alternative; che però convinsero poco quelli della narod e meno ancora i loro avversari che seguitarono a guardare in avanti dando ragione solo a quello che Marx aveva affermato in quelle due righe. Quando Lenin poi ottenne la sua vittoria politica, costrinse all’esilio chi preferiva il Marx della prima maniera. Ma le difficoltà nell’attuazione del socialismo in Russia – sostennero poi i critici di Lenin – sono insite appunto nel tentativo di realizzare una rivoluzione proletaria in un paese che era prevalentemente agricolo. Lenin nel 1901 emigrato in Svizzera fondò un periodico rivoluzionario intitolato Iskra (la scintilla), per guidare e organizzare all’estero le lotte e le agitazioni degli operai russi. Ma al secondo congresso del partito socialdemocratico russo, tenutosi a Londra nel 1903 il partito si spaccò in due fazioni; quella maggioritaria (bolscevica) capeggiata da Lenin e quella minoritaria (menscevica) capeggiata da Plechanov e altri: i Menscevichi volevano instaurare un movimento sul modello della Socialdemocrazia tedesca, i Bolscevichi guardavano invece alla rivoluzione e volevano un partito ‘di quadri’, costituito da pochi esponenti altamente qualificati che guidassero la rivoluzione. In effetti, in Germania, dove spazio per la democrazia ve n’era (sebbene poi il parlamento, con Bismarck, non contasse nulla), poteva avere un senso un movimento di massa quale la Socialdemocrazia; ma in una realtà quale la Russia, in cui ogni cosa che si intraprendeva naufragava miseramente e tutto era dominato dal rigido regime zarista, aveva molto più senso un movimento elitario a mò di setta segreta, una sorta di seme sotto la neve , per dirla con Silone, che sotto la fredda coltre dell’inattivo regime zarista in mano allo stregone ciarlatano Rasputin, potesse cogliere il momento opportuno per dare una fioritura magnifica. . Lenin intendeva creare l’organizzazione del partito con una struttura fortemente centralizzata alla quale dovevano essere ammessi solo i “rivoluzionari di professione”, non le masse popolari (sul modello della Socialdemocrazia tedesca). La divisione interna si approfondì in occasione della rivoluzione del 1905, scoppiata a seguito dell’ingiuriosa sconfitta inflitta dai Giapponesi ai Russi . I menscevichi intendevano lasciare la guida della rivoluzione alle forze della borghesia liberale russa, mentre Lenin pur riconoscendo il carattere democratico-borghese della rivoluzione, sosteneva che essa dovesse essere capeggiata dalla classe operaia e dai contadini, giudicando che la borghesia russa, per la sua debolezza, sarebbe stata incapace di portare la rivoluzione sino all’abbattimento dello zarismo e avrebbe sempre ripiegato su un compromesso con la monarchia e con l’aristocrazia terriera. ‘ Quando Lenin andò all’estero all’età di trent’anni ‘ racconta Trotsky, che proprio a Londra, dopo essere fuggito dalla Siberia, lo conobbe per la prima volta, ne La mia vita, ‘ era già completamente maturo. In Russia, nei circoli studenteschi, nei gruppi socialdemocratici e nelle colonie degli esiliati, egli era un personaggio di spicco. Non poteva non realizzare questo suo potere, se non altro per il fatto che chiunque lo incontrasse o lavorasse con lui glielo dimostrava in modo chiaro. Quando lasciò la Russia, possedeva già un ottimo equipaggiamento teorico ed un solido bagaglio d’esperienza rivoluzionaria. All’estero, c’erano collaboratori che lo attendevano: il gruppo di ‘Emancipazione del lavoro’ e, primo fra loro, Plechanov […] ‘con questi Lenin entrò presto in contrasto, ‘ ma Lenin era vigoroso. Tutto ciò di cui necessitava era la convinzione che i più anziani erano incapaci di assumersi una leadership diretta dell’organizzazione militante dell’avanguardia proletaria nella rivoluzione ch’era chiaramente vicina. I più anziani – e non erano gli unici – si sbagliavano nel loro giudizio; Lenin non era semplicemente un rimarcabile lavoratore del partito, egli era un leader, un uomo in cui ogni fibra era tirata verso il raggiungimento di un fine particolare, un uomo che infine, dopo aver lavorato fianco a fianco coi più anziani, aveva realizzato di essere un leader e di essere più forte e più necessario di loro. Nel mezzo degli ancor vaghi atteggiamenti che eran comuni nel gruppo che sorreggeva le bandiere dell’Iskra, Lenin solo, ed in modo definito, concepiva il ‘domani’, con tutte le sue severe fatiche, i suoi crudeli conflitti e le innumerevoli vittime ‘. Dopo il fallimento della rivoluzione del 1905 (conclusasi in un bagno di sangue per il movimento operaio, fucilato sulle piazze dalla polizia), si videro i bolscevichi e i menscevichi impegnati sempre di più in questa aspra polemica; i secondi si identificavano sempre di più con il movimento di “revisione” del marxismo rivoluzionario, inaugurato in Europa occidentale da Bernstein. Ma la rottura definitiva si completa nella II Internazionale e con lo scoppio della prima guerra mondiale. La parola d’ordine di Lenin è quella di trasformare la “guerra imperialista” in “guerra civile”: Lenin era sì convinto che la guerra imperialista fosse un male, ma tuttavia ne vedeva anche gli aspetti positivi. Tutto stava nel riuscire a trasformare la guerra in rivoluzione e così effettivamente fu. Tuttavia il partito bolscevico, a differenza di quello menscevico, fu contrario alla guerra e la Russia bolscevica, all’indomani della rivoluzione, pur di uscire dalla guerra stipulerà accordi con le nazioni nemiche a tal punto sfavorevoli che Lenin li definirà ‘vergognosi’. L’unico scontro conflittuale riconosciuto dai Bolscevichi era, del resto, lo scontro di classe, non la guerra, quell’inutile strage contro cui Lenin si scaglia in chiusura di Stato e Rivoluzione : La deformazione e la congiura del silenzio intorno al problema dell’atteggiamento della rivoluzione proletaria nei confronti dello Stato non potevano mancare di esercitare un’immensa influenza, in un momento in cui gli Stati, muniti di un apparato militare rafforzato dalle competizioni imperialiste, sono diventati dei mostri militari che mandano allo sterminio milioni di uomini per decidere chi, tra l’Inghilterra e la Germania, tra questo o quel capitale finanziario, dominerà il mondo. Quando scoppia la Rivoluzione in Russia nel febbraio del 1917 Lenin era ancora esule in Svizzera. Rientrato a Pietroburgo con la sua celebre Tesi di Aprile traccia il programma per l’abbattimento del governo liberal-democratico nel frattempo salito al potere dai Cadetti (di ispirazione liberale) e per il passaggio della rivoluzione alla sua fase socialista. Nei successivi mesi compone la sua famosa opera Stato e Rivoluzione , poi guida l’insurrezione di Ottobre che si conclude con la formazione del primo governo sovietico da lui capeggiato. Gli anni dal 1918 al 1921, sono gli anni del “comunismo di guerra”, della “nuova politica economica”, ma anche dei forti contrasti con Stalin, che Lenin non può più avversare ma di cui ha già presagito la pericolosità (celebre è lo scritto ‘ Quello Stalin è pericoloso ‘) , gravemente ammalato muore il 21 gennaio del 1924, all’età di 54 anni.
CHE FARE?
Alla fine del secolo diciannovesimo, Lenin dovette sostenere, prima in Russia e poi all’estero, una dura lotta contro i “marxisti legali” e gli “economisti”. In quegli anni particolarmente difficili, carichi di contraddizioni sociali ed economiche, privi di una vera prospettiva rivoluzionaria, in quanto il movimento socialdemocratico era ancora troppo debole, soprattutto nei livelli direttivi, il marxismo legale era riuscito a emergere nella letteratura sottoposta a censura solo perché il governo zarista, vendendolo impegnato a combattere le idee populiste, pensava che fosse una corrente meno pericolosa. In realtà i marxisti legali contribuivano alla diffusione del marxismo rivoluzionario, benché tale teoria -osserva Lenin- venisse esposta in un “linguaggio esopico”, cioè indiretto, mediato, non trasgressivo. Il progressivo declino del populismo fece diventare il marxismo molto popolare in Russia. Lenin e la sua “Unione di lotta” non disdegnavano l’intesa con i marxisti legali in funzione antipopulistica, pur essendo consapevoli che tali pseudo-marxisti erano nati dalla fusione di “elementi estremisti con elementi molto moderati”. Quando infatti -dopo che il governo s’accorse della loro pericolosità- ci si trovò di fronte all’alternativa di radicalizzare il taglio rivoluzionario degli interventi o di rinunciarvi definitivamente, la maggioranza dei marxisti legali non ebbe dubbi: scelse il revisionismo di Bernstein. A questo punto la rottura, fra marxismo rivoluzionario e legale, divenne inevitabile. Gli “ex-marxisti” continuarono a scrivere su giornali e riviste autorizzati dal governo, rivendicando una piena “libertà di critica” nei confronti dello stesso marxismo, ma questa volta con lo scopo principale di subordinare il movimento operaio agli interessi della borghesia. Affermavano, da un lato, che lo sviluppo capitalistico in Russia era una necessità storica, ma, dall’altro, non ne chiedevano il superamento immediato. Il loro marxismo era “senza socialismo”. Molti di questi “compagni di strada” -come li chiamava Lenin- diventeranno dei “cadetti” (il partito principale della borghesia russa) e persino delle “guardie bianche” durante la guerra civile. Nel tentativo di superare gli evidenti limiti del marxismo legale, si sviluppò all’interno del movimento socialdemocratico una corrente più pratica e concreta, ma unicamente interessata a risolvere i problemi di natura sindacale: era la corrente che Lenin chiamava col nome di “economicismo”. Non si trattava di una vera alternativa al marxismo legale ma di un suo complemento. Sul piano “legale” infatti si continuava a predicare, anche da parte degli economicisti, la fusione degli intellettuali marxisti coi liberali, mentre su quello “illegale” si chiedeva agli operai di lottare sindacalmente contro i padroni. Gli economicisti -che, come dice Lenin, rifuggivano da qualsiasi ” discussione teorica, dissenso di frazione, ogni vasta questione politica, ogni progetto di organizzare i rivoluzionari ecc. “- avevano un loro manifesto: il Credo (redatto dalla Kuskova), che Lenin e altri 17 compagni sottoposero a dura critica scrivendo dalla prigione siberiana la Protesta dei socialdemocratici russi (1899). Con la Protesta, pubblicata sul Raboceie Dielo, Lenin rivendicava l’unità della lotta economica della classe operaia con quella politica e condannava il revisionismo di Bernstein, che voleva trasformare il partito operaio da rivoluzionario a riformista, spazzando via l’ingrediente fonfdamentale del marxismo: la rivoluzione . Lenin e gli altri autori della Protesta volevano integrare la battaglia contrattuale della classe operaia con una lotta politico-rivoluzionaria organizzata in un partito indipendente, che portasse, anche attraverso il consenso e l’appoggio degli elementi democratico-borghesi del Paese, all’emancipazione di tutti i lavoratori oppressi. Nello stesso tempo Lenin scrisse, fra le altre cose, Il nostro programma , che però rimase inedito fino al 1925. In esso si costatava che l’opinione dominante in seno alla socialdemocrazia russa considerava il marxismo rivoluzionario “invecchiato e inadeguato”. L’influenza del revisionismo si faceva sempre più sentire. Alla stregua di Bernstein ci si limitava -dice Lenin- ad elaborare “piani per riorganizzare la società”, a proporre “ai capitalisti e ai loro reggicoda il modo di migliorare la situazione degli operai”, a predicare agli operai “la teoria dell’arrendevolezza”. Lenin si rendeva conto che un’interpretazione dogmatica del marxismo poteva trasformare questa scienza in una fraseologia senza senso; però teneva a precisare che qualsiasi critica del marxismo non poteva andare oltre le “pietre angolari” da esso poste, “i principi direttivi generali”. La teoria di Marx -diceva Lenin nel Programma- non è qualcosa di “definitivo e di intangibile”; i socialisti devono anzi farla progredire “se non vogliono lasciarsi distanziare dalla vita”; ma con ciò -prosegue Lenin- resta vero che mai potrà esistere “un forte partito socialista se manca una teoria rivoluzionaria che unisca tutti i socialisti”. Queste idee Lenin, a causa delle persecuzioni dell’infame regime zarista, dovette portarle avanti all’estero. Con l’aiuto di molti compagni pubblicò per tre anni il giornale Iskra. Nell’importante articolo di fondo scritto nel primo numero, I compiti urgenti del nostro movimento , Lenin, rifiutando le teorie opportuniste dell’economicismo, rivendicava l’unità del socialismo col movimento operaio. Solo mediante questa unità si poteva -a suo giudizio- superare la mera attività propagandistica esercitata, a livello di circolo, dai socialdemocratici russi negli ultimi decenni e, nel contempo, evitare che il movimento operaio e il socialismo cadessero nell’ideologia borghese o degenerassero nello sterile terrorismo individuale (come quello dell’organizzazione clandestina “Volontà del popolo”, che, dopo aver assassinato nel 1881 lo zar Alessandro II, venne immediatamente liquidata dal governo). L’unità, in sostanza, era indispensabile non solo per l'”ortodossia” del socialismo, ma anche per la “ortoprassi” del movimento operaio. “Nessuna classe della storia -dice Lenin nell’articolo suddetto- ha conquistato il potere senza esprimere dei propri capi politici, dei propri rappresentanti d’avanguardia capaci di organizzare e dirigere il movimento”. A contatto con le organizzazioni socialdemocratiche all’estero, Lenin poteva facilmente rendersi conto di come la tendenza economicistica avesse acquistato sempre più seguaci. Infatti, dopo il giornale Rabociaia Mysl, stampato in Russia, anche la rivista Raboceie Dielo, stampata a Ginevra, decideva, a partire dal numero 10, di compiere la svolta revisionista verso l’economicismo. Alle giustificazioni ch’essa ne dava, e cioè: 1) l’inesistenza delle condizioni “oggettive” per compiere una rivoluzione (donde l’inutilità di organizzare un partito politico); 2) il timore di vedere la propria attività equiparata a quella dei terroristi – Lenin ribatteva dicendo: 1) “si deve lavorare per creare un’organizzazione combattiva e condurre un’agitazione politica in qualsiasi situazione”, anzi, proprio nei momenti di declino dello “spirito rivoluzionario” è particolarmente necessario tale lavoro, “poiché nei momenti degli scoppi e delle esplosioni non si farebbe in tempo a creare un’organizzazione”; 2) “oggi il terrorismo non viene affatto proposto come un’operazione dell’esercito operante, strettamente legata e adeguata a tutto il sistema di lotta, ma come mezzo di attacco singolo, autonomo e indipendente da ogni esercito” (così in due articoli pubblicati nei numeri 23 e 24 dell’Iskra). In altre parole, la situazione di quel momento storico non era “oggettiva” per la rivoluzione solo in questo senso, che non si doveva compiere un “assalto frontale” alle postazioni nemiche prima di aver organizzato debitamente un “regolare assedio”. E, allo scopo -pensava Lenin-, nulla era più indispensabile di un giornale politico panrusso: ecco perché era nata l’Iskra. “La maggiore o minore frequenza e regolarità dell’uscita (e diffusione) del giornale -diceva Lenin, con grande senso della concretezza- potrà essere l’indice più esatto della solidità con la quale saremo riusciti a organizzare [il settore della] propaganda e dell’agitazione multiformi e conseguenti”. La scelta di un giornale politico, comune a tutto il marxismo rivoluzionario, era stata imposta dalla situazione di frazionamento localistico del movimento operaio. Essendo “l’enorme maggioranza dei socialdemocratici quasi completamente assorbita dal lavoro puramente locale”, l’instabilità e l’incertezza del movimento e dei suoi dirigenti diventavano un fatto inevitabile. Ciò spiega il motivo per cui il giornale non era nato solo per svolgere un ruolo di propagandista e agitatore collettivo, penetrando, attraverso il proletariato, “nelle file della piccola borghesia urbana, degli artigiani rurali e dei contadini”, che avrebbe conquistato alla rivoluzione: esso doveva pure svolgere la funzione di “organizzatore collettivo”. Nel senso cioè che la rete di “fiduciari” del partito preposta alla redazione e diffusione del giornale, doveva mantenere strettissimi legami “con i comitati locali (gruppi, circoli) del partito”, o almeno con quelli che desideravano la loro unificazione in un partito. Attraverso questo lavoro tutti i militanti avrebbero avuto la possibilità non solo di osservare gli avvenimenti da un punto di vista nazionale, ma, in virtù dell’organizzazione capillare, anche l’opportunità d’intervenire direttamente su tali avvenimenti. Gli stessi militanti insomma dovevano diventare i protagonisti dell’Iskra. Un altro importante articolo pubblicato sul no 12 del giornale è il Colloquio con i sostenitori dell’economicismo. Qui Lenin risponde, approfondendo gli argomenti soprattutto nel capitolo Secondo di Che fare? , a una lunga lettera che “un gruppo di compagni” aveva fatto pervenire alla redazione del giornale. In particolare, Lenin rilevava il fatto che “i dirigenti coscienti sono in ritardo sullo sviluppo del movimento spontaneo della massa operaia e degli altri strati sociali”. Ai dirigenti, di cui il movimento dispone, mancano le cose più necessarie: solida teoria, vasti orizzonti politici, energia rivoluzionaria, capacità organizzativa. Il grave però è che “dalla fine del 1897 e specialmente dall’autunno del 1898” -dice Lenin-, cioè proprio quando si è voluto costituire il partito operaio socialdemocratico, essi hanno fatto di questi difetti una “virtù”, portando il “ritardo” della coscienza rivoluzionaria al livello di una “giustificazione teorica”. Tutte le questioni che in quel periodo più urgevano nel dibattito interno alla socialdemocrazia russa, saranno efficacemente sintetizzate e magistralmente risolte in Che fare? (1902), il libro più importante che Lenin scrisse prima della rivoluzione del 1905. Dopo la svolta del Raboceie Dielo verso l’economicismo, con la quale, fra l’altro, s’impedì d’unificare le organizzazioni socialdemocratiche all’estero in nome del marxismo rivoluzionario, Lenin fu costretto a radicalizzare, anche nello stile letterario, i termini dello scontro. Rendendosi d’altra parte conto che l’economicismo aveva molto più seguito di quel che non si credesse, egli non poteva agire diversamente. L’opposizione fra le due correnti di pensiero era per lui così netta da imporre una “chiarificazione sistematica” su tutti gli aspetti fondamentali del dissenso. Proprio nella drammaticità del confronto con il marxismo “ufficiale”, “dominante”, venivano alla luce le indicazioni più sicure da seguire.
LA CRITICA ALLA LIBERTA’ DI CRITICA
La “libertà di critica” è il primo aspetto che Lenin esamina nella sua importante opera anti-opportunista Che fare? Trattasi di quella libertà che i marxisti legali e soprattutto gli economicisti, in Russia, si erano presi per indurre il neonato Posdr a trasformarsi da rivoluzionario a riformista. Emulando i colleghi revisionisti di Germania e Francia, essi chiedevano di rinunciare alla pretesa di dare un fondamento scientifico al socialismo e di limitarsi ad accettarlo solo sul piano utopistico, in quanto l’opposizione di principio fra socialismo e liberalismo era per loro inesistente. Essi inoltre negavano il fatto della crescente miseria sociale, cioè della proletarizzazione di ampi strati sociali e dell’inasprimento delle contraddizioni capitalistiche. Respingevano, in sostanza, la teoria della lotta di classe e l’idea della dittatura del proletariato. In un contesto del genere, la “libertà di critica” -pensava Lenin- altro non significava che “critica borghese di tutte le idee fondamentali del marxismo”. Naturalmente la novità non era piovuta dal cielo. “Già da tempo -scrive Lenin- si muoveva contro il marxismo questa critica dall’alto della tribuna e della cattedra universitaria, in innumerevoli opuscoli e in una serie di dotti trattati; da decine di anni tutta la nuova gioventù delle classi colte è stata educata a questa critica”. In pratica, la linea opportunistica del marxismo era stato il risultato di un trasferimento di concezioni borghesi dalla letteratura liberale a quella socialista. A livello europeo i migliori rappresentanti di questa nuova tendenza erano Bernstein, sul piano teorico, e Millerand su quello pratico. Avvalendosi della “libertà di critica” come di una rivendicazione politica, essi e gli economicisti in genere evitavano di confrontarsi con le tesi del marxismo rivoluzionario, tacciato preventivamente di “dogmatismo”. Ma in tal modo -spiega bene Lenin- la tanto declamata parola d’ordine, libertà di critica anche nei confronti del marxismo, “si riduceva all’assenza di ogni critica”, anzi, “all’assenza di ogni giudizio indipendente”. Di nuovo, in realtà, c’era solo questo, che “l’urto delle diverse tendenze in seno al socialismo si era per la prima volta trasformato da nazionale in internazionale”. Storicamente parlando, gli economicisti rappresentarono una reazione all’intellettualismo parolaio dei marxisti legali. Là dove, nell’ultimo decennio dell’800, si lottò con successo contro il populismo, paventando però l’idea della rivoluzione proletaria, qui invece si pretendeva una maggiore concretezza, una più sollecita attenzione ai problemi di natura sindacale dei lavoratori, benché i tempi -a giudizio di Lenin- fossero maturi per ben altro che non per una semplice politica tradunionista. Di fronte alle posizioni rinunciatarie e rigorosamente circoscritte, a livello sia teorico che pratico, degli economicisti, Lenin raccomandava anzitutto di “riprendere [sottoponendolo a critica] quel lavoro teorico appena cominciato all’epoca del marxismo legale”; dopodiché occorreva rimediare alla confusione e all’esitazione prodotte dagli economicisti nel movimento “pratico”. “Libertà di critica [per gli opportunisti] non significa -scriveva Lenin- la sostituzione di una teoria con un’altra, ma la libertà da ogni teoria coerente e ponderata, eclettismo e mancanza di principi”. Quando una tendenza del genere diventa dominante nel movimento operaio o addirittura nel partito, non resta che separarsene – e Lenin operò appunto in questa direzione. “Ci hanno biasimato -disse- per aver costituito un gruppo a parte e preferito la vita della lotta alla via della conciliazione”. Ma non si trattava di settarismo o di frazionismo fine a se stesso. Il fine era quello di realizzare l’unità della classe operaia con un’avanguardia rivoluzionaria. E perché questo potesse avvenire “occorreva anzitutto -dice Lenin- definirsi risolutamente e nettamente” (un’altra traduzione italiana usa il termine delimitarsi). Quando l’unità di un partito o di un movimento è palesemente, irrimediabilmente nociva agli interessi della verità delle masse che aspirano a liberarsi dallo sfruttamento capitalistico, non resta che denunciarla, che rompere il suo formalismo e la sua ipocrisia, ricostituendola su fondamenta più solide, soprattutto più autentiche. Certo, sarà il consenso delle masse popolari a decidere dell’efficacia di una iniziativa del genere. D’altra parte “senza teoria rivoluzionaria -ha detto Lenin- non ci può essere movimento rivoluzionario”: “la predicazione opportunistica venuta di moda, viene accompagnata dall’esaltazione delle forme più anguste di azione pratica”. Non deve dunque spaventare l’idea d’essere una piccola minoranza (cosa peraltro inevitabile agli inizi); è invece indispensabile avere le idee chiare, saper dove andare, lottare contemporaneamente sul fronte teorico, politico ed economico – questo l’insegnamento che si trae dalle prime pagine di Che fare? .
SPONTANEITA’ DELLE MASSE E COSCIENZA RIVOLUZIONARIA
Nell’esordio dell’importante libro Che fare? , in particolare nel capitolo dedicato alla “libertà di critica” degli opportunisti, Lenin imposta e conduce la sua battaglia sul fronte “teorico”, un fronte che nel capitolo 2° viene approfondito a livello “filosofico” e “ideologico”, per poi esplicitarsi compiutamente in modo “politico” nel capitolo successivo e “organizzativo” negli ultimi due (il primo dei quali di carattere generale, mentre l’altro -delineante il piano di un giornale politico panrusso- a titolo esemplificativo). Il capitolo 2° porta come titolo significativo: La spontaneità delle masse e la coscienza della socialdemocrazia. Lo scopo che lo muove è quello di dimostrare la validità di una precisa tesi posta nella premessa: “La forza del movimento contemporaneo consiste nel risveglio delle masse (e principalmente del proletariato industriale) e la sua debolezza nella mancanza di coscienza e d’iniziativa dei dirigenti rivoluzionari”. Per “risveglio spontaneo delle masse” Lenin intende quelle manifestazioni popolari di protesta, tipo scioperi, tumulti, distruzioni di macchine ecc., che in Russia, a partire dal 1890, avvennero non con una coscienza esatta della natura dello sfruttamento, ma con l’istinto, giunto a maturazione, di ribellarvisi senza indugio. Il sentire la necessità di una resistenza collettiva, ovvero il bisogno di rompere risolutamente “con la sottomissione servile all’autorità”, faceva parte appunto di quegli atteggiamenti “di disperazione e di vendetta” che, se solo fosse esistita una direzione cosciente e attiva degli intellettuali, avrebbero potuto aprire le porte alla lotta rivoluzionaria vera e propria. “L’elemento spontaneo infatti non è che una forma embrionale della coscienza”. Lenin non sta qui a discutere, in astratto, su quale debba essere il rapporto ideale tra spontaneità delle masse e coscienza dei dirigenti. Il problema, per lui, non stava neppure nel criticare quei dirigenti che non avevano saputo prevedere l’evolversi dei tempi. Certo, questo era un difetto che andava corretto. Ma il problema più grave da risolvere restava un altro, e precisamente quello di come valorizzare la spontaneità delle masse portandola a un livello di consapevolezza politica, tale per cui l’istintiva protesta fosse indotta a rifiutare una semplice opposizione “legale” o “settoriale” al sistema. Per Lenin ciò che più contava era che il dirigente sapesse convincere le masse ad avvertire i loro interessi generali e quelli del sistema di sfruttamento come direttamente antitetici. In effetti, per cambiare qualitativamente la situazione non basta la coscienza di sentirsi sfruttati, né quella di voler reagire in qualche modo: occorre piuttosto -dice Lenin- avere coscienza che l’antagonismo fra gli interessi degli operai e di tutto l’ordinamento politico-sociale capitalistico è irrimediabilmente inconciliabile. Cioè l’antagonismo tra capitale e lavoro non è relativo ma assoluto. Questo significa che se le masse si limitano a una protesta spontanea e locale, al massimo riusciranno ad ottenere una parziale vittoria sul terreno economico, potranno cioè sentirsi soddisfatte d’aver conseguito nell’immediato determinati obiettivi contrattuali, ma in nessun modo esse saranno riuscite ad eliminare i motivi di fondo che le obbligano, con maggiore o minore frequenza e intensità, ad avanzare queste ed altre rivendicazioni. Ora, perché le masse si rendano conto della realtà di questo irriducibile antagonismo non basta -dice Lenin- che la loro situazione economica peggiori drammaticamente: occorre anche che vi siano dei dirigenti capaci d’iniziativa rivoluzionaria sulla base d’una teoria scientifica, oggettiva. Le masse cioè, in virtù dell’apporto di questi dirigenti, devono arrivare a trasformare la loro lotta sindacale in una lotta generale, rivoluzionaria, per la conquista del potere politico. E perché questo accada occorre ch’esse abbiano la coscienza esatta dei termini dell’antagonismo. Una coscienza del genere può essere il frutto solo di uno studio approfondito, scientifico, uno studio che l’operaio normalmente non fa, sia perché non ne ha il tempo materiale, sia perché non rientra nei suoi immediati interessi. “La classe operaia, con le sole sue forze -dice Lenin-, è in grado di elaborare soltanto una coscienza tradunionistica, cioè la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni ecc.”. Ma in tal modo essa non giunge mai a considerarsi in “alternativa” a tutto il sistema: lotta sì contro il capitale ma sentendovisi legata. Il fatto stesso di dover lavorare alle sue totali dipendenze, subendone i ritmi e le condizioni di lavoro, le impedisce di assumere una posizione radicale, capace di trasformare la rivendicazione economica in una lotta politica di carattere generale. Ecco perché la coscienza rivoluzionaria “può essere apportata alla classe operaia solo dall’esterno”. Da chi precisamente? Da quell’intellettuale (od operaio colto) che dopo aver compreso il carattere inconciliabile delle contraddizioni capitalistiche, si dedica a tempo pieno, sostenuto dal partito, alla lotta politico-rivoluzionaria, organizzando le forze di quelle classi sociali i cui interessi sono antagonistici agli interessi del capitale. Un operaio “cosciente”, cioè un operaio che sa quanto l’emancipazione della sua classe corrisponda all’emancipazione di tutti i lavoratori, è un operaio che deve essere valorizzato più come “militante” del partito che non come “lavoratore” della fabbrica. L’ideologia politica che aiuta meglio a comprendere la necessità di un rivolgimento totale della società è -come noto- il socialismo scientifico. “La dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate -dice Lenin- dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali”. Anche in Russia il socialismo scientifico è sorto “come risultato naturale ed inevitabile dello sviluppo del pensiero fra gli intellettuali socialisti rivoluzionari”. Lo sviluppo della teoria, pur basandosi sulla prassi storico-sociale, procede indipendente da questa e può giungere a intravedere delle soluzioni finali ai problemi fondamentali delle classi sociali, mentre la coscienza di tali classi è ancora ferma a un tipo di lotta parziale, riduttiva, contro il capitale. Ciò che il leader rivoluzionario deve assolutamente evitare è che lo sviluppo spontaneo delle masse arrivi a soffocare -seppure in modo spontaneo- lo sviluppo della loro propria coscienza. Quando si è consapevoli dell’irriducibile antagonismo fra capitale e lavoro non si può mai giustificare lo spontaneismo delle masse adducendo, come pretesto, la mancanza di condizioni oggettive per la rivoluzione. Se queste condizioni mancassero non vi sarebbe neppure la loro coscienza riflessa. “Se certi elementi spontanei dello sviluppo -dice Lenin- sono accessibili in generale alla coscienza umana, l’errata valutazione di essi equivarrà a una sottovalutazione dell’elemento cosciente. E se sono inaccessibili, noi non li conosciamo e non ne possiamo parlare”. Il che vuol dire, in altre parole: se il dirigente non prende coscienza dello sviluppo spontaneo della rivolta, quando questa c’è, non sottovaluta l’elemento spontaneo, ma la sua stessa coscienza. Ora, sottovalutare la coscienza rivoluzionaria significa subordinare il movimento alla spontaneità e questo, nelle condizioni del capitalismo, significa, inevitabilmente -come dice Lenin- determinare “un rafforzamento dell’influenza dell’ideologia borghese sugli operai”. Ciò in quanto: 1) “in una società dilaniata dagli antagonismi di classe non potrebbe mai esistere un’ideologia al di fuori o al di sopra delle classi”; 2) “l’ideologia borghese è ben più antica di quella socialista, è meglio elaborata in tutti i suoi aspetti e possiede una quantità incomparabilmente maggiore di mezzi di diffusione”. Ecco perché “quanto più giovane è il movimento socialista di un determinato Paese, tanto più energica dev’essere la lotta contro tutti i tentativi di consolidare l’ideologia non socialista”. Né si deve pensare che il pericolo dell’”imborghesimento” degli operai sia infondato solo perché essi vanno “spontaneamente” verso il socialismo. Che essi ci vadano è dovuto al fatto che la teoria socialista sa meglio interpretare le cause di tutti i loro mali; cionondimeno, se l’adesione immediata, istintiva, non viene approfondita in sede scientifica e non trova nella prassi un adeguato impegno rivoluzionario, l’ideologia borghese, che è “la più diffusa e che resuscita costantemente nelle più svariate forme”, non tarderà a imporsi nuovamente, spontaneamente, alla coscienza dell’operaio. Paradossalmente è proprio il movimento meramente spontaneo delle masse che conduce al rifiuto (inconsapevole) del socialismo. In sintesi, la teoria riflette sempre una realtà che la precede, ma essa la riflette adeguatamente solo se sa portare la realtà stessa a un livello di autoconsapevolezza critica. Traendo insegnamento dagli errori interpretativi compiuti nel passato, il socialismo scientifico deve saper portare la spontaneità del movimento operaio ad un livello cosciente e rivoluzionario. La spontaneità è la forma istintiva, immediata di lotta: “I primi mezzi di lotta che cadono sottomano saranno sempre nella società contemporanea [capitalistica] i mezzi tradunionistici”. Lenin tuttavia non ha alcuna intenzione di accusare lo spontaneismo in sé: la sua critica è rivolta a quegli intellettuali che lo giustificano per impedire agli operai di sviluppare una coscienza veramente rivoluzionaria. Egli infatti afferma che “quanto più è grande la spinta spontanea delle masse, quanto più il movimento si estende, tanto più aumenta, in modo incomparabilmente più rapido, il bisogno di coscienza nell’attività teorica, politica e organizzativa”. L’intellettuale che non comprende questo fa, anche senza volerlo, gli interessi del capitale. “Dal fatto che gli interessi economici esercitano una funzione decisiva non consegue affatto che la lotta economica (professionale) sia di sommo interesse, poiché gli interessi essenziali, “decisivi”, delle classi possono essere soddisfatti solamente con trasformazioni politiche radicali”. E’ da questa e da altre analoghe affermazioni di Lenin, contenute in Che fare?, che si è compreso come nell’imperialismo si sia attuato, nell’ambito del marxismo, il passaggio dal primato dell’economia a quello della politica.
LENIN E CHE FARE?
E’ impressionante la sicurezza con cui Lenin afferma, in Che fare? , che la coscienza politica di classe può essere portata all’operaio solo dall’esterno, cioè dall’esterno della lotta economica o della sfera dei rapporti contrattuali tra operai e imprenditori: ‘ la coscienza politica di classe può essere portata all’operaio solo dall’esterno, cioè dall’esterno della lotta economica, dall’esterno della sfera dei rapporti tra operai e padroni ‘ egli scrisse. Perché questa necessità? Perché l’operaio che lotta sindacalmente contro l’imprenditore capitalistico non ha per questo la consapevolezza che la sua stessa lotta economica, se non si traduce in lotta politica, non serve che a perpetuare il suo sfruttamento. “La politica tradunionistica della classe operaia -dice Lenin- è precisamente la politica borghese della classe operaia”. Ora, un operaio che ha consapevolezza di questo non può continuare a fare l’operaio: deve lottare per un fine superiore, organizzando la propria attività in modo politico. “Le masse non impareranno mai a condurre la lotta politica fino a quando non contribuiremo a educare dei dirigenti per tale lotta, sia fra gli operai colti che fra gli intellettuali”. Ma come può un operaio passare dalla lotta economica a quella politica? Egli deve acquisire la consapevolezza che tutta la società borghese va superata e non solo il suo rapporto contingente coll’imprenditore. Se non ha consapevolezza di questa necessità di ordine generale, se non ha rinunciato a tutte le illusioni sulla possibilità di “riformare” la società borghese, egli continuerà per tutta la vita a chiedere aumenti salariali o migliori condizioni di lavoro, senza mai riuscire a superare l’idea in sé dello sfruttamento. Noi invece -dice Lenin- “dobbiamo occuparci di spingere coloro che sono insoddisfatti [di singoli aspetti sociali] a convincersi che quel che non va è l’intero regime politico”. Ma, di nuovo, come può l’operaio acquisire tale consapevolezza politica? E’ forse l’intellettuale che deve dargliela? Un intellettuale staccato dalle classi sociali non è in grado di fare alcunché. Lenin dice chiaramente che “per dare agli operai cognizioni politiche, i socialdemocratici devono andare fra tutte le classi della popolazione”. Ciò in pratica significa che la coscienza politica della necessità di superare in maniera globale la società, può essere solo il frutto di una sensibilizzazione di tutte le classi popolari. Ovvero, quando la stragrande maggioranza è convinta che la società nel suo complesso va superata, ecco che allora si realizza il socialismo. La consapevolezza politica deve maturare nelle masse in modo progressivo, ma chi già la possiede non deve aspettare ch’essa maturi da sola. Egli anzi deve “reagire -dice ancora Lenin- contro ogni manifestazione di arbitrio e di oppressione, ovunque essa si manifesti e qualunque sia la classe o la categoria sociale che ne soffre”. L’operaio cioè di per sé, solo perché “operaio”, non ha maggiore consapevolezza politica di chi non lo è.
LA COSCIENZA DALL’ESTERNO
Perché, secondo Lenin, gli operai non possono avere “la coscienza dell’irriducibile antagonismo fra i loro interessi e tutto l’ordinamento politico e sociale contemporaneo” ? Risposta: perché tale coscienza non riesce a sorgere in loro spontaneamente, naturalmente, ma deve essere data “dall’esterno”, dall’intellettuale consapevole. Lenin arriva a porsi questa domanda guardando la storia del movimento operaio russo, euroccidentale e mondiale. Questa storia dimostra che “la classe operaia con le sole sue forze è in grado di elaborare soltanto una coscienza tradunionista”, cioè sindacale. Perché questo limite? Per due ragioni: 1) all’operaio manca il tempo di farsi una consapevolezza teorica dell’irriducibile antagonismo tra lavoro e capitale (non dispone cioè delle condizioni materiali favorevoli); 2) il capitalismo, stando al potere, è in grado di disporre d’ingenti mezzi per propagandare l’ideologia borghese, che è molto più antica di quella socialista: chi detiene il potere materiale detiene anche quello ideologico. Dunque al massimo l’operaio arriva a “sentire”, a “percepire” il suddetto antagonismo, ma non arriva -proprio perché il lavoro da schiavo e il condizionamento dell’ideologia borghese glielo impediscono- a maturare la consapevolezza della necessità di un’alternativa organica, globale, al sistema dominante. Questo è un compito che spetta ai rivoluzionari di professione. “La dottrina del socialismo -dice Lenin- è sorta da quelle teorie filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali”. Ciò significa ch’esiste un processo autonomo del pensiero, indipendente “dallo sviluppo spontaneo del movimento operaio”, che porta alla consapevolezza della necessità del socialismo. Gli intellettuali progressisti arrivano a “comprendere” sul piano teoretico ciò che gli operai arrivano a “sentire” su quello pratico. Cosa proponeva Lenin? Due cose: 1) permettere anzitutto agli operai dotati di capacità intellettuali, di dedicarsi esclusivamente all’attività politica del partito (le capacità ovviamente vanno dimostrate, cioè possono essere riconosciute solo a-posteriori); 2) far convergere la teoria rivoluzionaria degli intellettuali verso la protesta sindacale degli operai, al fine di creare un movimento di massa capace di prassi rivoluzionaria. Altrimenti la teoria resterà utopica e la prassi velleitaria. Lo sviluppo coerente di queste due condizioni è in grado di evitare due pericoli: 1) quello di credere che la coscienza dell’irriducibile antagonismo sia un processo che possa maturare solo “dall’esterno” e non anche “dall’interno”; 2) quello di credere che senza “teoria rivoluzionaria” possa esserci una “prassi rivoluzionaria”, ovvero che una “teoria rivoluzionaria”, per funzionare praticamente, possa essere formulata una volta per tutte, e non continuamente riformulata. L’elemento spontaneo e quello consapevole devono quindi integrarsi in un’unica esperienza. Lenin aveva così chiarito il motivo fondamentale per cui, a suo parere, erano falliti tutti i tentativi rivoluzionari condotti in Europa occidentale e in Russia. Ma mentre in Russia si arrivò ad accettare questo suo nuovo modo d’impostare la lotta politica, in Europa invece, in un modo o nell’altro, lo si è sempre rifiutato: sia perché l’individualismo non permetteva di accettare, da parte degli operai, l’idea di una consapevolezza trasmessa dall’esterno; sia perché l’intellettualismo non permetteva di accettare, da parte degli intellettuali, la responsabilità di dover organizzare lo sviluppo di tale consapevolezza in un’esperienza politico- rivoluzionaria.
L’INCONSCIO IN LENIN
Qualunque attività (persino quella onirica) ha un significato per il soggetto solo se egli è consapevole. La psicanalisi ha sì scoperto l’inconscio, ma nella misura in cui ha preteso di conoscerlo lo ha reso “conscio”, intelligibile. L’inconscio era sicuramente più oscuro e misterioso in quei filosofi romantici tedeschi che ne parlarono prima della psicanalisi (Herbart, Hartmann, Brentano e altri ancora). L’analogia tra questi filosofi e Freud sta nell’aver delineato, dopo aver costatato le contraddizioni della civiltà borghese, un’identità irrazionale dell’inconscio, senza però riuscire a comprendere l’origine economico-sociale di tali contraddizioni; la differenza sta nell’aver cercato di dimostrarlo con esempi concreti: sotto tale aspetto, l’importanza di Freud è decisamente superiore, anche se le sue interpretazioni dei sintomi nevrotici sono spesso arbitrarie. In particolare, Freud ha dimostrato (e qui la differenza da quei filosofi tedeschi è molto netta), che se l’inconscio fosse assolutamente “inconscio”, nessuno ne potrebbe parlare, essendo del tutto incomprensibile. In seguito però, Freud è arrivato a sostenere che gli effetti dell’inconscio possono essere rilevanti anche su un soggetto che non ha consapevolezza della propria malattia, in quanto l’Es (fonte di tutti gli istinti) è una forza cieca e irrazionale. Cioè, in pratica, Freud non ha mai abbandonato l’idea tradizionale che l’inconscio fosse una realtà, in ultima istanza, incomprensibile. Questo non gli ha mai permesso di approfondire adeguatamente l’idea secondo cui le nevrosi più significative sono quelle per le quali il soggetto è cosciente della propria alienazione: maggiore è la coscienza e maggiore è la nevrosi, se con una diversa esperienza disalienante non la si risolve. Il che apre le porte alla comprensione del campo delle psicosi, il cui profondo significato sfugge ancora all’indagine analitica. La psicanalisi pretende di conoscere l’inconscio attraverso i sogni, i lapsus, gli errori di lettura, le dimenticanze dei nomi, i tic, le manie…, ma in realtà l’inconscio può essere conosciuto solo in rapporto alla coscienza. Un lapsus ci indica che esiste un inconscio, ma finché non parliamo col soggetto, a partire dal lapsus, interrogandolo sul perché e sul come, noi non faremo un passo avanti. La stessa follia è il frutto di una coscienza distorta delle cose, anche se il soggetto non vuole ammetterlo e ha rimosso nell’inconscio le cause della sua malattia. Non è possibile risalire a queste cause se non passando attraverso la coscienza del malato. Se vogliamo, l’inconscio non ha realtà propria: è come la tasca in cui la mano si nasconde dopo aver gettato il sasso. Nascondiamo la mano perchè ci sentiamo giudicati, da noi stessi e soprattutto dagli altri. Naturalmente è anche possibile che un’azione negativa sia compiuta da un’intera collettività, più o meno grande: in tal caso dovrà essere una coscienza sociale alternativa (che può anche essere minoritaria) a porre il giudizio. L’inconscio, in ogni caso, resta subordinato alla coscienza. Ciò che inoltre si deve accettare è l’idea che non è l’inconscio che può avere la forza di opporsi all’alienazione di una determinata coscienza sociale, ma è la stessa coscienza, la quale può essere superficiale, istintiva, o riflessiva, matura. Parlare di “opposizione inconscia” (p.es. a una ingiustizia, a un’etica formalizzata) altro non vuol dire che parlare dell’opposizione più superficiale della coscienza, destinata a durare poco e a non essere molto efficace. Questo viene in mente leggendo il Che fare? di Lenin (cap.II). “L’elemento spontaneo -dice Lenin- [cioè poco consapevole, istintivo, di cui non si ha ancora piena coscienza e che non permette di acquisirla] non è che la forma embrionale della coscienza”. E ancora: “La coscienza dei propri errori [fatti coll’istinto e quindi solo parzialmente consapevoli] equivale già ad una mezza correzione [cioè ad un aumento del lato conscio], ma il mezzo male [cioè la scarsa consapevolezza] diventa un male effettivo quando questa coscienza comincia ad oscurarsi, cioè quando si tenta di giustificare teoricamente la propria sottomissione servile alla spontaneità [o all’inconscio]”. Lenin voleva dire che il “mezzo male” (o la mancanza di forte consapevolezza), viene utilizzato dagli intellettuali borghesi, regressivi, come pretesto per non prendere consapevolezza dei propri errori (il che porta a un “male intero”). Il “vero male”, quello “totale”, nasce quando si vuole imporre la logica dell’inconscio alla coscienza, cioè quando si vuole opporre all’esigenza di un’alternativa, di una transizione, la logica della rassegnazione, dell’opportunismo, del relativismo, sino all’irrazionalismo. Tuttavia, il male peggiore di tutti -dice Lenin- è quello per cui “il soffocamento della coscienza da parte della spontaneità avviene in modo spontaneo, cioè senza lotta dichiarata fra due concezioni diametralmente opposte”, ma attraverso una “lotta occulta”, invisibile, difficilissima da combattere. Vi sono degli intellettuali, infatti, che, in piena coscienza, cercano di far passare alle masse, in un modo che dia l’impressione della naturalezza, l’esigenza di conservare inalterato il sistema. Questa tattica porta gli individui a credere che il prevalere dell’inconscio sulla coscienza delle cose, sia un fatto normale, inevitabile, e non un fatto opinabile, su cui si può e si deve discutere. Lasciare che l’inconscio predomini significa affidarsi alla spontaneità degli eventi, alla casualità del vivere quotidiano, non avere un progetto di vita su di sé, credere ciecamente nel destino o nel potere di un “duce”, ovvero lasciarsi dominare dai rapporti di forza. In realtà è la discussione ad essere inevitabile: potrà essere poca o tanta, in rapporto alla coscienza che abbiamo dei nostri problemi, ma è impossibile che non ci sia. Una vita affidata alla spontaneità delle cose può far contento qualcuno, non la maggioranza delle persone o comunque non per un periodo illimitato. Finché queste persone istintive sono ignoranti e sottomesse, non vi sarà dibattito democratico, ma appena inizia ad aumentare la consapevolezza e la cultura, grazie alle quali possiamo capire gli inganni, i meccanismi dello sfruttamento, la protesta s’impone da sé, anche di fronte alla reazione più dura del sistema. “Se certi elementi spontanei dello sviluppo [sociale] sono accessibili in generale alla coscienza umana -dice Lenin-, l’errata valutazione di essi equivarrà a una sottovalutazione dell’elemento cosciente. E se sono inaccessibili, noi non li conosciamo e non ne possiamo parlare”. Dunque, ciò che condiziona negativamente non è tanto l’inconscio, quanto piuttosto il suo prevalere (specie quello teorizzato dagli intellettuali) sulla coscienza. Ecco perchè la spontaneità delle masse esige da parte degli intellettuali progressisti un alto grado di coscienza politica.
CENTRALISMO E DEMOCRAZIA
Nella storiografia marxista spesso si notano dei giudizi positivi circa il fatto che lo sviluppo degli Stati borghesi implicò la fine delle autonomie locali e regionali, in quanto -si afferma- senza la centralizzazione dei poteri difficilmente la borghesia avrebbe potuto avere la meglio su feudatari e clero. Tuttavia, la stessa storiografia, subito dopo aver costatato il successo della centralizzazione politica, afferma che proprio essa creò nuovi problemi, nuove contraddizioni antagonistiche, che finirono col danneggiare soprattutto gli interessi dei ceti non proprietari. Questo modo di vedere le cose oggi può essere considerato superato, poiché una qualunque forma di centralizzazione dei poteri (anche la più progressista sul piano ideologico), senza una forte democratizzazione a livello locale e regionale, porta sempre a favorire gli interessi di una ristretta minoranza (anche se le intenzioni originarie andavano nella direzione opposta). Lenin si accorse subito di questo pericolo, ma non ebbe il tempo per scongiurarlo (il suo testamento politico, purtroppo, non venne neppure preso in considerazione). La centralizzazione non può servire a giustificare il superamento più agevole del passato regime, se in tal modo si rischia di compromettere, anche nel breve periodo, l’interesse della maggioranza dei cittadini. Il socialismo sovietico fu favorevole (anche con Lenin) al centralismo, al fine di combattere meglio l’aristocrazia feudo-clericale e la borghesia, e pensò che nel lungo periodo -dopo la vittoria sulla controrivoluzione- le masse avrebbe beneficiato di una ricaduta positiva delle conquiste rivoluzionarie. Ma tale ricaduta, in realtà, non si è mai verificata, se non in termini molto limitati (relativamente alla situazione socioeconomica, poiché in quella delle libertà civili e politiche la ricaduta non ci fu per nulla). Oggi bisogna affermare che il centralismo può essere condiviso solo a condizione che si affermi, nel contempo, un’ampia democrazia di base e che, in ogni caso, il centralismo ha senso solo se è funzionale alla democrazia e non questa a quello. Nessun centralismo può vincere l’antagonismo sociale e politico senza l’appoggio delle masse.
DALLE TESI D’APRILE A STATO E RIVOLUZIONE
Nel 1917 Lenin ritorna in Russia dall’esilio svizzero, godendo dell’appoggio del governo tedesco, che ha astutamente capito che nel partito bolscevico (favorevole alla pace) può sperare una breve uscita della Russia dallo scacchiere bellico. Rientrato in Russia, Lenin trova un partito bolscevico dalle idee confuse e decide di stabilizzarlo sfruttando la propria abilità di teorico marxista. Ed è per questo che egli pubblica le celeberrime Tesi d’aprile . In esse si affrontano molti dei problemi che travagliavano la Russia: in primis, come effettuare una rivoluzione in un paese tanto arretrato quale era la Russia. I Menscevichi, in sintonia con il pensiero marxiano, intendevano fare la rivoluzione solo dopo il pieno sviluppo del capitalismo, poiché ritenevano assurdo fare la rivoluzione ancor prima che si fosse giunti al capitalismo. Lenin la pensava diversamente: ci voleva una rivoluzione immediata, senza passare per il capitalismo, il che sembra assurdo poiché non ha senso fare la rivoluzione socialista in un paese dove non c’è il capitalismo. Ma Lenin sosteneva l’esigenza della rivoluzione proprio per questo: in un paese che di più arretrati non ce n’erano, non aveva senso alcuno che a governare fosse la borghesia. Ne venne fuori una situazione paradossale, in disaccordo con le previsioni di Marx: la piena industrializzazione russa doveva essere gestita non dalla borghesia (come era avvenuto in tutti i paesi europei), bensì dal proletariato. Lenin ci tiene a precisare che il capitalismo non è un fatto di un singolo paese, bensì è un processo di portata mondiale, sicchè non ci si deve aspettare la rivoluzione da paesi capitalisticamente progrediti (quali la Germania o l’Inghilterra), ma dal più arretrato e feudale di tutti (la Russia appunto), poiché essa è ‘ l’anello debole ‘ della catena del capitalismo mondiale. La rivoluzione sarebbe dunque divampata in Russia (il paese più arretrato) per poi coinvolgere l’intero mondo, trovando il suo epicentro in paesi progrediti quali la Germania o l’Inghilterra: non è dunque corretto parlare di tante e singole rivoluzioni, bensì vi è una sola grande rivoluzione, destinata ad abbattere l’unico capitalismo che infesta il mondo. E del resto, notava Lenin, se la rivoluzione avesse attecchito solo in Russia, una volta terminata la guerra, le grandi potenze reazionarie europee si sarebbero coalizzate per estinguerla brutalmente. Questo ci permette di capire come il Lenin delle Tesi d’ aprile avesse in mente un’idea che verrà poi meglio esplicitata da Trotsky : l’idea di ‘rivoluzione permanente’, che altro non era che la convinzione che la rivoluzione dovesse svilupparsi in tutto il mondo per annientare in esso il capitalismo. Una delle grandi novità proposte da Lenin nelle Tesi d’aprile fu la parola d’ordine ‘ il potere ai soviet ‘: aveva dichiarato aperta ostilità al governo provvisorio di Kerenskij, in nome della lotta intransigente contro la guerra, definita come imperialista indipendentemente dall’assetto politico del paese e aveva espresso la volontà di trasformare il partito di forza minoritaria in forza di maggioranza, guida di una nuova rivoluzione, quella appunto destinata a conseguire il potere ai soviet. Secondo Lenin il partito bolscevico doveva ‘ spiegare alle masse in modo paziente, sistematico, perseverante, conforme ai loro bisogni pratici, gli errori della loro tattica […], sostenendo in pari tempo la necessità del passaggio di tutto il potere statale ai consigli dei deputati operai, perché le masse possano liberarsi dai loro errori sulla base dell’esperienza ‘. Una parola d’ordine che comportava il massimo di democrazia diretta e di autogoverno per le masse popolari veniva così sostenuta attraverso l’esaltazione del ruolo del partito, posto implicitamente al di sopra delle masse stesse, alle quali doveva insegnare a vincere. L’iniziativa spontanea delle masse, che aveva portato ai soviet (Lenin riconobbe sempre il carattere spontaneo delle nuove organizzazioni), doveva assoggettarsi alla direzione del partito: le masse potevano sbagliare, anzi il loro cammino era disseminato di errori, mentre il partito era infallibile. La concezione di Lenin sulla rivoluzione era nettamente diversa da quella di tutte le altre forze socialiste, poiché infatti Lenin, come accennavamo, voleva arrivare immediatamente al regime socialista, senza passare per il capitalismo. In una delle prime Tesi d’aprile egli dice che ‘ l’originalità dell’attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase della rivoluzione, che ha dato il potere alla borghesia a causa dell’insufficiente grado di coscienza del proletariato alla seconda fase che deve dare il potere al proletariato e agli strati più poveri dei contadini ‘. Lenin voleva arrivare al socialismo bruciando le tappe del capitalismo per diversi motivi: uno di questi consisteva nella convinzione che la guerra avesse creato una crisi profonda degli equilibri politici e dei rapporti di forza nella società in tutta Europa. La Russia sarebbe stato il punto di partenza della rivoluzione che avrebbe presto (secondo Lenin) raggiunto tutto il pianeta proprio perché essa era l’anello debole della catena imperialista, ovvero era il paese in cui il rovesciamento del potere esistente era più facile e rapido. Questa tesi era già stata sostenuta con grande precisione da Lenin, nel marzo 1917, dall’esilio svizzero: ‘ la Russia è un paese contadino, uno dei paesi più arretrati d’Europa. Il socialismo non vi può vincere direttamente e immediatamente. Ma il carattere contadino del paese […] può dare alla rivoluzione democratica borghese in Russia un’ampiezza formidabile e far sì che la nostra rivoluzione sia il prologo della rivoluzione socialista mondiale, sia un passo verso di essa ‘. Giocava poi a favore della Russia un altro fattore, notava Lenin: la rivoluzione in Russia non avrebbe assunto il carattere di rivoluzione proletaria (come nel resto d’Europa), non sarebbe cioè stata una ribellione di una sola classe sociale (gli operai), ma della stragrande maggioranza della società (operai e contadini), all’interno della quale il partito bolscevico doveva avere un ruolo di guida. Considerando il nuovo stato come il potere della stragrande maggioranza del popolo, contrapposto ad un’esigua minoranza (sia pure la minoranza degli ex privilegiati), Lenin vedeva nel parlamentarismo un inutile orpello, reso oltre tutto antiquato dalle trasformazioni politiche in tutto il mondo. La formula ‘ dittatura democratica degli operai e dei contadini ‘ riassumeva bene il concetto: si sarebbe dovuto trattare di una dittatura, poiché non avrebbe lasciato alla minoranza borghese e aristocratica il diritto di opporsi, ma democratica poiché avrebbe comunque rappresentato la stragrande maggioranza della popolazione. Di questa dittatura democratica i soviet sarebbero stati la migliore espressione ed è per questo che nelle Tesi d’aprile campeggia il motto ‘il potere ai soviet’. Oltre che nelle Tesi, Lenin tratta dello stato anche in un altro suo scritto, intitolato Stato e Rivoluzione (composto nell’estate del 1917) , in cui sostiene che la rivoluzione deve mettere lo stato in mano al proletariato, ovvero al partito del proletariato poiché il Bolscevismo è un partito di quadri. Lo stato non viene abolito, bensì resta ed è strumento della dittatura del proletariato: qualsiasi regime è sempre, per definizione, la dittatura di una classe sulle altre, anche quando si dà una maschera democratica (il regime pre-rivoluzionario è per esempio dominio della borghesia). Si tratta dunque non di instaurare una dittatura, ma di passare da una dittatura ad un’altra: da quella borghese a quella proletaria. Ed è una dittatura ‘democratica’ perché a favore della stragrande maggioranza contro pochi contrari. Dopo un po’ di tempo di tale dittatura, però, lo stato porterà all’eliminazione definitiva delle vecchie classi sociali (borghesia in primis), sicchè verrà meno il conflitto di classe (non essendoci più classi antagoniste) e anche la dittatura, in quanto ad esistere sarà solo più il proletariato e la dittatura era sui non-proletari. A questo punto lo stato perderà ogni significato: se prima serviva come strumento di dittatura, ora sarà del tutto inutile. Esso dunque si estingue (l’intera macchina statale finisce ‘ nel posto che da quel momento le spetta, cioè nel museo delle antichità accanto alla rocca per filare e all’ascia di bronzo ’, diceva Engels) e si passa all’anarchia. Tuttavia nella storia della Russia rivoluzionaria non si riuscirà mai a sorpassare la fase di dittatura del proletariato e lo stato non verrà mai eliminato, come già temeva Bakunin quando accusava Marx sostenendo che dalla dittatura non si sarebbe mai usciti. Quando Lenin dice che bisogna dare tutto il potere ai soviet, intende soprattutto dire che è opportuno uscire, il più presto possibile, da quella strana ambiguità di potere per cui il potere effettivo è in mano al governo democratico-liberale dei Cadetti ma senza il consenso dei soviet non può fare nulla. La soluzione la si otterrà quando i Bolscevichi attueranno la Presa del Palazzo d’Inverno. E’ curioso il fatto che Lenin si accorga di come, con la guerra mondiale, lo stato, a livello europeo ma anche mondiale, abbia cessato di essere un puro e semplice strumento del dominio di classe per diventare la massima potenza economica: sul piano dei rapporti delle classi, restava e anzi si esasperava il capitalismo, ma sul piano economico era stata avviata una statalizzazione della produzione che anticipava il socialismo o, addirittura, cominciava ad attuarlo. ‘ La metà materiale, economica ‘ del socialismo era già realizzata; si trattava di realizzare l’altra metà, cioè quella politica. ‘ Il socialismo non è altro che il capitalismo monopolistico di stato messo al servizio di tutto il popolo e che, in quanto tale, ha cessato di essere monopolio capitalistico. Non vi è via di mezzo. La guerra imperialista è la vigilia della rivoluzione socialista. E non solo perché la guerra con i suoi orrori genera l’insurrezione proletaria, ma perché il capitalismo monopolistico di Stato è la preparazione materiale più completa del socialismo, è la sua anticamera, è quel gradino della scala storica che nessun gradino intermedio separa dal gradino chiamato socialismo ‘. Lenin avvertiva che con la guerra lo stato si era sempre più militarizzato anche nella sua politica interna (reprimendo ovunque i movimenti socialisti) e andava sempre più maturando la convinzione che alla fine lo stato andasse eliminato, tant’è che fu più volte accusato duramente di anarchismo (soprattutto da Kamenev).
IL MARXISMO E LA SUA APPLICAZIONE PRATICA IN LENIN
Lenin era convinto nel 1917 della possibilità di una rivoluzione proletaria in Russia, nonostante tale arretratezza. Da tempo Lenin aveva criticato i populisti russi, fautori di un comunismo agrario anticapitalistico, opponendo ad essi la necessità di passare attraverso la fase capitalistica. Ciò non significava che la transizione al socialismo dovesse avvenire attraverso le riforme e la lotta parlamentare: anche per Lenin l’ unica via era data dalla rivoluzione. Ma per condurre ad essa era necessaria la formazione di un partito di rivoluzionari professionisti, inteso come avanguardia della classe operaia. Già nel 1902, in Che fare? , Lenin aveva elaborato la sua concezione del partito, come gruppo fortemente cementato al suo interno dall’ unità ideologica, disciplinato e centralizzato nelle sue decisioni ed efficiente sul piano operativo. Con queste tesi egli si opponeva a tutte le forme di anarchismo e spontaneismo, che affidavano l’ iniziativa rivoluzionaria a moti spontanei e improvvisi delle masse, non preparati, organizzati e guidati dal partito, o indulgevano ad atti di terrorismo puramente individuali, svincolati dai movimenti di massa. Su questi temi Lenin tornerà ancora nel 1920 con lo scritto Estremismo, malattia infantile del comunismo . Questi erano i problemi preliminari alla presa del potere, ma alla vigilia della vittoria della rivoluzione nel 1917 egli affrontava in Stato e rivoluzione la questione dei caratteri che avrebbe assunto il periodo di transizione al comunismo, con il passaggio del potere nelle mani del proletariato. Lenin riteneva necessaria una fase transitoria di dittatura del proletariato, ossia un momento coercitivo caratterizzato dall’ uso della forza per preparare il passaggio al regno della libertà. Infatti il controllo operaio sulla produzione e la partecipazione dei lavoratori alla direzione dello Stato, attraverso la formazione dei Soviet (consigli) degli operai e dei contadini, avrebbero avviato il processo, che avrebbe condotto all’ estinzione dello Stato stesso. Per la formazione dei membri del partito, in quanto guida consapevole della classe operaia nei suoi momenti di lotta e di esercizio del potere, è essenziale una componente teorica, fornita dal marxismo. Lenin individua i due elementi fondamentali della teoria marxiana nel materialismo e nella dialettica e torna a collegarli, mentre per ragioni opposte i marxisti di stampo positivistico ed evoluzionistico e i marxisti revisionati li avevano scissi o eliminati. Per combattere la diffusione dell’empiriocriticismo tra i marxisti russi egli pubblica Materialismo e empiriocriticismo (1909). Qui egli sostiene che la materia , agendo sui nostri sensi, produce le sensazioni: questo significa che essa e, quindi, le cose in generale esistono indipendentemente dalle nostre sensazioni e dalla nostra coscienza. In questo senso la scienza conferma l’ esistenza della terra prima che esistesse l’ umanità in grado di conoscerla. Non si può dunque affermare che esista una di9fferenza di principio tra i fenomeni, ossia le cose come appaiono a noi, e le cose in sè, come pretendevano certe forme di kantismo. L’ unica differenza rilevante è quella intercorrente fra quel che è conosciuto e ciò che non lo è ancora. Esiste dunque una verità oggettiva assoluta, a cui ci si avvicina progressivamente: dire che la conoscenza è relativa equivale soltanto a dire che essa non è ancora in possesso della verità totale, non che non esiste una verità unica, ma esistono soltanto verità diverse in relazione a ciascun individuo. L’ errore dei positivisti, dei neokantiani e degli empiristi consiste, secondo Lenin, nel considerare i dati della conoscenza come qualcosa di già costituito e invariabile. Si tratta invece di analizzare questi dati all’ interno del processo dinamico che conduce alla conoscenza. In questo senso la conoscenza è il “riflesso” della realtà, ma ciò non significa che essa sia un rispecchiamento puramente passivo di una realtà intesa come qualcosa di fisso e immutabile. La realtà e il processo della conoscenza devono, invece, essere interpretati alla luce della dialettica. Su questo punto Lenin insisterà anche nei Quaderni filosofici , pubblicati postumi nel 1933, frutto anche della sua rilettura delle opere di Hegel. Egli giunge alla conclusione che ” non si può comprendere perfettamente il Capitale se non si è compresa e studiata attentamente tutta la logica di Hegel. Di conseguenza, mezzo secolo dopo nessun marxista ha compreso Marx “. Hegel e Marx avevano insegnato che la dialettica non è un movimento o un’ evoluzione puramente meccanica, ma è sviluppo che ha il suo motore nella lotta degli opposti. In questo senso la dialettica offriva secondo Lenin, la chiave di lettura della storia come lotta di classi, alla quale sarebbe seguito il momento sintetico della società senza classi. In Stato e Rivoluzione riprende a sviluppare le idee di Marx sulla dittatura del proletariato e sulla trasformazione rivoluzionaria dello Stato nell’autogoverno dei produttori (che egli intendeva attuare attraverso il movimento dei Soviet).
LA RELIGIONE
Nel primo articolo pubblicato da Lenin, su Novaia Gizn, riguardo all’interpretazione marxista della religione, intitolato Socialismo e religione (1905), sono presenti, in nuce, non solo tutte le tesi fondamentali del marxismo, ma anche tutti gli argomenti sui quali Lenin, in seguito, tornerà per approfondirli ulteriormente. L’articolo si può dividere in cinque punti: 1) “La religione è una delle forme dell’oppressione spirituale” che nella società borghese è realizzata in virtù dell’oppressione materiale dei capitalisti e proprietari fondiari su operai e contadini. Lenin, come si può notare, si riferisce qui a una religione storicamente individuabile, quella sotto il regime capitalistico, ma i suoi giudizi, in realtà, presumono di avere un valore anche in retrospettiva. 2) Come si realizza questa oppressione è presto detto: a) “La religione predica l’umiltà e la rassegnazione nella vita terrena a coloro che trascorrono tutta l’esistenza nel lavoro e nella miseria, consolandoli con la speranza di una ricompensa celeste”. A Lenin qui non interessa dimostrare che la religione non ha sempre avuto una funzione del genere: interessa solo far capire che la funzione “reazionaria” è sempre stata prevalente nella storia della religione. b) “Invece, a coloro che vivono del lavoro altrui la religione insegna la carità in questo mondo, offrendo così una facile giustificazione alla loro esistenza di sfruttatori”. Un giudizio del genere, ovviamente, può essere applicato anche alla religione di ogni regime antagonistico. 3) Il proletariato, cosciente di questo, deve anzitutto rivendicare una precisa libertà politica: “La religione dev’essere dichiarata un affare privato” (della coscienza). Di qui la separazione completa della chiesa dallo Stato. “Ognuno dev’essere libero di professare qualsiasi religione o di non riconoscerne alcuna, cioè di essere ateo”. “E’ inammissibile tollerare una sola differenza nei diritti dei cittadini che sia motivata da credenze religiose”. Qui Lenin, nel tentativo di garantire una vera giustizia a tutti i cittadini, atei o credenti che fossero, commette l’errore di voler azzerare giuridicamente le differenze quando, nei fatti concreti, esse sussistono e da esse non si può assolutamente prescindere. Lenin cioè pensò di dover ritenere la giustezza della propria consapevolezza ateistica così evidente da poterla far valere alla consapevolezza religiosa del credente. E non si accorse che una rigorosa uguaglianza sul terreno giuridico non può che causare delle discriminazioni su quello sociale, poiché qui si ha a che fare con due atteggiamenti verso la religione del tutto opposti, che non possono essere resi equivalenti per decreto, soprattutto in considerazione del fatto che la storia della religione ha radici molto più profonde nella coscienza sociale dei cittadini. Negli atti ufficiali non va riportata l’eventuale confessione religiosa cui si appartiene -prosegue Lenin. Nessuna sovvenzione statale va data alle chiese. Questo va inteso nel senso che le chiese non possono godere di alcun privilegio. Tuttavia qui Lenin non aggiunge che le chiese possono continuare a svolgere i loro servizi grazie al sostegno materiale dei loro fedeli, i quali sono anche cittadini che pagano le tasse, per cui nei loro confronti una qualunque discriminazione sociale, dovuta a motivi ideologici, non è legittima. Questo significa che non si può pretendere che la religione resti un fenomeno privato della coscienza, senza alcuna manifestazione pubblica o sociale. 4) Questa privatezza della religione è valida solo di fronte allo Stato, non di fronte al partito. “La nostra propaganda comprende necessariamente anche quella dell’ateismo”, in forma materialistica e scientifica, non volgare e anticlericale. La quale comunque non è sufficiente, di per sé, a vincere i pregiudizi religiosi, in quanto è necessaria la trasformazione socialista dei rapporti produttivi. Lenin qui raccomanda la diffusione delle opere dei filosofi materialisti francesi (Diderot, Holbach, Helvetius ecc.) che in Russia non erano ancora state tradotte. In pratica Lenin voleva un partito non solo politico (capace di combattere la religione sul terreno giuridico, mediante la separazione di Stato e chiesa), ma anche ideologico (capace di combattere la religione sul terreno culturale, mediante la propaganda scientifica dell’ateismo). Lenin però doveva prevedere che un partito del genere, una volta giunto al potere, avrebbe avuto molte più difficoltà a comportarsi in maniera democratica nei confronti della religione. In nome infatti di una superiorità ideologica il partito avrebbe potuto impedire alla religione di manifestarsi non solo sul terreno politico (cosa che qui solo i cittadini possono decidere), ma anche su quello culturale, il che avrebbe comportato un abuso di tipo giacobino. 5) Il fatto che l’oppressione economica sia più importante di quella spirituale obbliga il partito a “non dichiarare l’ateismo nel suo programma”. Ciò significa che il partito accetta la militanza di proletari che conservano “residui di vecchi pregiudizi”, La professione di ateismo non è quindi una condizione per diventare comunisti; e tuttavia il militante deve sapere che l’ateismo è parte integrante della filosofia marxista. Lenin distingue chiaramente, senza però separarle, le questioni ideologiche da quelle politiche. E’ chiaro però che, stando le cose in questi termini, difficilmente un credente avrebbe potuto militare in un partito del genere. Avrebbe potuto farlo solo se motivato da cause oggettive di ordine sociale, ma a rivoluzione compiuta, se fosse rimasto credente, avrebbe inevitabilmente lasciato il partito. Un partito politico non può esprimersi così nettamente nei confronti dell’atteggiamento da tenere verso la religione: gli è sufficiente appoggiare il libero dibattito culturale sul problema, lasciando che sia il tempo, oltre che la coscienza dei cittadini, a decidere quale atteggiamento sia migliore. L’altro articolo metodologico è quello intitolato: L’atteggiamento del partito operaio verso la religione (1909). La prima parte non aggiunge nulla a quanto già detto nell’articolo precedente. Lenin precisa e conferma: 1) che il materialismo dialettico, sul piano filosofico, si riallaccia alle “tradizioni storiche del materialismo del XVIII sec. in Francia e di Feuerbach (prima metà del sec. XIX) in Germania”, portandole alle loro ultime conseguenze; 2) che “tutte le religioni e chiese moderne, tutte le organizzazioni religiose d’ogni tipo sono sempre considerate dal marxismo quali organi della reazione borghese”; 3) che l’ateismo -come vuole Engels- non va inserito nel programma del partito (cfr. invece i blanquisti e Dühring); 4) che il programma di Erfurt (1891) della socialdemocrazia tedesca non va interpretato nel senso che la religione va considerata come un affare privato per i marxisti (cioè di fronte anche al partito). Per Lenin l’indifferenza nei confronti della religione equivaleva a una posizione opportunistica, che avrebbe sicuramente avuto un riflesso sul terreno politico. Questo perché Lenin tendeva a subordinare la politica all’ideologia, anche se si rendeva conto che non si poteva in nome dell’ideologia rischiare di non conseguire determinati obiettivi politici. Infatti, la novità più rilevante di questo secondo articolo sta in alcune precisazioni fatte riguardo all’atteggiamento del partito verso la religione. 1) Lenin cominciò a considerare un grave errore credere che “l’apparente ‘moderazione’ del marxismo verso la religione si spieghi con le cosiddette considerazioni ‘tattiche’, come il desiderio di ‘non spaventare’, ecc.”. La realtà è che se il marxismo rifiuta d’inserire l’ateismo nel programma politico del partito non è per ragioni di tipo strumentale, ma perché è convinto: a) che la propaganda atea deve restare “subordinata” allo sviluppo della lotta di classe (subordinata non vuol dire “esclusa”); b) che la presenza della religione nelle masse va spiegata “materialisticamente”, cioè in rapporto ai problemi di natura economico-sociale, problemi che devono essere affrontati e risolti anzitutto in modo politico. La religione va superata non tanto o non solo in una contrapposizione frontale coll’ateismo (ciò che, in sostanza, si ridurrebbe a un’astratta, illuministica, predicazione ideologica), quanto piuttosto in collegamento con la lotta di classe che elimina le radici sociali della religione (“la forza cieca del capitale”). Di volta in volta, quindi, va deciso quale rapporto tattico tenere con la religione. Mentre infatti sul piano ideologico il contrasto è irriducibile, sul piano politico invece sono possibili alleanze fra credenti e atei sulla base di piattaforme programmatiche che nulla hanno a che vedere né con l’ateismo né con la religione. Tuttavia, Lenin non è ancora arrivato a formulare l’idea che la religione va rispettata anche nel caso in cui, dopo aver affrontato i problemi socioeconomici attraverso la lotta di classe (e l’aiuto dei credenti), la coscienza dei credenti coinvolti in tale lotta voglia restare religiosa. Un partito operaio così caratterizzato ideologicamente avrebbe mai permesso ai credenti di poter acquisire delle posizioni di potere nei propri ranghi? 2) Un’altra questione da considerare, per Lenin, è appunto questa: visto che nel programma del partito non è richiesta un’esplicita professione di ateismo, fino a che punto è legittimo accettare la militanza di un credente? La risposta a questa domanda viene posta da Lenin a un duplice livello: a) “la contraddizione fra lo spirito o i principi del nostro programma e i convincimenti religiosi del credente può restare una contraddizione puramente personale, che riguarda esclusivamente questo credente; e il partito non può sottoporre i suoi iscritti a un esame sull’assenza di contrasti tra le loro opinioni e il programma del partito”. Ciò in pratica significa che se un credente accetta la linea politica del partito, deve poi preoccuparsi da solo di risolvere le sue incoerenze sul piano ideologico. Dal partito avrà l’assicurazione che non sarà discriminato per la sua diversa ideologia. b) E tuttavia -aggiunge Lenin- “noi ammettiamo all’interno del partito la libertà di opinione, ma entro i limiti precisi fissati dalla libertà di associazione: non siamo tenuti ad andare d’accordo con i predicatori attivi di concezioni respinte dalla maggioranza del partito”. Il partito quindi garantisce al credente la libertà di restare credente, ma a condizione che il credente rinunci alla propaganda religiosa all’interno del partito, o comunque a una propaganda ostile al socialismo (cfr. Gorki e Lunaciarskij). Si tratta, come si può notare, di una soluzione di compromesso: il partito operaio non può rinunciare alla propria ideologia, però farà in modo di non far pesare questa ideologia sulla coscienza del credente, a condizione naturalmente che il credente faccia altrettanto. Lenin comunque mostra d’essersi reso conto con questo articolo che le questioni politiche possono avere un’importanza equivalente a quelle ideologiche, per cui non si può in nome dell’ideologia sacrificare gli interessi della politica. Naturalmente questo modo di impostare il problema deve fare molto affidamento sull’atteggiamento soggettivo di tutti i militanti del partito. 3) L’ultima questione che Lenin affronta in questo articolo è quella della privatezza della religione. Lo fa non tanto per ribadire la differenza, ormai acquisita, fra la posizione dello Stato e quella del partito, quanto per sottolineare che il principio della privatezza della religione ha subìto in Occidente un’interpretazione di tipo opportunistico. L’ossessiva indifferenza dei comunisti occidentali per la questione religiosa la si può spiegare: a) col fatto che la lotta contro la religione è stata un compito in gran parte assolto dalla democrazia borghese nell’epoca delle sue rivoluzioni contro il feudalesimo e il medioevo. In Russia invece questo compito è stato affrontato direttamente dalla classe operaia; b) col fatto che la lotta borghese contro la religione ha preso in Occidente la forma dell’anarchismo anticlericale (blanquisti, Dühring, ecc.), ovvero della contrapposizione frontale, inducendo così i comunisti (che allora si chiamavano socialdemocratici) ad assumere posizioni più moderate; c) col fatto che i governi borghesi, esaurita la loro spinta propulsiva progressista, si sono coscientemente serviti anche dell’anticlericalismo pur di poter distrarre le masse dal socialismo, cioè hanno fatto dell’anticlericalismo un terreno comune di lotta fra operai e padroni. Questo in Russia non era mai accaduto. In pratica, Lenin contesta la mancanza di coerenza ideologica del marxismo occidentale, e quindi la sua subordinazione culturale, nelle questioni religiose, alla scienza borghese, infine lascia intravedere il rischio di assumere posizioni strumentali nei confronti della religione. L’indifferenza infatti è “ambiguità” non “chiarezza”, per cui il marxismo occidentale potrebbe arrivare all’opportunismo in materia di atteggiamento verso la religione appunto per avere dalla sua parte, per un obiettivo politico, il maggior numero possibile di credenti. Nel Progetto di programma del PC bolscevico (1919) Lenin precisa che nella propaganda scientifica antireligiosa “bisogna evitare con cura di offendere i sentimenti dei credenti, il che condurrebbe soltanto al rafforzamento del fanatismo religioso”. Fanatismo che non nuoce solo alla politica di classe del partito (il quale cerca di far convergere in un medesimo programma politico forze sociali diverse e ugualmente ostili al capitale), ma nuoce anche ai rapporti etico-sociali di queste stesse classi. Lenin in pratica s’era accorto che, nel rapporto dei militanti comunisti coi credenti all’interno o all’esterno del partito, non esistevano dei criteri oggettivi che salvaguardassero il rispetto delle opinioni religiose. Ora pone quello etico della tutela della dignità umana, che non può certo essere violata per motivi di opinione. Lenin tuttavia, cercando di stabilire una ragione primaria di questa tutela, fa leva sul fatto che la violazione dei sentimenti religiosi comporterebbe un danno politico nei confronti dello stesso ateismo, e cioè il rafforzamento del fanatismo religioso. Non vi sono ragioni di carattere ontologico. Cioè Lenin non avrebbe mai accettato l’idea che una religione può essere vissuta praticamente meglio dell’ateismo, se il credente manifesta una coscienza umanistica superiore a quella dell’ateo. Lenin guardava le cose da un punto di vista prevalentemente politico. Un altro documento molto importante è la seconda lettera spedita a Gorki nel 1913 da Cracovia. Essa contiene alcune affermazioni che ancor meglio chiariscono l’atteggiamento politico che deve tenere il militante iscritto al partito. Lenin rimproverò Gorki per aver espresso considerazioni “piccolo-borghesi” nell’analisi del rapporto fra socialismo e religione. Lo scrittore russo, infatti, aveva lasciato intendere, in uno dei suoi articoli, che il socialismo era stato capace di depurare o di purificare l’”idea di Dio” da tutte quelle sovrastrutture ideologiche del clericalismo cristiano. Lenin lo ammonì scrivendo: “Questa vostra buona intenzione rimane vostro patrimonio personale, un ‘pio desiderio’ soggettivo. Una volta che l’avete scritto, è bell’e passato fra le masse, e il suo significato viene determinato non dalla vostra buona intenzione, ma dal rapporto tra le forze sociali, dal rapporto oggettivo tra le classi. In virtù di questo rapporto ne consegue (malgrado la vostra intenzione e indipendentemente dalla vostra coscienza), che voi avete imbellettato, inzuccherato l’idea dei clericali”. In pratica cosa significano queste parole? 1) Che il socialismo è un fenomeno integralmente laico, cioè assolutamente umanistico, e che quindi, come tale, esso non ha nulla da spartire con la religione (il “socialismo cristiano” -aveva precisato Lenin poche righe più sopra- è “la peggior specie di ‘socialismo’ e la sua peggiore deformazione”); 2) che qualsiasi opinione religiosa sul socialismo, cioè sull’utilità laica del socialismo nei confronti della “purificazione” della religione, deve necessariamente restare privata, altrimenti (cioè divenendo pubblica e trasformandosi quindi in giudizio politico) essa farà immediatamente il gioco dei clericali. Lenin vedeva le cose solo in maniera conflittuale e, per questa ragione, non voleva concedere al “nemico” (in questo caso i “clericali”) alcuna opportunità. I “clericali”, per Lenin, in pratica, coincidevano con tutti coloro che avevano delle opinioni religiose, o che comunque le usavano in funzione antisocialista. Lenin fa capire a Gorki che il giudizio politico del socialismo sul fenomeno religioso è esplicitamente e irreversibilmente negativo, senza soluzione di continuità. Nei tempi passati -dice Lenin- “la lotta della democrazia e del proletariato assumeva la forma di lotta di un’idea religiosa contro un’altra. Ma anche questo tempo è passato da un pezzo. Oggi, tanto in Europa che in Russia, ogni difesa o giustificazione dell’idea di Dio, persino la più raffinata, la meglio intenzionata, è una giustificazione della reazione”. Una giustificazione per l’appunto “oggettiva” della reazione, a prescindere cioè dalle intenzioni soggettive di chi si fa carico di tali apologie. Lenin giustamente non faceva alcuna differenza tra idea “nuova” e “vecchia” di dio: su “dio” tutte le idee, per lui, erano “vecchie”, incredibilmente superate. Tuttavia, Lenin non s’è mai posto il problema se possa esistere un diverso modo, più laico ed umanistico, d’interpretare la figura del “Cristo” così com’essa appare nei vangeli canonici. In sostanza “l’idea di Dio -aggiunge Lenin- non ha mai legato l’individuo alla società, ma, al contrario, essa ha sempre legato le classi oppresse con la fede nella divinità degli oppressori”. Ciò, in altri termini, vuol dire che qualsiasi giustificazione pubblica dell’idea di dio fa sempre gli interessi dell’oppressione padronale. Se c’è dunque la possibilità che un credente lotti per l’emancipazione degli oppressi, ciò è dovuto non tanto alla sua religione, quanto alle cause oggettive e concrete dello sfruttamento economico. E’ su questo che i marxisti devono organizzare il consenso col mondo dei credenti. Le religioni tradizionali, in specie il cristianesimo (e soprattutto il cristianesimo politico, quale s’è venuto configurando da Costantino in poi), di fatto e di diritto, hanno sempre legittimato -a volte contro le loro stesse intenzioni- l’oppressione materiale dei popoli; sicché, la dove esiste l’ideologia religiosa, ovvero una religione “ideologizzata”, esiste pure l’oppressione materiale ed economica. Nel senso che la religione è un indice, un sintomo, di un’oppressione esistente sul piano socioeconomico. A questa tesi di Lenin si può forse aggiungere che là dove manca l’oppressione materiale, manca anche la pretesa della religione a volersi porre in modo politico nella società. Il che però non significa che alla mancanza di oppressione materiale segua o debba necessariamente seguire la fine della religione. La religione avrà una fine quando saranno le coscienze degli uomini a deciderlo. Nel Discorso pronunciato al III Congresso dell’Unione della gioventù comunista di Russia (1920) Lenin afferma che i comunisti, pur essendo generalmente atei, non sono amorali. “Per noi la moralità dipende dagli interessi della lotta di classe del proletariato”. Non quindi una morale astratta, dogmatica, da applicare alle diverse situazioni, ma piuttosto una morale che emerga dalle diverse situazioni in cui il proletariato è soggetto protagonista. Naturalmente un discorso del genere dà per scontato che i motivi della lotta politica del proletariato siano giusti e che lo stesso proletariato, combattendo per degli ideali giusti, si comporti in maniera adeguata. Difficilmente Lenin avrebbe accettato l’idea che pur perseguendo ideali politicamente giusti, il proletariato può commettere delle azioni moralmente riprovevoli. Nell’ultimo scritto di Lenin sulla questione religiosa, e cioè Sul significato del materialismo militante (1922), Lenin mette in guardia i comunisti dall’illusione di poter edificare il socialismo senza l’aiuto dei credenti, riconosce chiaramente che esistono dei materialisti anche nel campo dei “non comunisti” e ammette la totale inutilità della mera propaganda ateistica ai fini del superamento dell’ideologia religiosa: senza un rapporto sociale di attiva collaborazione coi contadini e gli artigiani per un miglioramento delle loro condizioni di vita, i marxisti non potranno mai sperare di vincere le idee del passato. Lenin arrivò a mitigare il duro approccio ideologico nei confronti della religione solo dopo che il partito bolscevico conquistò il potere politico. Egli infatti si rese subito conto che “conquistare il potere in un’epoca rivoluzionaria è molto più facile che sapersene servire correttamente”.
LA COOPERAZIONE
Lenin cominciò a studiare il problema della cooperazione nel 1918. Fino alla svolta della NEP, egli ha sempre considerato “utopico” il socialismo cooperativistico. Il limite dell’”utopia” risiedeva -a suo giudizio- nella pretesa di poter realizzare la transizione dal capitalismo al socialismo senza “lotta politica della classe operaia per l’abbattimento del dominio degli sfruttatori” (così nell’art. Sulla cooperazione, scritto per la “Pravda” nel 1923). Lenin non ha mai accettato l’idea di poter utilizzare questa forma di socialismo per spingere le contraddizioni del capitalismo verso una soluzione socialista (che implicasse ovviamente anche la rivoluzione politica). Le energie impiegate per sviluppare la cooperazione in ambito capitalistico sarebbero state inevitabilmente tolte -secondo Lenin- alla causa rivoluzionaria vera e propria. La cooperazione poteva diventare utilissima dopo la rivoluzione, non prima. In caso contrario essa avrebbe finito coll’imborghesirsi, diventando una forma “socializzata” di produzione o di consumo capitalistici. Negli anni del “comunismo di guerra” Lenin era prevalentemente interessato alle cooperative dei consumatori, che svolgevano la funzione di assicurare la distribuzione dei prodotti alimentari. Peraltro, in quegli anni, il termine “cooperazione” designava, il più delle volte, il sistema territoriale di razionamento (relativamente alla cooperazione massiccia e forzata tipica del “comunismo di guerra”). Mentre la vera cooperazione risiede -come noto- sul principio della partecipazione volontaria. Lenin, tuttavia, fu sempre contrario all’idea di una cooperazione di produzione forzata nelle campagne. Lo attesta la risoluzione redatta per l’VIII congresso del partito, relativa all’atteggiamento da tenere verso i contadini medi: “Nell’incoraggiare le cooperative d’ogni tipo, così come le comuni agricole dei contadini medi, i rappresentanti del potere sovietico non devono esercitare alcuna costrizione durante la loro creazione. Soltanto le associazioni dovute alla libera iniziativa dei contadini, hanno un qualche valore”. Negli anni immediatamente seguenti alla rivoluzione, la cooperazione non veniva identificata col socialismo. Questo era anche il frutto di un condizionamento ideologico. Molti bolscevichi infatti credevano che il comunismo si dovesse costruire velocemente, rifiutando le forme sociali ereditate dal passato. In pratica essi identificavano la statizzazione dei mezzi produttivi e della terra con la loro diretta, immediata, socializzazione. Fu però la NEP a mettere in discussione questo schematismo. Lenin rivalutò la cooperazione quando s’accorse del fallimento del “comunismo di guerra”, cioè quando costatò che il socialismo non poteva essere imposto in alcun modo, neanche avvalendosi delle situazioni più critiche e drammatiche. Nel suo articolo Sulla cooperazione, Lenin affermò che “ogni nostro punto di vista sul socialismo è radicalmente mutato”. La cosa -a suo stesso giudizio- dipendeva dal fatto che si era spostato il “centro di gravità” dalla lotta politica per la conquista del potere, alla costruzione pacifica, culturale, del socialismo. Le cooperative, che nella fase politica non erano state considerate utili dal partito, ora, nella fase culturale, diventavano uno strumento fondamentale per la costruzione del socialismo. Per cui -diceva Lenin- “nelle nostre condizioni, la cooperazione coincide interamente col socialismo”: il socialismo cioè non è che “un regime di cooperatori colti”, ovvero la sua realizzazione in URSS doveva per forza passare per la tappa della cooperazione. Questa tesi non venne capita a sufficienza dai leaders del partito. Nella cooperazione -diceva Lenin- “abbiamo trovato il modo di combinare l’interesse commerciale privato, da una parte, con il suo controllo statale, dall’altra, cioè il modo di subordinare l’interesse privato a quello generale”. Già nello scritto del 1918, Sull’infantilismo di sinistra e lo spirito piccolo-borghese, Lenin aveva sottolineato che l’economia reale del periodo di transizione doveva necessariamente contenere elementi di socialismo e di capitalismo di stato. Questi elementi potevano anche avere degli aspetti in “comune”, in quanto il socialismo non è che “l’assimilazione e l’applicazione, mediante l’avanguardia del proletariato al potere, di ciò che è stato creato dai trusts”. Anzi, secondo Lenin, certi processi manageriali e organizzativi della produzione capitalistica avrebbero potuto dimostrare veramente il loro potenziale soltanto sotto il socialismo. In questo stesso scritto, polemizzando coi comunisti di “sinistra”, Lenin era arrivato alla formidabile intuizione – rimasta però quasi suo patrimonio esclusivo- che nessuna “nazionalizzazione” avrebbe potuto portare di per sé alla “socializzazione” dei mezzi produttivi. Le forme collettive di realizzazione della proprietà presuppongono necessariamente una diversità d’interessi e metodi adeguati per la loro organizzazione, ovvero un sistema sociale ampiamente democratico e pluralistico. Le forze sociali devono cooperare tra loro. Di questo Lenin era perfettamente consapevole. Non a caso nei suoi ultimi interventi (soprattutto nel “testamento politico”) egli mise l’accento sulle questioni della democrazia. Di fatto Lenin rivalutò la democrazia politica dopo averla vista realizzare sul piano economico, dopo essersi accorto che il centralismo del partito-stato rischiava, concedendo troppo all’autoritarismo, di minare le basi della NEP. Anzi, la cooperazione, per l’ultimo Lenin, doveva essere una forma di positivo superamento della stessa NEP, poiché questa era stata concepita soltanto come una “concessione al contadino in quanto mercante, al principio del commercio privato”. Attraverso la cooperazione -diceva Lenin- si poteva realizzare “quel grado di coordinazione dell’interesse commerciale privato con la verifica e il controllo da parte dello Stato, quel grado di subordinazione dell’interesse privato all’interesse generale”. Ciò, in sostanza, significava che mentre con la NEP il partito era stato costretto a fare delle “concessioni” al contadino privato, con la cooperazione invece si sarebbe potuti arrivare “automaticamente” al socialismo. Dov’era il limite di questo ragionamento, che pur in quel periodo superava di gran lunga quelli dei suoi compagni di partito? Nel fatto che si considerava la cooperazione un modo per realizzare al meglio il socialismo di stato e non un modo per superarlo. Per Lenin e per gli altri dirigenti di partito, non era lo Stato a doversi porre al servizio della cooperazione ma il contrario. La cooperazione cioè veniva considerata come un mezzo non come un fine: il fine era lo Stato socialista. L’interesse “generale” per Lenin poteva essere soltanto quello deciso dallo Stato. L’interesse generale della collettività locale era considerato alla stregua di un interesse “particolare”, che andava appunto mediato dalla cooperazione per poter diventare “generale”. La cooperazione, per Lenin, non era ancora, e giustamente, “la vera costruzione della società socialista”, poiché questa presuppone la fine della legge del valore, del denaro, del mercato, ecc., mentre la cooperazione continua ad avvalersi di queste cose. Sennonché, il rapporto Stato/cooperazione -nell’ottica di Lenin, doveva avvenire unicamente dall’alto al basso, per ritornare poi in alto. Lo Stato finanziava ciò che poteva incrementare i suoi poteri e solo il partito-stato avrebbe potuto stabilire quando la costruzione del socialismo sarebbe stata compiuta. Nella seconda parte dell’art. Sulla cooperazione, Lenin specifica che esistevano in URSS diverse forme d’imprese produttive: 1) quelle capitalistiche private (sotto controllo statale e senza proprietà terriera), 2) quelle di tipo socialista conseguente (dove tutto è statalizzato), 3) quelle cooperativistiche (che erano collettive e non private come le prime, ma socialiste come le seconde, perché terra e mezzi produttivi erano statali). Per Lenin dunque le cooperative erano tanto più socialiste quanto più assomigliavano alle aziende statali. Il carattere del “socialismo” era dato anzitutto dal monopolio statale della terra e dei mezzi produttivi, nonché dalla gestione collettiva dell’economia. Lo Stato non lasciava alla società il compito di decidere quale fisionomia dare al futuro socialismo. Non solo, ma come lo Stato andava considerato superiore alla società civile, così la classe operaia andava considerata superiore a quella contadina, poiché i partiti operai rivoluzionari avevano conquistato il potere, mentre quelli tradizionalmente contadini non vi erano riusciti. Era dunque il partito-stato che, in nome del proletariato industriale, deteneva il monopolio dei mezzi produttivi, mediante il quale esso avrebbe consolidato l’alleanza operaio-contadina. In questa visione delle cose non c’è mai stato un rapporto paritetico tra operai e contadini. La superiorità politico-organizzativa dimostrata dal proletariato industriale nel corso della rivoluzione (la quale pur ottenne vasti appoggi dal mondo contadino) rischiava, in ogni momento, d’essere ipostatizzata nel periodo post-rivoluzionario. Probabilmente la scoperta più sensazionale che fece Lenin all’inizio degli anni ‘20 (testimoniata non solo dall’art. Sulla cooperazione, ma anche da quello contro il menscevico N. Sukhanov, Sulla nostra rivoluzione), è l’importanza fondamentale della “cultura”, una volta compiuta la rivoluzione politica. Contro Sukhanov, Lenin difende la legittimità dell’Ottobre, dicendo che non si può aspettare che le masse abbiano un’elevata cultura prima di decidersi per la rivoluzione. Le rivoluzioni, infatti, scoppiano quando ve n’è la necessità, con o senza cultura di massa. Peraltro, afferma con acume Lenin: 1) non si può stabilire a priori il grado esatto di cultura, necessario a giustificare una rivoluzione (esso peraltro varia da nazione e nazione), e 2) è certamente indice di cultura volersi liberare con decisione degli sfruttatori, permettendo così a tutti di accedere alla cultura e al benessere. In sostanza, Lenin sosteneva che né Sukhanov né alcun altro aveva il diritto di contestare la legittimità dell’Ottobre, facendo leva sul basso livello culturale dei rivoluzionari russi. La legittimità dell’Ottobre stava unicamente nel fatto che la rivoluzione fu un movimento di vaste masse popolari e non un colpo di stato di pochi estremisti. Che poi i bolscevichi abbiano dato più peso alla politica che alla cultura, ciò andava considerato -diceva Lenin- come una mera contingenza storica, non come una legge del marxismo. Lenin era disposto ad accettare delle contestazioni sul piano del merito, non su quello della legittimità. In effetti, nel tentativo di dare un risvolto democratico al processo post-rivoluzionario, egli riconosceva che il partito aveva commesso molti errori dovuti all’ingenuità, all’infantilismo di sinistra, alla fretta del “tutto e subito”. D’altra parte se l’URSS stava diventando totalitaria, ciò non dipendeva solo da cause interne, ma anche dall’ostilità dell’Occidente capitalistico, che cercò immediatamente di rovesciare il nuovo potere in modo economico e militare. Lo sviluppo privilegiato dell’industria pesante fu determinato anche dalla paura di dover soccombere a un nuovo attacco dell’imperialismo. Lenin si rendeva perfettamente conto che il socialismo avrebbe potuto sopravvivere, sul piano economico, solo a tre condizioni: 1) sostenere l’azienda agricola individuale-familiare, 2) sviluppare la cooperazione a tutti i livelli, 3) risparmiare le risorse per sviluppare la grande industria, parallelamente a quella leggera (al fine di poter offrire delle merci ai contadini in cambio del grano). Sempre relativamente al tema della cultura, Lenin era dell’avviso che per formare e sviluppare la cooperazione occorreva istruire i contadini circa i suoi vantaggi, creando un “commerciante intelligente e colto” (alla maniera europea, non asiatica). “Nelle nostre condizioni” -diceva Lenin- il sistema del socialismo è quello dei “cooperatori colti”. La cultura era l’unico mezzo a disposizione, poiché la cooperazione aveva senso solo in quanto fenomeno volontario. Dato il basso livello di cultura del suo Paese, Lenin prevedeva di poter realizzare gli obiettivi nell’arco di “uno o due decenni, se tutto andava per il meglio”. In realtà, egli sapeva che sarebbe occorsa un’intera epoca storica, però aveva fiducia che il socialismo avrebbe potuto accelerare i tempi. Lenin non considerava anomalo il fatto che in Russia “il rivolgimento politico e sociale avesse preceduto quello culturale”. Anzi, forse con eccessiva sicurezza, sosteneva che il contrario era “teoria da pedanti”, in quanto con tutti i suoi rivolgimenti “culturali”, l’Europa occidentale, di fatto, non era mai giunta a porre le premesse politiche per l’edificazione del socialismo. Su questo era impossibile dargli torto. Lenin concentrò tutta la sua attenzione e tutte le sue energie verso un unico obiettivo: portare al potere un partito e una classe rivoluzionari. La scienza ch’egli doveva necessariamente privilegiare era quella della politica. Solo dopo la rivoluzione si poteva pensare al “pacifico lavoro organizzativo culturale”. In questo senso il gramscismo può validamente rappresentare una variante significativa del leninismo, poiché esso ha la pretesa di partire proprio dall’esperienza socioculturale per rovesciare politicamente il sistema borghese. L’importante, naturalmente, è che a questo obiettivo ci si arrivi, altrimenti la ricerca delle mediazioni e dei compromessi rischierà di vanificare la qualità dell’opposizione. Lenin, in fondo, non ha mai avuto torto nel ritenere impossibile costruire il socialismo senza conquista politica del potere da parte delle classi oppresse. Bisogna dunque riprendere le sue idee economiche sulla cooperazione e politiche sulla democrazia, ma a un livello superiore, tenendo conto degli sviluppi storici. Infatti, anche se per molti aspetti tragica, la storia non può essere trascorsa invano, come se nulla fosse. L’aggancio al passato non può mai avvenire sic et simpliciter. Ad es. l’idea che le cooperative diventano “socialiste” solo perché edificate su un terreno nazionalizzato, usando mezzi produttivi statali, è decisamente superata. D’altro canto Lenin aveva già superato l’idea che le cooperative potevano essere utilizzate dal punto di vista meramente tattico, ai fini della costruzione del socialismo. A causa del fatto che nella sua concezione politica del “centralismo democratico”, la democrazia si trovava spesso sacrificata al centralismo, Lenin non arrivò a comprendere adeguatamente l’idea che doveva essere lo Stato socialista a porsi al servizio della cooperazione socializzata e non il contrario. Per Lenin doveva piuttosto essere lo Stato, che, guidato dal partito politico, avrebbe dovuto gestire dall’alto il processo di socializzazione progressiva della produzione e della distribuzione. Esso avrebbe cominciato a estinguersi soltanto quando tutto sarebbe stato socializzato per iniziativa del vertice. Questa tesi in sé non sarebbe stata del tutto sbagliata, se Lenin avesse accettato l’idea che il modo di socializzare la società doveva essere un compito da svolgersi liberamente, lasciando cioè libera la società di capire i vantaggi del socialismo. Senza questa fondamentale libertà (ovviamente possibile quando la stragrande maggioranza dei cittadini rivendica la fine della proprietà privata dei mezzi produttivi), è destino che, nella dialettica tra centralismo e democrazia, il centralismo, in ultima istanza, abbia sempre la meglio, proprio perché non emerge mai con nettezza la convinzione che il centralismo ha senso solo in quanto è funzione della democrazia. Lenin di fatto pensava che il centralismo fosse di per sé capace di democrazia o che la democrazia fosse un’esperienza che il centralismo del partito-Stato avrebbe dovuto consegnare alla società. Quand’egli s’accorgeva che il centralismo tendeva a prevaricare, perdendo il contatto con le masse, abusando dei mezzi coercitivi ed amministrativi, l’accortezza di promuovere subito le esigenze della democrazia gli impediva di peggiorare la situazione. Ma questa era una sua caratteristica personale, non una strategia costante del partito. Ecco perché morto Lenin, il centralismo prese subito il sopravvento. Anche Stalin e Trotski tendevano al centralismo, ma quanto più forti erano le contrapposizioni della democrazia tanto più tendevano ad accentuare le pretese autoritarie. Lenin aveva posto le basi della futura democrazia socialista, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Si poteva andare avanti anche senza di lui: lo dimostra il fatto che è nata la perestrojka anche nell’ambito del Pcus e che diversi tentativi in direzione della democrazia economica e quindi politica sono stati fatti in URSS prima del 1985. Il passaggio tuttavia dal socialismo centralizzato a quello democratico non è cosa che si possa compiere facilmente: lo hanno dimostrato i fatti dell’agosto 1991 accaduti in URSS. Oggi più nessun politico democratico mette in dubbio il principio che vede il partito al servizio del popolo e non viceversa. Il partito “guida” il popolo finché il popolo non è in grado di “autoguidarsi”, e tanto prima il popolo vi riuscirà quanto più saprà tenere sotto controllo il potere delegato e rappresentativo del partito. Il centralismo dev’essere al servizio della democrazia in qualunque momento, anche in quelli più critici, che minacciano la riuscita di una rivoluzione, la realtà del socialismo, quelli che per questa ragione esigono l’unità delle forze politiche e sociali. Il centralismo, senza la democrazia, è da subito una forma di autoritarismo, e nulla può giustificare la sospensione della democrazia per poter salvare la stessa democrazia. Una democrazia può essere salvata solo da se stessa, e il centralismo che pretende di farlo al suo posto, eo ipso la nega. Il primato politico spetta sempre e comunque alla democrazia. Il valore del centralismo è organizzativo. Peraltro le funzioni del centralismo devono diminuire (in quantità e qualità) in maniera inversamente proporzionale alla distanza degli organi centrali dagli ambiti delle realtà locali, da gestirsi con la pienezza dei poteri e non sulla base d’un mandato ricevuto dall’alto. Quanto più il “centralismo” è lontano dalle masse tanto meno potere deve disporre, semplicemente perché sarebbe molto difficile controllarlo. Centralismo, partito, Stato e istituzioni devono tutti essere al servizio della società, nel comune destino di estinguersi progressivamente in virtù del socialismo democratico. Oggi, nell’URSS della perestrojka, si sta affermando, in sede economica, che le cooperative non devono essere in funzione dello Stato, ma deve essere il contrario; che proprio lo sviluppo della cooperazione (su basi volontarie) può comportare l’estinzione graduale dello Stato e la piena autonomia locale; che una cooperativa oggi è “socialista” se applica metodi socialisti e persegue finalità socialiste, volontariamente e consapevolmente, non tanto se la terra e i mezzi produttivi sono di proprietà statale. La statizzazione dev’essere in funzione della socializzazione, altrimenti il socialismo diventa autoritario e burocratico. Non solo, ma la perestrojka è stata anche in grado di scoprire che un piano dall’alto non può mai essere realizzato e se lo è (quando le cifre non sono truccate), i suoi indici sono sempre inferiori a quelli che si sarebbero potuti realizzare con una serie di piani locali. Il piano infatti ha senso solo a livello locale. Esso può essere impostato solo dalle persone che conoscono adeguatamente un determinato territorio e le sue risorse, nonché le potenzialità intrinseche a una determinata attività produttiva. Esso può essere rispettato solo dalle stesse persone che lo hanno impostato e che sanno in anticipo di quali vantaggi potranno beneficiare. Gli abusi non possono essere limitati ope legis. La possibilità dell’abuso (speculazione, furto, aggiotaggio, ecc.) non può mai essere evitata a priori. Allorquando l’abuso si manifesta, i cittadini, se resi responsabili a livello locale, sapranno presto individuarlo e superarlo.
RIFLESSIONI FAMOSE
Revisionisti : Sul piano politico il revisionismo ha tentato di rivedere il fondamento reale del marxismo, la dottrina della lotta di classe. La libertà politica, la democrazia, il suffragio universale, ci è stato detto, distruggono le basi stesse della lotta di classe e confutano la vecchia tesi del Manifesto comunista secondo cui gli operai non hanno patria. In regime di democrazia, dove domina la “volontà della maggioranza”, non si può più considerare lo Stato come un organo del dominio di classe e non ci si può più sottrarre all’alleanza con la borghesia progressista, propugnatrice di riforme sociali, contro i reazionari. E’ incontestabile che queste obiezioni dei revisionisti danno vita a un sistema abbastanza irganico di idee, cioè; al sistema già noto da un pezzo delle concezioni liberali borghesi. I liberali hanno sempre sostenuto che il parlamentarismo borghese distrugge le classi e la divisione in classi, perché tutti i cittadini senza distinzione hanno diritto al voto, hanno diritto di partecipare agli affari dello Stato. Ma tutta la storia dell’Europa nella seconda metà del XIX secolo, tutta la storia della rivoluzione russa all’inizio del secolo XX dimostrano chiaramente quanto siano assurde queste concezioni. Con la libertà del capitalismo “democratico” le differenze economiche non si attenuano, ma si accentuano e si inaspriscano. Il parlamentarismo non elimina ma mette a nudo l’essenza delle repubbliche borghesi più democratiche come organi dell’oppressione di classe. (Lenin, Marxismo e revisionismo, marzo-aprile 1908)
Cretinismo parlamentare : Soltanto dei mascalzoni o dei semplicioni possono credere che il proletariato debba prima conquistare la maggioranza alle elezioni effettuate SOTTO IL GIOGO DELLA BORGHESIA, sotto IL GIOGO DELLA SCHIAVITU’ SALARIATA, e poi conquistare il potere. E’il colmo della stupidità o dell’ipocrisia; ciò vuol dire sostituire alla lotta di classe e alla rivoluzione le elezioni fatte sotto il vecchio regime, sotto il vecchio potere. Il proletariato conduce la sua lotta di classe senza aspettare le elezioni per incominciare uno sciopero, benché per il completo successo dello sciopero occorra la simpatia della maggioranza dei lavoratori (e di conseguenza anche della maggioranza della popolazione). Il proletariato conduce la sua lotta di classe abbattendo la borghesia, senza aspettare nessuna votazione preliminare (organizzata dalla borghesia e che si svolga sotto la sua oppressione), e nel farlo sa benissimo che per il successo della sua rivoluzione, per l’abbattimento della borghesia E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIA la simpatia della maggioranza dei lavoratori (e di conseguenza della maggioranza della popolazione). I cretini parlamentari e i moderni Louis Blanc “esigono” assolutamente delle elezioni, e assolutamente organizzate dalla borghesia, per determinare la simpatia della maggioranza dei lavoratori. Ma questo è; un punto di vista di pedanti, di cadaveri o di abili ingannatori. La realtà viva, la storia delle vere rivoluzioni mostrano che assai spesso “la simpatia della maggioranza dei lavoratori” non può essere dimostrata da nessuna votazione (per non parlare delle elezioni organizzate dagli sfruttatori, con l'”eguaglianza” tra sfruttatore e sfruttato!). Assai spesso “la simpatia della maggioranza dei lavoratori”è dimostrata NON da votazioni, ma dallo sviluppo di un partito, o dall’aumento del numero dei sui membri nei soviet, o dal successo di uno sciopero che, per un qualche motivo, abbia acquistato grandissima importanza, o dal successo della guerra civile, ecc. ecc. (…) La rivoluzione proletaria è impossibile senza la simpatia e l’appoggio dell’immensa maggioranza dei lavoratori per la loro avanguardia, il proletariato. Ma questa simpatia, questo appoggio non si ottengono di colpo, non sono le elezioni a deciderli, ma SI CONQUISTANO con una lunga, difficile, dura lotta di classe. La lotta di classe del proletariato PER la simpatia, PER l’appoggio della maggioranza dei lavoratori non si esaurisce con la conquista del potere politico da parte del proletariato. DOPO la conquista del potere questa lotta CONTINUA, ma in ALTRE forme. (Lenin, Saluto ai comunisti italiani, francesi e tedeschi, 10 ottobre 1919)
La Borsa : La potenza del capitale è tutto, la Borsa è tutto, mentre il parlamento, le elezioni, sono un gioco da marionette, di pupazzi. (Lenin, Sullo Stato., 11 luglio 1919)
Concezione del mondo : Tutta l’esperienza della storia moderna e, in particolare, la lotta rivoluzionaria del proletariato di tutti i paesi, sviluppatasi per più di cinquant’anni, dopo la pubblicazione del MANIFESTO COMUNISTA, dimostrano inconfutabilmente che la concezione marxista del mondo è; la sola espressione giusta degli interessi, delle opinioni e della cultura del proletariato rivoluzionario. (Lenin, Sulla cultura proletaria, 8 ottobre 1920)
Dottrina marxista-leninista La dottrina di Marx è onnipotente perché è giusta. Essa è completa e armonica, e dà agli uomini una concezione integrale del mondo, che non può conciliarsi con alcuna superstizione, con nessuna reazione, con nessuna difesa dell’oppressione borghese. Il marxismo è il successore legittimo di tutto ciò che l’umanità ha creato di meglio durante il secolo XIX: la filosofia tedesca, l’economia politica inglese e il socialismo francese. (Lenin, Tre fonti e tre parti integranti del marxismo, marzo 1913)
Concezione proletaria : Tutta l’esperienza della storia moderna e, in particolare, la lotta rivoluzionaria del proletariato di tutti i paesi, sviluppatasi per più di cinquant’anni, dopo la pubblicazione del MANIFESTO COMUNISTA, dimostrano inconfutabilmente che la concezione marxista del mondo è la sola espressione giusta degli interessi, delle opinioni e della cultura del proletariato rivoluzionario. (Lenin, Sulla cultura proletaria, 8 ottobre 1920)
Gioventù : Il compito della Gioventù Comunista consiste nell’indirizzare la propria attività in modo che, studiando, organizzandosi, raggruppandosi, lottando, questa gioventù educhi se stessa e tutti coloro che vedono in essa una guida così da formare dei comunisti.
GIACOBINISMO LENINIANO, SOVIET E ACCUSE DI BLANQUISMO
L’accusa di essere una tendenza “giacobina” e “blanquista” è quella che più di frequente si muove alla Corrente Leninista Internazionale e al suo Manifesto. E’ sintomatico che essa ci sia lanciata da organizzazioni che, pur accusandosi reciprocamente delle peggiori nefandezze teoriche e pratiche, fanno a gara nel considerarsi “trotskyste ortodosse”. Caratteristica comune di tutti i trotskysti più o meno ortodossi è quella di avere introiettato il peccato originale di Trotsky (peccato di cui egli si vergognerà per tutta la vita): quello di aver inizialmente combattuto il bolscevismo come “deviazione giacobina”. E’ tipico dei trotskysti dimenticare quanto Trotsky stesso ebbe modo di dire più volte negli anni ’20 e ’30, e che cioè sul Partito, cioè sulla questione del “giacobinismo”, Lenin, e non lui o Rosa Luxemburg , ebbe ragione sin dall’inizio. Tutta la titanica lotta per costruire la Quarta Internazionale (lotta che egli considerò il compito più importante della sua vita), Trotsky la condusse infatti sotto la bandiera del leninismo più intransigente: “Non si possono esprimere gli interessi di classe se non sotto forma di programma; non si può difendere il programma se non costituendo un Partito. La classe in sé considerata non è che oggetto di sfruttamento. Il ruolo specifico del proletariato comincia nel momento in cui una classe sociale in sé diviene una classe politica per sé. Ciò può avvenire solo tramite il Partito. Il Partito è l’organo storico mediante il quale la classe acquista coscienza di sé. Dire “la classe è al di sopra del partito”, significa affermare: la classe allo stato bruto è al di sopra della classe che sta per acquistare coscienza di sé. Non solo questo è falso, ma è reazionario”. ( L.D.Trotsky. “E ora?”. Gennaio 1932) Molti trotskysti non hanno fatto mistero che, dalla scissione del POSDR al 1917, sarebbero stati con Trotsky contro Lenin, dimostrando così di non avere capito nulla né del leninismo né del trotskysmo. E’ un fatto che la gran parte delle correnti trotskyste, sulla questione del Partito, dell’insurrezione e della dittatura proletaria, cioè del “giacobinismo”, sono molto più vicine alle posizioni della Luxemburg che a quelle di Lenin. Esse attaccano il giacobinismo ma in realtà il loro vero bersaglio è la concezione leninista. E’ degno di nota che la critica al giacobinismo ha sempre tentato di mascherare la sua natura opportunista e socialdemocratica camuffandosi coi panni dell’estremismo parolaio e con il culto della spontaneità operaia. I trotskysti hanno anche un altro difetto, di non aver mai afferrato il contenuto reale della parola d’ordine leninista del 1905 che va sotto il nome di “dittatura democratica rivoluzionaria degli operai e dei contadini”, dimenticando quanto Trotsky stesso ebbe modo di precisare nel 1940. L. Trotsky. “Tre concezioni della rivoluzione”. 1940 Per loro Lenin voleva tenere, durante la rivoluzione democratico-borghese, il proletariato russo a rimorchio della borghesia. Ma questa era la posizione dei menscevichi (per i quali, siccome la rivoluzione era borghese, occorreva spingere al governo il Partito liberale) non dei bolscevichi! Già nel giugno 1905 Lenin affermava: “I giacobini della socialdemocrazia contemporanea, i bolscevichi, vogliono elevare, con le loro parole d’ordine, la piccola borghesia rivoluzionaria e repubblicana, e specialmente i contadini, al livello del democratismo conseguente del proletariato, senza che questo perda la sua fisionomia di classe. Vogliono che il popolo, cioè il proletariato e i contadini, regoli i conti con lo zarismo e l’aristocrazia “alla plebea”, sterminando implacabilmente i nemici della libertà, reprimendo con la forza la loro resistenza, non facendo alcuna concessione al maledetto passato di schiavitù, di asiatismo, di oltraggio all’essere umano”. (V.I.Lenin. “Due tattiche della socialdemocrazia russa”. Giugno 1905) In altre parole Lenin non era affatto per una coalizione con la borghesia, per appoggiare la borghesia, ma per prendere a calci nel sedere la borghesia, riteneva, in polemica con i menscevichi, che “Alcuni mesi di dittatura rivoluzionaria del proletariato e dei contadini faranno molto di più che decenni di pacifica e abbrutente atmosfera di stagnazione politica”. (V.I. Lenin “La dittatura democratica rivoluzionaria”. Aprile 1905) Con estrema chiarezza affermava che la rivoluzione del 1905 non doveva essere un nuovo 1789, ma un 1793 (nel senso della dittatura giacobina dal giugno 1793 al 27 luglio 1794) o, per essere più precisi, un 1848, nel senso che “Il compito della socialdemocrazia deve essere spingere più in là possibile la rivoluzione borghese, senza dimenticare mai l’obbiettivo principale: l’organizzazione autonoma del proletariato”. (V.I.Lenin “Una rivoluzione del tipo 1789 o del tipo 1848?” . Marzo 1905) I sostenitori di una supremazia di Trotsky su Lenin, non solo mostrano una pericolosa sottovalutazione della questione del Partito;la cui costruzione è stato il principale merito strategico di Lenin su tutte le altre correnti di sinistra della II. Internazionaleas; essi giustificano la loro tesi con l’argomentazione (notoriamente di origine staliniana) secondo cui Lenin avrebbe fino all’ultimo respinto l’idea che il proletariato doveva prendere il potere durante la rivoluzione democratica. In realtà Lenin giunge alle conclusioni essenziali di Trotsky (rivoluzione permanente) molto prima dell’aprile del 1917: “Nessuno è in grado di predire fino a che punto saranno attuate in Russia trasformazioni realmente democratiche nell’epoca delle sue rivoluzioni borghesi, ma non v’è ombra di dubbio che solo la lotta rivoluzionaria del proletariato determinerà il grado e il successo delle trasformazioni. Tra le “riforme”
BENEDETTO CROCE

L’arte è visione o intuizione. L’artista produce un’immagine o fantasma: e colui che gusta l’arte volge l’occhio al punto che l’artista gli ha additato, guarda per lo spiraglio che colui gli ha aperto e riproduce in sé quell’immagine.
” Un sistema filosofico è una casa che, subito dopo costruita e adornata, ha bisogno di un lavorio, più o meno energico, ma assiduo di manutenzione, e che a un certo punto non giova più restaurare e puntellare, e bisogna gettare a terra e ricostruire dalle fondamenta. Ma con siffatta differenza capitale: che, nell’opera del pensiero, la casa perpetuamente nuova è sostenuta perpetuamente dall’antica, la quale, quasi per opera magica, perdura in essa. ” (“Breviario di estetica”)
INTRODUZIONE AL NEO-HEGELISMO ITALIANO
L’indirizzo di cui Croce e Gentile sono espressione ha preso originariamente l’insegna del neo-hegelismo: è cioè l’indirizzo corrispettivo in Italia agli analoghi indirizzi di ritorno a Hegel che, marginalmente però ad altre correnti di pensiero, fiorivano tra l’Otto e il Novecento anche in altri Paesi. Per quanto riguarda nondimeno in particolare i due pensatori italiani, è più vivo e più accentuato in essi, rispetto a tutti gli altri, l’intento di operare una revisione critica innovatrice dell’hegelismo. E, ad onor del vero, dei due è più propriamente hegeliano Gentile, per essersi formato direttamente alla scuola, rigida e metafisicizzante, di Spaventa. Nipote di Spaventa, invece, Croce si è formato alla scuola del de Sanctis (risalendo, attraverso il de Sanctis, a Vico) e del Labriola (risalendo, attraverso il Labriola, a Herbart e a Marx), cosicchè alla diretta conoscenza del pensiero hegeliano egli è giunto (per influenza del suo stesso amico Gentile) solo in una fase giù matura (nel 1905) del suo sviluppo intellettuale. Sia Croce sia Gentile hanno accolto del pensiero di Hegel il principio animatore: l’idea cioè dello Spirito come attività dialettica che si svolge nel ritmo di sempre rinascenti opposizioni. E’ il principio per il quale la realtà è attività pensante, è Soggetto che si oggettiva e si naturalizza per tornare in se stesso fatto più altamente personale e più consapevole. Diversamente da Hegel, tuttavia, essi prescindono del tutto, nella loro speculazione, dai problemi della natura, ritenendo pertinenti alla vita dello spirito solo i problemi propriamente umani. Ne consegue che non si è avuta in Italia la polemica che invece divampò e fu assai vivace nel mondo culturale tedesco tra scienziati assertori del metodo sperimentale e hegeliani propugnatori d’una razionalistica e aprioristica interpretazione della natura. In Italia, al contrario, l’indifferenza di Croce e di Gentile per i problemi della scienza ha solo concorso (in virtù del peso culturale dei due personaggi) ad approfondire il solco tra ricerca scientifica e investigazione filosofica, a rendere estranea quella a questa e, di conseguenza, questa a quella. Ne deriva dunque anche la crescente influenza ch’essi hanno esercitato nel campo letterario e nella vita politica del Paese: nel campo letterario hanno notevolmente innovato gli studi di estetica e di ricerca storica, giungendo per tale via a diffondere largamente tra le giovani generazioni del loro tempo il gusto e il modo della visione e della valutazione idealistica dei relativi problemi. Nella vita politica hanno esercitato un’influenza ancor maggiore e, soprattutto, ancor più differenziata: Croce s’è fatto espressione ideologica delle istanze liberali, Gentile è divenuto il filosofo e, al tempo stesso, il padre ideologico del fascismo.
LA VITA E I RAPPORTI CON GENTILE
La vita dei due filosofi si intreccia strettamente per una lunga serie dapprima di reciproci rapporti, successivamente di reciproci contrasti. Benedetto Croce, nato a Pescasseroli, in Abruzzo, il 25 febbraio 1866 da famiglia assai agiata e formatosi negli anni universitari a Roma presso il Labriola, si trasferì intorno all’86 a Napoli, dove visse da allora la sua lunga e operosa vita. Dalle iniziali ricerche di carattere erudito nel campo dell’arte e della storia egli passò ben presto all’indagine sulla natura stessa dei problemi di cui si era venuto occupando. Un primo tentativo di dare ad essi una sistemazione teoretica lo troviamo nel suo saggio giovanile ” La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte ” (1893): saggio nel quale, in polemica con la visione naturalistica dei positivisti, egli asserisce appunto che il conoscere storico dev’essere ricondotto sotto il concetto generale dell’arte, cosicchè gli eventi umani non sono, come i fenomeni fisici, soggetti a un principio meccanico di necessità, ma sono, come le figurazioni artistiche, espressione di una libera attività creatrice. Ciò che nondimeno resta indeterminato nel saggio è il concetto stesso di arte: ed è proprio su tale concetto che Croce, negli anni successivi, concentrò la propria attenzione. Frutto di tali sue meditazioni fu la pubblicazione, avvenuta nel 1902, dell’ ” Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale “. Da quest’opera, che è la prima grande opera crociana, egli trasse via via, come per sviluppo sempre maggiore di concetti già impliciti embrionalmente, le altre opere: la ” Logica come scienza del concetto puro ” (1909), la ” Filosofia della pratica, economica ed etica ” (1909), la ” Teoria e storia della storiografia ” (1917). Sono queste le opere che formano la tetralogia, in cui Croce ha dato trattazione organica di sistema al suo pensiero, alla sua Filosofia dello Spirito. Ma, congiuntamente ad esse, egli pubblicò negli stessi anni una serie di saggi (sul materialismo storico, su Hegel, su Vico, ecc), traendo di volta in volta in tali saggi le conclusioni del suo dialogo ideale coi filosofi con cui era venuto direttamente o indirettamente a contatto per l’influenza del De Sanctis, di Labriola e di Gentile. Proprio Gentile fu suo collaboratore per circa vent’anni nella rivista ” La critica “, da lui fondata nel 1903 e diretta ininterrottamente per più di quarant’anni. Con ” La critica ” egli si foggiò lo strumento della più larga penetrazione nella vita culturale dell’Italia, orientando le giovani generazioni per lungo tratto di tempo così come prima dopo l’avvento del fascismo. L’avvento del fascismo segna il progressivo distacco di Croce da Gentile, o, meglio, di Gentile da Croce: l’accentuato contrasto o atteggiamento critico di Gentile verso il pensiero di Croce e, più ancora, la diversa posizione da essi assunta nei confronti della dittatura fascista valsero a cambiare i loro rapporti di sincera amicizia in rapporti d’irriconciliabile inimicizia. Se, infatti, Gentile aderì pienamente al nuovo regime dittatoriale e soffocatore di ogni libertà e se ne fece anzi propugnatore, Croce, dopo un periodo d’incertezza e di cautissima adesione, si scostò da esso e decisamente gli si oppose, giocando contro il fascismo la carta di un liberalismo ormai tramontato definitivamente. E bisogna riconoscere che Croce fu l’unico oppositore del regime a non essere brutalmente massacrato (come invece accadde a Gobetti) o indegnamente incarcerato (come accadde a Gramsci): gli fu anzi sempre riconosciuta la sua carica di senatore, forse anche in virtù del fatto che la sua era un’opposizione meramente teorica e che si appellava ad un liberalismo ormai incompatibile con la nuova temperie culturale e con la situazione in cui l’Italia versava; tanto più che il fascismo ci teneva a dimostrarsi un regime “aperto”, pronto a dar voce agli oppositori. Liberale conservatore, Croce vide dapprima nel fascismo un’utile e, come s’illudeva, temporanea forza di contenimento del movimento socialista, il quale, dopo il celebre “biennio rosso” (1918-1920), pareva avanzasse quasi a travolgere anche in Italia come in Russia le dighe della struttura borghese della società. Ma, trasformatosi il nuovo regime in dittatura permanente col colpo di stato del 3 gennaio 1925, le istanze liberali prevalsero sempre più nel suo animo e lo indussero, senza comunque smettere l’aspra polemica contro il socialismo (per il quale da giovane aveva pure simpatizzato), ad avversare senza più esitazioni il totalitarismo fascista: si accorse che il fascismo, seppur idoneo per tenere a bada gli appetiti socialisti e per conservare la società così com’era, non era uno strumento di cui ci si poteva servire solo quando faceva comodo per poi rimetterlo nel cassetto; viceversa, il fascismo era una malattia passeggera dello Stato, quasi una sorta di deviazione nel corso assolutamente razionale della storia: si trattava dunque, una volta terminata la parentesi fascista, di ritornare allo Stato liberale vigente prima dell’avvento della “malattia” fascista. Il liberalismo di cui Croce si fece vessillifero fu, tuttavia, sempre di stampo conservatore, senza troppe aperture sul versante socialista: quando gli parlarono della possibilità di creare un liberal-socialismo, che coniugasse le istanze proprie del socialismo con quelle proprie della tradizione liberale (nella convinzione che la vera libertà è possibile solo in condizioni di uguaglianza sociale), Croce bollò questa iniziativa come ” ircocervo “, ovvero come fantasticheria inattuabile. Croce, poi, rispose al manifesto con cui Gentile aveva raccolto l’adesione al fascismo da parte di alcuni intellettuali fascisti (tra cui Pirandello) con un manifesto di vibrante protesta firmato da un mare magnum di intellettuali antifascisti (tra cui ricordiamo Antonio Banfi). In questa seconda fase della sua vita Croce venne pertanto gradatamente accentuando il suo interesse speculativo per il problema politico (che aveva fin da allora considerato con un certo distacco), per il problema di un più intimo nesso tra il pensiero e l’azione, per il problema della libertà (centrale in Hegel). Frutto di tali sue nuove meditzioni è la pubblicazione in questo periodo di una serie di scritti, di cui meritano di essere menzionati, per la grande risonanza che ebbero e per la larga efficacia educativa che esercitarono sui giovani di allora, la ” Storia d’Italia dal 1871 al 1915 ” (1928), la ” Storia d’Europa nel secolo XIX ” (1932), ” La storia come pensiero e come azione ” (1938). Sono gli scritti nei quali la nozione di libertà è, secondo la stessa espressione crociana, innalzata a ” religione della libertà ” e identificata con lo Spirito nel suo dispiegarsi. La definizione molto vaga (e pressochè mistica) del problema della libertà doveva rivelarsi nondimeno, per l’istanza morale da cui procedeva, strumento efficace di educazione antifascista, finchè il fascismo imperò nel Paese; e anche, caduto il fascismo, continuò a ispirare in qualche modo le nuove generazioni nella loro azione per la ricostruzione del Paese, ma impregnandosi via via di nuove e più concrete istanze, in virtù delle quali non pochi degli antichi discepoli di Croce finirono col prendere, un poco alla volta, altre vie. Croce sopravvisse all’avversato regime: con la caduta di esso, però, riprese con rinnovato vigore, nella mutata condizione culturale determinatasi nel Paese, la polemica contro il marxismo. Si spense nel 1952, circondato dalla generale stima per quel che il suo nome aveva significato, per circa cinquant’anni, nella vita culturale della penisola. Egli fu una delle menti più poliedriche e versatili che il Novecento ricordi.
IL PENSIERO
Croce è, secondo la sua stessa definizione, il ” filosofo dei distinti “: nella sua revisione della dialettica hegeliana, infatti, egli ha scoperto che l’errore precipuo di essa sta nel confondere insieme concetti puri e concetti empirici da un lato, momenti opposti e momenti distinti dall’altro lato. E in realtà altra cosa sono, egli dice, i concetti puri (o categorie filosofiche), che concernono le forme fondamentali dell’attività dello spirito; altra cosa sono i concetti empirici (o pseudoconcetti), che risultano da pure generalizzazioni e classificazioni, utili ai bisogni della pratica, ma destituite di ogni verità. Solo i concetti puri sono, nel senso hegeliano dell’espressione, universali concreti; solo per mezzo di essi è dato concepire la realtà spirituale (che è la sola realtà e la sola universalità) nella sua concretezza, nel suo concreto dispiegarsi o procedere secondo il movimento dialettico che le è proprio. Gli pseudoconcetti , invece, sono o universalità senza concretezza (come le astrazioni matematiche) o concretezza senza universalità (come le empiriche e sempre mutevoli classificazioni delle scienze naturali). Il vizio della filosofia hegeliana della natura, ed in parte anche di quella dello Spirito, risiede pertanto, secondo Croce, nell’aver voluto includere nel procedimento dialettico molti concetti empirici che, come determinazioni irrigidite e astratte, non sono per questo stesso motivo suscettibili di mediazione, di sintesi. Ma, per quel che riguarda i concetti puri, nell’ambito solo di ciascuno di essi, è valido il procedimento dialettico degli opposti, afferma Croce: il procedimento per il quale i termini dell’opposizione si risolvono nella sintesi, perdendo in essa ogni loro esistenza distinta. Nei loro reciproci rapporti, invece, i concetti puri non si risolvono l’uno nell’altro, ma restano sempre distinti l’uno dall’altro: vale per essi un diverso principio di unificazione filosofica. Ecco perché Croce sdoppia l’unica dialettica hegeliana in una dialettica degli opposti e in una dialettica dei distinti: l’errore di Hegel, infatti, consiste, stando a Croce, nell’aver esteso indebitamente la dialettica degli opposti ai distinti, cioè ai concetti puri o alle forme categoriali dello Spirito: “ Hegel non fece, fra teoria degli opposti e teoria dei distinti, la distinzione importantissima, che io mi sono sforzato di dilucidare. Egli concepì dialetticamente, al modo della dialettica degli opposti, il nesso dei gradi; e applicò a questo nesso la forma triadica, che è propria della sintesi degli opposti. Teoria dei distinti e teoria degli opposti diventarono per lui tutt’uno ” ( “ Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel ”, cap. IV). Il vero precursore della dialettica dei distinti è da Croce ravvisato, più che in Hegel, in Vico: secondo Croce, tra le forme dell’attività spirituale si svolge l’eterno processo, che Vico aveva chiamato “storia ideale eterna”; queste forme, infatti, sono eterne, ma si sviluppano e manifestano di volta in volta arricchite di nuovi contenuti. Pubblicato come volume autonomo nel 1906, il saggio “ Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel ” (tradotto presto anche in francese e in tedesco) è emblematico a partire dal titolo: esso simboleggia l’atteggiamento con cui Croce guarda ai filosofi del passato per trarne alimento al proprio pensiero e, in particolare, con cui si rapporta a Hegel. Questi, secondo il filosofo abruzzese, ha fatto oggetto del suo pensiero “ non solo la realtà immediata, ma la filosofia stessa, contribuendo per tal modo a elaborare una logica della filosofia ”. Contro ogni filosofia meramente individuale fondata su una conoscenza immediata, egli ha rivendicato la centralità del metodo della filosofia e della teoria di questo metodo. Nell’affrontare questo problema, Hegel ha individuato l’importanza della dialettica degli opposti, come motore del processo della realtà e del pensiero, ma ha commesso l’errore di estendere questa forma di dialettica anche al rapporto fra le forme dell’attività spirituale. Su questo punto, Croce non può più seguirlo, sicchè la coscienza moderna, a suo avviso, si troverebbe di fronte a Hegel come il poeta latino di fronte alla sua donna, quando affermava “nec tecum vivere possum, nec sine te”. E in realtà bello e brutto, vero e falso, utile e dannoso, bene e male sono realmente termini opposti tra loro: vale per essi il principio hegeliano secondo cui il termine positivo (il bello, ad esempio) non ha vita se non trionfando sul negativo (il brutto). Nell’ambito di ciascuna di queste coppie di opposti dunque ogni termine ha significato solo nell’altro e per l’altro (chi prende il vero senza il falso, il bene senza il male, fa del vero qualcosa di non pensato – perché pensiero è lotta contro il falso – e quindi qualcosa di non vero; del bene qualcosa di non voluto – perché volere il bene è negare il male – e quindi qualcosa di non buono): al di fuori della loro sintesi, che sola è reale, gli opposti non sono, in conclusione, che delle vuote astrazioni. Ma lo stesso non può dirsi di ciascuno dei termini positivi che si son sopra elencati (il bello, il vero, l’utile, il bene): nei loro rapporti, infatti, essi non si annullano l’uno nell’altro, ma si armonizzano l’un con l’altro. Sicchè il vero non sta al falso nello stesso rapporto in cui sta al buono, il bello non sta al brutto nello stesso rapporto in cui sta alla verità filosofica: bello e vero, vero e bene sono invece tra loro in un nesso di gradi, per il quale bello, vero e bene sono forme distinte e insieme unite. Questa unità-distinzione è il nesso, è la dialettica dei distinti o, meglio, la dottrina dei gradi dello Spirito. Per essa, lo Spirito si distingue in due gradi teoretici (mediante cui l’uomo vede, comprende le cose) e in due corrispondenti gradi pratici (mediante cui l’uomo muta, crea le cose). Le forme proprie dei due gradi teoretici sono quella, estetica, dell’intuizione o della visione-espressione dell’individuale e quella, logica, della concezione dell’universale. Le forme proprie dei due corrispondenti gradi pratici sono quella, economica, della volizione del particolare e quella, morale, della volizione dell’universale. Ne deriva che, come si è venuto chiarendo, le quattro forme fondamentali dello Spirito sono: quella estetica del bello, quella logica del vero, quella economica dell’utile, quella morale del bene. All’infuori di tali forme non vi sono altri concetti puri, non vi sono altri valori in cui o mediante cui si esplichi l’attività dello Spirito. Evidente è, nella loro determinazione, l’influenza che, attraverso Labriola, hanno esercitato su Croce la triade herbartiana, per un verso, dei tre supremi valori del vero, del bene e del bello e la concezione di Marx, per l’altro, del valore assoluto dell’attività economica: i quattro valori, fusi in unità di sistema, sono gli elementi costitutivi del pensiero crociano. Il rapporto tra queste quattro forme dello Spirito è tale che il passaggio, nell’attività teoretica, al grado superiore della concezione dell’universale può avvenire solo attraverso il grado inferiore dell’intuizione dell’individuale: nel senso che la logica, in quanto produttrice di concetti, implica l’estetica, mera produttrice di intuizioni (non può esservi concetto senza intuizione) e non viceversa (cosicchè può esservi intuizione senza concetto). E, in modo corrispettivo, il passaggio, nell’attività pratica, al grado superiore della volizione dell’universale può avvenire solamente attraverso il grado inferiore della volizione del particolare: nel senso appunto che anche per l’attività pratica vale il criterio che la morale implica l’economia (non può esservi azione morale senza la consapevolezza che l’ideale etico rappresenta il grado più alto di utilità), non viceversa (sicchè può esservi azione volta al perseguimento del mero vantaggio individuale, del tutto scevra di preoccupazione morale). E le due attività teoretica e pratica sono, infine, anch’esse legate l’una all’altra in modo tale che la prima è presupposto e condizione del dispiegarsi della seconda (l’agire è un agire secondo ragione, secondo conoscenza); e la seconda, a sua volta, è presupposto e condizione dell’ulteriore dispiegarsi della prima (per ciò che diventa materia di nuova intuizione, di nuova conoscenza). E’ così che, secondo Croce, il ciclo teoretico-pratico si rinnova eternamente ed eternamente si arricchisce, nell’incessante svolgersi e crescere su se stesso della realtà spirituale. Di conseguenza, per la circolarità della vita spirituale appena illustrata, le quattro sue forme s’implicano a vicenda: si affermano tutte insieme nella loro positività e nella solidarietà che le lega e le fa compresenti in ogni singolo momento della vita dello Spirito. In questo propriamente consiste il rapporto di unità-distinzione: rapporto per il quale le quattro forme categoriali sono distinte nell’unità dello Spirito o (il che è la stessa cosa) lo Spirito è uno nella distinzione delle sue forme. Ora, passando ad esaminare il modo di esplicarsi delle singole forme, la prima forma dello Spirito teoretico è l’ arte , la conoscenza intuitiva. L’arte è, cioè, visione-espressione di un’immagine contemplata per sé, senza che ci si chieda se essa sia corrispettiva o meno a una realtà oggettiva o che si tenti di determinare la natura della realtà di cui è espressione: essa è, perciò, solo conoscenza intuitiva, non conoscenza concettuale del contenuto della vita dello Spirito. E, oltre a non essere conoscenza concettuale, l’arte, a maggior ragione, in quanto forma teoretica, non è né atto utilitario, né atto morale: non è, cioè, né determinazione dell’utile, né in dipendenza di un fine morale. Ciò che conferisce unità e significato all’intuizione artistica è il sentimento: non il sentimento immediato, nella sua tumultuosa passionalità, bensì il sentimento mediato e, per così dire, trasfigurato, elevato a pura forma, a pura immagine, a pura espressione. Ciò equivale a dire che l’arte è intuizione lirica, è sintesi a priori di sentimento e di immagine, è unità indissolubile di contenuto (il sentimento) e di forma (l’immagine, l’espressione). Ne deriva che per Croce l’arte, in quanto intuizione di un sentimento, di un contenuto di vita, si identifica con l’espressione stessa di quel sentimento, di quel contenuto di vita: l’intuizione è la stessa espressione, l’espressione è la stessa intuizione. E da tale identificazione deriva anche, secondo Croce, l’ identificazione di linguaggio e di poesia : è questo il motivo in parte tratto dalle dottrine del Romanticismo e, più ancora, dalla viva esperienza critica del De Sanctis e, attraverso il De Sanctis, dalla filosofia di Vico; ed è questo il motivo per il quale il linguaggio non è un segno convenzionale mediante cui gli uomini comunicano tra loro, ma è espressione viva, immagine spontaneamente prodotta dalla fantasia, dallo Spirito. Con l’identificazione di linguaggio e di poesia si spiega l’universalità dell’arte: il linguaggio poetico, quali che siano i modi tecnici (del suono, del colore, ecc) attraverso cui è espresso, è il linguaggio stesso degli uomini; quindi ogni uomo ha il potere di aprirsi una suggestione dell’arte, di rivivere in sé, contemplandola, l’opera d’arte, in qualsiasi tempo o luogo sia stata creata. Altra considerazione relativa all’arte è che, risolto il concetto di arte in quello di intuizione lirica, è negata da Croce ogni validità alla tradizionale dottrina dei generi letterari: alla dottrina che, come dice, è del tutto estranea al problema estetico ed è solamente espressione del bisogno pratico (economicistico, classificatorio) dello Spirito e, di conseguenza, è solamente costruttrice di preconcetti. All’estetica Croce dedica l’opera “ Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale ”: essa (che è l’opera che diede immediata celebrità a Croce) è lo sviluppo di una memoria che il filosofo aveva letto in tre sedute, all’Accademia Pontaniana di Napoli nel 1900. Croce individua i caratteri costitutivi dell’arte nel fatto di essere conoscenza intuitiva, inscindibile dall’espressione. L’espressione, però, non deve essere confusa con l’estrinsecazione fisica in lettere scritte, suoni o colori materiali: Croce chiarisce che questo aspetto rientra nell’attività pratica dello Spirito, non in quella conoscitiva che è specifica dell’arte. Curioso è il metodo impiegato da Croce: egli procede alla determinazione dei significati dei concetti mediante negazioni e distinzioni rispetto ad altri concetti imparentati o affini o opposti.
“ La conoscenza ha due forme: è o conoscenza intuitiva o conoscenza logica; conoscenza per la fantasia o conoscenza per l’intelletto; conoscenza dell’individuale o conoscenza dell’universale; delle cose singole ovvero delle loro relazioni; è, insomma, o produttrice d’immagini o produttrice di concetti. […] Della conoscenza intellettiva c’è una scienza antichissima e ammessa indiscussamente da tutti, la Logica; ma una scienza della conoscenza intuitiva è appena ammessa, e timidamente, da pochi. La conoscenza logica si è fatta la parte del leone; e, quando addirittura non divora la sua compagna, le concede appena un umile posticino di ancella o di portinaia. Che cosa è mai la conoscenza intuitiva senza il lume della intellettiva? E’ un servitore senza padrone; e, se al padrone occorre il servitore, è ben più necessario il primo al secondo, per campare la vita. L’intuizione è cieca; l’intelletto le presta gli occhi. Ora, il primo punto che bisogna fissare bene in mente è che la conoscenza intuitiva non ha bisogno di padroni; non ha necessità di appoggiarsi ad alcuno; non deve chiedere in prestito gli occhi altrui perché ne ha in fronte di suoi propri, validissimi. […] I concetti che si trovano misti e fusi nelle intuizioni, in quanto vi sono davvero misti e fusi, non sono più concetti, avendo perduto ogni indipendenza e autonomia. Furono già concetti, ma sono diventati, ora, semplici elementi d’intuizione. […] Noi non possiamo volere o non volere la nostra visione estetica: possiamo, bensì, volerla o no estrinsecare, o, meglio, serbare e comunicare o no agli altri l’estrinsecazione prodotta. ” (Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, parte I, cap. I).
Croce impiega una procedura dicotomica, distinguendo le due forme possibili di conoscenza, caratterizzate da due serie parallele di proprietà; da una parte, la conoscenza intuitiva, che avviene mediante la fantasia, ha per oggetto l’individuale, ossia entità singole, e dà luogo alla produzione di immagini; dall’altra, invece, la conoscenza logica (cui Croce dedicherà una trattazione apposita, la “ Logica come scienza del concetto puro ”), che avviene mediante l’intelletto, ha per oggetto l’universale, cioè le relazioni tra le cose, e dà luogo alla produzione di concetti. Contro la tradizionale subordinazione della conoscenza intuitiva, immediata, rispetto a quella intellettiva e concettuale, Croce rivendica a pieno titolo l’autonomia e la dignità di essa. In campo estetico, Croce mostra una netta chiusura verso l’allora trionfante decadentismo: esso è, ai suoi occhi, una grave malattia, una mancanza di sincerità, poiché con esso si crede e non si crede, si annega la confusione mentale in un mare magnum di parole altisonanti e suadenti che suggestionano, si creano miti nei quali si finisce per credere troppo. In altre parole, la cultura del decadentismo è un’offesa che l’uomo di cultura conduce contro i suoi lettori; la stessa nascita della dittatura fascista è da Croce, per alcuni versi, letta come produzione estrema del decadentismo: per usare le sue stesse parole, è “ un’industria del vuoto ”, che si adopera per non produrre nulla. La poesia, secondo Croce, non è tale in quanto dice belle cose imbevute di patriottismo (com’era per D’Annunzio): la vera poesia non è propagandistica, ma è intuizione pura, rappresentazione alimentata da un forte sentimento individuale in cui l’artista realizza una perfetta ed armoniosa fusione fra contenuto e forma: tipico esempio è la figura di Polifemo, che rappresenta in modo impeccabile la forza bruta. D’Annunzio è, del resto, secondo Croce il “ padre spirituale ” del nazionalismo italiano: il poeta e soldato, la cui sola musa fu la violenza, è un mistificatore del pensiero di Nietzsche, dice Croce, e ciò è perfettamente espresso nella frase crociana “ letto che ebbe qualcosa del Nietzsche ”, con cui sottolinea come D’Annunzio fosse andato incontro a colossali fraintendimenti del pensiero nietzscheano, in buona parte dovuti al fatto che l’aveva letto in modo non sistematico. Dal primo momento (appena descritto) dello spirito teoretico si passa, nel sistema crociano, al secondo momento, che è costituito dal pensiero logico . Come l’arte è conoscenza dell’individuale, così il pensiero logico è pensamento dell’universale; e, per il principio dell’implicazione dei distinti, il pensamento dell’universale è unità di universale e d’individuale, di concetto e d’intuizione. Come tale, il pensiero logico è rapporto di soggetto (ossia di un fatto, quale che esso sia) e di predicato, è determinazione della particolarità del fatto (che si è intuito) nell’universalità del concetto (di cui lo si predica): è, in fin dei conti, giudizio su singole realtà di fatto. E, giacchè il giudizio sulle singole realtà di fatto è giudizio sui fatti nel loro farsi (per la ragione che fatti che non si facciano, che non diventano, o fatti per così dire immobili non si ritrovano né si concepiscono nel mondo della realtà), evidente è che tale giudizio è e non può essere che un giudizio storico. Ne consegue che il pensiero logico è, in quanto tale, un pensare storico : proprio in ciò risiede la tesi portante della ” Logica ” e, anzi, di tutta l’opera crociana. E’ la tesi per la quale la filosofia, scienza dei concetti, si identifica con la storia, scienza dei giudizi: ecco perché Croce può asserire che ” i veri filosofi, se ne avvedessero o no, non hanno mai fatto altro che rinvigorire e raffinare i concetti per far sì che meglio si intendano i fatti, cioè la realtà, cioè la storia “; è dunque necessario, per usare le stesse parole impiegate da Croce, rendere ” filosofica la storia, ma nell’atto stesso storica la filosofia, e indirizzandola a non altro che a risolvere i problemi che il corso delle cose propone sempre nuovi “. Questa identità tra filosofia e storia implica un approfondimento storico dei problemi della filosofia e, insieme, un approfondimento filosofico della storia, cosicchè la storia non si compendia in un’arida registrazione e giustapposizione di nudi fatti individuali, ma in un’interpretazione e connessione mentale di essi, per cui il loro svolgimento coincide con lo sviluppo stesso della vita dello Spirito: e poiché lo Spirito è pura razionalità, allora la storia (come già aveva sottolineato Hegel) procede in modo assolutamente razionale. L’identità della filosofia con la storia rappresenta, di conseguenza, per Croce un’istanza decisiva contro la vecchiaia e, possiam dire, teologica filosofia della storia, che avanzava la pretesa di compendiare in astratti schemi e di predeterminare le leggi del divenire storico: il divenire storico, viceversa, ha in se stesso, e non fuori né al di sopra, la norma e la misura dei suoi valori. Ma, identificata la filosofia con la storia e intesa la storia come una realtà piena dello Spirito, ne consegue anche che l’idea di una scienza distinta ed autonoma che si occupi di problemi “massimi” ed “eterni” è un’idea antiquata (che non ha più ragion d’essere) della filosofia, dovuta alla sopravvivenza in essa delle vecchie sue forme metafisicizzanti. L’idea adeguata della filosofia è invece, nella prospettiva di Croce, quella per la quale essa diviene un semplice momento trascendentale della conoscenza storica, sicchè il suo solo compito è di apprestare alla conoscenza storica le categorie della sensibilità del reale. Ne deriva che la filosofia è, come dice Croce, il mero momento metodologico della storiografia, la mera delucidazione delle categorie costitutive dei giudizi storici; e poiché la storiografia ha per contenuto la vita concreta dello Spirito, e questa vita è vita di fantasia e di pensiero, di azione e di moralità (quali sono appunto le forme in cui si estrinseca) e in questa varietà delle sue forme è pur una, la delucidazione delle categorie storiche si muove secondo la distinzione dell’estetica e della logica, dell’economia e dell’etica, e le congiunge tutte nella filosofia dello Spirito: questa tesi Croce la esprime in ” Teoria e storia della storiografia ” e, più particolarmente, in ” La storia come pensiero e come azione “. In questa concezione, tuttavia, vi è qualcosa di più della mera identità tra la filosofia e al storia: la filosofia, infatti, negata come scienza a sé stante e considerata come categoria della storia, finisce col trovare solo in quest’ultima il suo inveramento, finisce cioè col risolversi integralmente nella storia. E’ così che Croce è via via pervenuto al pieno capovolgimento della posizione iniziale del suo pensiero di fronte al problema storico: dalla considerazione iniziale della storia come arte (nel saggio giovanile ” La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte “) a quella che ne fa una forma di realtà autonoma, inferiore alla filosofia, a quella dell’identità e reciprocità piena con la filosofia, infine a quella dell’integrale risoluzione della filosofia nella storia come ” storia pensata “, egli ha, come si vede, descritto un ciclo evolutivo, parallelo all’evolversi stesso e all’arricchirsi progressivo del suo pensiero. Ecco perché si è soliti definire la filosofia di Croce come la “filosofia dello storicismo assoluto”. Per essa, infatti, tutta la realtà è Spirito, tutta la realtà è storia: anche ciò che chiamiamo natura è processo storico, è processo spirituale che abbiamo, nondimeno, distanziato così tanto che, per il fatto che ci limitiamo a considerarne le manifestazioni sommariamente e dall’esterno, ci sembra che siano manifestazioni di una realtà meccanica e quasi esterna allo Spirito. E’ così mostrata l’umanità della storia nel senso più largo, nel senso inclusivo anche della storia della cosiddetta natura: come dell’uomo si può fare una storia naturale (esteriore e meccanizzata), così della natura si può fare una storia umana (interiore, cioè, e spiritualizzata). L’opposizione tra natura e spirito è pertanto opposizione non tra due realtà, ma tra due metodi diversi d’investigazione della medesima realtà, dice Croce. Il metodo interno al reale, o della spiritualità e storicità del reale, è il metodo per il quale la storia, per remoti o remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti presi a considerare, è sempre storia contemporanea, è sempre storia riferita al bisogno e alla situazione presente che la suscita e la crea: ecco perché ” ogni storia è storia contemporanea “, in quanto la ricerca sul passato è sempre frutto di interessi, domande, curiosità, che nascono dall’oggi. Ed è, insieme, il metodo per il quale ogni storia, per particolare che sia il problema preso in considerazione, è sempre storia universale, è sempre storia procedente dall’universalità del soggetto e comprendente nella particolarità di quel problema la totalità dello Spirito. Il metodo invece esterno al reale, o della materializzazione e meccanizzazione del reale, è il metodo del giudizio classificatorio (produttore di pseudoconcetti), che, a differenza del giudizio storico (fondato sui concetti), dà d’una realtà oggettiva e resa estranea e delle infinite sue determinazioni una rappresentazione schematica, abbreviata secondo formule che non sono né vere né false ma sono solo utili ai bisogni della pratica. Si è pervenuti, per questa via, ad esaminare la sfera dell’ attività pratica e, più precisamente, economica dello Spirito. E’ la sfera nella quale, appunto, rientrano, secondo Croce, i “giudizi classificatori”, che si son detti, e le scienze empiriche, che su quei giudizi si costruiscono. Appare qui evidente l’influenza delle filosofie empiriocriticistiche (specialmente quella di Mach) per le quali, come si ricorderà, le leggi formulate dalle scienze sono solo espressione di economia di pensiero; ma è anche evidente che, diversamente da quelle filosofie e conformemente in qualche modo alle filosofie spiritualistiche francesi, il sapere scientifico, come totalmente estraneo all’attività teoretica, non è per Croce che una sorta di sapere inferiore, non è anzi alcun sapere affatto (dato che il vero o il solo sapere è quello filosofico). Con le scienze della natura, o con la considerazione naturalistica della realtà, rientrano anche nella sfera dell’economico, dell’utile, le altre attività pratiche dello Spirito: quali quelle del diritto, della politica, dell’economia in senso stretto. Sono le attività su cui Croce si è soffermato con particolare attenzione, per la viva influenza che ha esercitato su di lui (anche se volto a tutt’altro segno) il pensiero di Marx. Come Marx, infatti, egli riduce a economia, a espressione dell’attività economica, il diritto e la politica; ma, in contrasto con Marx, da tale attività distingue, secondo la sua dottrina, e afferma come aventi propria assoluta autonomia così i valori morali (che stanno a quelli economici come l’universale all’individuale) come, e a maggior ragione, i valori del bello e del vero. Si conclude così l’esame delle forme categoriali dello Spirito, che (per il nesso dei distinti) sono insieme congiunte in un procedimento circolare, per il quale la teoresi è condizione per la prassi e la prassi è condizione per la nuova teoresi, e così via nell’infinito procedere della realtà. Giacchè la realtà, come è noto, non è altro se non storia: storia intesa come pensiero e come azione, come libero esplicarsi e incessante progredire della vita attraverso il dispiegarsi delle forme o dei valori (teoretici e pratici) che sono ad essa immanenti.
A cura di Giuseppe Di Donato
VITA
Benedetto Croce nacque a Pescasseroli (L’Aquila) il 25-2-1866, in una famiglia di proprietari terrieri, ricca ma molto conservatrice (era attaccata ancora ai Borboni!), e frequentò le scuole secondarie in un collegio di religiosi, anch’esso culturalmente chiuso.
 Nel 1883 villeggiò a Casamicciola (nell’isola d’Ischia), ed un terremoto durato 90 secondi gli uccise i genitori Pasquale e Luisa Sipari e la sorella Maria, rimanendo lui stesso “sepolto per parecchie ore sotto le macerie e fracassato in più parti del corpo”.
Nel 1883 villeggiò a Casamicciola (nell’isola d’Ischia), ed un terremoto durato 90 secondi gli uccise i genitori Pasquale e Luisa Sipari e la sorella Maria, rimanendo lui stesso “sepolto per parecchie ore sotto le macerie e fracassato in più parti del corpo”.
Fu allora accolto a Roma dallo zio, il senatore Silvio Spaventa (famoso storico e fratello di Bertrando Spaventa, filosofo idealista che aveva tentato una riforma dell’Hegelismo): fu un gesto nobile da parte dello Spaventa anche perché era in rotta coi Croce, dal momento che questi, a causa del tradizionalismo a cui abbiamo accennato, gli avevano rimproverato un eccessivo liberalismo (e del resto i Croce si erano allontanati anche da Bertrando, perché apostata).
Nel salotto di Silvio, Benedetto incontrò importanti uomini politici ed intellettuali, tra i quali ad esempio Antonio Labriola (che allora era herbartiano), del quale frequentò le lezioni di filosofia morale all’università di Roma (anche se era iscritto a giurisprudenza a Napoli); Benedetto non finì gli studi universitari, non volendo conseguire titoli accademici, ma continuò comunque a studiare, trascurando inizialmente Hegel, poiché i libri che circolavano in casa Spaventa gli diedero l’idea ch’esso dovesse essere un filosofo quasi incomprensibile.
 Nel 1886 lasciò la “politicante società romana, acre di passioni”, e tornò a Napoli, dove comprò la casa nella quale aveva vissuto il filosofo Giambattista Vico; negli anni seguenti viaggiò in Spagna, Germania, Francia ed Inghilterra, ed aumentò l’interesse per la storia, grazie alle letture di Francesco De Sanctis (letture già iniziate durante gli studi ginnasiali, assieme a quelle del Carducci: De Sanctis e Carducci diventeranno per lui due punti fissi).
Nel 1886 lasciò la “politicante società romana, acre di passioni”, e tornò a Napoli, dove comprò la casa nella quale aveva vissuto il filosofo Giambattista Vico; negli anni seguenti viaggiò in Spagna, Germania, Francia ed Inghilterra, ed aumentò l’interesse per la storia, grazie alle letture di Francesco De Sanctis (letture già iniziate durante gli studi ginnasiali, assieme a quelle del Carducci: De Sanctis e Carducci diventeranno per lui due punti fissi).
Nel 1895 Labriola (che intanto aveva abbandonato la filosofia di Herbart), col quale Benedetto aveva mantenuto il dialogo intellettuale, gli fece conoscere le idee del Marxismo, alle quali inizialmente il filosofo napoletano si interessò, studiando i saggi di Labriola, leggendo libri di economia, riviste e giornali italiani e tedeschi d’ispirazione socialista, e l’interesse si diresse così verso la politica; tra l’altro aveva espresso sul Marxismo, tra il 1895 ed il 1899, una “critica tanto più grave, in quanto voleva essere una difesa e una rettificazione del Marxismo stesso”, pensando egli che la società capitalista studiata da Marx non esistesse, né fosse mai esistita, ma gli interessi per il Marxismo fecero sentire al nostro il bisogno di risalire ad Hegel, al cui studio lo invitava anche il suo amico e filosofo Giovanni Gentile.
 Col Gentile fondò, nel 1903, la rivista “La Critica”, il cui progetto era maturato nell’estate del 1902, ma l’amicizia col Gentile, che aveva conosciuto quando quest’ultimo era studente a Pisa, si ruppe quando quest’ultimo aderì al fascismo.
Col Gentile fondò, nel 1903, la rivista “La Critica”, il cui progetto era maturato nell’estate del 1902, ma l’amicizia col Gentile, che aveva conosciuto quando quest’ultimo era studente a Pisa, si ruppe quando quest’ultimo aderì al fascismo.
“La Critica” fu pubblicata dal 1903 al 1944, ed il suo prestigio culturale ne rese impossibile al fascismo la soppressione: è noto che Mussolini chiese “Quante copie tira Critica?”, ed essendogli stato risposto “1500”, disse “allora lasciatelo stare”.
Nel 1910 Benedetto fu nominato senatore per censo e fu ministro della Pubblica Istruzione nel 1920-21, nel quinto ministero Giolitti: elaborò anche una riforma scolastica, che non volle attuare per la propria non adesione al fascismo, ma essa fu comunque ripresa e realizzata dal Gentile nel 1923 (oggi quella riforma è infatti nota come “riforma Gentile”).
Nel 1914 sposò Adela Rossi, con la quale ebbe 4 figlie (Alda, Elena, Livia e Silvia).
 Come s’è detto, Croce ruppe con Gentile in occasione della sua adesione al fascismo (ma già da tempo c’era forte dissenso tra i due): dopo l’avvento al potere di Mussolini ed il delitto Matteotti (1924) fu pubblicato il 1-5-1925 su “Il Mondo” (rivista liberale per la quale scrisse, nel 1950, la prefazione a “1984” di George Orwell, tradotto da Gabriele Baldini), in risposta al “Manifesto degli intellettuali fascisti” di Gentile, il suo “Manifesto degli intellettuali anti-fascisti” (al quale aderirono Eugenio Montale ed Aldo Palazzeschi, e tra i matematici Leonida Tonelli, Ernesto e Mario Pascal, Vito Volterra, Giuseppe Bagnera, Guido Castelnuovo, Beppo Levi, Tullio Levi Civita, Alessandro Padoa, Giulio Pittarelli e Francesco Severi), scritto su invito di Giovanni Amendola, e smise di intervenire direttamente nella politica, attività che esercitò dopo la caduta del fascismo, essendo stato presidente del ricostituito Partito Liberale nel 1943-1947 (fu avverso al comunismo ma lodò il valore letterario di Gramsci), ministro nei governi Badoglio e Bonomi, membro dell’Assemblea Costituente e poi del Senato.
Come s’è detto, Croce ruppe con Gentile in occasione della sua adesione al fascismo (ma già da tempo c’era forte dissenso tra i due): dopo l’avvento al potere di Mussolini ed il delitto Matteotti (1924) fu pubblicato il 1-5-1925 su “Il Mondo” (rivista liberale per la quale scrisse, nel 1950, la prefazione a “1984” di George Orwell, tradotto da Gabriele Baldini), in risposta al “Manifesto degli intellettuali fascisti” di Gentile, il suo “Manifesto degli intellettuali anti-fascisti” (al quale aderirono Eugenio Montale ed Aldo Palazzeschi, e tra i matematici Leonida Tonelli, Ernesto e Mario Pascal, Vito Volterra, Giuseppe Bagnera, Guido Castelnuovo, Beppo Levi, Tullio Levi Civita, Alessandro Padoa, Giulio Pittarelli e Francesco Severi), scritto su invito di Giovanni Amendola, e smise di intervenire direttamente nella politica, attività che esercitò dopo la caduta del fascismo, essendo stato presidente del ricostituito Partito Liberale nel 1943-1947 (fu avverso al comunismo ma lodò il valore letterario di Gramsci), ministro nei governi Badoglio e Bonomi, membro dell’Assemblea Costituente e poi del Senato.
Alcuni accusano Benedetto di falso liberalismo, poiché fino al ‘25 aveva appoggiato il fascismo, vedendolo come mezzo per sconfiggere le forze della sinistra: fatto ciò, la classe liberale avrebbe potuto continuare a reggere lo Stato, con le mani pulite; ricordiamoci anche che al grido di “oro alla patria!”, quando lo Stato per sostenere il costo della guerra cambiava (a chi lo sceglieva) le fedi nuziali di oro con anelli di ferro, Croce donò la propria medaglia di senatore.
 Dopo la firma dei Patti Lateranensi (11-2-1929), mostrò la sua contrarietà al Concordato tra Stato e Chiesa dicendo in Senato che “accanto o di fronte ad uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri per i quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché è affare di coscienza”, nella sua replica Mussolini definisce Croce “un imboscato della storia”.
Dopo la firma dei Patti Lateranensi (11-2-1929), mostrò la sua contrarietà al Concordato tra Stato e Chiesa dicendo in Senato che “accanto o di fronte ad uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri per i quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché è affare di coscienza”, nella sua replica Mussolini definisce Croce “un imboscato della storia”.
Nel 1946 fondò a Napoli (nel frattempo si era ritirato a vivere nel palazzo di Trinità Maggiore, che era appartenuto ai Filomarino) l’Istituto Italiano per gli studi storici, la direzione del quale venne affidata al prof. Federico Chabod.
Il tradizionalismo di Croce emerge nei suoi giudizi negativi verso i poeti simbolisti francesi: fu apertamente critico di Rimbaud e Valéry, come del resto lo fu verso Pirandello, D’Annunzio e Pascoli (espresse inizialmente perplessità verso il Decadentismo in generale, e le perplessità maturarono poi in decisa avversione): proprio per questo ci fu un lieve contrasto tra il Croce e Cesare Angelini, come racconta Angelini stesso ne “Gli uomini della Voce” (clicca qui se vuoi approfondire)
Nel 1949 fu colpito da un ictus cerebrale, che limitò le sue possibilità di movimento, ed il filosofo non uscì più di casa, dove continuava a studiare: fu colto dalla morte mentre era seduto in poltrona nel suo studio-biblioteca, il 20-11-1952.
PENSIERO FILOSOFICO
Dialettica: Benedetto riprende alcuni aspetti della filosofia di Hegel; innanzitutto concorda con Hegel nel dire che il pensamento filosofico è concetto (non intuizione o sentimento), universale (e non generale, come le nozioni delle scienze empiriche) e concreto (poiché riguarda la realtà): se ti va puoi leggere qui le parole esatte del Croce nel suo “Saggio sullo Hegel”.
universale (e non generale, come le nozioni delle scienze empiriche) e concreto (poiché riguarda la realtà): se ti va puoi leggere qui le parole esatte del Croce nel suo “Saggio sullo Hegel”.
In questo modo Hegel riuscì a definire l’universale concreto come sintesi di opposti, “unità nella distinzione e nell’opposizione”; ha però, ad avviso di Benedetto, commesso tutta una serie di errori, che deriva da un unico errore, e cioè l’aver visto la realtà solo come prodotti di opposti che si sintetizzano, mentre Benedetto precisa che esistono anche i distinti, e crea una sua nuova dialettica che prevede la sintesi di opposti (come quella Hegeliana) e il nesso di distinti
I distinti nella filosofia crociana sono fondamentalmente 4, e sono generati dalle 2 attività fondamentali dello Spirito (conoscitiva, o teoretica, e volitiva, o pratica) a seconda che si dirigano verso il particolare o l’universale; detti distinti (o categorie) sono la fantasia, l’intelletto, l’attività economica e l’attività morale, e non si sintetizzano, non essendo opposti, mentre si sintetizzano, al loro interno, rispettivamente il bello ed il brutto (estetica), il vero ed il falso (logica), l’utile ed il dannoso (economia), il bene ed il male (morale).

Arte: Benedetto afferma, nel Breviario di estetica, che “l’arte è ciò che tutti sanno che cosa sia”, perché se non si sapesse nulla di essa non si potrebbe chiedere cosa sia l’arte, perché ogni domanda contiene in sé già delle informazioni sull’oggetto della domanda stessa.
Il filosofo pensa che l’uomo abbia una precomprensione delle verità di fondo, e che la filosofia porti ad un livello di chiarezza critica queste precomprensioni; la differenza tra un buon filosofo ed una persona qualsiasi è che il filosofo pone le domande con maggiore “intensità”, e di conseguenza cerca di rispondere con maggiore intensità.
 L’arte viene definita come conoscenza intuitiva, e si identifica la stessa come espressione dell’intuizione: in questo modo Croce critica le persone che dicono di aver dentro di sé grandi idee, grandi intuizioni, ma di non riuscire ad esprimerle: in realtà queste persone non hanno dentro di sé ciò che dicono di avere, perché ciò che si intuisce, automaticamente e spontaneamente si esprime.
L’arte viene definita come conoscenza intuitiva, e si identifica la stessa come espressione dell’intuizione: in questo modo Croce critica le persone che dicono di aver dentro di sé grandi idee, grandi intuizioni, ma di non riuscire ad esprimerle: in realtà queste persone non hanno dentro di sé ciò che dicono di avere, perché ciò che si intuisce, automaticamente e spontaneamente si esprime.
Questa intuizione artistica non è propria solo dei grandi artisti, dei geni, ma appartiene ad ogni persona, che sa ricreare e fruire della creazione del genio, infatti se non fosse così il genio non sarebbe un uomo, e del resto gli altri uomini non potrebbero capirlo.
L’arte è anche libera di esprimersi, nel senso ch’essa non è subordinata a nulla, al piacere, all’utile, alla morale (non immorale, ma amorale: se anche rappresentasse situazioni oscene, rimarrebbe arte), questo perché essa è una forma di conoscenza, che è funzionale a sé, senza il problema della veridicità o meno di tale conoscenza perché l’intuizione artistica ha come oggetto un’immagine (non necessariamente corrispondente al vero).
Ci sono, è vero, opere d’arte che tramandano valori morali, religiosi, filosofici (ecc.), ma essi non sono gli scopi dell’opera d’arte, sono solo parte integrante di essa: non viene negata all’artista la possibilità di esprimere determinati valori, ma si sottolinea come essi “integrino” l’intuizione artistica.
A proposito dell’arte come intuizione, il pensatore distingue l’espressione/intuizione dall’estrinsecazione dell’espressione: mentre il primo elemento è caratterizzato dal sentimento, il secondo riguarda delle tecniche, è quindi un’attività pratica; l’intuizione si ha grazie al sentimento, “rappresenta il sentimento, e solo da esso e sopra di esso può sorgere”, perciò il sentimento si identifica con la lirica (“l’arte è sempre lirica”): per Croce “lirica” ed “intuizione” sono sinonimi.
Altra precisazione crociana è che l’arte sia una sintesi a priori estetica, sintesi di sentimento ed immagine nell’intuizione: il sentimento senza l’immagine è cieco, e l’immagine senza il sentimento è vuota; essi possono anche presentarsi distinti, ed in questo caso non si ha arte, che si può presentare come contenuto o come forma, lasciando sottintendere che “il contenuto è formato” e “la forma è riempita”, il sentimento è “sentimento figurato” e la figura è “figura sentita”.
 L’arte viene vista anche come sintesi di particolare ed universale, perché un artista opera partendo da determinazioni particolari, dando ad esse, mediante il proprio percorso interiore, valori, significati man mano meno immediati e soggettivi, più generali.
L’arte viene vista anche come sintesi di particolare ed universale, perché un artista opera partendo da determinazioni particolari, dando ad esse, mediante il proprio percorso interiore, valori, significati man mano meno immediati e soggettivi, più generali.
Si criticano anche le espressioni che definiscono i “generi”: i generi letterari non esistono, e le distinzioni che comunemente facciamo (comico, tragico, epico…) sono solamente schemi di comodo introdotti dall’intelletto che, classificando, compie un’operazione estranea all’arte, in quanto tale operazione appartiene alla logica; in questo modo viene anche a mancare la “bellezza fisica” (il “bello” appartiene all’estetica).
La personalità di un poeta scompare naufragando nel mare della poesia: “il poeta è nient’altro che la sua poesia”, la sua opera poetica (è sempre lo Spirito che agisce attraverso l’uomo); la linguistica è estetica, perché il linguaggio è espressione (come l’arte), creazione estetica.
Guardando l’attività di Croce, vediamo con assoluta chiarezza che è stato attento all’aspetto soggettivo-creativo della produzione artistica, ma non si è comportato allo stesso modo con le sue componenti, i suoi momenti tecnico-materiali, ed ha fatto la stessa cosa per determinate attività artistiche: la sua filosofia ha guardato all’arte in generale, ma non ha esaminato attentamente, per esempio, la musica, l’architettura… privilegiando l’attività letteraria.
 All’interno dell’attività letteraria ha continuato questa sua “politica”, valorizzando più di altri certi generi e stili, come la poesia (secondo Croce le espressioni non poetiche devono essere intese come “modi” di servirsi dell’unico vero linguaggio, che è quello poetico) e le produzioni con contenuto lirico, fantastico (al posto di quelle più razionali, concettuali); il simbolo della poesia per il nostro filosofo fu l’Ariosto, definito come poeta dell’“armonia” in “Ariosto, Shakespeare e Corneille”.
All’interno dell’attività letteraria ha continuato questa sua “politica”, valorizzando più di altri certi generi e stili, come la poesia (secondo Croce le espressioni non poetiche devono essere intese come “modi” di servirsi dell’unico vero linguaggio, che è quello poetico) e le produzioni con contenuto lirico, fantastico (al posto di quelle più razionali, concettuali); il simbolo della poesia per il nostro filosofo fu l’Ariosto, definito come poeta dell’“armonia” in “Ariosto, Shakespeare e Corneille”.
Infine sull’arte si deve ricordare che per Croce non sono possibili le traduzioni, “in quanto abbiano la pretesa di effettuare il travasamento di un’espressione in un’altra, come di un liquido da un vaso in un altro di diversa forma. Noi possiamo elaborare logicamente ciò che prima abbiamo elaborato solo in forma estetica; ma non possiamo, ciò che ha avuto già la sua forma estetica, ridurre ad altra forma, anche estetica.” (da “Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, 1904, II edizione).
Logica: si propone di studiare la struttura generale dello Spirito, ed in parte, quindi, ne abbiamo già parlato con la dialettica; essa viene definita anche “scienza del concetto puro”, che è l’universale concreto (come già detto, esso è razionale, universale e concreto), chiamato anche “trascendentale”, e guardandolo nella forma, esso naturalmente è unico (“non sussistono più forme nel concetto, ma una sola”), la forma teoretica universale dello spirito è una sola (la logica, appunto), e quando penso una varietà di concetti, è chiaro che si riferiscono ad altrettanti oggetti che vengono pensati in quella forma.
C’è un’idea comune tra estetica e logica, infatti il concetto ha carattere di espressività, è quindi opera conoscitiva, opera espressa dello Spirito, ed essendo quindi il pensare anche esprimere, parlare, “chi non esprime o non sa esprimere un concetto, non lo possiede” (la stessa cosa accade, abbiamo già visto, per l’intuizione estetica).
Il concetto puro è diverso da una rappresentazione empirica (ad es.: “biancospino”, “gatto”, “matita”), ed anche dai concetti usati dalle scienze, che sono concetti astratti (ad es.: “cerchio”), e vengono definiti dal Croce come “pseudo-concetti”, poiché non hanno un elemento corrispondente nella realtà: gli pseudo-concetti si distinguono così in empirici e puri, entrambi sono privi di carattere logico, ma sono di grande utilità (organizzano le nostre esperienze ed aiutano la nostra memoria), perciò sono propri dell’Economia, ed a quest’attività pratica dello Spirito vengono ad appartenere tutte le scienze empiriche e matematiche.
e vengono definiti dal Croce come “pseudo-concetti”, poiché non hanno un elemento corrispondente nella realtà: gli pseudo-concetti si distinguono così in empirici e puri, entrambi sono privi di carattere logico, ma sono di grande utilità (organizzano le nostre esperienze ed aiutano la nostra memoria), perciò sono propri dell’Economia, ed a quest’attività pratica dello Spirito vengono ad appartenere tutte le scienze empiriche e matematiche.
Nella logica crociana concetto, giudizio e sillogismo vengono a coincidere, vediamo il perché: il giudizio è concetto puro, ed il “concetto stesso nella sua effettualità” è l’universale concreto; quando pensiamo un concetto, lo pensiamo nelle sue distinzioni, lo mettiamo in relazione cogli altri concetti e lo unifichiamo con essi “nell’unico concetto” (cioè in un’unica forma concettuale), e perciò si ha un sillogismo.
Nell’ambito della logica c’è un’altra identificazione, quella tra giudizio definitorio (es.: “l’arte è intuizione lirica”) e giudizio individuale (es.: “l’Orlando furioso è un’opera d’arte”), poiché il giudizio individuale ci fa conoscere concretamente il mondo (e di conseguenza possedere), un giudizio, attribuendo un predicato ad un oggetto, lo valorizza come elemento partecipe della realtà.
 È possibile dire che il giudizio definitorio è il predicato del giudizio individuale (se dico che l’Orlando furioso è un’opera d’arte, affermo che l’Orlando furioso è quello che si è definito per opera d’arte dando un giudizio definitorio, ed intanto dico anche che è intuizione lirica).
È possibile dire che il giudizio definitorio è il predicato del giudizio individuale (se dico che l’Orlando furioso è un’opera d’arte, affermo che l’Orlando furioso è quello che si è definito per opera d’arte dando un giudizio definitorio, ed intanto dico anche che è intuizione lirica).
Per questi motivi il giudicare è un atto logico che è sintesi a priori logica.
Da ciò consegue che filosofia e storia coincidono (“non sono già due forme, sibbene una forma sola, e non si condizionano a vicenda, ma addirittura si identificano”), perché la sintesi a priori è concretezza sia della filosofia che della storia, ed “il pensiero, creando se stesso, qualifica l’intuizione e crea la storia”).
Ultimo aspetto della logica, la sua estraneità all’errore: per Croce l’errore infatti ha una natura pratica, non può appartenere alla conoscenza (che è assoluta, proprio perché è conoscenza), non corrisponde al conoscere, ma all’agire, appartiene non al pensiero ma alle azioni umane, che possono essere sbagliate; una persona quindi sbaglia quando, parlando, emette dei suoni “ai quali non corrisponde un pensiero, o, che è lo stesso, non corrisponde un pensiero che abbia valore, precisione, coerenza, verità”.
Economia: l’attività pratica dello Spirito, abbiamo già visto, non produce conoscenze ma azioni, e l’azione coincide con la volontà (già Kant…), poiché non c’è volizione senza azione, né azione senza volizione; quando noi desideriamo, vogliamo, aspiriamo, abbiamo un fine, e se questo fine è individuale, si ha un’attività economica.
L’attività economica “vuole ed attua ciò che è corrispettivo soltanto alle condizioni di fatto i n cui l’individuo si trova”, ed in questa sfera rientrano gli pseudo-concetti e le scienze empiriche e matematiche, come detto precedentemente, ma anche il diritto, l’attività politica, la vita stessa dello Stato, che, come già Machiavelli aveva affermato, non ha una natura etica, ma utilitaria (e quindi, appunto, economica).
n cui l’individuo si trova”, ed in questa sfera rientrano gli pseudo-concetti e le scienze empiriche e matematiche, come detto precedentemente, ma anche il diritto, l’attività politica, la vita stessa dello Stato, che, come già Machiavelli aveva affermato, non ha una natura etica, ma utilitaria (e quindi, appunto, economica).
Vediamo meglio questi tre elementi: per quanto riguarda il diritto, apparentemente sembra contraddirsi il nostro pensatore, quando mette lo stesso nella sfera dell’economia e non in quella che ci pare più ovvia, quella dell’etica: ciò si spiega col fatto che per il nostro i valori del diritto non sono gli stessi valori della morale, avendo logica e fini diversi: quest’ipotesi viene avvalorata dal fatto che anche una società per delinquere ha una propria giuridicità (basti pensare ai patti tra criminali, od anche solo alle famiglie mafiose, che difficilmente hanno obiettivi etici).
La politica, invece, penso che appaia ad ognuno di noi del tutto naturale se messa nella sfera dell’economia: essa viene vista dal Croce come incontro/scontro tra interessi opposti, e questo scontro non sempre avviene secondo leggi etiche, ma piuttosto secondo leggi di forza, ma ciò non è visto negativamente, essendo simbolo di forza, vigore degli individui.
 Lo Stato si basa anch’esso non su un’Idea (astratta), ma sulla realtà (concreta), fatta di individui che con le proprie azioni stabiliscono, “producono”, leggi, istituzioni, strutture, usi, che riflettono le loro volontà.
Lo Stato si basa anch’esso non su un’Idea (astratta), ma sulla realtà (concreta), fatta di individui che con le proprie azioni stabiliscono, “producono”, leggi, istituzioni, strutture, usi, che riflettono le loro volontà.
Lo Stato è quindi il prodotto delle azioni di un insieme di persone, ed è dato dalle mediazioni forza/consenso e autorità/libertà, e di questi 4 elementi il filosofo valorizza quello dell’autorità, perché essa garantisce l’ordinato svolgersi della vita pubblica, e perciò critica l’ideologia democratica, i cui valori (libertà, uguaglianza, fratellanza) non sono certo negativi, ma forse un po’ troppo astratti.
È nell’economia che si riflette la vita dell’uomo, la sua natura, il “pratico processo dei desideri, degli appetiti, delle cupidità, delle soddisfazioni e insoddisfazioni risorgenti, delle congiunte commozioni, dei piaceri e dei dolori”, ma non è un ambito irrazionale, essendoci un principio che vi opera: esso è l’utile (ed ha come opposto il dannoso).
L’utile è visto come un valore positivo, anche se spesso si scontra con gli altri valori, ma è in virtù dell’utile che l’uomo organizza la propria vita e le proprie relazioni, così come fanno i gruppi di uomini (probabilmente gli studi sul marxismo l’hanno aiutato in questa elaborazione): mi sembra indiscutibile a questo punto che nella filosofia crociana ci sia una buona sintesi tra idealismo e realismo.
All’economia come la intendiamo oggi, scienza che si andava sviluppando proprio nell’epoca in cui visse il nostro filosofo, egli non guardò con molta simpatia, accusandola di produrre una conoscenza troppo astratta ed astorica.
Etica

E’ l’attività pratica dello Spirito che si verifica quando il fine che noi desideriamo è universale (quando è individuale è l’economia, come detto prima); questo universale è lo Spirito stesso, Realtà “come unità di pensiero e volere”; l’attività etica vuole ed attua ciò che corrisponde alle condizioni di fatto in cui una persona si trova, ma si riferisce a qualcosa che le trascende.
L’uomo morale quando vuole l’universale (ciò che lo trascende come individuo) guarda “allo Spirito, alla Realtà reale, alla Vita vera, alla Libertà”, in questo modo chi agisce trascende i propri interessi, che sono “particolari” (l’utile), per cogliere valori universali (il bene)
L’etica ha un carattere di totalità, perché l’agire secondo morale raccoglie e “sublima” dentro di sé le diverse istanze date dai diversi fattori che compongono la realtà individuale e sociale; l’ideale supremo di quest’etica è la Vita, che dà valore e sviluppa l’agire umano, infatti tutte le azioni degli uomini che siano conformi al dovere etico sono conformi alla vita, e se la deprimessero e mortificassero, sarebbero immorali.
Evidentissima la critica contro lo Stato che Giovanni Gentile definì sotto la voce “Fascismo” nell’enciclopedia Italiana Treccani, poiché esso viene visto come entità che ingloba in sé gli individui, che è artefice della legge (e fin qui Croce sarebbe d’accordo), e che è artefice anche della morale, ed in seguito il Gentile parlò anche di “Stato etico” (eredità di Hegel, filosofo dal quale anche Croce era partito, ma con conclusioni diverse, come abbiamo visto).
Storia: non è una delle 4 forme dello spirito, ma un altro “capitolo” della filosofia crociana.
Abbiamo già visto come filosofia e storia coincidono, poiché (ripetiamolo) il pensiero autentico è pensiero dell’universale concreto, ed il giudizio definitorio coincide col giudizio individuale; da quest’uguaglianza deriva che qualsiasi realtà alla quale il giudizio storico si riferisce, nascendo quest’ultimo da un bisogno pratico (quello di risolvere i problemi della situazione presente), diventa attuale.
 Vediamo facilmente anche come la storia sia vera conoscenza del reale, una sintesi a priori tra intuizione e categoria; secondo il filosofo tutto è storia: tale teoria viene definita come “Storicismo assoluto”.
Vediamo facilmente anche come la storia sia vera conoscenza del reale, una sintesi a priori tra intuizione e categoria; secondo il filosofo tutto è storia: tale teoria viene definita come “Storicismo assoluto”.
Nulla sta al di sopra della storia, per cui non ci sono idee o valori eterni, e la storia non è mai “giustiziera”, ma sempre “giustificatrice”: uno storico deve solo conoscere e comprendere certi avvenimenti, senza giudicarli; questo potrebbe essere visto come una contraddizione del nostro pensatore, poiché condannò il fascismo (che è un evento storico).
Per Benedetto ciò che è reale è necessariamente razionale, ma afferma essere razionale anche l’imperativo morale: non giustificò mai il fascismo, ma lo lesse come “malattia morale”, una parentesi nella storia dell’Italia (espresse questa teoria sul New York Times nel novembre del 1943, la riprese in un discorso tenuto nel gennaio del 1944 a Bari, al I Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, ed in un’intervista del marzo 1947).
La storia, non potendo giudicare, non può né lodare né biasimare un evento: la lode od il biasimo riguardano un singolo nel momento in cui agisce, ma quando la sua azione è diventata evento, non può più essere giudicata.
La storia, inoltre, non si deve discutere coi “se” (es.: “se Garibaldi non avesse organizzato la Spedizione dei Mille…”), perché essendo lo Spirito immanente alla storia, il “se” negherebbe il nesso logico e razionale dell’universale concreto; il “se” non deve riguardare nemmeno l’individuo singolo (“se non avessi fatto l’errore di…”), perché l’individuo è ciò che è, è se stesso, proprio perché ha compiuto ciò che ha compiuto.
La storia ha un effetto catartico: conoscendola, noi che siamo prodotti del passato (già i Decadentisti sottolineavano come l’uomo fosse risultato del passato e seme che germoglierà nel suo futuro), ci liberiamo da esso (già Goethe affermava che scrivere storia è un modo per toglierci dalle spalle il passato ed affrancarci da esso).
La storia inoltre ha un carattere di positività, perché analizzando un evento storico si deve sempre captarne l’intimo senso e razionalità, per quanto negativo l’evento possa apparire.
Nella storia, inoltre, c’è un nesso di pensiero ed azione, infatti la conoscenza storica stimola l’azione, ma è essa stessa stimolata dall’azione.
La nostra epoca presta minor attenzione alla dialettica crociana, e si concentra di più sullo studio degli altri aspetti della filosofia del Croce, una filosofia, direi, molto semplice da comprendere, leggendo gli stessi libri del nostro filosofo, scritti con un stile vivo e chiaro (si dice che pensasse in napoletano e poi traducesse le sue intuizioni sulla carta).
Ci sono però degli effetti negativi nell’attività di Benedetto: la sua critica letteraria tenne l’Italia al di fuori delle novità che maturavano altrove, la sua svalutazione delle scienze della natura approfondì il solco tra cultura umanistica e cultura scientifica, e l’avversione alle scienze umane e sociali (perché cercavamo di “invadere” con metodi empirici il campo filosofico delle scienze dello spirito) ha ritardato lo sviluppo in Italia della linguistica moderna, della psicologia e della sociologia.
APPROFONDIMENTI
Manifesto degli intellettuali anti-fascisti
Gl’intellettuali fascisti, riuniti in congresso a Bologna, hanno indirizzato un manifesto agl’intellettuali di tutte le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista.
 Nell’accingersi a tanta impresa quei volenterosi signori non debbono essersi rammentati di un consimile e famoso manifesto, che, agli inizi della guerra europea, fu bandito al mondo dagli intellettuali tedeschi: un manifesto che raccolse, allora, la riprovazione universale, e più tardi dai tedeschi stessi fu considerato un errore.
Nell’accingersi a tanta impresa quei volenterosi signori non debbono essersi rammentati di un consimile e famoso manifesto, che, agli inizi della guerra europea, fu bandito al mondo dagli intellettuali tedeschi: un manifesto che raccolse, allora, la riprovazione universale, e più tardi dai tedeschi stessi fu considerato un errore.
E, veramente, gl’intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell’arte, se, come cittadini, esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con l’ascriversi a un partito e fedelmente servirlo, come intellettuali hanno il solo dovere di attendere, con l’opera dell’indagine e della critica e con le creazioni dell’arte, a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale, affinché, con effetti sempre più benefici, combattano le lotte necessarie. Varcare questi limiti dell’ufficio a loro assegnato, contaminare politica e letteratura, politica e scienza, è un errore, che, quando poi si faccia, come in questo caso, per patrocinare deplorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi neppure un errore generoso.
E non è nemmeno, quello degli intellettuali fascisti, un atto che risplenda di molto delicato sentire verso la Patria, i cui travagli non è lecito sottoporre al giudizio degli stranieri, incuranti (come, del resto, è naturale) di guardarli fuori dei diversi e particolari interessi politici delle proprie nazioni.
Nella sostanza, quella scrittura è un imparaticcio scolaresco, nel quale ad ogni punto si notano confusioni dottrinali e mal filati raziocini: come dove si prende in iscambio l’atomismo di certe costruzioni della scienza politica del secolo decimottavo col liberalismo del secolo decimonono, cioè l’antistorico e astratto e matematico democratismo con la concezione sommamente storica della libera gara e dell’avvicendarsi dei partiti al potere, onde, mercé l’opposizione, si attua, quasi graduandolo, il progresso; o come dove, con facile riscaldamento retorico, si celebra la doverosa sottomissione degli individui al Tutto, quasi che sia in questione ciò, e non invece la capacità delle forme autoritarie a garantire il più efficace elevamento morale: o, ancora, dove si perfidia nel pericoloso indiscernimento tra istituti economici, quali sono i sindacati, ed istituti etici, quali sono le assemblee legislative, e si vagheggia l’unione o piuttosto la contaminazione dei due ordini, che riuscirebbe alla reciproca corruttela, o, quanto meno, al reciproco impedirsi. E lasciamo da parte le ormai note e arbitrarie interpretazioni e manipolazioni storiche.
 Ma il maltrattamento della dottrina e della storia è cosa di poco conto, in quella scrittura, a paragone dell’abuso che vi si fa della parola ” religione “; perché, a senso dei signori intellettuali fascisti, noi ora in Italia saremmo allietati da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e di un nuovo apostolato contro una vecchia superstizione, che rilutta alla morte, la quale le sta sopra e alla quale dovrà pur acconciarsi; e ne recano a prova l’odio e il rancore che ardono, ora come non mai, tra italiani e italiani. Chiamare contrasto di religione l’odio e il rancore che si accendono da un partito che nega ai componenti degli altri partiti il carattere d’italiani e li ingiuria stranieri, e in quest’atto stesso si pone esso agli occhi di quelli come straniero e oppressore, e introduce così nella vita della Patria i sentimenti e gli abiti che sono propri di altri conflitti; nobilitare col nome di religione il sospetto e l’animosità sparsi dappertutto, che hanno tolto perfino ai giovani delle università l’antica e fidente fratellanza dei comuni e giovanili ideali, e li tengono gli uni contro gli altri in sembianti ostili: è cosa che suona’ a dir vero, come un’assai lugubre facezia.
Ma il maltrattamento della dottrina e della storia è cosa di poco conto, in quella scrittura, a paragone dell’abuso che vi si fa della parola ” religione “; perché, a senso dei signori intellettuali fascisti, noi ora in Italia saremmo allietati da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e di un nuovo apostolato contro una vecchia superstizione, che rilutta alla morte, la quale le sta sopra e alla quale dovrà pur acconciarsi; e ne recano a prova l’odio e il rancore che ardono, ora come non mai, tra italiani e italiani. Chiamare contrasto di religione l’odio e il rancore che si accendono da un partito che nega ai componenti degli altri partiti il carattere d’italiani e li ingiuria stranieri, e in quest’atto stesso si pone esso agli occhi di quelli come straniero e oppressore, e introduce così nella vita della Patria i sentimenti e gli abiti che sono propri di altri conflitti; nobilitare col nome di religione il sospetto e l’animosità sparsi dappertutto, che hanno tolto perfino ai giovani delle università l’antica e fidente fratellanza dei comuni e giovanili ideali, e li tengono gli uni contro gli altri in sembianti ostili: è cosa che suona’ a dir vero, come un’assai lugubre facezia.
In che mai consisterebbe il nuovo evangelo, la nuova religione, la nuova fede, non si riesce ad intendere dalle parole del verboso Manifesto; e, d’altra parte, il fatto pratico, nella sua muta eloquenza, mostra allo spregiudicato osservatore un incoerente e bizzarro miscuglio di appelli all’autorità e di demagogismo, di professata riverenza alle leggi, di concetti ultramoderni e di vecchiumi muffiti, di atteggiamenti assolutistici e di tendenze bolsceviche, di miscredenza e di corteggiamento alla Chiesa cattolica, di aborrimento dalla cultura e di conati sterili verso una cultura priva delle sue premesse, di sdilinquimenti mistici e di cinismo. E, se anche taluni plausibili provvedimenti sono stati attuati o avviati dal governo presente, non è in essi nulla che possa vantare un’originale impronta, tale da dare indizio di un nuovo sistema politico, che si denomini dal fascismo.
 Per questa caotica e inafferrabile ” religione ” noi non ci sentiamo, dunque, di abbandonare la nostra vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l’anima dell’Italia che risorgeva, dell’Italia moderna: quella fede che si compose di amore alla verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento. Noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del Risorgimento, di coloro che per l’Italia operarono, patirono e morirono, e ci sembra di vederli offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri italiani avversari, e gravi e ammonitori a noi perché teniamo salda in pugno la loro bandiera. La nostra fede non è un’escogitazione artificiosa e astratta o un invasamento di cervello, cagionato da mal certe o mal comprese teorie; ma è il possesso di una tradizione, diventata disposizione del sentimento, conformazione mentale e morale.
Per questa caotica e inafferrabile ” religione ” noi non ci sentiamo, dunque, di abbandonare la nostra vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l’anima dell’Italia che risorgeva, dell’Italia moderna: quella fede che si compose di amore alla verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento. Noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del Risorgimento, di coloro che per l’Italia operarono, patirono e morirono, e ci sembra di vederli offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri italiani avversari, e gravi e ammonitori a noi perché teniamo salda in pugno la loro bandiera. La nostra fede non è un’escogitazione artificiosa e astratta o un invasamento di cervello, cagionato da mal certe o mal comprese teorie; ma è il possesso di una tradizione, diventata disposizione del sentimento, conformazione mentale e morale.
Ripetono gl’intellettuali fascisti, nel loro manifesto, la trita frase che il Risorgimento d’Italia fu l’opera di una minoranza; ma non avvertono che in ciò appunto fu la debolezza della nostra costituzione politica e sociale; e anzi par quasi che si compiacciano della odierna per lo meno apparente indifferenza di gran parte dei cittadini d’Italia di fronte ai contrasti tra il fascismo e i suoi oppositori. I liberali di tal cosa non si compiacquero mai, e si studiarono a tutto potere di venire chiamando sempre maggior numero d’italiani alla vita pubblica; e in questo fu la precipua origine anche di qualcuno dei più disputati loro atti, come la largizione del suffragio universale. Perfino il favore, col quale venne accolto da molti liberali nei primi tempi, il movimento fascistico, ebbe tra i suoi sottintesi la speranza che, mercé di esso, nuove e fresche forze sarebbero entrate nella vita politica, forze di rinnovamento e (perché no?) anche forze conservatrici. Ma non fu mai nei loro pensieri di mantenere nell’inerzia e nell’indifferenza il grosso della nazione, appagandone taluni bisogni materiali, perché sapevano che, a questo modo, avrebbero tradito le ragioni del Risorgimento italiano e ripigliato le male arti dei governi assolutistici e quietistici.
Anche oggi, né quell’asserita indifferenza e inerzia, né gli impedimenti che si frappongono alla libertà, c’inducono a disperare o a rassegnarci. Quel che importa, è che si sappia ciò che si vuole e che si voglia cosa d’intrinseca bontà. La presente lotta politica in Italia varrà, per ragione di contrasto, a ravvivare e a fare intendere in modo più profondo e più concreto al nostro popolo il pregio degli ordinamenti e dei metodi liberali, e a farli amare con più consapevole affetto. E forse un giorno, guardando serenamente al passato, si giudicherà che la prova che ora sosteniamo, aspra e dolorosa a noi, era uno stadio che l’Italia doveva percorrere per rinvigorire la sua vita nazionale, per compiere la sua educazione politica, per sentire in modo più severo i suoi doveri di popolo civile.”
Cesare Angelini, “Gli uomini della Voce”: lieve contrasto con Benedetto Croce
Ciascuno di noi, qualunque sia il suo orientamento spirituale e l’educazione e l’abito e gli umori, ma che della coltura faccia una condizione di civiltà e di vita e, direi, un aumento di onestà, deve qualcosa a lui: chi più, chi meno, a seconda della sua capacità a prendere da un uomo che ha dato tanto. Molto Croce vive in noi, anche in chi non lo confessa. Se D’Annunzio fu un modo tutto esteriore di vivere, Croce è, più severamente, un modo di pensare, che è un vivere interno e intenso.
E ognuno di noi ha il suo «episodio» con Croce, che vorrà narrare in forma di ricordo o d’augurio, di riparazione o di ringraziamento. Il mio, mi è tanto più caro in quanto c’è di mezzo Renato Serra. Eran gli anni ch’ero capitato a vivere nella pura e cara città di Romagna – ditemi: che ne è di Cesena ? – e Serra, che aveva scoperto qualche piccolo pregio in un mio quadernetto andatogli in mano – ma lo riguardava troppo da vicino, parlava addirittura di lui – mi consigliò di mandarlo a Napoli, al Croce. Aggiunse: “vedrà che lo leggerà e le risponderà”. Croce difatti rispose: alleggerissi le pagine di qualche indugio lezioso e fastidioso, e le mandassi alla Voce di Prezzolini come a luogo naturale: forse l’avrebbe pubblicate. Per una disciplina cui mi piacque esser docile, le tenni invece nel cassetto. Ma il buon consenso di Croce mi rallegrò, e glie ne fui grato come d’un credito che mi faceva e d’uno stimolo al lavoro.
Come fu, dunque, che poco dopo e proprio sulla Voce passata da Prezzolini a De Robertis gli dissi contro male parole con una sufficienza gratuita che non mi pare mi sia mai appartenuta e ancora oggi mi umilia? In quel tempo Croce “aveva detto male” del Pascoli. Ed io, che le Myricae le leggevo in ginocchio quasi per divozione, e a San Mauro di Savignano ci andavo da Cesena ogni settimana come in pellegrinaggio, anch’io mi ritenni offeso. Quasi un fatto personale. Toccava un mio amore; mio e di tanti, in quegli anni sensibili in cui era ancor lecito ammalarsi per la poesia. Più tardi (ma molto più tardi) capii quanto sciocca era la mia irritazione. Anche nel caso del Pascoli, Croce non mutilava ma purificava, non negava ma ripuliva, e le sue osservazioni sul poeta romagnolo – fra tant’altre fluide e sempre perplesse – rimangono ancora oggi severe ma ferme e orientative. A ogni modo Croce era un uomo troppo superiore per volermene male; e mentre so che quel “quadernetto serriano”, con verdissima memoria e sorriso benevolo, ancora negli ultimi suoi anni ne accennava ad amici, dalla sua bocca seppi che quell’altre mala parole egli intese e giustificò come un giovanile amore di poesia; quell’amore per il quale ben più gagliardamente egli spese i suoi grandi e fecondissimi anni. E non conosco più cristiano umanismo di questa comprensione.
Si ricorda quando per la prima volta, nel 1912, lei mi scrisse dal seminario di Cesena? Il suo nome è restato da allora congiunto nel mio animo con quello del povero Serra.
L’ultima volta che lo vidi fu nel ’30 (o ’31), e proprio in questo Borromeo, dov’egli era venuto per incontrarsi (che da anni vi era ospite) col poeta russo Venceslao Ivanov. Ricordo quel loro colloquio su cose di religione e di lettere come un’impegnatissima lotta di due giganti cortesi. L’amico di Merezkovkii, convertito da poco al cattolicismo, spiegava il suo lucente fervore di neofita; il nipote di Spaventa difendeva le sue posizioni idealistiche col sentimento con cui si difende un’eredità. Un vento di foresta soffiava sulle loro parole.
Ma per sapere che avvenimento fu il Croce per la coltura italiana (la Critica è del ‘903 e l’Estetica del ‘902), bisogna essere stati giovani ancora verso il 1910 quando ampiamente si respiravano i benefici del suo rinnovamento prima delle arbitrarie applicazioni e esasperazioni.
Naturalmente non parlo della sua filosofia: e chi la conosce tutta?
Sappiamo poi che c’è su la condanna della Chiesa, e non ne diciamo di più.
Certo molte riserve deve fare un cattolico sulla sua dottrina: e a troppe astiose «postille» egli ha ceduto e non tutte serene. Ma, al di là delle riserve, resta il valore morale del suo insegnamento, che è grande; restano i suoi meriti che non sono facilmente elencabili, specialmente nel campo della critica letteraria, che è il più suo. Rinnovamento di coltura per il Croce voleva dire rinnovamento di spirito, e la serietà del metodo e la sincerità della ricerca in una religiosa tenacia di volontà. Croce insegnava che bisogna leggerli i libri, prima di parlarne o di citarli; che bisogna studiarla la storia d’un soggetto prima di trattarne.
E combatté la superficialità, il dilettantismo, l’equivoco decadentismo e i fabbricatori del vuoto, per giungere a schiettezza di coltura e sanità di gusto.
L’influenza esercitata dalla sua Estetica fu immensa. Non partita dall’università, entrò nelle università e nelle scuole e in tutti gli Italiani. Con l’estetica o scienza della espressione, Croce ha aiutato a chiarire, a ripulire il concetto di poesia. Se l’arte è intuizione, è chiaro il carattere fondamentalmente lirico d’ogni opera d’arte. E, partendo dall’abolizione dei generi letterari, è arrivato alla distinzione fra struttura e poesia o poesia e il diverso dalla poesia, o, più semplicemente, poesia e non poesia, che è la semplificazione di molte situazioni e problemi. Viva è anche l’altra distinzione fra poesia e poesia della poesia, che è tutt’altro che un gioco. Croce ebbe naturalmente una scuola, che si disse dei «critici nuovi»; i quali, dando alle loro pagine presupposti filosofici, parvero opporsi a critici di stampo vecchio o di puro metodo storico-filologico, e che non diremo carducciani per rispetto al Carducci, benché dessero occasione alla «polemica carducciana» del 1912. Fedele alla sua estetica, Croce ha sollevato secoli che parevano decaduti; ha fatto giustizia a scrittori dimenticati, ha risuscitato libri trascurati; ha riveduto tutti i nostri poeti dell’Ottocento, i maggiori e i minori (e i forastieri), in medaglioni pressoché definitivi e con giudizi ai quali si dovrà per sempre tornare ogni volta che si vorrà discorrere di alcuno di essi. Ha sollecitato l’interesse per il Vico; ha fatto conoscere agli Italiani De Sanctis, difendendolo dagli attacchi carducciani.
Punti deboli nella sua critica? Certo, ce ne sono; dovuti più che altro alla rigorosa coerenza del suo sistema. Ma oltre alla potentissima coltura, alla ricchezza del pensiero, alla sicurezza del gusto, alla pienezza dell’informazione, alla sincerità del lavoro, che fanno di lui un maestro, in Croce è particolarmente da notare la chiarezza, la nitidezza dell’espressione. E un giorno, volendoci occupare dello stile di Croce, dovremo pur concludere che, sopra le mode e i rumori e gli ingrati bastardumi che ci infestarono e c’infestano, Croce è stato in questi decenni il nostro scrittore più potente, certo più italiano. Che non è l’ultimo suo insegnamento. Dice che dovere dello scrittore è quello d’essere italiano anche quando scrive.
E in questo è il nostro nuovo classicismo.
(questo brano è il capitolo IX del libro UOMINI DELLA «VOCE», di Cesare Angelini, a cura di Vanni Scheiwiller; Milano 1986.
Il volume è stato impresso dalla stamperia Valdonega di Verona in millecinquecento copie numerate il 27 settembre 1986)
Cesare Angelini, “Questa mia Bassa (e altre terre)”: ricordo di Croce
[…] Leggo in una cartolina di Benedetto Croce, scritta nel settembre del ‘37: “Le rinnovo i ringraziamenti per il ricordo della mia figliola pregante in Cieldoro di Pavia”. In uno dei suoi ritorni a Milano per trovare gli amici, sopra tutti Alessandro Casati, quell’anno il Croce era venuto anche a Pavia a cercare nella biblioteca del Museo civico un libro del Seicento, di rarissima edizione. Gliel’aveva segnalato il Casati, bibliofilo di fiuto sicuro.
Aveva dietro la figlia Elena, e lo accompagnavano lo stesso Casati, Gallarati Scotti, Francesco Flora, Stefano Iacini, Balsamo Crivelli, e un Treves, non so più se Pietro o Paolo: lo stato maggiore della cultura milanese di quegli anni. Nel gruppo c’era anche il volatore-scrittore Beonio Brocchieri, appena tornato dal mondo.
Dopo un caffè al Demetrio (che rischiò d’essere disturbato per zelo politico troppo grossolano) si andò insieme in Cieldoro [Chiesa di S. Pietro in Cieldoro di Pavia, ndr]. Il desiderio era stato dello stesso Croce che, piuttosto loquace per strada, entrando nel tempio s’era fatto silenzioso e quasi allontanato in se stesso, come se i suoi pensieri avessero cambiato registro. Il filosofo si trovava tra i suoi, coi suoi, Agostino e Boezio [nella chiesa pavese ne sono custodite le reliquie, ndr], uomini che avevano udito parlare la Filosofia; e uno ne trascrisse le “consolazioni”, l’altro ne ebbe il colmo della “rivelazione”, la Grazia. Nell’epitaffio metrico inciso sulla tomba di Boezio, giù nella cripta, il Croce notò, puntandovi il dito, l’accenno alla traduzione che il grande romano fece della logica di Aristotele: “Nobis Logicen de graeco transtulit artem”. Altra commozione non lasciò trasparire.
Intanto la figliola che in una cappella di destra aveva visto ardere una gran macchia di lumi, mi domandò quale santo vi si onorasse. E, avendole risposto che si onorava Santa Rita, ritenuta in Pavia “la santa degli impossibili”, disse: “Allora vado a pregarla per mio padre”. E la vedemmo inchinata a quell’altare. Non so se ce ne fosse bisogno; ma certo Dio concede tante cose per le preghiere d’una figliola.
Benedetto Croce, “Saggio sullo Hegel”: il pensamento filosofico
Il pensamento filosofico è, per Hegel: 1°, concetto; 2°, universale; 3°, concreto. È concetto, vale a dire non è sentimento o rapimento o intuizione o altro simile stato psichico alogico e privo di forze dimostrativa. Il che stabilisce la differenza della filosofia rispetto alle teorie del misticismo e del sapere immediato; le quali hanno, tutt’al più, un significato negativo, in quanto riconoscono che la filosofia non può costruirsi col metodo delle scienze empiriche e naturali, delle scienze del finito; e sono, se così si vuole, profonde, ma di una « profondità vuota ». Contro il misticismo, le smanie, i sospiri, il levare gli occhi al cielo e piegare i colli e serrar le mani, gli sdilinquimenti, gli accenni profetici, le frasi misteriose da iniziati, Hegel diventa ferocemente satirico; e mantiene sempre che la filosofia deve avere forma intelligibile e ragionata; dev’essere « non esoterica, ma essoterica », non cosa di setta, ma di umanità.
– Il concetto filosofico è universale, e non già meramente generale: non è da confondere con le rappresentazioni generali, come, ad esempio, la « casa », il « cavallo », l’ «azzurro », le quali, per un uso, come Hegel dice, barbarico, si denominano ordinariamente concetti. Il che stabilisce la differenza tra la filosofia e le scienze empiriche o naturali, che si soddisfano di tipi e concetti di classe.
– L’universale filosofico, infine, è concreto: non ischeletrimento della realtà, ma comprensione di questa nella sua pienezza e ricchezza: le astrazioni filosofiche non sono arbitrarie ma necessarie, e perciò si adeguano al reale, e non lo mutilano o falsificano. E ciò stabilisce la differenza della filosofia rispetto alle discipline matematiche; le quali non giustificano i loro punti di partenza, ma « li comandano », e bisogna (dice Hegel) ubbidire al comando di tirare proprio queste e queste linee, con la buona fiducia che la cosa sarà « opportuna » per l’andamento della dimostrazione. La filosofia invece ha per oggetto ciò che realmente è; e deve giustificare pienamente sé stessa, non ammettendo né lasciando sussistere alcun presupposto.
Nota: il testo citato risale al 1913, ma il “Saggio sullo Hegel” originale è del 1912
Alberto Einstein – Lettera a B. Croce (e risposta del Croce)
Princetown, 7 giugno 1944.
Apprendo che una persona di qui, che ebbe la fortuna di visitarla, ricusò di lasciarle la lettera da me indirizzata a lui ma scritta a Lei. Pure, di ciò mi consolo nel pensiero che Ella è ora presa da occupazioni e sentimenti incomparabilmente più importanti, e particolarmente dalla speranza che la sua bella patria sia presto liberata dai malvagi oppressori di fuori e di dentro. In questo tempo di generale sconvolgimento possa a Lei essere concesso di rendere al suo paese un servigio oltremodo prezioso, perchè ella è dei pochi che, stando di sopra dei partiti, hanno la fiducia di tutti.
Se l’antico Platone potesse in qualche guisa vedere quello che ora accade, si sentirebbe come in casa sua, perchè, dopo lungo corso di secoli, vedrebbe ciò che di rado aveva visto, che si viene adempiendo in certo modo il suo sogno di un governo retto da filosofi; ma vedrebbe altresì, e ciò con maggiore orgoglio che soddisfazione, che la sua idea del circolo delle forme di governo è sempre in atto.
La filosofia e la ragione medesima sono ben lungi, per un tempo prevedibile, dal diventare guide degli uomini, ed esse resteranno il più bel rifugio degli spiriti eletti; l’unica vera aristocrazia, che non opprime nessuno e in nessuno muove invidia, e di cui anzi quelli che non vi appartengono non riescono neppure a riconoscere l’esistenza.
In nessuna altra società i vincoli fra viventi e morti sono così vivi, e i nostri simili dei secoli precedenti stanno con noi come amici, i cui detti non perdono mai la loro attrattiva, la loro fecondità e la personale loro magia. E, infine, chi realmente appartiene a quella aristocrazia, potrà bensì dagli altri uomini essere messo a morte, ma non offeso.
Con rispettosi saluti e auguri.
A. EINSTEIN
Sorrentino, 28 luglio 1944
Illustre amico,
La sua lettera mi è stata carissima, perchè ho avuto sempre nel ricordo la lunga conversazione che facemmo in Berlino nel 1931, quando ci accomunammo nello stesso sentimento ansioso sul pericolo in cui versava la libertà in Europa: comunanza di sentimento e di propositi che vidi confermata allorchè mi trovai a collaborare con Lei, – fatta esule dalla sua patria per l’inferocita lotta contro la libertà – nel volume di saggi sulla libertà (Freedom), preparato, or son quattro anni, in New York.
Delle due teorie di Platone, che Ella richiama, non è stata, in verità, ricevuta, anzi è stata respinta, dal pensiero moderno quella della repubblica perfetta, costruita e governata dalla ragione e dai filosofi; ma l’altra è stata serbata, che a lui non era particolare, del circolo delle forme, ossia delle forme necessarie in cui perpetuamente si muove la storia: con questo di più che quel circolo è stato rischiarato dall’idea complementare del perpetuo avanzamento ed elevamento dell’umanità attraverso il percorso necessario, o, secondo l’immagine che piacque al vostro Goethe, del suo <<corso a spirale>>. Questa idea è il fondamento della nostra fede nella ragione, nella vita e nella realtà.
Quanto alla filosofia, essa non è severa filosofia se non conosce, con l’ufficio suo, il suo limite, che è nell’apportare all’elevamento dell’umanità la chiarezza dei concetti, la luce del vero. È un’azione mentale, che apre la via, ma non si arroga di sostituirsi all’azione pratica e morale, che essa può soltanto sollecitare. In questa seconda sfera a noi, modesti filosofi, spetta di imitare un altro filosofo antico, Socrate, che filosofò ma combattè da oplita a Potidea, o Dante, che poetò ma combattè a Campaldino, e, poichè non tutti e non sempre possono compiere questa forma straordinaria di azione, partecipare alla quotidiana, e più aspra e più complessa guerra, che è la politica. Anch’io frequento la compagnia della quale Ella parla con così nobili parole, di coloro che già vissero sulla terra e ci lasciarono le opere loro di pensiero e di poesia, e mi rassereno e ritempro in esse. Di volta in volta m’immergo in questo bagno spirituale, che è quasi la mia pratica religiosa. Ma in quel bagno non è dato restare, e da esso bisogna uscire per abbracciare gli umili e spesso ingrati doveri che ci aspettano sull’uscio.
Perciò mi sento oggi, conforme ai miei convincimenti e ai miei ideali, impegnato nella politica del mio paese; e vorrei, ahimè, possedere per essa a dovizia le forze che le sono più direttamente necessarie, ma tuttavia le do quelle, quali che siano, che mi riesce di raccogliere in me, sia pure con qualche stento. e ringrazio Lei dell’augurio generoso che fa all’Italia, la quale ha sofferto una triste e dolorosa vicenda preparata dal collasso prodotto in essa come in altri paesi dalla guerra precedente onde fu possibile ai dissennati e violenti d’impadronirsi dei poteri dello Stato, non senza il gran plauso e la larga ammirazione del mondo intero, e volgere e sforzare l’Italia in una via che non era la sua, che tutta la sua storia smentiva. Perchè non mai l’Italia, dalla caduta dell’Impero romano, ha delirato di dominio nel mondo ed essa per secoli ha attuato o ha cercato libertà e nella libertà si è unificata, e il suo nazionalismo e fascismo è venuto da concetti forestieri, che solo quei dissennati e violenti potevano adottare a pretesto del loro malfare. Neppure Roma antica ebbe cotesto delirio, perchè l’opera sua fu di proseguire quella luminosamente iniziata dall’Ellade e creare un’Europa, dando leggi civili ai barbari che non ne avevano o le avevano barbariche.
La guerra è la guerra e non ubbidisce ad altro principio che al suo proprio, e anche le più nobili ideologie sono per essa mezzi di guerra, come ogni conoscitore di storia sa e ogni uomo sagace intende. La lotta interna per la civiltà e la libertà si svolgerà poi, a guerra finita, nei paesi vincitori non meno che nei vinti, tutti sconvolti dalla guerra sostenuta, tutti dal più al meno disabituati alla libertà; e durerà anni e sarà assai travagliosa e assai perigliosa. Ma poichè le guerre mirano, come a naturale loro effetto, a un assetto di pace, è da augurare e da raccomandare che gli uomini di Stato, che oggi le dirigono, pensino sin da ora a non preparare nei vari paesi condizioni tali che renderebbero impossibile una solida pace e danneggiando così la causa stessa della libertà, preparerebbero una nuova guerra, la quale non potrà mai essere impedita dalla semplice coercizione, ma richiede la disposizione degli animi alla pace, alla concordia e alla dignità del lavoro. <<Le lingue legano le spade>>, come diceva un vecchio filosofo italiano.
Ma non voglio tediarla con entrare a discorrere di quel che io osservo e giudico nelle cose della politica internazionale, in riferimento particolare all’Italia; chè anzi dovrei altresì chiederle venia di avere tolto occasione dalle sue parole gentili e cordiali per esporle i miei pensieri sulle alte questioni da Lei toccate. Ma <<naturam expelles furca, tamen usque recurret>>; la natura cioè del filosofo che distingue e teorizza. E, ringraziandola della sua buona lettera, Le stringo la mano
Suo
B. CROCE
Nota 1: la frase in latino del Croce si può tradurre con “caccia quanto vuoi la natura con la forca, questa tuttavia tornerà indietro” (Orazio Epistola I, 10, v. 24).
Nota 2: nel ricopiare le lettere ho ricopiato fedelmente anche gli errori grammaticali, che se non apparvero sulle lettere originali, apparvero di certo sul libretto pubblicato dalla Laterza & figli nel 1944: ogni “e” bisognosa di accento è stata scritta con la “è” chiusa anche quando doveva essere una “é” aperta (vedi “perché”, “poiché” ecc.)
Discorso tenuto da Benedetto Croce il 24-7-1947 all’Assemblea Costituente
Io non pensavo che la sorte mi avrebbe, negli ultimi miei anni, riservato un così trafiggente dolore come questo che provo nel vedermi dinanzi il documento che siamo chiamati ad esaminare, e nell’essere stretto dal dovere di prendere la parola intorno ad esso. Ma il dolore affina e rende più penetrante l’intelletto che cerca nella verità la sola conciliazione dell’interno tumulto passionale.
Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l’abbiamo perduta tutti, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l’ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l’opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ciò è pacifico quanto evidente.
Senonché il documento che ci viene presentato non è solo la notificazione di quanto il vincitore, nella sua discrezione o indiscrezione, chiede e prende da noi, ma un giudizio morale e giuridico e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi e innalzarsi o tornare a quella sfera superiore in cui, a quanto sembra, si trovano coi vincitori gli altri popoli, anche quelli del continente nero.
E qui mi duole di dovere rammentare cosa troppo ovvia, cioè che la guerra è una legge eterna del mondo, che si attua di qua e di là da ogni ordinamento giuridico, e che in essa la ragion giuridica si tira indietro lasciando libero il campo ai combattenti, dall’una e dall’altra parte biasimati o considerati traditori se si astengono da cosa alcuna che sia comandata come necessaria o conducente alla vittoria.
Chi sottopone questa materia a criteri giuridici, o non sa quel che si dica o lo sa troppo bene e cela l’utile, ancorché egoistico del proprio popolo o Stato, sotto la maschera del giudice imparziale. Segno inquietante di turbamento spirituale sino ai giorni nostri (bisogna pure avere il coraggio di confessarlo), i tribunali senza alcun fondamento di legge, che il vincitore ha istituiti per giudicare, condannare e impiccare, sotto i nomi di criminali di guerra, uomini politici e generali dei popoli vinti, abbandonando la diversa pratica, esente d’ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere ai vinti o ad alcuni dei loro uomini, e se ne richiedeva la consegna per metterli a morte, proseguendo o concludendo con ciò la guerra.
Giulio Cesare non mandò innanzi a un tribunale ordinario o straordinario l’eroico Vercingetorige, ma esercitando vendetta o reputando pericolosa alla potenza di Roma la vita e l’esempio di lui, poiché gli si fu nobilmente arreso, lo trascinò per le strade di Roma dietro il suo carro trionfale e indi lo fece strozzare nel carcere. Parimente si è preso oggi il vezzo, che sarebbe disumano se non avesse del tristemente ironico, di tentar di calpestare i popoli che hanno perduto una guerra, con l’entrare nelle loro coscienze e col sentenziare sulle loro colpe e pretendere che lo riconoscano e promettano di emendarsi: che è tale pretesa che neppur Dio, il quale permette nei suoi ascosi consigli le guerre, rivendicherebbe a sé, perché egli non scruta le azioni dei popoli nell’ufficio che il destino o l’intreccio storico di volta in volta a loro assegna, ma unicamente i cuori e i reni, che non hanno segreti per lui dei singoli individui. Un’infrazione della morale qui indubbiamente accade, ma non da parte dei vinti, si piuttosto dei vincitori, non dei giudicati ma degli illegittimi giudici.
Noi italiani, che abbiamo nei nostri grandi scrittori una severa tradizione di pensiero giuridico e politico, non possiamo dare la nostra approvazione allo spirito che soffia in questo dettato, perché dovremmo approvare ciò che sappiamo non vero e pertinente a transitoria malsania dei tempi: il che non ci si può chiedere. Ma altrettanto dubbio suscita questo documento nell’altro suo aspetto di dettato internazionale che dovrebbe ristabilire la collaborazione tra i popoli nell’opera della civiltà e impedire, per quanto è possibile, il rinnovarsi delle guerre. Il tema che qui si tocca è così vasto e complesso che io non posso se non lumeggiarlo sommariamente e in rapporto al solo caso dell’Italia e nelle particolarità di questo caso.
L’Italia, dunque, dovrebbe, compiuta l’espiazione con l’accettazione di questo dettato, e così purgata e giustificata, rientrare nella parità di collaborazione con gli altri popoli. Ma come si può credere che ciò sia possibile se la prima condizione di ciò è che un popolo serbi la sua dignità e il suo legittimo orgoglio, e voi, o sapienti uomini dei tripartito, o quadripartito internazionale, l’offendete nel fondo più geloso dell’anima sua, perché, scosso che ebbe da sé l’Italia, non appena le fu possibile, l’infesto regime tirannico che la stringeva, avete accettato e sollecitato il suo concorso nell’ultima parte della guerra contro la Germania, e poi l’avete, con pertinace volontà, esclusa dai negoziati della pace, dove si trattava dei suoi più vitali interessi, impedendole di fare udire le sue ragioni e la sua voce e di suscitare in sè spontanei difensori in voi stessi o tra voi?
E ciò avete fatto per avere le sorti italiane come una merce di scambio tra voi, per equilibrare le vostre discordi cupidigie o le vostre alterne prepotenze, attingendo a un fondo comune, che era a disposizione.
Così all’Italia avete ridotto a poco più che forza di polizia interna l’esercito, diviso tra voi la flotta che con voi e per voi aveva combattuto, aperto le sue frontiere vietandole di armarle a difesa, toltole popolazioni italiane contro gli impegni della cosiddetta Carte Atlantica, introdotto clausole che violano la sua sovranità sulla popolazioni che le rimangono, trattatala in più cose assai più duramente che altri stati ex nemici che avevano tra voi interessati padroni, toltole o chiesto una rinunzia preventiva alle colonie che essa stessa aveva acquistate col suo sangue e amministrate e portate a vita civile ed europea col suo ingegno e con dispendio delle sue e tutt’altro che ricche finanze, impostole gravi riparazioni anche verso popoli che sono stati dal suo dominio grandemente avvantaggiati, e perfino le avete, come ad obbrobrio, strappati pezzi di terra del suo fronte occidentale da secoli a lei congiunti e carichi di ricordi della sua storia, sotto pretesto di trovare in quel possesso la garanzia contro una possibile irruzione italiana, quella garanzia che una assai lunga e assai fortificata e assai vantata linea Maginot non seppe dare.
Non continuo nel compendiare gli innumeri danni ed onte inflitte all’Italia e consegnati in questo documento, perché sono incisi e bruciano nell’anima di tutti gli italiani; e domando se, tornando in voi stessi, da vincitori smoderati a persone ragionevoli, stimate possibile di avere acquistato con ciò un collaboratore in piena efficienza per lo sperato nuovo assetto europeo.
Il proposito doveroso di questa collaborazione permane e rimarrà saldo in noi, e lo eseguiremo perché corrisponde al nostro convincimento e l’abbiamo pur ora comprovato col fatto; ma bisogna non rendere troppo più aspro all’uomo il già aspro suo dovere, né dimenticare che al dovere giova la compagnia che gli recano l’entusiasmo, gli spontanei affetti, l’esser libero dai pungenti ricordi di torti ricevuti, la fiducia scambievole che presta impeto ed ali.
Noi italiani, che non possiamo accettare questo documento perché contrario alla verità, e direi alla nostra più alta scienza, non possiamo, sotto questo secondo aspetto dei rapporti fra i popoli, accettarlo, nè come italiani curanti dell’onore della loro patria, né come europei, due sentimenti che confluiscono in uno; perché l’Italia è tra i popoli che più hanno contribuito a formate la civiltà europea, e per oltre un secolo ha lottato per la libertà e l’indipendenza sua e, ottenutala, si era per molti decenni adoperata a serbare con le sue alleanze e intese difensive la pace in Europa.
E cosa affatto estranea alla sua tradizione è stata la parentesi fascistica, che ebbe origine dalla guerra del 1914, non da lei voluta, ma da competizioni di altre potenze, la quale, tuttoché essa ne uscisse vittoriosa, nel collasso che seguì dappertutto, la sconvolse a segno da aprire la strada in lei alla imitazione dei nazionalismi e totalitarismi altrui. Libri stranieri hanno testé favoleggiato la sua storia nei secoli come una incessante aspirazione all’imperialismo, laddove l’Italia una sola volta fu imperiale, e non propriamente essa, ma l’antica Roma, che peraltro valse a creare la comunità che si chiamò poi l’Europa; e, tramontata quell’egemonia, per la sua posizione geografica divenne campo di continue invasioni e usurpazioni dei vicini popoli e stati.
Quei libri, dunque, non sono storia, ma deplorevole pubblicistica di guerra, vere e proprie falsificazioni.
Nel 1900 un ben più sereno scrittore inglese, Bolton King, che con grande dottrina narrò la storia della nostra Unità, nel ritrarre l’opera politica dei governi italiani nel tempo seguito all’Unità, riconosceva, nella conclusione del suo libro, che, al confronto degli altri popoli di Europa, l’Italia “possedeva un ideale umano e conduceva una politica estera comparativamente generosa”.
Ma se non approveremo questo documento, che cosa accadrà? In quali strette ci cacceremo? – Ecco il dubbio e la perplessità che può travagliare alcuno o parecchi di voi, i quali nel giudizio di sopra esposto e ragionato del cosiddetto trattato so che siete tutti e del tutto concordi con me ed unanimi, ma pur considerate l’opportunità contingente di una formalistica ratifica.
Ora non dirò ciò che voi ben conoscete: che vi sono questioni che si sottraggono alla spicciola opportunità e appartengono a quella inopportunità inopportuna o a quella opportunità superiore che non è del contingente, ma del necessario; e necessaria e sovrastante a tutto è la tutela della dignità nazionale, retaggio affidatoci dai nostri padri, da difendere in ogni rischio e con ogni sacrificio.
Ma qui posso stornare per un istante il pensiero da questa alta sfera che mi sta sempre presente, e, scendendo anch’io nel campo del contingente, alla domanda su quel che sarà per accadere rispondere, dopo avervi ben meditato, che non accadrà niente, perché in questo documento è scritto che i suoi dettami saranno messi in esecuzione anche senza l’approvazione dell’Italia: dichiarazione in cui, sotto lo stile di Brenno, affiora la consapevolezza della verità che l’Italia ha buona ragione di non approvarlo. Potrebbero bensì, quei dettami, venire peggiorati per spirito di vendetta; ma non credo che si vorrà dare al mondo di oggi, che proprio non ne ha bisogno, anche questo spettacolo di nuova cattiveria, e, del resto, peggiorarli mi par difficile, perché non si riesce a immaginarli peggiori e più duri.
Il governo italiano certamente non si opporrà alla esecuzione del dettato; se sarà necessario, coi suoi decreti o con qualche suo singolo provvedimento legislativo, la seconderà docilmente, il che non importa approvazione, considerato che anche i condannati a morte sogliono secondare docilmente nei suoi gesti il carnefice che li mette a morte.
Ma l’approvazione no! Non si può costringere il popolo italiano a dichiarare che è bella una cosa che esso sente come brutta, e questo con l’intento di umiliarlo e di togliergli il rispetto di se stesso, che è indispensabile a un popolo come a un individuo, e che solo lo preserva dall’abiezione e dalla corruttela.
Del resto, se prima eravamo soli nel giudizio dato di sopra del trattamento usato all’Italia, ora spiritualmente non siamo più soli: quel giudizio si avvia a diventare un’opinio communis e ci viene incontro da molti altri popoli e perfino da quelli vincitori, e da minoranze dei loro parlamenti che, se ritegni molteplici non facessero per ora impedimento, diventerebbero maggioranze, e fin da ora ci esorta a ratificare sollecitamente il trattato per entrare negli aeropaghi internazionali da cui siamo esclusi, e nei quali saremmo accolti a festa, se anche come scolaretti pentiti; e ci si fa lampeggiare l’incoraggiante visione che le clausole di esso più gravi e più oppressive non saranno eseguite e tutto sarà sottoposto a revisione.
Noi non dobbiamo cullarci nelle facili speranze e nelle pericolose illusioni e nelle promesse più volte provate fittizie, ma contare anzitutto e soprattutto su noi stessi; e tuttavia possiamo confidare che molti comprenderanno la necessità del nostro rifiuto dell’approvazione, e l’interpreteranno per quello che esso è: non un’ostilità contro il riassetto pacifico dell’Europa, ma , per contrario, non ammonimento e un contributo a cercare questo assetto nei modi in cui soltanto può ottenersi; non una manifestazione di rancore e di odio, ma una volontà di liberare noi stessi dal tormento del rancore e dalle tentazioni dell’odio.
L’Unità, 22-1-2000: “Croce, da “papa laico” a grande dimenticato” – di Guido Liguori
Singolare, la sorte di Croce in Italia. Dopo essere stato per decenni grazie anche a una vita e a una attività intellettuale lunghissime il “papa laico” (così lo ebbe a definire Gramsci) della cultura italiana, dopo aver influenzato in vario modo molti passaggi decisivi del Novecento, italiano e non solo dal dibattito marxista di inizio secolo alla lotta al “giolittismo”, dagli anni agitati del primo dopoguerra alla riscoperta della democrazia e all’opposizione al fascismo, fino alla costruzione della democrazia postfascista, a partire dalla morte (1952) Croce è stato sostanzialmente dimenticato. Con eccessivo ottimismo, infatti, si è parlato di “ritorno di Croce”, agli inizi degli anni Novanta, forse in coincidenza con la nuova, pregevole edizione delle sue opere presso l’editore Adelphi, a cura di Giuseppe Galasso.
Perché questo sia accaduto non è difficile a dirsi. Non tanto per colpa di quella “battaglia per l’egemonia” che la “filosofia della prassi”, ossia il marxismo italiano, sulla scorta dei Quaderni del carcere, avrebbe dovuto intraprendere contro il pensiero di Croce: perché anzi riconoscendolo a lungo (e forse erroneamente, cioè in parte fraintendendo lo stesso Gramsci) come il “nemico principale” – il marxismo italiano non faceva altro se non riconfermarne indirettamente la centralità. No, Croce piuttosto è stato sconfitto, o meglio travolto, dalla piena di quella cultura europea e americana che egli a lungo si era adoperato di tenere ai margini del discorso filosofico e ideologico, almeno nel nostro Paese, e che poi, rotti gli argini, tutto ha pervaso e sommerso, con un mare di traduzioni (del resto meritorie), studi critici, tesi di laurea.
“Nessuno dei miei allievi – afferma Norberto Bobbio nel libro che vogliamo qui presentare -, dalla prima generazione degli anni quaranta all’ultima degli anni ottanta, si è mai occupato di Croce. Nessuno mi ha mai chiesto di avviarlo allo studio della filosofia crociana”. E sarebbe ingeneroso obiettare che se ciò è accaduto, la ragione va forse ricercata anche nell’insegnamento del maestro in questione, di Bobbio stesso. La realtà è che – con le profonde trasformazioni vissute dall’Italia dei decenni cinquanta e sessanta – il pensiero di Croce, il suo modo così forte e così peculiare di rispecchiare quel mondo che non c’era più, è irrimediabilmente sembrato lontano. Fino a pochi anni prima la sua presenza era tutto o quasi, sulla scena culturale italiana. Solo pochi anni dopo – per un ingiusto contrappasso, si potrebbe dire – è stato niente, o poco più. Quelle stagioni sono ormai lontane. E se certo Croce non è più destinato a “tornare” in modi e forme paragonabili a quelli registrati mentre ancora egli era in vita, è altrettanto certo che è non solo ingiusto, ma sciocco, per gli intellettuali italiani, lasciarlo nell’oblio in cui è stato a lungo tenuto. Croce è un grande classico. E’ un grande patrimonio della cultura italiana. E come tale va trattato. E’ quindi da apprezzare lo sforzo di Paolo Bonetti, che ha saputo raccogliere in un volume da lui curato “Per conoscere Croce”, a cura di Paolo Bonetti, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 275, £. 35.000) i contributi di alcuni dei migliori studiosi ed esperti di Croce, impegnati a riflettere, in modo anche accessibile a un pubblico colto ma non specialistico, su tutti i principali te mi del vasto sapere crociano: dalla sua lettura del marxismo (Giuseppe Bedeschi) alle varie sfaccettature del suo liberalismo (Norberto Bobbio), dal rapporto con la cultura del suo tempo (Giuseppe Galasso) al rapporto col cristianesimo (Nicola Matteucci), dalla concezione della libertà (Giovanni Sartori) e dal rapporto con la tradizione liberale (Gennaro Sasso) alla polemica col decadentismo (Gianni Vattimo).
La prima parte del volume che comprende le conversazioni di Bonetti con gli autori sopra richiamati – è seguita da una seconda parte, saggistica, in cui altri studiosi completano il quadro ricostruttivo, a volte con risultati di grande interesse. E’ il caso innanzitutto del contributo di Giuseppe Cacciatore, su Filosofia della pratica e filosofia pratica in Croce, o del saggio di Pio Colonnello sullo storicismo di Croce e sulla sua concezione dell’individuo. E di tanti altri ancora. Insomma, un volume ricco e di grande interesse, che permette letture a più livelli.
E che può contribuire a riportare l’attenzione su Croce come sarebbe giusto. In fondo, in un momento in cui tutti parlano, spesso a sproposito, di liberalismo (e spesso anche, ahimè, di liberismo) è davvero originale che non si torni a fare i conti con questo grande classico del pensiero italiano.
Il Mattino, 19-10-2001: “Croce – Un insolito ritratto del filosofo nelle lettere allo zio di Luigi Pintor: perché non ripubblicarle?” – di Giorgio Frasca Polara
Tra poco, l’anno venturo, saranno cinquant’anni dalla morte di Benedetto Croce, ricordato oggi in un importante convegno a Napoli. Tra le prevedibili, innumerevoli iniziative, sarebbe assai utile la ristampa, da parte del Senato, di un prezioso volume curato dieci anni fa dall’allora presidente dell’assemblea di Palazzo Madama: «Il carteggio di Benedetto Croce con la Biblioteca del Senato». Nell’inesauribile produzione di Spadolini questa rappresentò una vera chicca: la pubblicazione di un grosso complesso di inediti crociani – 341 tra lettere, biglietti e cartoline: la gran parte conservati in Senato, e in minor misura ritrovati, grazie a Marino Raicich, in un fondo dell’Archivio centrale dello Stato – che testimoniano di cinquant’anni esatti, dal 1903 sino ai prodromi della morte nel ‘52, di stretti rapporti del filosofo con la ricca biblioteca senatoriale. Sono tutte richieste di prestiti di libri, o suggerimenti di acquisti, o sollecitazioni di pareri o chiarimenti bibliografici e non solo.
È insieme una preziosa documentazione per la storia e del pensiero e degli studi di Croce, una fonte inesauribile di informazioni sul retroterra di molte opere crociane, un ritratto curioso e affascinante di «don Benedetto» e una essenziale integrazione dei poderosi, ormai leggendari Taccuini che Croce stese praticamente per tutta la vita. Ed è proprio il Croce bibliofilo che più affascina, consentendo di misurare il suo atteggiamento nei confronti degli usi e costumi inveterati delle biblioteche. Alcuni manoscritti del primo dopoguerra sono in questo senso assolutamente deliziosi. È l’agosto del ‘18 (Croce da otto anni è senatore del regno: non per meriti culturali attenzione, ma per censo), e dalla villeggiatura, dove sta studiando il teatro elisabettiano, chiede in prestito un libro su Shakespeare di Friedrich Gundolf, stampato a Berlino e non ancora tradotto. Dal Senato gli fanno sapere che il volume è stato rintracciato alla Nazionale di Milano ma che al momento lo ha qualcun altro.
A fine settembre Croce torna alla carica e, scoprendo che il libro non è stato ancora riconsegnato, sbotta: «E Gundolf? Vorrei conoscere quello studioso shakesperiano che vi medita tanto sopra!» (Nell’ordinare il carteggio, i documentaristi della Biblioteca del Senato scopriranno più di settant’anni dopo l’arcano, forse mai rivelato a Croce: era stato lo stesso direttore della Nazionale di Milano a prorogare il prestito al meditabondo studioso ma, allertato da così pressante e prestigiosa richiesta, si affrettò a comunicare al collega del Senato che «con un ritardo di soli pochi giorni il suo illustre cliente potrà essere servito, com’è suo e mio vivissimo desiderio»…).
Un altro ingiallito biglietto, questa volta dell’estate del ‘29 documenta con precisione come, quanto e perché il filosofo e storico napoletano non si desse pace per l’uso disinvolto di un inestimabile bene comune di cui era invidiosissimo, lui che pur poteva contare già allora su una immensa raccolta personale. Da direttore della Critica eccolo dunque chiedere che gli si mandi una miscellanea di libri «assicurata per lire 300». «Io la rimanderò allo stesso modo», e spiega: «Queste precauzioni, dato il mio amore e la mia gelosia per i libri delle pubbliche biblioteche, mi fanno piacere». Dai riscontri, la conferma del rispetto di Benedetto Croce per i libri altrui: di norma egli non trattiene più di un mese i volumi in prestito (che, spiega in un’altra lettera, «sono da me serbati in uno scaffale speciale per non confonderli coi miei propri») e un mese non è certo gran tempo dal momento che le fotocopiatrici sono ancora di là da venire.
Tra richieste sofisticate («Mi occorre il seguente opuscolo: Apologia del genere umano accusato di essere stato una volta bestia, appendice all’opera di G.F. Finetti, Venezia 1786»), e richieste che lo sono assai meno («Abbiate pazienza, desidererei trovare sabato presso il Senato le seguenti opere di Marco Praga (…) Bella roba che sono costretto a leggere! Compiangetemi»), continui sono i suggerimenti su come arricchire e in quale direzione il patrimonio bibliografico del Senato. Una volta il motivo vero è che un certo libro serve a lui, altra volta è che «se la Bibl. del Senato li acquistasse, acquisirebbe volumi di monografie su odierni scrittori italiani, il che non sarebbe ripugnante alla sua indole».
Il suo referente privilegiato è il leggendario Fortunato Pintor, zio di Giaime e di Luigi, filologo e bibliofilo finissimo, per molti anni direttore della Biblioteca del Senato nell’età giolittiana e anche nei primi anni del fascismo, ma che proprio a cagione della dittatura sarà costretto a lasciarne la responsabilità effettiva a soli cinquantatré anni. Così, nel ‘14, «all’amico Pintor presento, e non ho bisogno di raccomandare, il Prezzolini che desidera studiare nella Bibl. del Senato», e nel ‘27 segnala che «l’amico De Ruggero» ha bisogno di consultare alcuni rari libri «per un suo lavoro di storia della filosofia» (che sarà poi la monumentale Storia edita più tardi, come tutte le opere crociane, da Laterza) e suggerisce a Pintor di insistere perché, una volta ottenuto il prestito, «egli venga a studiare quei libri presso la Bibl. del Senato».
Di grande interesse sono anche le tracce del lavoro preparatorio di alcuni classici di «don Benedetto». Nel ‘27 sta scrivendo la Storia d’Italia dal 1871 al 1914. È il momento in cui s’indurisce la sua opposizione al fascismo, e il carteggio rivela non solo il complesso di approfondimenti che andava facendo mentre scriveva, ma anche come la riflessione storica diventi per lui strumento di battaglia politica. La storia del movimento socialista è al centro di gran parte delle richieste. Il 15 ottobre vuole addirittura sapere come e quando esattamente D’Annunzio aveva annunciato alla Camera l’abbandono della Destra: «Mio caro Pintor, volete farmi il favore di darmi questa indicazione: in quale giorno (del 1900, durante l’ostruzionismo) il D’Annunzio, deputato, disse ”Colà è la vita ecc.” e, staccandosi dalla destra, passò all’estrema sinistra? E quali furono le sue precise parole?». Per la Storia d’Europa Croce era andato a caccia di libri alla Biblioteca di Berlino, ed era tornato con una lista di «altre storie molto importanti» che anche a Roma «non dovrebbero mancarvi». Croce la trasmette a Pintor proponendo l’acquisto di 10 opere in 17 volumi: eseguito.
L’ultima pagina del carteggio è del ‘52, poco prima della scomparsa di Croce. Con una cartolina postale il filosofo ricorda di aver fatto acquistare «una trentina di anni fa» un saggio dello storiografo Maritz Ritter. «Ora, dopo tanti anni, ho bisogno di rileggerlo e, sebbene lo abbia richiesto ai librai tedeschi, non so se e quando l’avrò, cosicché incomodo lei per che abbia la cortesia di mandarmi in lettura di nuovo il volume». Ma quando il libro arriverà a Napoli, Croce è appena morto.
Il Mattino, 1-6-2002: “Nel ‘44 doveva diventare la prigione di Benedetto Croce” – di Gennaro Pappalardo
C’è nella millenaria storia della Baia di Jeranto una pagina non scritta ma ben presente nella memoria degli eruditi, degli storici e dei filosofi: nel 1944 la mitica alcova delle Sirene, all’epoca una cava di macigni calcarei destinati agli altoforni di Bagnoli ormai in via di dismissione, avrebbe dovuto essere una prigione fascista per Benedetto Croce.
Il piano per rapire il filosofo napoletano, ospite della Villa del Tritone di Sorrento dopo il suo trasferimento da Napoli nel 1942 a causa dei bombardamenti, era perfetto nella mente dei suoi organizzatori: secondo le disposizioni dei gerarchi fascisti Croce doveva essere rapito perché potesse essere portato a Firenze per commemorare il suo amico-rivale di pensiero, ed anche di azione politica, Giovanni Gentile assassinato il 17 aprile ‘44. La messa in opera del programma era affidata all’avvocato Nando Di Nardo, una vita politica spesa tra la milizia fascista e la carica di deputato del Msi nel dopoguerra: dopo un suo sopralluogo tra Sorrento e Massa Lubrense si costituì un «commando» di volontari, quattro esponenti del fascismo della penisola sorrentina. A capo l’avvocato Sorrentino Stelio Sguanci e tre massesi: l’impiegato comunale Vittorio Marcia, il falegname Domenico Zarrella ed il custode della cava di Jeranto Cataldo Massa. Insomma Benedetto Croce sarebbe stato rapito dai quattro a Sorrento e con un’auto, rubata poco prima, trasportato sulla strada statale 163 amalfitana verso Positano: giunti ai Colli di San Pietro i quattro avrebbero proseguito a piedi col prigioniero fino alla Baia di Jeranto attraverso una serie di stradine da Sant’Agata sui due Golfi fino a Nerano. Il delicato compito di nascondere e vigilare su Benedetto Croce era affidato a Cataldo Massa.
Per fortuna il piano fallì: lo stesso Di Nardo, che ne aveva riferito ai principi Pignatelli per avere l’autorizzazione da Mussolini, si pentì e lasciò che altri consigliassero ed attuassero il trasferimento di Croce e delle figlie Silvia e Lidia nella più sicura isola di Capri, dove poi fu raggiunto dalla moglie Adelina e dalla figlia Alda. Malgrado già avesse nel ‘42 espresso le prime resistenze di a lasciare prima Napoli e poi Sorrento dopo le prime minacce subite per il suo antifascismo Croce accettò a malincuore i convincimenti a raggiungere Capri da parte del genero Raimondo Craveri, dell’amico avvocato Giuseppe Brindisi all’epoca commissario prefettizio nell’isola azzurra e d’un ufficiale della marina inglese di origini spagnole Federico Gallegos. In una sua intervista poco prima della morte (avvenuta a Massa Lubrense il 30 marzo 2000 – gli altri componenti del) commando erano già deceduti anni prima) il mancato carceriere di Croce a Jeranto Cataldo Massa, che intanto era stato operato alla laringe, ebbe ad esprimere a gesti di essersi commosso nel sapere della grandissima statura culturale del suo mancato prigioniero.
La Repubblica, 23-6-2002: “così spiavano don Benedetto” – di Lucio Villari
Era luminosa e calda l’alba del primo giorno d’estate di settanta anni fa, ed erano le 5.55 quando alla stazione di Campobasso si fermava, sbuffando, il diretto proveniente da Napoli. Ne scendevano pochi viaggiatori insonnoliti e tra questi due signori, uno anziano l’altro più giovane, dall’aria tranquilla e distinta. Al cocchiere della vettura pubblica chiesero di essere portati al Grand Albergo. Era il 21 giugno 1932. Poco più di un mese dopo, il 28 luglio, il prefetto di Campobasso veniva raggiunto da un secco telegramma del capo della polizia Arturo Bocchini.
«N° 18440/442. Viene riferito che notte 21 giugno decorso giunse codesta città noto Senatore Benedetto Croce cui sera successiva fu offerta cena dal Ragioniere Alberto Cancellario Vice Podestà codesto Comune et alla quale parteciparono anche Avv. Antonino Mancini Archivista presso codesta Amministrazione provinciale, elemento notoriamente avverso Regime, Avv. Alberto Florio Podestà codesto Comune et tale Cortese Lino stop Pregasi riservati accertamenti riferendo esito pel Ministro Bocchini».
Evidentemente il capo della polizia citava informazioni ricevute da agenti che da tempo, per ordine di Mussolini, tenevano sotto controllo Benedetto Croce e ne seguivano puntigliosamente gli spostamenti segnalando anche (vi era un agente fisso nell’ingresso di palazzo Filomarino di Napoli, dove Croce abitava) le persone che lo frequentavano. C’era però nel telegramma di Bocchini una malcelata irritazione, presagio di una tempesta in arrivo, per la familiarità dimostrata al «noto Senatore» dal podestà e dal vice podestà, autorità di sicura fede fascista.
Il lavoro di Intelligence degli agenti era stato impeccabile ma non era andato oltre il racconto minuzioso della giornata particolare trascorsa da Croce a Campobasso. Il 22 giugno era stata stilata una «Relazione circa il soggiorno in questa città di S.E. il Senatore Croce Benedetto», dove la cronaca nuda e cruda da «mattinale», dell’agente che seguiva i passi di Croce non avrebbe certamente soddisfatto il capo della polizia. Anche in questa occasione il puntuale servizio di Intelligence non investigava, naufragando nel povero linguaggio della burocrazia.
«S.E. Benedetto CROCE furono Pasquale e Sipari Luigia, nato a Pescasseroli il 25.2.1866, Senatore del Regno, residente Napoli, arrivò in questa Città alle ore 5,55 di ieri in compagnia del Prof. di Università CORTESE Lino fu Vincenzo e di Spermide Emilia, nato a Perugia il 25.9.1896, residente a Napoli, prendendo alloggio al locale Grand Albergo.
Verso le 9 circa, in compagnia del Cortese e dell’Avv. Mancini Antonino, archivista della locale Biblioteca di Stato, si recarono sui Monti, ove visitarono quei paraggi.
Verso le ore 11 discesero recandosi al Municipio ove incontrarono il V. Podestà Sig. Cancellario, il quale li accompagnava, a desiderio di S.E. Croce, negli Uffici di detto Municipio.
Alle ore 15 circa discesero dal Municipio recandosi al Grand Albergo ove consumarono il pasto in compagnia anche del Podestà Avv. Florio, del V. Podestà Sig. Cancellario e delle surripetute persone.
Verso le ore 15 circa tanto il V. Podestà che il Podestà e il Mancini se ne andarono.
Verso le ore 17.30 venne rilevato dal Mancini e dal Prof. Verrecchia del locale R. Liceo-Ginnasio e insieme si recarono di nuovo al Monte Monforte ove visitarono la Chiesa di S. Giorgio in quei paraggi, il Castello Monforte e la Chiesa dei Cappuccini discendendo verso le ore 19 circa, per recarsi alla Biblioteca di Stato di via Pennino.
Verso le 20 dopo aver passeggiato per la città rincasava al Grand Albergo ove consumò la cena col prof. Cortese.
Stamane verso le 8.30 è uscito dall’albergo in compagnia del Prof. Cortese del Prof. Verrecchia e dell’Avv. Mancini e si è recato con essi a visitare la Chiesa di S. Antonio Abate.
Alle ore 9,15 sempre insieme si recarono al Convitto Nazionale Mario Pagano per salutare quel Preside.
Alle ore 10 ha fatto visita a S.E. il Vescovo e alle 11 si è recato nello studio fotografico del Prof. Trombetta.
Accompagnato dal Prof. Trombetta verso le 11,40 è tornato all’albergo ove ha pranzato insieme al Prof. Cortese.
Alle ore 12,30 accompagnato dall’Avv. Mancini, dal Prof. Verrecchia e dal Prof. sacerdote Verna e dal Trombetta, si è diretto allo scalo ferroviario e col Prof. Cortese è partito col treno delle ore 12,50 diretto a Benevento e Napoli».
Un profluvio di orari, avvocati, professori, eccellenze (con qualche errore: il nome di Cortese, storico del Risorgimento, era Nino, non Lino; anzi, «tale Cortese Lino», lo definiva Bocchini nel telegramma), anche un fotografo, ma nessuna spiegazione delle ragioni del viaggio di Croce, né degli incontri con le autorità podestarili. Di qui l’intimazione del capo della polizia al prefetto che, a sua volta, chiese immediatamente informazioni al questore. Il 29 luglio, poche ore dopo l’arrivo del tele gramma di Bocchini, il questore era in grado di aggiungere altri particolari alla stringata relazione dell’agente pedinatore. Il questore insinuava il dubbio che Croce potesse essersi recato a Campobasso per ragioni di studio.
L’informazione saliva di tono, anche se la lingua italiana continuava a soffrirne.
«Il Senatore Benedetto Croce, giunse in questa Città col treno delle ore 5.55 del 21 giugno u.s., segnalato dal Commissario di P.S. presso lo Scalo Ferroviario di Napoli con telegramma della sera precedente. Il Senatore arrivò qui assieme al Professore di Università Cortese Lino fu Vincenzo e presero alloggio al Grand Albergo. Verso le 9 i predetti, accompagnati dall’Avv. Antonio Mancini, Archivista del locale Archivio di Stato, si recarono sul
Castello Monforte per visitare quei paraggi. Verso le ore 11 si recarono poi sul Comune per esaminare al cune pergamene antiche, poiché sembra che il Senatore Croce stia scrivendo un libro su Cola Monforte, personaggio appartenente a nobile ed antica famiglia di Campobasso. Verso le ore 13 i soprascritti unicamente al Podestà Avv. Florio ed al Vice Podestà Rag. Cancellario si recarono al Grand Albergo ove le cinque cennate persone consumarono una colazione che venne pagata dal Vice Podestà Rag. Cancellario». Seguivano, con qualche dettaglio in più, informazioni analoghe a quelle dell’agente, ma veniva corretta un’altra svista (restava comunque il nome errato dì Cortese): l’avv. Mancini era archivista dell’Archivio di Stato non di una inesistente Biblioteca di Stato.
Restava però un nodo da sciogliere: che c’entravano il podestà e il vice podestà con il senatore Croce? Spettava al prefetto dare la risposta alla domanda implicita nel telegramma dei capo della polizia. Il prefetto non si scomodò più di tanto: sulla lettera-relazione del questore scrisse a mano aggiunte e postille per poi passare il tutto verosimilmente alla dattilografa che doveva comporre la risposta a Bocchini.
RIASSUNTO DELL’ ESTETICA
L’ ” Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale “, pubblicata per la prima volta nel 1902 dall’editore Laterza di Bari e destinata ad una durevole fortuna editoriale, rappresenta il primo grande lavoro filosofico di Benedetto Croce, nonché il primo dei quattro volumi che costituiscono la “Filosofia dello spirito”. L’opera si compone di due ampie sezioni: la prima, dedicata all’esposizione teorica dell’estetica, intesa come scienza dell’intuizione pura, risulta in realtà un rifacimento, riveduto ed aggiornato, della memoria sulle “Tesi fondamentali di un’estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale”, letta all’Accademia Pontaniana di Napoli nelle tre tornate del 18 febbraio, 18 marzo e 6 maggio del 1900. La seconda parte consiste invece in una storia dell’estetica, ossia in un’analisi delle diverse concezioni della conoscenza intuitiva e della filosofia dell’arte nel corso della storia della filosofia occidentale, a partire dalla negazione platonica dell’arte fino al saggio sul “Riso” di Bergson. La concezione teorica sulla quale si fonda essenzialmente l’estetica crociana consiste nell’individuazione della conoscenza intuitiva (rappresentazione immediata) come primo grado dell’attività conoscitiva dello spirito, e dunque come momento “aurorale” dell’attività spirituale. Inoltre l’intuizione viene prioritariamente distinta da intelletto, percezione e sensazione, per essere piuttosto identificata con l’espressione. Quest’ultima non consiste infatti nell’atto estrinseco (ad esempio, il dipingere o lo stendere le mani su un pianoforte) che viene considerato un aspetto pratico dell’attività spirituale, ma coincide piuttosto con l’atto intuitivo, indipendentemente da ogni abilità tecnica: pertanto l’espressione risulta anch’essa primo momento dell’attività conoscitiva. In questo modo Croce rifiuta categoricamente ogni concezione dell’arte che allontani quest’ultima dalla sua vera natura, che è appunto quella di conoscenza intuitiva, e non può dunque essere intesa come imitazione del vero, né può essere legata ad alcuna concezione filosofica, né risulta in qualche modo connessa ad impulsi sessuali o fisici in generale. La critica stringente del Croce esclude progressivamente tutte le concezioni dell’arte in cui in qualche modo la forma risulti concepita separatamente dal suo contenuto, travolgendo con l’arma della critica ogni teorizzazione dei generi letterari, ritenuti per l’appunto il risultato di astratte catalogazioni. E’ proprio in questa prima parte dell’ “Estetica” che Croce introduce per la prima volta in una sua opera di rilievo la sua proposta di “sistemazione” dell’attività dello spirito, articolata in attività conoscitiva, a sua volta suddivisa in intuizione (arte) e concetto (filosofia), e in attività pratica, distinta in volontà particolare (economia) e volontà universale (etica). Nella sezione storica dell’opera, l’autore prosegue invece la sua requisitoria contro le concezioni dell’arte criticate nella prima parte, ricostruendo una storia dell’estetica orientata sull’esposizione di diverse dottrine e inserendo in tale percorso un senso di progressione che connette idealmente la sua opera a quella di Giambattista Vico e di Francesco De Sanctis, ritenuti entrambi suoi maestri e principali ispiratori.
ANTONIO GRAMSCI

Non c’è attività umana da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale, non si può separare l’homo faber dall’homo sapiens. Ogni uomo infine, all’infuori della sua professione esplica una qualche attività intellettuale, è cioè un “filosofo”, un artista, un uomo di gusto, partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare.
Io sono stato abituato dalla vita isolata, che ho vissuto fino dalla fanciullezza, a nascondere i miei stati d’animo dietro una maschera di durezza o dietro un sorriso ironico. Ciò mi ha fatto male, per molto tempo: per molto tempo i miei rapporti con gli altri furono un qualcosa di enormemente complicato.
CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE
1891-1911
Antonio Gramsci nasce ad Ales (presso Oristano), in Sardegna, il 22 gennaio 1891, quarto dei sette figli di Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias. Nel 1894 la famiglia si trasferisce a Sòrgono (Nuoro): per due anni viene mandato, insieme alle sorelle, in un asilo di suore. A questo periodo, dopo una caduta, risale la malattia che gli lascerà una malformazione fisica: la schiena andrà lentamente incurvandosi e le cure mediche tenteranno invano di arrestare la sua deformazione.
Nel 1897 il padre viene sospeso dall’impiego all’Ufficio del registro di Ghilarza e arrestato per irregolarità amministrative.
Nel 1902 consegue la licenza elementare a Ghilarza. Studia poi privatamente e intanto lavora, per aiutare la famiglia, presso l’ufficio catastale di Ghilarza.
Nel 1905 si iscrive al liceo-ginnasio di Santu Lussurgiu, cittadina a 15 km da Ghilarza. Inizia a leggere la stampa socialista che il fratello Gennaro gli invia da Torino.
Nel 1908 consegue la licenza ginnasiale e si iscrive al liceo Dettori di Cagliari, città dove vive presso il fratello Gennaro, segretario della locale sezione socialista. Con molti giovani del liceo Dettori, Gramsci partecipa alle “battaglie” per l’affermazione del libero pensiero e a discussioni di carattere culturale e politico. Abita in una poverissima pensione in via Principe Amedeo, poi si trasferisce in un’altra del Corso Vittorio Emanuele. A scuola si distingue tra i compagni per i suoi vivi interessi culturali, legge moltissimo (in particolare Croce e Salvemini). Rivela spiccatissime tendenze per le scienze esatte e per la matematica. Cagliari, in quel tempo, è una cittadina culturalmente vivace, dove si diffondono i primi fermenti sociali, che influiranno nella sua formazione di una ideologia socialista. Conseguita la licenza liceale, nel 1911 vince una borsa di studio e si iscrive all’università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia. Si trasferisce a Torino. Gramsci vive i suoi anni universitari in una Torino industrializzata, dove sono già sviluppate le industrie della Fiat e della Lancia, che hanno eliminato le concorrenti più deboli. Il forte sviluppo industriale ha conferito un aspetto nuovo alla città, che intorno al 1909 ospita circa 60.000 immigrati, che lavorano nelle fabbriche. Data l’alta concentrazione operaia e il ruolo avanzato dell’industria torinese, la organizzazione sindacale costituisce, nella città, una presenza attiva e dinamica, sostenuta da un’ampia mobilitazione dal basso. Sono le iniziative di lotta nelle fabbriche che portano alla costituzione delle prime commissioni interne e alla elezione di delegati di fabbrica, che siedono, durante le vertenze, al tavolo delle trattative con i rappresentanti padronali. È in questo periodo di forti agitazioni sociali che lo studente Gramsci vive i suoi anni universitari e matura la sua ideologia socialista. Studia i processi produttivi, la tecnologia e l’organizzazione interna delle fabbriche e si impegna per far acquisire agli operai “la coscienza e l’orgoglio di produttori”. A Torino frequenta anche gli ambienti degli immigrati sardi; l’interesse per la sua terra sarà sempre vivo in lui, sia nelle riflessioni di carattere generale sul problema meridionale, sulle sue abitudini, sul linguaggio, sui luoghi e sulle persone dell’infanzia; temi ricorrenti anche negli anni della maturità.
Gli avvenimenti. L’Italia è ancora nettamente divisa tra un Nord in cui è presente un relativo sviluppo industriale e un Meridione caratterizzato dal latifondo a coltivazione estensiva. L’assetto del potere nello Stato e nella società è dunque determinato da un’alleanza tra industriali e agrari, fondata sulla politica protezionistica, che esclude ogni partecipazione al potere da parte delle masse popolari. Ma la crisi di fine secolo, con i movimenti dei fasci siciliani (1894) e l’insurrezione proletaria di Milano (1898), costringe la borghesia italiana a scendere a patti con il movimento operaio. Dall’inizio del secolo, Giolitti, che dichiara la neutralità dello Stato nei conflitti di lavoro, apre un nuovo corso politico fondato su un accordo sociale con il movimento socialista riformista. A questo accordo si oppongono l’ala rivoluzionaria del partito socialista e il movimento sindacalista rivoluzionario.
1912
In cattive condizioni economiche e di salute, Gramsci segue i corsi universitari e sostiene alcuni esami. Ha anche i primi contatti con il movimento socialista torinese.-
Gli avvenimenti. Al congresso socialista di Reggio Emilia i riformisti perdono la direzione del partito. Mussolini diventa direttore dell’Avanti!.
1913
Aderisce ad un pubblico appello contro la politica protezionistica. Probabilmente in quest’anno si iscrive alla sezione socialista di Torino.
Gli avvenimenti. Con il patto Gentiloni, i cattolici partecipano alla competizione elettorale in appoggio a Giolitti.
1914
Soffre di periodiche crisi nervose. Sostiene sul Grido del popolo le posizioni della neutralità attiva e operante in contrasto con la politica della neutralità assoluta prevalente in ambito socialista.
Gli avvenimenti. Crisi dell’Internazionale socialista e del movimento operaio europeo che non riescono a far prevalere una politica di pace. Scoppia la Prima guerra mondiale.
1915
Continua la collaborazione con Il Grido del popolo e, a dicembre, entra nella redazione torinese dell’Avanti!, organo del Partito socialista italiano. La sua attività giornalistica s’impone all’attenzione generale non solo per la qualità della scrittura, ma anche per lo spessore della ricerca culturale.
Gli avvenimenti. L’italia entra in guerra a fianco dell’intesa. Lenin lancia a Zimmerwald la parola d’ordine di “trasformare la guerra imperialista in guerra civile”.
1916
Gramsci cura la rubrica “Sotto la mole” dell’Avanti! dove si occupa di critica teatrale e di note di costume.
Gli avvenimenti. Nel movimento socialista antimilitarista (conferenza di Kientbal) si fanno strada le posizioni radicali di Lenin.
1917
Dopo la sommossa operaia di agosto, Gramsci diventa segretario della commissione esecutiva provvisoria della sezione socialista di Torino. Dirige di fatto Il Grido del popolo.
Nel febbraio del 1917 per conto della Federazione giovanile socialista piemontese esce La città futura, il cui tema di fondo é la contrapposizione tra l’ordine della società borghese e quello della società socialista; a originali articoli di teoria e di propaganda socialista si affiancavano scritti di Croce, Salvemini e A. Carlini. In questo perioda l’influenza di Croce e della polemica antipositivistica dell’idealismo italiano traspare anche nella valutazione entusiastica della rivoluzione russa del novembre 1917, interpretata come “rivoluzione contro il Capitale” (cioè contro la versione deterministica dell’opera di Marx).
Gli avvenimenti. In agosto scoppiano in Italia movimenti di protesta contro il carovita e la guerra. In Russia la rivoluzione di febbraio porta all’abdicazione dello zar Nicola II; il governo provvisorio viene rovesciato in novembre dalla rivoluzione bolscevica.
1918
Cessano le pubblicazioni del Grido del popolo (ottobre) e nasce l’edizione piemontese dell’Avanti! (dicembre), diretta da Ottavio Pastore, nella cui redazione Gramsci entra dall’inizio.
Gli avvenimenti. Finisce la guerra mondiale. Movimenti rivoluzionari in vari paesi d’Europa. In Russia la controrivoluzione si militarizza: scoppia la guerra civile.
1919
Gramsci e altri (tra cui Tasca, Terracini, Togliatti) danno vita al settimanale L’Ordine nuovo (maggio), che si schiera per l’adesione del Psi all’Internazionale comunista e in favore del movimento dei consigli di fabbrica. Nei suoi articoli Gramsci afferma che il consiglio di fabbrica deve essere eletto da tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro collocazione politica, in modo che gli operai assumano in pieno la funzione dirigente che spetta loro come “produttori”. Questa esperienza si collocava, in una prospettiva rivoluzionaria, a sinistra del movimento socialista dell’epoca, ma in consonanza con altri fermenti della cultura italiana del periodo come quelli che facevano capo al neo-liberalismo di Piero Gobetti, che giudicò infatti positivamente l’opera del gruppo.
Gli avvenimenti. La nuova legge per il suffragio universale permette al Psi e al Partito popolare di eleggere rispettivamente 156 e 100 deputati, modificando radicalmente l’assetto del potere politico. A Parigi si inaugura la Conferenza di pace. Viene fondata a Mosca la Terza Internazionale (Comintern). Il congresso socialista di Bologna delibera l’adesione alla nuova Internazionale comunista.
1920
Lo sciopero degli operai dell’industria di Torino di marzo-aprile (sciopero delle lancette) per il riconoscimento dei consigli di fabbrica apre una vivace polemica tra la direzione socialista e il gruppo dell’Ordine nuovo, le cui posizioni politiche ricevono l’approvazione di Lenin. Gramsci si avvicina alla frazione astensionista del Psi, guidata da Bordiga, che prospetta la costruzione del Partito comunista.-
Gli avvenimenti. Giolitti torna a formare il governo. In settembre lo scontro sociale porta all’occupazione delle fabbriche. La sconfitta segna l’inizio del riflusso del movimento proletario. In Russia, i bolscevichi sbaragliano definitivamente gli eserciti controrivoluzionari.
1921
Gramsci si convince che bisogna dar vita a un partito nuovo, secondo le direttive di scissione già indicate dall’Internazionale comunista. Il 25 gennaio 1921 si apre a Livorno il 17° congresso nazionale del Psi; le divergenze tra i vari gruppi: massimalisti, riformisti ecc., inducono Gramsci e la minoranza dei comunisti a staccarsi definitivamente dal Psi. Il 21 gennaio dello stesso anno, nella storica riunione di San Marco, nasce il Partito comunista d’Italia: Gramsci sarà un membro del Comitato centrale. Come organo del nuovo partito Gramsci diresse, ancora a Torino, L’Ordine Nuovo, diventato quotidiano (al quale collaborò anche come critico teatrale Gobetti). Tuttavia nei primi anni del nuovo partito la sua attività fu condizionata dalla direzione di Bordiga, che avendo organizzato una frazione nazionale prima della scissione aveva acquisito una posizione di preminenza, influenzando anche gran parte dello stesso gruppo torinese dell’Ordine Nuovo..-
Gli avvenimenti. 15 gennaio 1921: si apre a Livorno il XVII Congresso del Psi. Il 21 gennaio, da una scissione minoritaria del Psi, nasce il Partito comunista d’Italia (Pcd’I), sezione italiana della Terza Internazionale comunista. Dopo la grande paura dell’occupazione delle fabbriche, gli industriali guardano con favore al movimento fascista. Lenin lancia la Nuova politica economica.-
1922
Nel secondo congresso del Pcd’I (Roma, marzo) Gramsci sostiene le posizioni della maggioranza bordighiana, in dissenso con la politica del “fronte unico” con il Psi proposto dall’Internazionale. A maggio parte per Mosca, delegato del partito italiano nell’esecutivo dell’Internazionale e nel giugno partecipa alla conferenza dell’esecutivo allargato. Il soggiorno in Russia sarà importante sia per la sua formazione politica che per la sua vita privata, infatti Gramsci si innamora di una giovane violinista russa, Giulia Schucht che diventerà sua moglie e dalla quale avrà due figli: Delio e Giuliano. In Russia Gramsci approfondisce le sue conoscenze del leninismo e osserva gli sviluppi della dittatura del proletariato, ciò gli consente di misurare diversamente i problemi dei comunisti italiani, collocandoli in una visione di più ampio respiro. –
Gli avvenimenti. Si moltiplicano le violenze squadristiche e gli assalti alle Camere del lavoro e ai giornali antifascisti. Ulteriore scissione socialista: il congresso di Roma (ottobre) espelle i riformisti. In ottobre marcia su Roma e formazione del governo Mussolini, che in novembre ottiene pieni poteri.-
1923
L’esecutivo allargato dell’Internazionale (giugno) discute la situazione italiana e stabilisce d’autorità la formazione di un comitato esecutivo del Pcd’I maggiormente rispondente alla propria politica. Gramsci, in dissenso con le posizioni di Bordiga e favorevole a quelle dell’Internazionale (che sostiene la parola d’ordine del “governo operaio e contadino”), si fa carico della svolta (lettera di settembre per la fondazione dell’Unità). In novembre, viene inviato a Vienna per tenere i collegamenti tra il partito italiano e gli altri partiti comunisti d’Europa. Inizia, con un fitto carteggio, a ricostruire il gruppo dirigente del Pcd’I attorno a quella che era stata la redazione dell’Ordine nuovo.-
Gli avvenimenti. Nel febbraio arresto di Bordiga e di parte del comitato esecutivo del Pcd’I, che si riorganizza semiclandestinamente. Bordiga, in carcere, si schiera contro le posizioni dell’Internazionale per quanto riguarda i rapporti con il Psi. Il parlamento italiano approva la legge elettorale maggioritaria presentata dal fascista Acerbo. In Bulgaria viene rovesciato il governo di Stambolijski, leader del partito contadino.
1924
Il 6 aprile del 1924, dopo una campagna elettorale contrassegnata da violenze e intimidazioni fasciste, si svolgono le elezioni e Gramsci viene eletto deputato della circoscrizione del Veneto, quindi torna in Italia, dopo due anni di assenza e si stabilisce a Roma. In febbraio esce a Milano, su indicazione di Gramsci, il quotidiano l’Unità. Continua il lavoro per ricostruire il gruppo dirigente del partito. Gramsci entra nel comitato esecutivo del partito e viene eletto segretario generale. Partecipa all’opposizione parlamentare che si forma a seguito del delitto Matteotti e propone un appello per lo sciopero generale. In agosto nasce a Mosca suo figlio Delio. Imposta con Grieco e Di Vittorio la politica del partito verso il Mezzogiorno. In ottobre propone che l’opposizione aventiniana si costituisca in Antiparlamento e in novembre il gruppo parlamentare comunista rientra in aula.
Gli avvenimenti. Le elezioni politiche di maggio, contrassegnate da violenze e intimidazioni, assegnano il 65 per cento dei suffragi ai fascisti. In giugno viene assassinato il deputato riformista Giacomo Matteotti che aveva denunciato i brogli; ne segue una vasta ondata di proteste. In agosto il gruppo socialista che fa capo a Serrati (i “terzini”) aderisce al Pcd’I. Alla morte di Lenin, in Unione Sovietica il potere viene assunto da una direzione collegiale formata da Stalin, Trockij, Zinov’ev e Kamenev.
1925
Tra marzo e aprile partecipa a Mosca ai lavori dell’esecutivo allargato dell’Internazionale. In giugno apre la polemica con la sinistra interna al partito, guidata da Bordiga. Inizia a lavorare all’organizzazione del terzo congresso del Pcd’I.–
Gli avvenimenti. Superata la crisi Matteotti, Mussolini torna saldamente alla guida del governo. Vengono abolite le commissioni interne e soppressa la libertà sindacale.
1926
In gennaio si svolge a Lione il terzo congresso del Pcd’I: le tesi politiche, stese da Gramsci e Togliatti, vengono approvate con una maggioranza che supera il 90 per cento. La linea di Gramsci, che raccolse intorno a sé un nuovo gruppo dirigente “centrista,” prevalse terzo congresso del Partito comunista d’Italia; alcuni mesi dopo però i suoi rapporti con l’Internazionale comunista subirono una prima incrinatura, con la sua iniziativa di scrivere una lettera allarmata al Comitato centrale del Partito bolscevico per le divisioni interne a quel partito. Pur dando torto all’opposizione la lettere conteneva anche riserve sui metodi della maggioranza (Stalin-Bucharin), e per questo motivo Togliatti, allora rappresentante a Mosca dei comunisti italiani, ritenne opportuno non inoltrarla ufficialmente. Ne nacque una vivace polemica personale tra Gramsci e Togliatti, rilevante soprattutto per l’insistenza da parte del primo sulla necessità di “richiamare alla coscienza politica dei compagni russi, e richiamare energicamente, i pericoli e le debolezze che i loro atteggiamenti stavano per determinare.” In agosto nasce Giuliano, il secondogenito di Gramsci. L’8 novembre, a seguito delle leggi eccezionali del regime fascista contro gli oppositori, Gramsci viene arrestato, con gran parte del gruppo dirigente comunista e, nonostante l’immunità parlamentare, è rinchiuso a Regina Coeli. Al processo, tenuto a Roma nel maggio-giugno 1928, fu condannato a oltre vent’anni di reclusione. Il 18 novembre Gramsci è assegnato al confino per cinque anni a Ustica, dove giunge dopo soste nelle carceri di San Vittore a Milano e in quelle di Napoli e di Palermo. A Ustica abita in una casa privata con altri condannati politici con i quali organizza corsi di cultura differenziati a seconda del grado di preparazione dei partecipanti, allo scopo di educare i proletari, per i quali è un dovere, dice, non essere ignoranti, se vogliono essere protagonisti della politica e creatori di una nuova società. Per espiare la pena, Gramsci è poi destinato alla casa penale di Turi (Bari): vi rimane fino al dicembre 1933.
Gli avvenimenti. In Italia vengono sciolti i partiti di opposizione; vengono istituiti il confino di polizia e il Tribunale speciale. La Camera dichiara decaduti i deputati aventiniani. In Unione sovietica Stalin riesce a isolare Trockij e Zinov’ev.-
1927
Trasferito dal febbraio nel carcere di San Vittore a Milano, in attesa del processo, inizia a progettare uno studio di ampio respiro sugli intellettuali italiani. Il 28 maggio inizia il processo e il 4 giugno viene emessa la condanna a vent’anni quattro mesi e cinque giorni di reclusione. Poiché soffre di emicrania cronica viene destinato alla casa penale di Turi ed è messo in una cameretta con altri cinque detenuti politici.
Gli avvenimenti. Con la Carta del lavoro il fascismo enuncia i principi dello Stato corporativo. Il X congresso del Pcus espelle Trockij, Zinov ‘ev e Kamenev; inizia la politica dell’industrializzazione forzata. –
1928
Alla fine di maggio, a Roma, Gramsci è processato. Il 4 giugno viene emessa la sentenza: come accennato, è di venti anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione. In luglio Gramsci raggiunge il carcere di Turi.
Gli avvenimenti. Il Gran consiglio del fascismo diviene organo dello Stato. Il VII congresso dell’Internazionale lancia la parola d’ordine dell’intensificazione della lotta alla socialdemocrazia.-
1929
In febbraio, nel carcere di Turi, Gramsci, ottenuto il permesso di scrivere in cella, inizia la stesura dei Quaderni dal carcere: saranno 21 nel 1933, quando lascerà Turi per Civitavecchia e complessivamente 33 nel 1937.
Gli avvenimenti. Patti lateranensi tra Italia e Vaticano. In Unione Sovietica Bucharin si oppone alla politica di collettivizzazione forzata e viene rapidamente emarginato da Stalin. Il X plenum dell’Internazionale enuncia la teoria del social-fascismo. Crollo della borsa di New York: inizia la grande depressione.
1930
Emergono dissensi con altri detenuti comunisti sulla politica da seguire dopo la caduta del fascismo: Gramsci sostiene la necessità di una fase democratica e propone la parola d’ordine della Costituente.
Gli avvenimenti. La grande depressione colpisce anche l’Italia. Il Pcd’I, sulla base dell’analisi dell’Internazionale che ritiene in crisi il regime, fa rientrare decine di quadri in Italia. –
1931
Nel 1931 Gramsci è colpito da una grave malattia, perciò il fratello Carlo ottiene che sia messo in una cella individuale, dove Gramsci cerca di organizzarsi una vita “normale”, fatta di studio, di riflessione, di elaborazione teorica del suo pensiero politico e sociale, di affetti e di ricordi, sforzandosi di restare a contatto con i suoi familiari e con la realtà. Peggiorano le condizioni di salute: in agosto Gramsci ha un’improvvisa emorragia.
Gli avvenimenti. Viene rapidamente smantellata dalla polizia la rete clandestina del Pcd’I. Vittoria elettorale repubblicana in Spagna. –
1932
Non ha esito il progetto di uno scambio di prigionieri politici, che avrebbe incluso anche Gramsci, tra l’Italia e l’Unione Sovietica.
Gli avvenimenti. Condonato alla Germania il debito di guerra. Salazar assume la guida del governo portoghese. Roosevelt promuove negli Usa il regolamento dell’economia.-
1933
In marzo, seconda grave crisi delle condizioni di salute di Gramsci. In novembre viene trasferito nell’infermeria del carcere di Civitavecchia e da qui, in dicembre, nella clinica del dottor Cusumano a Formia.
Gli avvenimenti. In Italia viene creato l’Iri. I nazisti assumono il potere in Germania. In Unione Sovietica viene varato il secondo piano quinquennale.-
1934
Riprende la campagna per la liberazione di Gramsci. In ottobre viene accolta la richiesta per la libertà condizionale.
Gli avvenimenti. Patto di unità d’azione tra Pci e Psi. In Germania Hitler assume la carica di capo dello Stato. In Unione Sovietica Zinov’ev e Kamenev vengono processati per tradimento: iniziano le grandi purghe.
1935
In giugno nuova crisi e aggravamento delle condizioni di salute di Gramsci. In agosto viene trasferito nella clinica “Quisisana” di Roma.
Gli avvenimenti. L’Italia invade l’Etiopia. Leggi antisemite in Germania. L’Internazionale adotta la tattica dei fronti popolari. –
1936
Lo stato di prostrazione fisica impedisce a Gramsci di lavorare ai Quaderni.
Gli avvenimenti. Dopo la conquista dell’Etiopia, l’Italia proclama l’impero. Le sinistre vincono le elezioni in Francia e in Spagna; qui le forze reazionarie rispondono con un pronunciamento militare: è la guerra civile.
1937
Terminato il periodo di libertà condizionale, Gramsci riacquista la piena libertà, ma è in clinica ormai morente. Muore per emorragia cerebrale il 27 aprile. Il giorno seguente si svolgono i funerali. Le sue ceneri vengono inumate al cimitero del Verano a Roma e trasferite, dopo la Liberazione, al Cimitero degli Inglesi.- La sua vita in carcere era stata anche amareggiata dai difficili rapporti stabilitisi con il partito che aveva diretto prima dell’arresto. In disaccordo con la linea politica adottata alla fine del 1929 su pressione del Komintern, allora in lotta non solo con il fascismo ma anche con la socialdemocrazia (definita come “socialfascismo”), si era trovato, come si è detto, in aperto conflitto con la maggioranza degli altri comunisti detenuti a Turi, e ciò lo aveva indotto a fare del suo isolamento la forma esclusiva della propria esistenza. Si spiega così perché la sua situazione non sia stata allora posta in discussione negli organi dirigenti operanti in esilio, con i quale i suoi rapporti furono sempre indiretti (con la mediazione dell’amico economista Sraffa che lavorava a Cambridge). Tuttavia dopo il 1934, con l’abbandono della propaganda sul “socialfascismo” e il prevalere della politica di unità antifascista, furono intensificate le campagne di stampa internazionali per chiedere la sua liberazione.
Gli avvenimenti. Crisi del governo di fronte popolare in Francia. Si internazionalizza la guerra civile spagnola. L’Italia aderisce al patto anti Comintern con Germania e Giappone. In Unione sovietica vengono accusati di tradimento e fucilati Radek e Tukacevskij.
Dovete immaginarvi la Sardegna come un campo fertile e ubertoso la cui fertilità è alimentata da una vena d’acqua sotterranea che parte da un monte lontano. Improvvisamente voi vedete che la fertilità del campo è scomparsa. Là dove erano messi ubertose vi è soltanto più erba bruciata dal sole. Voi cercate la causa di questa sciagura, ma non la troverete mai se non uscite dall’ambito del vostro campicello, se non spingete la vostra ricerca fino al monte da cui l’acqua veniva, se non arrivate a capire che lontano parecchi chilometri un malvagio o un egoista ha tagliato la vena d’acqua che alimentava la fertilità ubertosa del vostro campo.
VITA E OPERE
Nato d Ales, presso Oristano, nel 1891, Antonio Gramsci studiò lettere e filosofia all’ università di Torino. Non conseguì però la laurea perchè assorbito dall’ impegno politico cui si era dedicato appena giunto nel capoluogo piemontese. Esponente del movimento socialista torinese, seguì con profonda simpatia le vicende della rivoluzione di ottobre e l’ azione di Lenin e del partito bolscevico. Nel 1919 fondò a Torino “Ordine Nuovo”, una delle più importanti riviste politiche dell’ immediato dopoguerra. In essa egli sostenne in più modi una linea di sinistra radicale, riprendendo tra l’ altro varie idee sia leniniste che democratico -“consiliari”. Nel 1921, al celebre Congresso di Livorno, fu uno dei promotori della scissione del Partito socialista e della successiva fondazione del “Partito comunista d’ Italia” (PCI). Subito dopo compì, a Mosca e a Vienna, un’ importante esperienza di dirigente politico in seno all’ Internazionale Comunista. Eletto deputato al Parlamento nel 1924, nello stesso anno divenne segretario del Partito comunista e fondò il giornale “L’ Unità” (il cui significativo sottotitolo era “Quotidiano degli operai e dei contadini”). Ma poco tempo dopo, nel 1926, fu arrestato dalla polizia (sebbene godesse dell’immunità parlamentare) e successivamente (1928) condannato dal tribunale speciale fascista a vent’ anni di reclusione. La morte lo colse prematuramente nel 1937. Durante la prigionia, Gramsci riuscì a completare i propri studi e a partecipare in qualche modo al vivace dibattito sviluppatosi negli anni ’30 all’ interno del movimento comunista. Manifestò, in particolare, profonde riserve sulle posizioni dell’ Internazionale Comunista, che sosteneva l’ imminenza della caduta dei regimi capitalistici ed autoritari (a cominciare dal fascismo) e condannava duramente la condotta delle socialdemocrazie europee, accusate di “socialfascismo”. Gramsci respinse radicalmente tali valutazioni, e alla prospettiva di uno scontro rivoluzionario a breve termine col capitalismo contrappose una linea molto più articolata (la cosiddetta “guerra di posizione”), aperta all’ accettazione di fasi e modalità di lotta democratica considerate ineludibili. A fianco della riflessione immediatamente politica Gramsci non trascurò un impegno di carattere più teorico. Ottenuta una certa serie di libri e riviste grazie all’ aiuto di alcuni amici, egli seppe anzi realizzare studi e indagini di grande rilievo. I cosiddetti Quaderni del carcere sono l’ ammirevole frutto di questo lavoro, portato avanti in condizioni psicologiche e pratiche assai difficili. In essi Gramsci condensa sotto forma di appunti, pagine sparse e talora veri e propri saggi una ricerca intellettuale riguardante, con uguale passione e competenza, ambiti culturali diversi: la storia (soprattutto la storia dell’ Italia moderna e contemporanea), la filosofia (soprattutto la filosofia idealista e marxista), la teoria politica (con particolare riferimento ai problemi connessi alla rivoluzione socialista), la critica letteraria e della cultura. I temi principali sui quali conviene qui fermare brevemente l’ attenzione sono i seguenti: a) l’ interpretazione del risorgimento e della prospettiva di una rivoluzione socialista in Italia; b) interpretazione del marxismo teorico nel contesto della tradizione filosofica otto-novecentesca; c) la riflessione sulla società contemporanea e sui modi e gli strumenti di una sua trasformazione in direzione democratico-socialista.
L’indifferenza é il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, é la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perchè inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica.
RIASSUNTO GENERALE
Indubbiamente Antonio Gramsci é la figura più importante del marxismo italiano. Nato ad Ales (Oristano) nel 1891, grazie ad una borsa di studio si potè iscrivere, nel 1911, alla facoltà di lettere all’università di Torino, ma verso la fine del 1913 aderì al Partito Socialista e abbandonò gli studi per dedicarsi attivamente alla politica. Contrario alla linea riformista, saluta con entusiasmo la rivoluzione russa, da lui interpretata, specialmente in un articolo pubblicato sull’ Avanti! del 24/12/1917 e intitolato La rivoluzione contro il ‘Capitale’ , come la dimostrazione che l’iniziativa rivoluzionaria può avere successo anche saltando fasi (come quella dello sviluppo capitalistico, pressochè assente in un Paese arretrato come la Russia) previste invece come necessarie dalle interpretazioni gradualistiche del processo storico. Nel 1919 fondò il settimanale ‘L’ordine nuovo’ e appoggiò la costituzione dei consigli di fabbrica a Torino. Nel settembre 1920 ebbe luogo l’occupazione delle fabbriche e la lotta si estese in tutta la Penisola, mentre il Governo Giolitti manteneva una posizione neutrale. A Livorno, nel 1921, Gramsci partecipò al Congresso socialista, contribuendo alla scissione che diede luogo al Partito Comunista; nominato rappresentante del Partito Comunista presso la Terza internazionale risiedette per due anni a Mosca. Eletto deputato nel 1924, rientrò in Italia e fondò il quotidiano ‘l’Unità’ , ma nel 1926 fu arrestato (nonostante godesse dell’immunità parlamentare) dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato a 20 anni di carcere. Qui la sua salute andò peggiorando fino a portarlo alla morte, avvenuta nel 1937, in una clinica di Roma, poco dopo essere stato amnistiato. Nel 1929, in carcere a Turi, aveva iniziato la stesura di appunti e analisi che sarebbero stati pubblicati in 6 volumi dopo la guerra, fra il 1948 e il 1951, con il titolo Quaderni del carcere . Problema di Gramsci é quello di individuare le condizioni di possibilità per la transizione al comunismo nella specificità della situazione italiana. Egli ne scorse la via in un’alleanza tra gli operai del nord e i contadini del sud e, al tempo stesso, nella conquista di un’ egemonia sulla società civile, come preparazione alla conquista del potere, un’egemonia da attuare anche nei libri di storia, cercando di indurre gli studenti ad abbracciare il comunismo. La supremazia di una classe all’interno della società si manifesta, infatti, attraverso la forza e attraverso la direzione intellettuale e morale. Il momento della forza appartiene alla società politica, mentre quello del consenso appartiene alla società civile; gli intellettuali sono quelli che hanno il compito di ottenere il consenso, mentre la classe politica è costituita da quelli che si servono della forza per raggiungere quel che non é ottenibile con il consenso. Quest’ultima ha, dunque, bisogno di intellettuali al suo servizio, anche se questi pretendono o si illudono di essere indipendenti. Negli Stati moderni sta ai partiti, che Gramsci paragona al principe di Machiavelli, l’organizzazione, all’interno della società civile, delle forze necessarie per conquistare lo Stato, ma a tale scopo occorre prima ottenere l’egemonia nella società civile: di qui l’importanza degli intellettuali organici alla classe, di cui il partito rappresenta la punta avanzata. Gramsci ritiene che già Lenin avesse elaborato la teoria dell’egemonia, rivalutando ‘ il fronte della vita culturale ‘, cioè l’importanza del momento sovrastrutturale. L’egemonia politico-culturale, all’interno di una società, é conseguente alla formazione di quello che Gramsci, mutuando l’espressione da Sorel, definisce blocco storico : in esso le forze materiali sono il contenuto, mentre le ideologie sono la forma; grazie alle ideologie le forze materiali possono essere comprese nella loro specificità storica, mentre senza forze materiali le ideologie sarebbero solo vuote astrazioni. L’elemento popolare, infatti, ‘sente’, ma non sempre comprende e sa; l’elemento intellettuale, invece, ‘sa’, ma non sempre ‘sente’. L’errore dell’intellettuale sta nel ‘ credere che si possa sapere ‘ senza sentire ed essere appassionato, cioè nel credere di poter essere un intellettuale staccato dalle concezioni del mondo e dalle passioni del popolo-nazione: si tratta invece di saper spiegare storicamente e collegare queste visioni del mondo, e le passioni ad esse annesse, a una visione del mondo elaborata scientificamente. Gramsci è convinto che ‘ La maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano praticamente e nel loro pratico operare è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia ‘ ed è altresì convinto che l’attività pratica e quella intellettuale siano indisgiungibili: ‘ Non c’è attività umana da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale, non si può separare l’homo faber dall’homo sapiens. Ogni uomo infine, all’infuori della sua professione esplica una qualche attività intellettuale, è cioè un “filosofo”, un artista, un uomo di gusto, partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare. ‘. Se non avviene il collegamento delle visioni del mondo alla visione scientifica, gli intellettuali si trasformano in una casta o in un sacerdozio; quando, invece, si realizza un’unità organica, si costituisce una nuova forza sociale, un nuovo blocco storico. La politica é il momento di saldatura fra la filosofia, elaborata dagli intellettuali, e il senso comune. La filosofia in grado di fornire la teoria necessaria alla costituzione del nuovo blocco storico, incentrato sulla classe operaia e sull’alleanza coi contadini (da qui lo stemma del Partito Comunista: la falce dei contadini e il martello degli operai), é la filosofia della prassi , cioè il marxismo. Contro la tendenza oggettivistica a fare della dialettica un principio esplicativo sia della natura sia della storia, Gramsci rivendica l’irriducibilità del sapere sociale a quello naturale. La prassi comprende sia la globalità dell’azione umana nel mondo sia la trasformazione rivoluzionaria della realtà. Proprio la tensione rivoluzionaria permette la comprensione dei meccanismi di dominio e dei rapporti tra le classi sociali, nella cui indagine si delinea il pensiero storico e politico di Gramsci. Questo si concentra nella concezione del partito operaio come intellettuale collettivo , erede del compito di unificazione sociale rimasto incompiuto nel Risorgimento; e Gramsci scrive un’opera intitolata proprio ‘Il Risorgimento’: in essa vengono criticamente analizzati i risultati dei moti che portarono all’unita’ d’Italia e se ne denunciano i limiti proprio nella mancata attuazione di una rivoluzione che unisca la borghesia e il proletariato urbano alle campagne. Ad avviso di Gramsci, però, l’egemonia culturale in Italia é rappresentata dalla filosofia di Benedetto Croce, intellettuale organico al blocco storico dominato dalla borghesia. Nei confront i di Croce, egli intendeva in qualche modo compiere l’operazione di rovesciamento compiuta da Marx nei confronti di Hegel. La differenza, però, sta nel fatto che Croce é venuto dopo Marx: gran parte della sua filosofia, infatti, non é che un tentativo, ad avviso di Gramsci, di riassorbire il marxismo e subordinarlo all’idealismo. Individuando la centralità della storia etico-politica, Croce riconosce l’importanza del movimento sovrastrutturale dell’egemonia e, in questo senso, permette di sfuggire alle interpretazioni materialistiche, economicistiche e deterministiche del marxismo. La filosofia della prassi, facendo della concezione crociana della storia etico-politica un canone di ricerca empirica, può fare storia globale, non puramente parziale, cioè solo economica o solo etico-politica. In questo modo, essa si può configurare come vero e proprio storicismo , mentre quello crociano, parlando dello spirito e delle sue attività, rimane ancora imprigionato nelle maglie del linguaggio speculativo e teologico. Come storicismo coerente, la filosofia della prassi può perfino giungere alla conclusione di essere essa stessa un momento storico meramente transitorio, vincolato ad una fase della società, di cui essa esprime coscientemente le contraddizioni. Col passaggio al regno della libertà, cioè al comunismo, é prevedibile che anche la filosofia della prassi arrivi al tramonto per lasciar spazio a nuove forme di pensiero, non più originate dalle contraddizioni, ormai inesistenti nella nuova società comunista, caratterizzata dalla libertà e dall’uguaglianza. Nei Quaderni del carcere Gramsci parla di ‘ cesarismo ‘, riferendosi ad un conflitto in cui le due parti interessate sono in equilibrio, tanto che la situazione può solo risolversi con una distruzione reciproca:
‘ Si può dire che il cesarismo esprime una situazione in cui le forze in lotta si equilibrano in modo catastrofico, cioè si equilibrano in modo che la continuazione della lotta non può concludersi che con la distruzione reciproca. Quando la forza progressiva A lotta con la forza regressiva B, può avvenire non solo che A vinca B o B vinca A, può avvenire anche che non vinca né A né B, ma si svenino reciprocamente e una terza forza C intervenga dall’esterno assoggettando ciò che resta di A e di B. Nell’Italia dopo la morte del Magnifico è appunto successo questo, com’era successo nel mondo antico con le invasioni barbariche. Ma il cesarismo, se esprime sempre la soluzione “arbitrale”, affidata a una grande personalità, di una situazione storico-politica caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica, non ha sempre lo stesso significato storico. Ci può essere un cesarismo progressivo e uno regressivo e il significato esatto di ogni forma di cesarismo, in ultima analisi, può essere ricostruito dalla storia concreta e non da uno schema sociologico. È progressivo il cesarismo, quando il suo intervento aiuta la forza progressiva a trionfare sia pure con certi compromessi e temperamenti limitativi della vittoria; è regressivo quando il suo intervento aiuta a trionfare la forza regressiva, anche in questo caso con certi compromessi e limitazioni, che però hanno un valore, una portata e un significato diversi che non nel caso precedente. Cesare e Napoleone I sono esempi di cesarismo progressivo. Napoleone III e Bismarck di cesarismo regressivo. Si tratta di vedere se nella dialettica rivoluzione-restaurazione è l’elemento rivoluzione o quello restaurazione che prevale, poiché è certo che nel movimento storico non si torna mai indietro e non esistono restaurazioni in toto. Del resto il cesarismo è una formula polemico-ideologica e non un canone di interpretazione storica. Si può avere soluzione cesarista anche senza un Cesare, senza una grande personalità “eroica e rappresentativa”. Il sistema parlamentare ha dato anch’esso un meccanismo per tali soluzioni di compromesso. ‘
Il vero nemico contro cui muovere guerra diventa allora l’ indifferenza : ‘ l’indifferenza é il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, é la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perchè inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica ‘. Il pensiero di Gramsci, dove ideologia, filosofia e prassi politica trovavano una profonda unità, era volto verso la comprensione della reale situazione italiana dell’epoca e nella certezza della possibilità di trasformarla in senso socialista. Gramsci considerava il fascismo come punto massimo di crisi della società borghese (fascismo= massima espressione della dittatura del capitale), poiché alla classe dominante, cui era sfuggita l’egemonia sociale, intellettuale e morale, per la perdita del consenso delle masse, rimaneva solo la forza coercitiva. La valorizzazione del concetto di cultura, non più vista come fatto aristocratico, ma come mezzo per acquistare consapevolezza della realtà, portò Gramsci a elaborare la nozione di “organizzazione della cultura” che metteva in luce la necessità di esplicare rapporti profondi fra organizzazione economico-sociale e visione del mondo, fra lotta di classe e scoperta scientifica e artistica. La convinzione che la cultura aveva le sue radici nel terreno storico-pratico nel quale era contenuta e che quindi vi era identità tra filosofia e storia, lo indusse a polemizzare con l’idealismo di Croce, visto in funzione ideologica di conservazione borghese, e a individuare la funzione del nuovo intellettuale nella società contemporanea come portatore ed elaboratore professionale dell’ideologia del “blocco storico”, cioè della forza politica formata dall’unione di una classe con classi o gruppi alleati, di cui egli stesso era espressione. La straordinaria varietà dei suoi interessi, che lo hanno portato dall’esame della storia d’Italia e del Risorgimento alla teoria di uno Stato socialista e del partito che, “moderno principe”, doveva promuoverne la realizzazione, ha fatto sì che nel pensiero gramsciano fosse presente gran parte della problematica politico- culturale del secondo dopoguerra. Abbiamo già accennato all’interesse che Gramsci nutre per il Machiavelli quando arriva a dire che i partiti sono come il principe illustrato dal pensatore toscano: Gramsci é anche autore di un ‘ Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno ‘ , in cui vengono rovesciate le interpretazioni allora ricorrenti di un Machiavelli precursore dello stato fascista. Gramsci, non senza forzature, vede nel grande politico fiorentino un anticipatore del giacobinismo. Nei quaderni gramsciani il partito stesso assume il ruolo di un “Principe” dominatore e totalitario, quale neppure Machiavelli aveva mai disegnato: ” Il moderno Principe, sviluppandosi, sconvolge tutto il sistema di rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso o scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno Principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo. Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità e dell’ imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume.” (Quaderni del carcere) Il partito-Principe si trovava al vertice della piramide sociale e politica del nuovo mondo immaginato da Gramsci. Ma il partito era costituito dagli intellettuali. Essi sarebbero stati il Principe della società rinnovata. ” Che tutti i membri di un partito politico debbano essere considerati come intellettuali, ecco un’ affermazione che può prestarsi allo scherzo e alla caricatura; pure, se si riflette, niente di più esatto. Sarà da fare distinzione di gradi […] non è ciò che importa: importa la funzione che è direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè intellettuale ” (Quaderni del carcere). Rifuggendo dalle individualistiche torri di avorio, gli intellettuali dovevano immergersi nella vita pratica e trasformarsi in “dirigenti organici di partito”, dovevano diventare insomma “intellettuali organici” come si ripeté tanto spesso nei tempi in cui le idee di Gramsci imperavano. La classe operaia, teoricamente posta al centro della storia, non possedeva la capacità di emanciparsi da sola, come già aveva dimostrato Lenin con il suo ‘partito di quadri’. Per affrancarsi dallo sfruttamento capitalistico aveva bisogno del partito e dunque degli “intellettuali organici”. Da sola, sarebbe rimasta un corpo privo di testa. ” L’innovazione non può diventare di massa, nei suoi primi stadi, se non per il tramite di una élite ” (Quaderni del carcere). Ecco una delle ragioni per le quali il Partito comunista ebbe sempre tanto successo fra gli intellettuali: prometteva di risolvere il problema della civiltà nuova affidando proprio a loro posizioni di prestigio e di comando di gran lunga superiori a quelle che essi avevano mai raggiunte nel passato. Gramsci, come accennato con la teoria dell’ egemonia , riduceva la democrazia a un meccanismo “molecolare” di mobilità sociale, a un mero rinsanguamento del gruppo dirigente con elementi provenienti dai gruppi diretti: ” Tra i tanti significati di democrazia quello più realistico e concreto mi pare si possa trarre in connessione col concetto di egemonia. Nel sistema egemonico, esiste democrazia tra il gruppo dirigente e i gruppi diretti, nella misura in cui [lo sviluppo dell’ economia e quindi] la legislazione [che esprime tale sviluppo] favorisce il passaggio [molecolare] dai gruppi diretti al gruppo dirigente ” (Quaderni del carcere).Non vi son dubbi sul fatto che il pensiero di Gramsci fosse innovativo nei confronti del leninismo e dello stesso marxismo, proprio perché poneva in primo piano i valori politici della cultura.: “ Si può dire che non solo la filosofia della praxis non esclude la storia etico-politica, ma che anzi la fase più recente di sviluppo di essa consiste appunto nella rivendicazione del momento dell’ egemonia come essenziale nella sua concezione statale e nella valorizzazione del fatto culturale, dell’ attività culturale, di un fronte culturale come necessario accanto a quelli meramente economici e meramente politici ” (Quaderni del carcere). Tuttavia questa valorizzazione dei fatti culturali era posta al servizio di un disegno politico molto lontano dalla democrazia liberale. Ed è sintomatico, a questo proposito, che un comunista come Luciano Gruppi, nel 1976, arrivasse ad ammettere che, restando fedeli al disegno gramsciano, non si poteva arrivare al “pluralismo”. Luciano Pellicani, lo studioso che forse più di ogni altro ci ha aiutati a comprendere i limiti di Gramsci, ha sostenuto che restandogli fedeli non soltanto non si poteva arrivare al pluralismo, ma si giungeva addirittura al totalitarismo ecclesiale, vale a dire al monolitismo politico, economico e culturale, l’ esatto contrario della società aperta scaturita dal processo di secolarizzazione.Il comunismo è stato una dei più potenti movimenti politico-religiosi di tutti i tempi e Gramsci non si pose mai al di fuori di esso, contribuendo viceversa a irrobustirne le tendenze messianiche. Per spiegarcelo dobbiamo ricorrere a una spiegazione storica, questa volta legata alla grande crisi spirituale prodottasi nel mondo in seguito alla rivoluzione tecnologica. Stava crollando una grande civiltà, quella agricola, durata ben diecimila anni, e la nuova civiltà tecnologica appariva ancora informe, immatura, incapace di sostituirsi all’ antica. Si attendeva insomma il messia dei tempi nuovi. I terribili strumenti della prima guerra mondiale, dai gas asfissianti agli aereoplani, avevano per di più svelato come anche il progresso tecnologico possedesse un volto demoniaco, rafforzando di molto le attese messianiche indirizzate verso l’ instaurazione di un ordine nuovo, capace di riportare armonia nella civiltà in frantumi. Il giovane Gramsci condivise queste attese e, nella tumultuosa città di Torino, uscì dal suo isolamento di studente sardo, povero, infelice, stringendo legami di amicizia e di partito con tanti altri che, come lui, erano animati da queste eccitanti speranze. Il comunismo avrebbe interpretato la svolta epocale sostituendosi al cristianesimo: ” Il Partito è, nell’ attuale periodo, la sola istituzione che possa seriamente raffrontarsi alle comunità religiose del cristianesimo primitivo “, ma non certo al fine di perpetuarle. A giudizio di Gramsci il comunismo era anzi ” la religione che doveva ammazzare il cristianesimo. Religione nel senso che anch’ esso è una fede, che ha i suoi martiri e i suoi pratici; religione perché ha sostituito nelle coscienze al Dio trascendentale dei cattolici la fiducia nell’ uomo e nelle sue energie migliori come unica realtà spirituale ” (Sotto la mole). In campo estetico-letterario , la tesi centrale di Gramsci è stata l’affermazione del nesso inscindibile che deve unire lo scrittore al popolo, delle cui esigenze materiali e spirituali egli deve farsi interprete (concetto di “intellettuale organico”). Di qui la polemica contro il cosmopolitismo, dovuto all’influsso esercitato dalla Chiesa sulla formazione degli intellettuali italiani, e contro l’apoliticismo, tara storica della cultura italiana dal Rinascimento in avanti; e la duplice, correlativa negazione sia di un’arte cosmica, ispirata ai valori astratti dell’umanità, sia di un’arte pura e individuale, che non si può giustificare, dal momento che i fatti artistici non si producono per partenogenesi, ma “con l’intervento dell’elemento maschile che è dato dalla storia”. La letteratura, secondo Gramsci, avrebbe dovuto essere nazionale-popolare, cioè operare una sintesi tra la componente culturale indigena (la “nazione”) e le esigenze di conoscenza che vengono dagli strati subalterni (il “popolo”). In questa prospettiva si colloca l’auspicato ritorno a De Sanctis, che Gramsci considerava come il più valido esponente della cultura della borghesia nazionale nella sua fase progressiva, mentre Croce ne rappresentava la fase difensiva e conservatrice. Gramsci scrive: ‘ Il tipo di critica letteraria propria della filosofia della prassi è offerto dal de Sanctis, non dal Croce o da chiunque altro (meno che mai dal Carducci): essa deve fondere la lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni del mondo, con la critica estetica o puramente artistica nel fervore appassionato, sia pure nella forma del sarcasmo ‘. E bellissimi, dal punto di vista letterario, sono i Quaderni del carcere, in cui Gramsci affronta in forma frammentaria, ma con rigoroso metodo marxista, alcuni fondamentali temi della storia italiana come quello degli intellettuali attivamente impegnati nel dibattito politico e culturale, delle carenze del partito d’azione e dei caratteri della letteratura nazional-popolare. Egli fa inoltre una scrupolosa opera di informazione sull’ evolversi della rivoluzione bolscevica in Russia e di sostegno dello stesso movimento. ‘Bisogna impedire a questo cervello di funzionare’ aveva detto Mussolini a proposito di Gramsci e ne aveva ordinato l’arresto e la reclusione; ma con i 32 Quaderni del carcere, in cui, nell’odissea di indicibili sofferenze che lo distrussero nel fisico, era venuto affidando alla scrittura minuta e precisa il frutto delle sue meditazioni (fortunosamente salvati dalla cognata Tatiana Schucht) proponevano alla commossa ammirazione degli uomini di ogni fede una straordinaria testimonianza di consapevolezza storica e di forza morale, un inestimabile patrimonio spirituale, un grande tesoro di cultura; Mussolini si era sbagliato: sì, perché in carcere il cervello di Gramsci funzionò come non mai, con spirito critico degno di un acuto osservatore e di uno spirito caparbio e tenace. Le ‘Lettere dal carcere’ sono poi uno dei più splendidi e commoventi epistolari della nostra letteratura, hanno messo in luce le qualità di scrittore di Gramsci, la sua intensa umanità, lo straordinario equilibrio con cui seppe affrontare le sofferenze del carcere, che, anche se insostenibili, egli affrontò con cuore sereno: ‘ il mio stato d’animo é tale che se anche fossi condannato a morte, continuerei a essere tranquillo e anche la sera prima dell’esecuzione magari studierei una lezione di lingua cinese per non cadere più in quegli stati d’animo volgari e banali che si chiamano pessimismo e ottimismo. Il mio stato d’animo sintetizza questi due sentimenti e li supera: sono pessimista con l’intelligenza, ma ottimista con la volontà ‘. Anche nella triste e tetra solitudine del carcere egli seppe mantenere la forza e la costanza, senza rinunciare ai suoi ideali, che non stentano a trasparire nelle lettere inviate a familiari e amici: in una lettera al primogenito Delio, lasciato ancora infante, egli scrive: ‘ Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa ‘. Sognare ad occhi aperti o fantasticare per Gramsci è inutile, è prova di mancanza di carattere e di passività: ‘ occorre invece violentemente attirare l’attenzione nel presente così com’è, se si vuole trasformarlo ‘. Gramsci, oltre che di filosofia e di politica, si interessò anche di letteratura e, tra le sue tante riflessioni in merito, è doveroso ricordare quella su ‘I promessi sposi’ di Manzoni : in Letteratura nazionale , dopo aver preso in esame il termine di ‘umili’, Gramsci esamina i seguenti caratteri della posizione del Manzoni nei loro confronti. 1) Lo scrittore lombardo assume un atteggiamento di ‘compatimento’ scherzoso verso di loro, mostrando ‘ condiscendente benevolenza, non medesimezza umana ‘ (a differenza di quanto accade in Tolstoij), un senso di distanza e un ‘ distacco sentimentale ‘. 29 Nega loro ‘ vita interiore ‘, riservandola solo ai potenti, ai colti e ai ricchi: a fare riflessioni profonde sono solo personaggi del calibro dell’ Innominato o di Don Rodrigo, non certo gli umili come Agnese, Lucia o Perpetua. 3) La sua opera è priva di ‘ spirito nazional-popolare ‘e nutrita invece di classicismo distaccato e aulico. 4) Il popolo non è voce di Dio, come in Tolstoij, poiché per il cattolico Manzoni è la mediazione della Chiesa a rappresentare l’unico interprete possibile della parola divina.
La maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano praticamente e nel loro pratico operare è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia. (Quaderni del carcere, 10, II)
L’INTERPRETAZIONE DEL RISORGIMENTO
Gramsci ha meditato a lungo sul processo storico che, nel secolo XIX, ha prodotto la travagliata costituzione dello stato italiano unitario. A suo avviso, tale processo è stato diretto fondamentalmente da forze moderate, e il cosiddetto Partito d’ azione (cioè il complesso di gruppi e di correnti che si richiamavano in parte a Mazzini e a Garibaldi) si è rivelato incapace di svolgere un’opera adeguatamente incisiva e trasformatrice nel contesto politico del tempo. Quella risorgimentale è stata, per usare una celebre espressione gramsciana, una ” rivoluzione mancata ” – e la causa e la natura di tale “mancanza” sono state essenzialmente di carattere sociale. In effetti il limite storico del Partito d’ azione va individuato nel fatto che è rimasto sempre un partito borghese di élite, non disposto o non capace di ricercare l’ appoggio dei ceti non borghesi. Quali ceti? E’ qui che Gramsci mostra la sua relativa eterodossia rispetto alle tesi canoniche del marxismo. Egli sa bene che nell’ Italia dell’ Ottocento non c’ era un proletariato industriale e tanto meno una classe operaia organizzata – ossia il solo soggetto sociale in grado, secondo i princìpi marxisti, di promuovere una trasformazione radicale della società. L’ autore dei Quaderni del carcere ritiene però che il risorgimento avrebbe potuto e dovuto ugualmente assumere un carattere rivoluzionario, acquisendo il consenso dei contadini. Proprio questi ultimi costituivano, infatti, quella massa popolare la cui partecipazione all’ azione risorgimentale le avrebbe dato un sostanziale contenuto sociale e un adeguato impulso rinnovatore. Gramsci precisa che il movimento democratico avrebbe realizzato tale disegno e tale strategia se fosse stato capace di farsi partito “giacobino”: se avesse saputo far propri gli interessi e le esigenze della classe contadina attraverso una riforma agraria volta a spezzare il latifondo e a creare un ceto di contadini piccoli proprietari. Proprio questo obiettivo era stato tenuto presente dai giacobini francesi, i quali avevano in tal modo evitato l’ isolamento delle città e convertito le campagne alla rivoluzione. Solo così essi erano riusciti a superare la situazione di minoranza elitaria in cui si erano trovati inizialmente, e a sconfiggere le forze della reazione aristocratica. Tutto ciò non significa per Gramsci che il risorgimento sia stato un processo storico completamente negativo. In effetti esso ha favorito non solo l’ unificazione della penisola ma anche la crescita della borghesia, gettando con ciò alcune premesse per lo sviluppo di una fase capitalistica in Italia. D’ altra parte tale sviluppo si è realizzato in misura insoddisfacente; inoltre il nuovo stato si è costituito su una base sia economico sociale che politica assai ristretta. In effetti, per un verso il neonato capitalismo (concentrato nelle sole regioni settentrionali), non ha potuto usufruire di un adeguato mercato per i suoi prodotti, a causa dell’ arretratezza economica della società italiana, soprattutto meridionale. Per un altro verso le masse indigenti (in primo luogo i ceti contadini) abbandonate sostanzialmente a loro stesse, non sono riuscite a divenire parte attiva della nuova compagine statuale. Quanto ai raggruppamenti politici anche più aperti e democratici, si sono rivelati incapaci di approfondire i loro legami con le forze sociali potenzialmente disponibili a un’ azione di reale emancipazione. Se tutto ciò è vero, si tratta per Gramsci di elaborare le condizioni di una profonda trasformazione della realtà italiana emersa dal processo risorgimentale: una trasformazione il cui obiettivo finale deve essere quella rivoluzione sociale – anzi socialista – che il risorgimento non ha saputo compiere. A giudizio di Gramsci, tale rivoluzione potrà essere fatta solo attraverso un’ alleanza tra proletariato settentrionale e contadini meridionali: sono essi, infatti, i soggetti sociali concretamente interessati alla realizzazione di un progetto politico così impegnativo e radicale.
Il comunismo è la religione che deve ammazzare il cristianesimo. Religione nel senso che anch’esso è una fede, che ha i suoi martiri e i suoi pratici; religione perché ha sostituito nelle coscienze al Dio trascendentale dei cattolici la fiducia nell’uomo e nelle sue energie migliori come unica realtà spirituale.
IL MARXISMO STORICISTICO-DIALETTICO
Ma la riflessione gramsciana non mira soltanto a un determinato, pur complesso e ambizioso, obiettivo politico. Non diversamente da quanto aveva fatto Lukàcs, essa mira anche a rivisitare criticamente il marxismo come teoria: e ciò con lo scopo, in primo luogo, di liberarlo dalle incrostazioni positivistiche ed economistiche e di valorizzarne l’ essenza storicistica e dialettica. Solo attraverso questo lavoro di “depurazione” il marxismo potrà, secondo Gramsci, ritrovare la propria ispirazione più profonda e originale, sostenere il confronto con le filosofie più influenti dell’ età presente (a cominciare da quella idealistica), e diventare così lo strumento teorico-politico rivoluzionario delle classi oppresse. Come Lukàcs, anche Gramsci respinge l’ identificazione del metodo del marxismo coi metodi delle scienze empiriche, perchè ciò lo priverebbe del suo nucleo essenziale, la dialettica. In polemica col filosofo sovietico Bucharin, che aveva presentato il marxismo come una sociologia scientifico-materialistica, Gramsci sostiene che tale sociologia è la ” filosofia dei non filosofi, un tentativo di descrivere e classificare schematicamente fatti storici e politici, secondo criteri costruiti sul modello delle scienze naturali “. Alla base della sociologia c’ è secondo Gramsci, un ” evoluzionismo volgare ” che ” non può conoscere il principio dialettico col suo passaggio dalla quantità alla qualità, passaggio che turba ogni evoluzione e ogni legge di uniformità intesa in senso volgarmente evoluzionistico “. E invero la sociologia, e più in generale le scienze empirico-naturali, studiano i fenomeni come dati puramente quantitativi e omogenei, connessi tra loro da legami causali e necessari (sicchè l’ effetto non può mai “superare” la causa). In tal modo esse si vietano a priori di comprendere adeguatamente il mondo umano-sociale. Quest’ ultimo per Gramsci, va concepito in effetti non come un inerte insieme di eventi concatenati deterministicamente l’ uno all’ altro, bensì come un vivente sviluppo storico-dinamico dotato di un suo senso e di una sua direzione. Ora, l’ unico modo e strumento teorico per comprendere la realtà come sviluppo storico è il modo/strumento dialettico. Solo la dialettica, a ben guardare, è in grado di cogliere unitariamente l’ orizzonte complesso (la “totalità”) in cui si inscrivono gli eventi umani, e al cui interno soltanto essi acquistano il loro significato. Solo essa, inoltre è capace di cogliere il movimento, la natura processuale ed autotrasformatrice di questa “totalità”. E non basta. Nella misura in cui la dialettica evidenzia per un verso il senso (il senso anche politico) delle vicende umane e per un altro la non-assolutezza, la storicità di queste ultime, essa sollecita l’ uomo a congiungere all’ analisi puramente cognitiva del mondo una presa di posizione pratica: la presa di posizione di chi vuole (e, insieme, ritiene possibile) trasformare tali vicende. Sotto questo profilo, la dialettica si configura non solo come una certa metodologia di indagine della realtà umana, e neppure come il mero superamento di una concezione naturalistico-meccanicistica di tale realtà, bensì anche come la precondizione di quel nesso di teoria e prassi, di conoscenza e azione che anche per Gramsci (come già per Lukàcs) è il principio più prezioso del marxismo. Risoluto critico di ogni interpretazione positivistico-evoluzionistica del marxismo, Gramsci è avversario non meno radicale di una sua lettura in chiave strettamente materialistica, o ” materialistico-volgare “. Se accetta la definizione canonica del marxismo come “materialismo storico”, sottolinea però con forza la necessità di ” posare l’ accento sul secondo termine ‘storico’ e non sul primo, di origine metafisica “. Si noti: per Gramsci il materialismo è essenzialmente “metafisica”. Anche la distinzione fra soggetto e oggetto e la correlata affermazione della “realtà oggettiva” del mondo esterno sono per lui mere affermazioni del senso comune, che questo ha ereditato dalla religione (secondo la quale è indubitabile che l’ uomo ‘trova’ un mondo già dato e creato da Dio). In verità , avverte Gramsci, per una filosofia laica e moderna ” oggettivo significa sempre ‘umanamente soggettivo’, ciò che non può non corrispondere esattamente a ‘storicamente soggettivo’ “. In altri termini, se nell’ ottica del materialismo e del realismo metafisico “oggettivi” significa un’ oggettività che esiste al di fuori dell’ uomo, per il marxismo, invece, la realtà esiste e può essere conosciuta solo in rapporto all’ uomo. In questa prospettiva Gramsci giunge a vedere una connessione tra l’ affermazione idealistica che la realtà è una creazione dello spirito umano e la concezione marxista del mondo: nel senso che anche per il marxismo non esiste il mondo in sé, ma esiste la coscienza umana del mondo, esiste una certa consapevolezza che gli uomini hanno delle situazioni e delle strutture nelle quali operano. Se questo è vero, allora va detto che il marxismo può e deve sostituire ” la concezione della realtà oggettiva del mondo esterno nella sua forma più triviale e acritica ” con una concezione più elevata e sofisticata. Qual’ è questa concezione? Qual’ è la corretta interpretazione della realtà? La filosofia per Gramsci risponde a questo duplice quesito in modo assai preciso. In primo luogo la realtà di cui il marxista deve occuparsi è essenzialmente la realtà umana, oppure la realtà naturale in quanto esperita/trasformata dall’ uomo. In secondo luogo, di tale realtà occorre rilevare e valorizzare anzitutto la sua natura di “sistema”, di “totalità”. Guidato da una razionalità profonda, l’ universo sociale tende per Gramsci a inverare i fenomeni particolari in strutture sempre più complesse, sempre più consapevoli delle proprie leggi e delle proprie contraddizioni. Il primo ispiratore di tale concezione (e, insieme, della particolare versione gramsciana del marxismo) è Hegel. Sotto più profili, Gramsci è (con Gentile e Croce) uno dei più significativi esponenti italiani della rinascita dell’ hegelismo che ha avuto luogo in Europa nel primo terzo del Novecento. Non diversamente da Lukàcs, anch’ egli insiste sulla sostanziale continuità tra il pensiero di Hegel e la dottrina marxiana e marxista. Grazie alla dottrina hegeliana, egli scrive, ” si riesce a comprendere cos’ è la realtà […]. In un certo senso, la filosofia della prassi (= il marxismo) è una riforma e uno sviluppo dello hegelismo, è una filosofia liberata (o che cerca di liberarsi) da ogni elemento ideologico unilaterale e fanatico, è la coscienza piena delle contraddizioni del mondo “. A Hegel e alla tradizione dialettica (della quale Marx è l’ interprete più valido) va inoltre attribuito, per Gramsci, il merito di aver concepito il reale come movimento e come processo. Tale processo è la storia, di cui la dialettica costituisce in qualche modo la legge. Se la storia e la dialettica sono senza dubbio uno dei temi della riflessione gramsciana, è però anche vero che Gramsci non intende assolutamente farne (rispettivamente) una realtà e una norma necessarie-trascendenti. In effetti, l’ unica realtà effettiva è rappresentata per lui solo dai soggetti umani. Solo il loro concreto impegno, la loro concreta attività promuovono il cammino storico e il progresso sociale. Per questo al centro del pensiero gramsciano si colloca non tanto (hegelianamente) la logica del reale e neppure (marxianamente) la dinamica oggettiva delle contraddizioni economico-sociali, bensì (umanisticamente) l’ opera di quelli che vengono chiamati gli ” omini reali “: coi loro bisogni e i loro progetti , i loro conflitti e le loro iniziative.
Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo della vita stessa.
LA PRASSI E IL RAPPORTO CON CROCE
Il concetto che esprime nel modo più diretto la prospettiva “umanistica” e “attivistica” della fiosofia gramsciana è quello di “prassi”. La sua origine è rintracciabile nell’ opera di Antonio Labriola, il quale con questa nozione si era proposto di superare criticamente le concezioni da un lato idealistiche e coscienzalistiche, dall’ altro naturalistiche e positivistiche dell’ umano e del sociale. Per quanto riguarda Gramsci, egli intende sviluppare e approfondire un programma teorico per più versi analogo a quello labriolano. Nel suo pensiero la prassi si configura, in qualche misura, come una mediazione tra gli uomini e la realtà in quanto natura ed esperienza e in quanto complesso di tradizioni e istituzioni. La prassi è, infatti, la maniera in cui gli agenti storico-sociali conoscono e trasformano il mondo impegnando le loro cognizioni ed energie e tenendo conto del contesto concreto in cui operano. E’ inoltre, attraverso la prassi che ( a parte subiecti ) gli uomini realizzano la loro crescita ed emancipazione sociale, e che ( a parte obiecti ) la storia procede nel suo travagliato itinerario. In conclusione, l’ essenza più originale e profonda della filosofia gramsciana sembra costruita dal quadruplice tema dell’ assenza di fondamenti trascendenti l’ operare umano (immanentismo), della necessità di concepire la struttura sociale in modo storico-concreto (antispeculativismo), della centralità degli uomini come soggetti, valori e motori del cammino storico (umanesimo) e della radicale storicità delle situazioni pratiche e delle dottrine intellettuali (ivi compreso lo stesso marxismo). ” La filosofia della praxis deriva certamente dalla concezione immanentistica della realtà, ma da essa in quanto depurata da ogni aroma speculativo e ridotta a pura storia o storicità o a puro umanesimo. Se il concetto di struttura viene concepito ‘speculativamente’ certo esso diventa un ‘dio ascoso’; ma appunto esso non deve essere concepito speculativamente ma storicamente, come l’ insieme dei rapporti sociali in cui gli uomini reali si muovono e operano. La filosofia della praxis è la concezione storicistica della realtà che si è liberata di ogni residuo di trascendenza e di teologia. ” (Quaderni del carcere, IX, 1, VIII). Un cenno a parte merita, infine, la posizione assunta da Gramsci nei confronti di Croce: e ciò sia per i consensi, sia per i dissensi espressi verso una filosofia di cui il pensatore sardo colse assai bene l’ importanza teorica e le ragioni del successo storico. Per Gramsci il motivo più sostanziale della grande diffusione e popolarità delle concezioni di Croce è ” intrinseco al suo stesso pensiero e al metodo del suo pensare “, ed è da ricercare ” nella maggiore adesione alla vita della filosofia del Croce che di qualsiasi altra filosofia speculativa “. Rispetto a quelle dei filosofi “tradizionali”, infatti, le principali caratteristiche della dottrina crociana sono, secondo Gramsci, le seguenti: ” dissoluzione del concetto di ‘sistema’ chiuso e definito e quindi pedantesco e astruso in filosofia: affermazione che la filosofia deve risolvere i problemi che il processo storico nel suo svolgimento presenta volta a volta “. In questa adesione della filosofia crociana alla vita e alla storia, nella sua lotta contro la trascendenza e la teologia, Gramsci individua il forte influsso esercitato su Croce dalla “filosofia della prassi”. Non è un caso, sottolinea Gramsci, che quando andava gettando le basi della propria concezione Croce avesse assunto verso il marxismo un atteggiamento tutt’ altro che negativo. Egli aveva scorto in esso, in particolare, un fecondo canone empirico per l’ interpretazione della storia. Inoltre, aveva giudicato la teoria del valore-lavoro il risultato di un paragone ‘ellittico’ fra un’ astratta società lavoratrice e la società borghese moderna: ma non aveva negato qualsiasi valore a quel paragone, ammettendo anzi che costituiva un notevole contributo ad un’ economia sociologica comparata. Infine aveva ricavato dalla filosofia della prassi alcune tesi di fondamentale importanza: dalla dottrina dell’ origine pratica dell’ errore (” l’ errore del Croce è l’ illusione dei filosofi della prassi “) alla concezione delle ideologie politiche considerate costruzioni pratiche e strumenti di direzione politica. Senonchè Croce, secondo Gramsci, ha poi inserito tutti questi elementi realistici all’ interno di una dottrina ‘speculativa’ (nel senso negativo del termine) che costituisce un grave arretramento non solo rispetto alla filosofia della prassi, ma anche rispetto allo stesso hegelismo. Anzi la concezione di Croce costituisce per Gramsci una sorta di ” hegelismo mutilato ” in quanto stravolge, ‘addomesticandola’ la dialettica hegeliana: ” L’ errore filosofico (di origine pratica!) di tale concezione consiste in ciò, che nel processo dialettico si presuppone ‘meccanicamente’ che la tesi debba essere ‘conservata’ dall’ antitesi per non distruggere il processo stesso, che pertanto viene ‘preveduto’, come una ripetizione all’ infinito, meccanica, arbitrariamente prefissata. In realtà si tratta di uno dei tanti modi di ‘mettere le brache al mondo’, una delle tante forme di razionalismo antistoricistico. La concezione hegeliana, pur nelle sua forma speculativa, non consente tali addomesticamenti e costrizioni mutilatrici. ” (Quaderni del carcere, X, 1, VI)
Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. (Lettera al figlioletto Delio)
L’EGEMONIA DELLA CLASSE OPERAIA
La forte accentuazione della componente umanistico-‘prassistica’ della realtà sociale ha sollecitato Gramsci a rivedere alcuni concetti centrali del marxismo, soprattutto nell’ ambito della teoria socio politica. Di particolare rilievo è la sua presa di posizione dinanzi alla questione della natura della sovrastruttura e del suo rapporto con la struttura. Gli stessi Marx ed Engels erano parsi in più occasioni ambigui nell’ interpretazione di tale questione. Successivamente, una parte cospicua del marxismo ufficiale aveva inclinato a privilegiare la struttura (economica) e a considerare la sovrastruttura (politica, istituzionale, culturale) una mera conseguenza o proiezione della prima. Ora, tra i marxisti primo-novecenteschi Gramsci è uno di coloro che modifica questa posizione nel modo più radicale. Per lui la sovrastruttura è una dimensione legata si a precise premesse di carattere socio-economiche: ma è dotata anche di una sua precisa e irriducibile specificità, che reclama un tipo di analisi e di intervento appropriato a tale specificità. Questa concezione della sovrastruttura è la premessa di un’ altra importante innovazione introdotta da Gramsci nella concezione marxista: quella relativa al concetto di società civile . Anche a proposito di tale fondamentale ‘figura’ dell’ intera tradizione dialettica il marxismo tra Otto e Novecento era parso poco propenso a fornire un’ immagine in qualche modo autonoma. Per Lenin e per altri teorici marxisti la società civile costituiva puramente la sfera dei rapporti materiali dell’ esistenza associata: essa veniva collegata cioè alla dimensione strutturale. Per Gramsci, invece, la società civile è da riferire essenzialmente alla sovrastruttura. Essa comprende per lui un ricco complesso di istituzioni e di funzioni sociali: la chiesa, i partiti, i sindacati, la stampa, i centri produttori di idee e ideologie. Ora tale complesso, se indubbiamente dipende da una determinata situazione socio-economica, altrettanto indubbiamente opera in un modo articolato, molteplice, che non consente di appiattirne entro schemi semplicistici la sua fisionomia e la sua azione. Con particolare riferimento alla realtà politico-sociale d’ occidente ciò significa che non si può ridurre la società civile a mera proiezione meccanica e passiva del sistema capitalistico. In effetti, secondo Gramsci alcune delle sue componenti contengono tendenze e tensioni conflittuali nei confronti delle strutture socio-economiche dominanti: di quì la necessità di un’analisi capace di cogliere le potenzialità di sviluppo critiche della società civile. Tale concezione ha anche importanti implicazioni pratiche. Essa sollecita infatti a prestare molta attenzione alle possibilità di azione trasformatrice su istituzioni e modalità di vita che un certo marxismo tendeva (perchè “sovrastrutturali”) a trascurare. L’iniziativa politica si viene così articolando per Gramsci in direzioni che investono i più diversi aspetti e livelli della convivenza sociale. A questo proposito egli ha lasciato in eredità tutta una serie di indicazioni sulle quali il pensiero marxista successivo è tornato spesso ad interrogarsi. Sempre nell’ambito della teoria politica è da sottolineare l’interpretazione per molti versi innovatrice che Gramsci dà, da un lato, della dialettica tra le classi, dall’altro delle funzioni e modalità d’azione del partito rivoluzionario. Estremizzando alcune tesi di Marx ed Engels, un certo marxismo aveva innegabilmente semplificato oltre il lecito il tema della lotta di classe, riportandola ad un puro e semplice scontro frontale tra capitalisti e lavoratori. Ora Gramsci, pur senza contestare la concezione marxista della dinamica fondamentale del capitalismo (crescente concentrazione del capitale, crescente impoverimento del proletariato, conflitto finale tra i due), ridisegna tale quadro in modo più sottile. Anzitutto, egli tende a non ridurre la competizione sociale alla meccanica contrapposizione tra le due forze; in secondo luogo prospetta interessanti strategie di alleanza tra diversi ceti e forze sociali; in terzo luogo sembra ammettere processi di trasformazione socialista del mondo capitalistico diversi da quelli teorizzati dal marxismo tradizionale. Sotto questo profilo, particolarmente rilevante appare la preferenza accordata alla nuova nozione di ” egemonia ” rispetto a quella di “dittatura” del proletariato. L’ “egemonia” di cui Gramsci parla a più riprese sembra infatti alludere non solo a un meccanismo più articolato e meno violento di transizione al socialismo, ma anche a un processo in cui le altre forze e ideali hanno la possibilità di cooperare col proletariato alla costruzione di una società più giusta e libera. Ma non basta. A proposito del ruolo privilegiato della classe operaia, Gramsci sottolinea ch’esso non è esclusivamente il prodotto necessario di una certa condizione economico-sociale. O, almeno, è indispensabile che la classe operaia sappia divenire quella che Gramsci definisce la “classe dirigente”. Classe dirigente non è agli occhi di Gramsci la stessa cosa che “classe dominante”: la prima espressione implica la duplice capacità del proletariato organizzato di elaborare una linea d’azione adeguata ai tempi e alle circostanze, e di conquistare autorità e seguito entro il sistema politico-sociale. La principale verifica della capacità dirigenziale della classe operaia è l’acquisizione del ” consenso “, un’altra originale nozione teorica del pensiero gramsciano. Il consenso è il riconoscimento della validità della prospettiva e della strategia elaborate dal partito rivoluzionario da parte di altre organizzazioni politiche e di ampi gruppi sociali. Esso deve essere ottenuto non solo in sede strettamente politica, ma anche nell’ambito della società civile, attraverso un’opera di persuasione che sappia influenzare le varie componenti e istituzioni di quest’ultima. Dal punto di vista politico, è necessario che il consenso sia conseguito a livello di massa, con particolare riferimento ai ceti sfruttati e subalterni. Su un altro versante il consenso può e deve essere ricercato anche presso la borghesia, o almeno presso le sue file socialmente e ideologicamente più avanzate. Su questo piano, in ideale rapporto col concetto di consenso sta l’altra e non meno nuova nozione gramsciana di ” blocco storico “: un’espressione con la quale Gramsci indica la possibilità/necessità di istituire un’alleanza (per più versi inter- o meta-classista) tra tutte le forze politico-sociali interessate alla modernizzazione e all’innovazione in senso democratico (e, in seconda approssimazione, socialista) del paese.
Il partito prende il posto, nella coscienza, della divinità e dell’imperativo categorico .
IL PARTITO E GLI INTELLETTUALI
La realizzazione del consenso, del blocco storico e, ancor prima, di una prospettiva di trasformazione della società richiede per Gramsci un’organizzazione politica appropriata. Non diversamente da Lenin, Gramsci dà anzi un rilievo centrale al momento propriamente organizzativo dell’azione politico-sociale: ” una massa non si ‘distingue’ e non diventa ‘indipendente’ senza organizzarsi “. E anche Gramsci, come Lenin, individua nel partito la struttura in grado di porre in essere nel modo più efficace tale organizzazione. Riflettendo sui caratteri e le funzioni che il partito deve avere nell’età contemporanea, egli riscopre l’attualità delle idee di un autore a lui (come a Croce) molto caro: Machiavelli. Per Gramsci il partito è e dev’essere, in larga misura, la reincarnazione del Principe machiavelliano. Naturalmente, come chiariscono alcune celebri pagine dei Quaderni , questo ” moderno Principe ” non può essere (come in Machiavelli) ” una persona reale, un individuo concreto “: esso è invece ” un organismo, un elemento di società complesso nel quale già abbia inizio il concretarsi di una volontà collettiva riconosciuta ed affermatasi parzialmente nell’azione . ” Tuttavia, non diversamente dal Principe, il partito opera in modo specificamente ed esclusivamente politi- co, in vista di fini e obiettivi pur essi soltanto politici. Di conseguenza esso si riferisce a una scala di valori e a criteri di condotta, i quali non possono essere valutati alla luce di astratti principi extra-politici. L’unico metro di giudizio è l’efficacia della sua azione: un’efficacia che si misura esclusivamente in rapporto al traguardo della trasformazione democratico-socialista della società. Per vari aspetti la teorizzazione gramsciana del partito-Principe assume toni e accenti simili a quelli che si trovano in Lenin. Il partito, scrive ad esempio Gramsci, ” prende il posto, nella coscienza, della divinità e dell’imperativo categorico “. Esso diventa l’unico principio, l’unico punto di riferimento dei soggetti impegnati nell’azione rivoluzionaria. Sotto altri profili le posizioni di Gramsci sono invece sensibilmente diverse da quelle di Lenin. Intanto egli appare molto più sensibile dell’eroe della Rivoluzione russa all’istanza di una conduzione democratica della vita interna del partito. In secondo luogo (e soprattutto) quest’ultimo non risulta edificato e operante in uno stato di ‘separatezza’ rispetto alla realtà della classe operaia e della restante società civile: al contrario esso viene strettamente intrecciato sia alla prima che alla seconda, così da coglierne adeguatamente i modi d’essere e le esigenze. Ma l’aspetto più caratteristico della concezione gramsciana del partito è il ruolo da essa assegnato agli intellettuali. Per Gramsci ” non c’è organizzazione senza intellettuali “: solo essi, in effetti, possono dare al proletariato ” la coscienza della sua missione storica “. Partito da questa premessa, in larga misura leninista, Gramsci è poi andato molto al di là di Lenin. Nessuno dei grandi teorici del marxismo contemporaneo ha sottolineato più di lui l’indispensabile nesso che deve sussistere fra teoria e politica, fra trasformazione rivoluzionaria del mondo e tradizione culturale borghese. E proprio gli intellettuali sono i preziosi, insostituibili depositari di tale tradizione. Essi sono, scrive Gramsci, i ” rappresentanti della scienza e della tecnica “, in grado di offrire i lumi e gli strumenti di queste alla causa rivoluzionaria. Solo essi, inoltre, possono realizzare appropriatamente quell’azione ammaestratrice in seno alla società che, come si è visto, appare a Gramsci un fattore indispensabile di crescita della coscienza democratico-socialista. E solo essi, infine, possono interpretare adeguatamente le linee di tendenza e le aspirazioni profonde della realtà sociale contemporanea. Naturalmente Gramsci ha in mente non già un intellettuale astratto, dedito a studi puramente speculativi, bensì un uomo capace di ” mescolarsi attivamente alla vita pratica come costruttore, organizzatore, persuasore permanente “. Questo intellettuale deve essere o diventare un uomo capace di parlare alle masse lavoratrici, di mediare l’alta cultura e i princìpi della strategia politica con le energie e le capacità di comprensione della gente comune. Il riferimento di fondo di questa attività di illuminazione e di mediazione resta peraltro il partito, rispetto al quale l’intellettuale viene concepito da Gramsci come una ,sorta di componente organica. E in effetti l’espressione ” intellettuale organico ” viene usata nei Quaderni del carcere per sottolineare la stretta connessione che deve esistere tra l’opera dell’uomo di cultura politicamente impegnato e la realtà del partito. D’altra parte, nella misura in cui quest’ultimo è in parte guidato da intellettuali e più in generale da una robusta coscienza teorica, da un pensiero culturalmente attrezzato, esso stesso si configura come una sorta di ” intellettuale collettivo “: un’espressione che esprime da un lato la già notata esigenza gramsciana che intelligenza e cultura, abbandonata ogni ‘separatezza’ elitaria, si reintegrino nel processo autoemancipativo dei ceti lavoratori; e dall’altro che l’organizzazione (politica) di tale processo dia adeguato spazio e rilievo al pensiero e al sapere. Il partito deve essere per Gramsci la mente non meno che il braccio della trasformazione democratico-socialista del mondo.
La filosofia della praxis č la concezione storicistica della realtā che si č liberata di ogni residuo di trascendenza e di teologia. (Quaderni del carcere, IX, 1, VIII)
QUADERNI DEL CARCERE
I Quaderni del carcere č l’opera che contiene le note, gli appunti, le riflessioni su vari argomenti che Gramsci elaborō nel periodo della sua reclusione compilando i quaderni che gli venivano concessi dalle autoritā carcerarie. La compilazione dei quaderni non aveva, nel progetto dell’autore, lo scopo della pubblicazione: l’opera non aveva perciō un titolo e quello attuale lo dobbiamo all’editore, non a Gramsci. Il pensatore sardo ne iniziō la stesura nel carcere di Turi l’8 febbraio 1929, due anni e tre mesi dopo l’arresto avvenuto l’8 novembre 1926. L’idea del lavoro, perō, era giā vivissima nel 1926 e in una lettera alla cognata Tania del 19 marzo di quell’anno Gramsci manifesta la volontā di ” far qualcosa ‘für ewig’ “, ossia “per l’eternitā”. Egli intendeva cioč occuparsi di argomenti di alto spessore culturale da un punto di vista “disinteressato”, libero dai limiti e dalle contingenze politiche del presente. Gramsci lavora alla stesura di ben 33 quaderni (non tutti compiuti perō) dal febbraio 1929 all’agosto 1935: seguendo l’evoluzione compositiva dell’opera, possiamo individuare tre fasi, di cui le prime due interessano il periodo di reclusione a Turi e la terza quello di Formia (1933-1935); il passaggio da una fase all’altra č annunciato o accompagnato dall’aggravarsi della condizione fisica del detenuto. La prima fase dura circa due anni (febbraio 1929-agosto 1931) e, in questo periodo, Gramsci compone 10 quaderni, di cui tre sono dedicati agli esercizi di traduzione per lo studio delle lingue che doveva servire come ” mezzo terapeutico ” contro l’inaridimento dovuto al carcere. La conclusione di questa prima fase e il passaggio alla seconda sono segnati dalla grave crisi che colpė Gramsci il 3 agosto 1931. La seconda fase si protrae per due anni (dalla fine del 1931 alla fine del 1933) ed č caratterizzata dall’intensificarsi del ritmo di lavoro sulle questioni giā individuate nel periodo precedente e dall’abbandono degli esercizi di traduzione (a cui son dedicati quattro dei 33 quaderni). In questo periodo, Gramsci compone altri 10 quaderni lavorando contemporaneamente alla stesura di note miscellanee e dei cosiddetti “quaderni speciali”; con questi ultimi, egli intendeva riordinare e riscrivere (in base ad una distinzione per argomenti) molte delle note giā abbozzate nei quaderni precedenti. Un’ulteriore, pių dura, crisi colpisce perō lo scrittore sardo nel marzo 1933, con stati di allucinazione, di ossessione e di tormenti psicologici. Proprio questa crisi sarā determinante per il passaggio alla terza fase: essa si apre alla fine del 1933 con il trasferimento di Gramsci (per via delle sue gravi condizioni di salute) nella clinica di Formia. Qui egli si avvierā alla stesura di altri dodici quaderni (tutti “speciali”), la maggior parte dei quali perō resteranno incompleti. L’irreversibile esaurimento di forze a cui Gramsci č giunto sfocia in una nuova crisi del giugno 1935, in seguito alla quale viene ricoverato nella clinica “Quisisana” di Roma; il lavoro di composizione dei Quaderni č interrotto e non sarā mai ripreso. L’opera č, pertanto, incompiuta e ciō fa sė che essa non abbia un carattere concluso e definitivo: Gramsci stesso afferma che le sue note sono spesso formate da ” affermazioni non controllate “, ” di prima approssimazione ” e che alcune di esse potrebbero in seguito essere abbandonate. Dopo la morte di Gramsci, i Quaderni furono numerati e custoditi dalla cognata Tania, che li spedė a Mosca, dove furono presi in consegna dai membri del Partito Comunista Italiano. I temi che ricorrono e che si intrecciano all’interno dei Quaderni sono molteplici; tra i pių importanti, meritano di essere ricordati:
FOLCLORE : Gramsci intende, con questo termine, la ” concezione del mondo e della vita ” e tutto il sistema di credenze e superstizioni propri degli strati sociali popolari. Nel folclore Gramsci individua una potenzialitā critica e rivoluzionaria rispetto alle concezioni del mondo “ufficiali” espresse dalle ” parti colte delle societā storicamente determinate “.
QUESTIONE MERIDIONALE : Gramsci vuole analizzare il problema dello squilibrio e della contraddizione dovuti all’incapacitā delle forze dirigenti risorgimentali di affrontare e di risolvere la questione contadina, particolarmente grave nel Sud. Il partito comunista doveva, agli occhi di Gramsci, assumersi l’impegno di favorire il superamento della disgregazione interna alle masse contadine che le rendeva incapaci di sottrarsi alla dura subordinazione nei confronti delle classi dominanti e di allearsi alla classe operaia settentrionale (la falce e il martello dello stemma comunista indicano esattamente questo: l’alleanza tra contadini del Sud e operai del Nord).
CROCE E L’ “ANTICROCE” : nei confronti di Benedetto Croce, Gramsci vuole ripetere l’operazione che Marx ha compiuto nei confronti di Hegel: come Hegel č stato il massimo rappresentante dell’idealismo e del progresso borghese del XIX secolo, cosė Croce lo č dell’idealismo e della borghesia italiana del XX secolo. Si tratta dunque di rovesciarne radicalmente le prospettive e, cosė, Croce č al tempo stesso il principale interlocutore e il principale antagonista del materialista Gramsci.
RISORGIMENTO : il Risorgimento viene letto, sulle orme di Gobetti, come “rivoluzione mancata”; l’egemonia dei moderati (che Gramsci analizza in tutte le sue articolazioni) ha impedito quelle trasformazioni radicali che pure erano necessarie. Spetterā quindi alla rivoluzione proletaria compiere il processo risorgimentale fino in fondo.
FILOSOFIA DELLA PRAXIS : č la parte dei Quaderni dedicata pių specificatamente alla filosofia e, in particolare, al materialismo storico o marxismo, che Gramsci definisce appunto ” filosofia della praxis “.
MACHIAVELLI E IL PRINCIPE : Gramsci interpreta il “Principe” di Machiavelli come un manifesto politico della nascente borghesia italiana; fallimento del nuovo ceto borghese e fallimento del progetto di unitā nazionale sono per Gramsci una cosa sola. In etā contemporanea, i processi politici non sono perō pių guidati da una singola persona (un principe) ma dai partiti: anche i rivoluzionari (secondo l’insegnamento di Lenin) per realizzare il loro progetto hanno bisogno di un partito, che Gramsci definisce il ” nuovo Principe “.
LA QUESTIONE DEGLI INTELLETTUALI : il ruolo riservato da Gramsci agli intellettuali č quello di elaboratori e mediatori delle ideologie ed č fondamentale per la conquista e per l’esercizio dell’egemonia culturale da parte di ogni classe sociale che miri a diventare dominante. A questo tema si legano quindi direttamente quello dell’egemonia e della rivoluzione passiva. Gramsci afferma che ” tutti gli uomini sono intellettuali “, poichč ogni uomo, consapevolmente o no, esplica ” una qualche attivitā intellettuale “, ha una propria concezione del mondo e una consapevole linea di condotta morale, e contribuisce a modificare altre visioni del mondo suscitando nuovi modi di pensare. Il linguaggio stesso č ” una minima manifestazione ” intellettuale, visto che giā in esso č cristallizzata una ” determinata concezione del mondo “, una qualche ” filosofia spontanea “. Non vi č pertanto attivitā umana (neppure la pių pratica) ” da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale “: “ non si puō separare l’homo faber dall’homo sapiens “. Ma se tutti gli uomini sono intellettuali, ” non tutti gli uomini hanno nella societā la funzione di intellettuali “; per l’esercizio di tale funzione, si formano storicamente delle categorie specializzate in connessioni con le classi sociali e specialmente con quelle pių importanti e dominanti. Gramsci distingue fra: 1) intellettuali “tradizionali”, che generalmente si rappresentano come ” autonomi e indipendenti dal gruppo sociale dominante ” e dal mondo della produzione, considerandosi piuttosto come seguaci disinteressati dei valori tradizionali; 2) intellettuali “organici”, cioč legati organicamente al gruppo sociale fondamentale; perō anche gli intellettuali “tradizionali”, anche se non ne sono consapevoli, sono in ultima analisi “commessi” della classe dominante, “organici” al gruppo sociale fondamentale e svolgono ” funzioni organizzative e connettive “, di direzione ideologica e culturale. Sta qui il rapporto tra intellettuali ed egemonia: la classe dominante o che aspira a divenire tale cerca di utilizzare gli intellettuali per esercitare un’egemonia su tutta la societā; Gramsci dice che ” la supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, come ‘dominio’ e come ‘direzione intellettuale e morale’ “; lo Stato stesso, poichč espressione diretta del gruppo dominante, si fonda e si regge su due elementi: a) la “dittatura”, ovvero l’apparato di decisione e di coercizione rappresentato dalla “societā politica”; 2) l’ “egemonia” e l’organizzazione del consenso, dipendenti dalla “societā civile” e attuate attraverso un apparato di “strutture ideologiche” e di istituzioni a cui spetta il compito della direzione culturale per conto della classe politica dominante. Operano nella societā civile e nelle strutture ideologiche la scuola, la Chiesa, i partiti, i sindacati, la stampa, e cosė via, nonchč i funzionari dell’ideologia e della cultura, cioč gli intellettuali, fra i quali Gramsci fa rientrare tutti quelli che ricoprono ruoli sociali di educazione, formazione, organizzazione. L’egemonia č dunque il dominio di una classe sulle altre attraverso un’operazione di controllo culturale e ideologico e di esercizio del potere, in senso non tanto coercitivo, quanto di persuasione razionale, di influenza sul pensiero, sulla vita, sulla moralitā, sulle abitudini sociali e culturali dei singoli. La conquista e la salvaguardia del potere da parte della classe dominante sono, per Gramsci, sempre pių determinati dalla stretta connessione di egemonia e coercizione. L’esercizio dell’egemonia (tipico dei regimi liberali e parlamentari) č caratterizzato dalla combinazione e dall’equilibrio fra forza e consenso e la forza deve sembrare sempre giustificata dal consenso della maggioranza; quest’ultimo č espresso dagli organi di opinione pubblica (giornali e associazioni) che, a questo scopo, ” vengono moltiplicati artificiosamente “. Poichč nell’epoca moderna, avverte Gramsci, ” la categoria degli intellettuali […] si č ampliata in modo inaudito ” e questi appaiono ormai necessari al funzionamento dello Stato moderno, la lotta per la conquista e per il mantenimento dell’egemonia non si puō risolvere nello scontro materiale delle classi, ma deve investire il piano culturale. Le trasformazioni rivoluzionarie non sono pių immaginate, secondo le modalitā tradizionali, come scontro diretto, violento, fra gruppi o classi sociali antagonisti. D’altra parte, per evitare conflitti pericolosi per la sua esistenza, la classe dominante favorisce una serie di trasformazioni volte ad adeguare la societā allo sviluppo economico: si tratta di “rivoluzioni passive”, tra cui rientra “l’americanismo”. Per la costruzione di uno Stato alternativo a quello di stampo americanista, Gramsci vede il bisogno di un reale processo rivoluzionario e di una sistematica contrapposizione operaia mossa da un concreto ” spirito di scissione “, rispetto al blocco sociale dominante. La conquista dell’egemonia e del potere da parte del proletariato č dunque indisgiungibile dallo scontro delle classi e dalla lotta proletaria, ma per far ciō la classe operaia ha bisogno di attirare a sč gli intellettuali “tradizionali” e di crearsi i propri intellettuali “organici”. L’intellettuale nuovo deve dunque ” mescolarsi attivamente alla vita pratica ” e diventare dirigente politico (cioč “specialista + politico”) proprio a partire dalla centralitā del lavoro industriale nella societā moderna.
EGEMONIA : Gramsci impiega questo termine nel senso di “direzione culturale”; egli contrappone infatti al concetto di dominio, basato sulla forza, quello di egemonia, fondato sul potere di persuasione. Gli stati moderni tendono a reggersi sempre pių sull’egemonia e sempre meno sul dominio, ma i due momenti sono comunque essenziali alla vita dello Stato.
RIVOLUZIONE PASSIVA : Gramsci deriva questa nozione dall’analisi della storia del Risorgimento. Lo applica poi allo studio di tutti quei fenomeni di profondo mutamento economico, sociale, culturale diretto e gestito dalle classi dominanti con una operazione che tende a favorire l’adeguamento passivo della mentalitā delle masse e del costume collettivo alle esigenze economiche dominanti.
AMERICANISMO E FORDISMO : tale concetto (esaminato a fondo nel Quaderno 22) nasce dalla riflessione di Gramsci sul fenomeno dello sviluppo capitalistico americano e dalla razionalizzazione del lavoro e della vita privata dei lavoratori, favorito, nei primi decenni del Novecento, dall’organizzazione del lavoro di Taylor e Ford. Con questi termini si definisce anche un modo di fare e di pensare tipicamente americano che viene preso a modello dai Paesi capitalistici occidentali: di qui il termine “americanismo”. Le considerazioni di Gramsci si basano su alcuni eventi concreti: la sempre maggiore deprofessionalizzazione del lavoro operaio e il suo adeguamento al funzionamento meccanico e automatico della macchina con la conseguente affermazione della figura dell’ “operaio-massa”, con il tramonto di quella dell’operaio artigiano e della dimensione dell’ “umanesimo del lavoro”, in cui la centralitā operaia era ancora rappresentata dal lavoratore creativo e specializzato, dotato di una forte coscienza delle proprie prestazioni; a tutto ciō si aggiunge, appunto, la radicalizzazione del taylorismo, attuata dalla politica economica e industriale di Ford. Gramsci č favorevole alla tecnologia e alla razionalizzazione del lavoro, ma non puō accettare l’intento capitalistico di ridurre il lavoratore a ” gorilla ammaestrato “, privato di coscienza e di pensiero. L’americanismo č una forma di “rivoluzione passiva”, perchč si mira ad ottenere, attraverso il dominio economico, il controllo politico e culturale degli operai e tale dominio imposto non resta solo in fabbrica, ma esce e passa alla societā civile, alla morale, alla cultura; il controllo da parte dei grossi industriali sulla vita privata del lavoratore costituisce appunto una rivoluzione capovolta, vissuta passivamente.
CRITICA LETTERARIA : Gramsci distingue in primo luogo la critica estetica, volta ad accertare il valore letterario delle opere, dalla critica ideologica e politica che considera solo il contenuto. Questa posizione differenzia notevolmente Gramsci dalla critica marxista promossa in Unione Sovietica dal despotico Stalin (aspre sono le critiche rivolte da Gramsci alla politica culturale di Stalin), che faceva dipendere il giudizio estetico da quello politico. Perō Gramsci cerca anche una mediazione tra le due forme di critica, ravvisandola nel modello di “critica militante” offerto da De Sanctis. Come sosteneva De Sanctis, bisogna battersi per una nuova cultura pių impegnata moralmente e civilmente, dalla quale soltanto potrā nascere una nuova letteratura.
CONCETTO DI NAZIONAL-POPOLARE : č un parametro che Gramsci impiega spesso per considerare la vicinanza delle opere letterarie rispetto alla realtā concreta dei problemi, degli interessi e dei sentimenti del popolo/nazione; non č tanto un concetto di natura estetica, quanto di natura sociologica. Privi di qualsiasi senso di appartenenza ad una classe sociale o ad una realtā nazionale e popolare, gli intellettuali italiani sono a lungo stati dominati da un “cosmopolitismo” umanistico; il che li ha portati spesso ad aderire a correnti o a categorie filosofiche-letterarie che restano astratte e prive di una reale rispondenza nella concreta realtā nazionale. Gramsci afferma la necessitā del nesso fra intellettuali e nazione, fra intellettuali e realtā popolare e dunque la necessitā del carattere nazional-popolare della letteratura. Gramsci riprende e corregge Croce su tre punti: 1) Gramsci tende a rivalutare il contenuto di pensiero di un’opera e perciō, ad esempio, a considerare positivamente anche la struttura della “Commedia” dantesca, che invece Croce condannava come “non poesia”; 2) studia in modo pių concreto il rapporto scrittore-societā, proponendosi di inserire la storia degli scrittori e degli artisti all’interno della storia degli intellettuali e dunque di condizioni storico-sociali precise e determinate; 3) tenta una mediazione tra critica estetica e critica politica, sull’esempio di De Sanctis. L’assunzione di de Sanctis a modello č funzionale alla proposta di una critica militante capace di fondere ” la lotta per una nuova cultura, cioč per un nuovo umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni del mondo con la critica estetica o puramente artistica “. Gramsci, grazie a de Sanctis come modello, vuole anche esaminare gli aspetti dell’opera d’arte grossolanamente trascurati da Croce, soprattutto il momento etico-ideologico. La letteratura, dice Gramsci, non nasce dalla letteratura (cioč ” per partenogenesi “) ma dal mondo della cultura, delle idee, della morale, dell’economia e, in definitiva, dalla storia di una nazione e dei suoi intellettuali; attraverso la categoria di nazional-popolare, Gramsci considera la letteratura in rapporto alla storia degli intellettuali e sottolinea, in fin dei conti, il nesso fra l’opera d’arte e la condizione dello scrittore nella societā, la reciprocitā e la dinamicitā dei rapporti fra dimensione spirituale (o sovrastrutturale) e dimensione materiale (o strutturale); il pensiero gramsciano muove perciō in direzione di uno storicismo assoluto. Altri criteri metodologici sono connessi alle categorie di “vecchio-nuovo” e di “distruzione-creazione”: alla loro luce, Gramsci esprime ad esempio un giudizio altamente positivo sull’opera di democratizzazione e di sprovincializzazione della cultura svolta dagli esponenti della rivista “La Voce”; viceversa, “La Ronda” viene da lui criticata per l’involuzione e per il “vecchio” che rappresenta con la riproposta di una concezione tradizionale del letterato e della cultura. Queste categorie spingono Gramsci a vedere nella ” vuota concettositā ” (quello che Labriola chiamava “verbalismo”) e nel “secentismo” della poesia pura (e anche di Ungaretti) il segno del ” vecchio che ritorna “. Ancora pių interessante č l’operazione critica che Gramsci svolge nei confronti di Pirandello, apprezzandolo per l’ ” importanza critica di corrosione del vecchio costume teatrale ” e della mentalitā borghese, cattolica o positivistica. La valutazione positiva dei vociani e di Pirandello mostra come la distruzione del vecchio e la creazione di nuovi atteggiamenti mentali siano fattori fondamentali del giudizio positivo dato da Gramsci. Con Pirandello, nota Gramsci, l’oggettivitā del reale, invalsa con la tradizione aristotelico-cristiana, viene spodestata da una nuova concezione soggettivistica e relativistica; cionostante, a Gramsci pare poco convincente (e in ciō si rivela vicino a Croce) la dimensione artistica dei drammi di pirandello per il loro carattere di “dialoghi filosofici” in cui la nuova concezione della realtā č inquinata da elementi intellettualistici. Ecco perchč la sua opera preferita di Pirandello era “Liolā”, in cui č del tutto assente ogni contenuto intellettualistico.
QUESTIONE DELLA LINGUA : Gramsci dedica grande attenzione al problema dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e in rapporto alla letteratura, alle classi intellettuali e soprattutto all’esercizio del dominio e dell’egemonia culturale.
Il mio stato d’animo é tale che se anche fossi condannato a morte, continuerei a essere tranquillo e anche la sera prima dell’esecuzione magari studierei una lezione di lingua cinese per non cadere più in quegli stati d’animo volgari e banali che si chiamano pessimismo e ottimismo. Il mio stato d’animo sintetizza questi due sentimenti e li supera: sono pessimista con l’intelligenza, ma ottimista con la volontà.
IL DISCORSO ALLA CAMERA
Gramsci pronunciò alla Camera un unico discorso prima di essere incarcerato: contro la legge che, col pretesto di colpire la massoneria (che invece <<passerà in massa al partito fascista e ne costituirà una tendenza>>, preconizza Gramsci), mirava a mettere a tacere ben altre “società segrete”, e segreta era già in pratica l’attività dei comunisti. Il discorso è importante per vari aspetti. I comunisti avevano deciso di interrompere la protesta aventiniana promossa dalle opposizioni in seguito all’assassinio (10 giugno ’24) di Matteotti per avvalersi del Parlamento al fine di imprimere slancio alla lotta contro il fascismo. Gramsci si rivelò allora come figura di primo piano a molti che fino ad allora non ne avevano saputo quasi nulla. Il ritorno in aula dei deputati comunisti, le energiche iniziative del loro piccolo gruppo (erano diciannove) contro l’arroganza degli avversari tornati all’attacco, diedero nuova ancorché precaria linfa al movimento antifascista. E si diffuse, proprio allora, l’interesse per quell’uomo singolare che rappresentava ormai notoriamente il centro intellettuale e propulsivo del partito. Così che egli venne a identificarsi con qualcosa di molto più profondo che non il protagonista di una iniziativa politico-parlamentare quando, quel 16 maggio, intervenne a Montecitorio. C’è la riprova in una lettera scritta alla moglie Julka pochi giorni dopo il discorso: <<I fascisti mi hanno fatto un trattamento di favore: quindi, dal punto di vista rivoluzionario, ho incominciato con un insuccesso>>. Perché? <<Poiché ho la voce bassa, si sono riuniti intorno a me per ascoltarmi, e [mi hanno] lasciato dire quel che volevo, interrompendomi continuamente solo per deviare il filo del discorso, ma senza volontà di sabotaggio: non seppi trattenermi dal rispondere e ciò fece il loro gioco, perché mi stancai e non riuscii più a seguire l’impostazione che avevo pensato di dare al mio intervento>>. Niente vero. Intanto Gramsci era riuscito a rivendicare (anche in trasparente polemica con altri settori della sinistra) che i comunisti erano già allora <<tra i pochi che abbiano preso sul serio il fascismo, anche quando sembrava che fosse solo una farsa sanguinosa, quando intorno al fascismo si ripetevano solo i luoghi comuni sulla ‘pricosi di guerra’ (…) Noi pensiamo che questa fase della ‘conquista fascista’ sia una delle più importanti attraversate dallo Stato italiano>>. Il fascismo dunque come erede delle forme retrive cui lo stato liberale non tardò a indirizzare le proprie eredità del Risorgimento.
Gramsci: <<La rivoluzione fascista è solo la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro>>.
Mussolini: <<Di una classe ad un’altra, com’è avvenuto in Russia, come avviene normalmente in tutte le rivoluzioni!>>.
Gramsci: <<E’ rivoluzione solo quella che si basa su una nuova classe. E il fascismo non si basa su nessuna classe che non sia già al potere>>.
Le interruzioni si moltiplicano quando Gramsci affronta il nodo del Mezzogiorno e delle enormi risorse che attraverso un’imposizione feroce <<lo Stato estorce alle regioni meridionali per dare una base al capitalismo dell’Italia settentrionale>>. Altro che capitalismo sviluppato, sembra dire il leninista Gramsci riferendosi al meridionalismo nordico del “Corriere” di Luigi Albertini come pure a quel che maturava nel Sud: sul “Mondo” di due settimane prima era uscito il Manifesto crociano degli intellettuali antifascisti.
Mussolini: <<Il Partito comunista ha meno iscritti del partito fascista!>>
Gramsci: <<Ma rappresenta la classe operaia!>>
Farinacci: <<La tradisce, non la rappresenta!>>
Gramsci: <<Il vostro è consenso ottenuto col bastone.>>
Presidente: <<Non interrompano! Lei però, onorevole Gramsci, non ha parlato della legge!>>
Rossoni: <<La legge non è contro le organizzazioni!>>
Gramsci : <<Onorevole Rossoni, ella stesso è un comma della legge contro le organizzazioni. I cittadini devono sapere a che cosa lavorate.>>
Presidente: <<Onorevole Gramsci, questo concetto lo ha ripetuto tre o quattro volte!>>
Gramsci: <<Bisogna ripeterle invece: bisogna che lo sentiate sino alla nausea. [interruzioni, rumori che impediscono li registrare le prime parole della frase successiva] …vincerà il fascismo [rumori, commenti]. Il resoconto stenografico finisce qui. A Gramsci è impedito di concludere.
L’8 novembre dell’anno dopo Gramsci, appena rientrato da Montecitorio, viene arrestato nel suo appartamento in violazione dell’immunità parlamentare.
LE CENERI DI GRAMSCI DI PASOLINI
III.
Uno straccetto rosso, come quello
arrotolato al collo ai partigiani
e, presso l’urna, sul terreno cereo,
diversamente rossi, due gerani.
Lě tu stai, bandito e con dura eleganza
non cattolica, elencato tra estranei
morti: Le ceneri di Gramsci… Tra speranza
e vecchia sfiducia, ti accosto, capitato
per caso, in questa magra serra, innanzi
alla tua tomba, al tuo spirito restato
quaggiů tra questi liberi. (O č qualcosa
di diverso, forse, di piů estasiato
e anche di piů umile, ebbra simbiosi
d’adolescente di sesso con morte…)
E, da questo paese in cui non ebbe posa
la tua tensione, sento quale torto
– qui nella quiete delle tombe – e insieme
quale ragione – nell’inquieta sorte
nostra – tu avessi stilando le supreme
pagine nei giorni del tuo assassinio.
Ecco qui ad attestare il seme
non ancora disperso dell’antico dominio,
questi morti attaccati a un possesso
che affonda nei secoli il suo abominio
e la sua grandezza: e insieme, ossesso,
quel vibrare d’incudini, in sordina,
soffocato e accorante – dal dimesso rione
ad attestarne la fine.
[…]
GIOVANNI GENTILE
 Questo è il punto fermo, a cui si attacca l’idealismo attuale. La sola realtà solida, che mi sia dato affermare, e con la quale deve perciò legarsi ogni realtà che io possa pensare, è quella stessa che pensa; la quale si realizza ed è cosí una realtà, soltanto nell’atto che si pensa. Quindi l’immanenza di tutto il pensabile all’atto del pensare; o, tout court, all’atto; poiché di attuale, per quel che s’è detto, non c’è se non il pensare in atto.
(G. Gentile, Introduzione alla filosofia)
Questo è il punto fermo, a cui si attacca l’idealismo attuale. La sola realtà solida, che mi sia dato affermare, e con la quale deve perciò legarsi ogni realtà che io possa pensare, è quella stessa che pensa; la quale si realizza ed è cosí una realtà, soltanto nell’atto che si pensa. Quindi l’immanenza di tutto il pensabile all’atto del pensare; o, tout court, all’atto; poiché di attuale, per quel che s’è detto, non c’è se non il pensare in atto.
(G. Gentile, Introduzione alla filosofia)
VITA E INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA
Gentile è stato, con Croce, l’esponente principale del neoidealismo italiano, ma la sua posizione filosofica è maturata attraverso esperienze in parte diverse da quelle crociane. Nato a Castelvetrano (Trapani) nel 1875, Giovanni Gentile si formò presso l’università di Pisa, dove ebbe come maestri soprattutto Alessandro D’Ancona e Donato Jaja, che lo avvicinò allo studio di Kant, di Rosmini e Gioberti, di Hegel. Il primo lavoro gentiliano, su Rosmini e Gioberti (1898), si colloca nella prospettiva di ripresa del pensiero criticistico-idealistico tedesco già avviata da Croce, e si ispira a una visione fortemente speculativa (teoretico-sistematica) della filosofia. Negli ultimi anni del secolo Gentile approfondisce, da un lato, Spaventa e, dall’altro, Marx, che esamina nel volume La filosofia di Marx (1899). A proposito del marxismo si tratta, per Gentile, di ritrovarne il nucleo speculativo più autentico e di affermarlo come una “filosofia della prassi” che unifica pensiero e azione e che occorre reinterpretare in termini idealistici. Ciò che viene a cadere, del pensiero di Marx, è proprio il materialismo. La realtà come materia viene interpretata come un residuo sensibile-oggettivo che limita l’attività creatrice della prassi umana. Ma è anche attraverso la nozione marxiana di prassi liberamente rivisitata (attraverso la lettura di Vico e degli idealisti tedeschi) che Gentile delinea la sua concezione della soggettività trascendentale intesa come ” attività creatrice ” per cui verum et factum convertuntur , come ” sviluppo necessario ” che collega soggetto e oggetto in un fare che ” è insieme conoscere ” e che si manifesta nella storia. In quegli stessi anni di fine secolo Gentile stringe con Croce un’amicizia che durerà fino a quando la differenza tra lo storicismo crociano e l’attualismo gentiliano si farà troppo vistosa. Nel 1903 Gentile, nella prolusione tenuta all’università di Napoli e dedicata a La rinascita dell’idealismo , delinea la propria posizione filosofica che prende il nome di attualismo e ch’egli svilupperà in una serie di saggi teorici fino al 1922. Contemporaneamente si dedica anche alla ricerca storico-filosofica con gli studi: Le origini della filosofia contemporanea in Italia (1903-1914), Dal Genovesi al Galluppi (1903), Il pensiero italiano del Rinascimento (1920), Studi vichiani (1915), Gino Capponi e la cultura italiana del secolo decimonono (1922). Nello stesso periodo il filosofo affronta anche i problemi della pedagogia ( Sommario di pedagogia come scienza filosofica , 1913-14; La riforma dell’educazione , 1920; Educazione e scuola laica , 1921; Preliminari allo studio del fanciullo , 1924) e poco più tardi quelli estetici in Filosofia dell’arte (].931). E soprattutto tra il 1911 e il 1922, che la riflessione gentiliana si articola intorno a temi prevalentemente teoretico-sistematici. Nel 1911 esce L’atto del pensare come atto puro , nel 1913 La riforma della dialettica hegeliana , nel 1916 Teoria generale dello Spirito come atto puro e, infine, dal ’17 al ’22, il Sommario di logica come teoria del conoscere . Nel dopoguerra Gentile affronta i problemi politici in Guerra e fede (1919) e si avvicina sempre più al fascismo, fino a divenirne uno dei principali esponenti in campo intellettuale. Dopo la marcia su Roma viene nominato ministro della Pubblica Istruzione ed elabora, nel ’23, un’importante e discussa riforma della scuola. Negli anni successivi si occupa quasi esclusivamente di organizzazione della cultura, è direttore dell’Enciclopedia Italiana e presidente della Accademia d’Italia. Dopo la crisi del 25 luglio 1943 si apre ad un ripensamento in chiave sociale della sua filosofia che prende forma nell’opera Genesi e struttura della società (1946). Nel 1944 muore a Firenze, ucciso barbaramente dai partigiani antifascisti.
LA RIFORMA DELLA DIALETTICA HEGELIANA
Determinante, nella formazione filosofica di Gentile, fu l’insegnamento di Donato Jaja (1839-1914), seguace dell’hegelismo e, sulle orme di Spaventa, impegnato a fondare nel soggetto l’identità di pensiero ed essere. Attraverso quell’insegnamento Gentile maturò la sua prima adesione all’idealismo. Nella già ricordata prolusione-manifesto del 1903, intitolata proprio La rinascita dell’idealismo , Gentile rivendicava contro ogni dualismo e naturalismo da un lato la fondamentale unità di natura e spirito nella coscienza, dall’altro il primato ontologico e gnoseologico di quest’ultima. La coscienza, affermava Gentile, è ” sintesi di soggetto e oggetto “: ma una sintesi nella quale è il primo termine-concetto che ‘pone’ il secondo. Correlativamente, anche “atto”, e “fatto” sono strettamente uniti e in qualche modo complementari: ma solo nel senso che, se indubbiamente il fatto c’è ed è necessario, esso si dà solo nell’unità dell’ “atto” – che è sempre atto della coscienza. Nella prolusione del 1903 sono già contenute in nuce alcune delle tesi chiave dell’attualismo gentiliano. Ma la definitiva maturazione speculativa di Gentile passa (come quella di Croce) attraverso un serrato confronto con l’hegelismo. Di Hegel il giovane filosofo siciliano apprezza (a differenza di Croce) non tanto la prospettiva storicistica (cioè il suo voler cogliere lo Spirito nel divenire stesso della realtà storica) quanto l’impianto più direttamente coscienzialistico-idealistico. Per Gentile il massimo merito di Hegel è di aver posto una Coscienza (un Logos, un Pensiero) a fondamento e inizio di tutto il reale, contribuendo con ciò a edificare l’idealismo moderno nella sua fase più evoluta. Hegel ha anche elaborato una raffinata logica dialettica. Ma è proprio a proposito di questa dialettica che Gentile (come anche Croce, seppure per ragioni e in prospettive diverse) sente di dover muovere critiche radicali al maestro tedesco. In effetti il filosofo tedesco ha confuso due dialettiche, che invece per Gentile devono restare nettamente separate. Queste dialettiche non sono (come per Croce) la “dialettica degli opposti” e la “dialettica dei distinti”: sono quelle che Gentile chiama la ” dialettica del pensare “e la ” dialettica del pensato “. Se Hegel ha genialmente colto e individuato la , “dialettica del pensare” (ossia la dialettica della Coscienza o del Pensiero attivo e vivente), egli vi ha poi lasciato forti residui della “dialettica del pensato” (ossia la dialettica del pensiero determinato e delle scienze) – anzi, come si è detto, ha mescolato l’una con l’altra. E questo, per Gentile, è un errore: ” La dialettica del pensato è, si può dire, la dialettica della morte; la dialettica del pensare, invece, la dialettica della vita. Infatti il presupposto fondamentale della prima è la realtà o verità tutta quanta ab aeterno determinata in guisa che non sia più concepibile una determinazione nuova, come determinazione attuale della realtà […]. La dialettica, invece, del pensare non conosce un mondo che già sia, che sarebbe un pensato; non suppone una realtà al di là della conoscenza e di cui toccherebbe a questa d’impossessarsi, perché sa, come ha dimostrato Kant, che tutto ciò che si può pensare della realtà (il pensabile, i concetti dell’esperienza) presuppone l’atto stesso del pensare. E’ in questo atto vede perciò la radice di tutto “. (La riforma della dialettica hegeliana, I) Nella misura in cui Hegel ha confuso queste due dialettiche, la ‘sua’ dialettica va “riformata”. Va riformata soprattutto eliminando dalla “dialettica del pensare” ogni componente oggettivistica, statica, inerte (come ad esempio la struttura categoriale fissata in modo universale e rigido-astratto), e conferendo invece un’assoluta libertà al vivente “dialettismo” del concreto atto del pensiero: quel dialettismo che è la ricca, vera e inesauribile ” inquietezza del pensare “.
I PRINCIPI FILOSOFICI DELL’ATTUALISMO
L’attualismo gentiliano si costruisce intorno ad alcuni precisi nuclei teorici: 1. L’interpretazione di Hegel e la riforma della dialettica hegeliana; 2. La teoria dell’atto puro 3. Il rapporto tra logica del pensare e logica del pensato. Nella costruzione del suo sistema Hegel ha perduto, secondo Gentile, l’unità di soggetto e oggetto raggiunta nella Fenomenologia . L’Idea hegeliana infatti, si articola nei momenti della logica e della filosofia della natura concepiti come anteriori alla filosofia dello spirito, il che ripropone un sostanziale e inammissibile dualismo. Inoltre Hegel separa l’ “intelletto che concepisce le cose, dalla ragione che concepisce lo spirito “. Da questo dualismo viene caratterizzata anche la concezione della dialettica, irrigidita in concetti “astratti” e “immobili” che non rendono ragione della dinamicità del reale. La dialettica va invece riformata attraverso la lezione di Spaventa, che ha saputo cogliere l’unità viva e concreta delle categorie nell’atto del pensiero. Attraverso Spaventa Gentile risale a Fichte e afferma, in parte sulle orme del filosofo tedesco, la priorità dello spirito inteso come pensiero in atto e come unità di coscienza e autocoscienza. ” La dialettica del pensare non conosce un mondo che già sia, che sarebbe un pensato; non suppone una realtà, al di là della conoscenza, e di cui toccherebbe a questa impossessarsi; perché sa, come ha dimostrato Kant, che tutto ciò che si può pensare della realtà (il pensabile, i concetti, l’esperienza) presuppone l’atto stesso del pensare. E in questo atto vede perciò la radice di tutto. ” (La riforma della dialettica hegeliana, I) L’atto del pensiero pensante, o Atto puro, è dunque per Gentile il principio e la forma della realtà in divenire. Esso è ” autoctisi ” (ossia creazione di sé) e sintesi a priori: crea se stesso, ma attraverso un oggetto che è (fichtianamente) condizione necessaria della sua attività e non può essere separato da essa. Ove lo fosse, infatti, l’oggetto decadrebbe a “natura”, a “pensato”, a “passato”, assumendo un aspetto dogmaticamente oggettivo e inerte. La dialettica dell’atto puro è, per Gentile, triadica e si articola nei due momenti della tesi e dell’antitesi, ambedue unilaterali e astratti, e nel terzo momento della sintesi. Il momento astratto della soggettività (tesi) è rappresentato dall’arte, quello dell’oggettività (antitesi) dalla religione, mentre la sintesi è propria della filosofia. Il compito della filosofia è, da un lato, quello di rendere autocosciente questa dialettica dell’atto e, dall’altro, di opporsi ad ogni interpretazione dell’attività dello spirito suscettibile di reintrodurre rigidi dualismi e dogmatismi. In particolare Gentile sottolinea la netta distinzione della filosofia dalla scienza, in quanto quest’ultima è dogmatistica ( ” presuppone il suo oggetto “), naturalistica e priva di storia (” non può avere svolgimento, perché presuppone una verità perfetta “). La filosofia, invece, coincide con la storia della filosofia poiché ogni posizione filosofica realizza, nella sua forma specifica, l’autocoscienza dello spirito in un dato momento storico. ” La nostra dottrina dunque è la teoria dello spirito come atto che pone il suo oggetto in una molteplicità di oggetti, e insieme risolve la loro molteplicità e oggettività nell’unità dello stesso soggetto. Teoria che sottrae lo spirito a ogni limite di spazio e di tempo e da ogni condizione esteriore; rende pure impensabile ogni sua reale moltiplicazione interna, per cui un momento suo possa dirsi condizionato da momenti anteriori; e fa quindi della storia, non il presupposto, ma la realtà e concretezza dell’attualità spirituale, fondando così la sua assoluta libertà. ” (Teoria generale dello spirito come atto puro, XVI) Un altro aspetto centrale dell’attualismo gentiliano è la dottrina del rapporto tra io empirico e io trascendentale. L’ io trascendentale è ” quello che si coglie nella realtà del nostro pensiero quando il pensiero si consideri non come atto compiuto, ma, per così dire, quasi atto in atto “: un Io rispetto al quale la nostra individualità, con le sue caratteristiche psicofisiche, si configura come un oggetto finito e condizionato. In tal modo, l’autonomia e il valore del soggetto umano concreto risultano nell’attualismo largamente ridotti, e per lo stesso soggetto si delinea un preciso compito “educativo”: quello della propria autoelevazione all’universalità e all’autocoscienza dell’Io trascendentale. Infine, dal punto di vista gnoseologico, l’atto puro si fonda sull’opposizione Tra “logica del pensiero pensante” e “logica del pensiero pensato”, o tra “logo concreto” e “logo astratto. La prima è una logica filosofica, dialettica e attivistica; la seconda e una logica astratta, formale ed erronea. A questa seconda forma del pensiero appartengono le logiche formali, antiche e moderne, che rendono invariabili e definitive le forme del pensiero, fissandole come “cose” o “fatti”. Anche l’errore è legato alla “logica dell’astratto”, in quanto scambia il pensiero coi pensati, l’atto con le sue determinazioni, operando un’indebita astrazione dell’oggetto dal pensiero che lo pensa.
ESTETICA E RELIGIONE
Accanto all’aspetto teoretico-sistematico, l’attualismo gentiliano svolge anche alcune analisi concrete di momenti fondamentali dell’esperienza e della cultura. Ciò accade, in particolare, in relazione alla dimensione dell’arte e della religione, della pedagogia e della politica, che vengono indagate nelle loro strutture teoretiche fondamentali. In verità questo aspetto analitico dell’attualismo resta spesso sopraffatto dall’altro, più teoreticistico e astratto, e le indagini gentiliane si risolvono, a volte, in un gioco di puri concetti filosofici. Nell’opera dedicata all’arte Gentile si sofferma essenzialmente su due temi: la soggettività dell’arte e il suo rapporto con l’intera vita dello spirito (religione e filosofia). Sotto il primo aspetto, l’arte si manifesta come il momento soggettivo dell’io in quanto è legata al sentimento e alla sua immediatezza, ed esprime soprattutto l’individualità dell’artista. Sotto il secondo aspetto, essa è però anche un atto sintetico, che comprende tutti i momenti della vita dello spirito. L’arte, cioè, è sì immediatezza del sentimento: ma solo in quanto questo assume consapevolezza di sé e sa esprimere la complessità del mondo spirituale. L’arte acquista quindi anche alcuni caratteri propri del discorso razionale. L’estetica gentiliana si differenzia rispetto all’estetica di Croce su altri punti non meno rilevanti: il rapporto tra forma e contenuto viene considerato come inscindibile e non risolvibile in un privilegiamento della forma; il fondamento dell’arte è il sentimento e non l’intuizione-espressione; lo scopo dell’estetica è non già quello di ricavare una metodologia sulla base della quale formulare i giudizi sull’arte e la non-arte (poesia e non-poesia), bensì l’altro di definire il ruolo che l’esperienza artistica occupa nella dialettica del- lo spirito. Nelle opere dedicate all’ esperienza religiosa – Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia (1909), Discorsi di religione (1920), la conferenza La mia religione (1943) – Gentile sviluppa una concezione della religione come momento dell’assoluta oggettività dello spirito, dell’unità oggettiva del reale; ma è un momento che si rivela ” unilaterale, astratto e falso “, alla luce della filosofia. Quest’ultima, infatti, dissolve i postulati dogmatici della religione e risolve lo stesso Dio nell’attività dell’io trascendentale. La religione viene così, ad un tempo, esaltata come la forma più alta della presa di coscienza del reale (prima dell’autocoscienza filosofica) e superata in quanto concepita come inferiore alla filosofia.
PEDAGOGIA E SCUOLA
Nell’importante saggio Il concetto scientifico di pedagogia (1900), Gentile avvia una rifondazione in senso idealistico della pedagogia, negandone i nessi con la psicologia e con l’etica. Affermato che l’oggetto specifico della pedagogia è l’educazione, egli sottolinea che questo processo, in quanto rivolto a “fare lo spirito”, si risolve nel “farsi dello spirito”, nella dialettica della vita spirituale – cioè nella filosofia. La pedagogia si identifica così con la filosofia, come l’educazione si esprime primariamente sotto forma di autoeducazione. Questi principi generali vengono poi svolti nelle loro implicazioni concrete. Di particolare rilievo sono le tesi sul rapporto tra maestro e scolaro. Esso è caratterizzato da un dualismo che deve risolversi in unità attraverso la comune partecipazione alla vita dello spirito che, tramite la cultura, muove dall’educatore verso l’educando e lo riassorbe nell’universalità dell’atto spirituale. Nella vita della scuola il maestro occupa quindi il posto centrale e in lui si esprime il modello formativo spirituale e culturale che deve guidare l’alunno. Per quanto riguarda i suoi contenuti culturali, la scuola che emerge dalla dottrina pedagogica gentiliana è tanto legata alla tradizione umanistico- letteraria quanto sorda nei confronti del sapere scientifico. Relativamente alla sua organizzazione, essa è caratterizzata da un ordinamento gerarchico e centralistico. Si tratta anche di una scuola aristocratica, pensata per gli “studi di pochi, dei migliori”, e rigidamente suddivisa a livello secondario in un ramo classico-umanistico per le classi dirigenti e in uno professionale per il popolo. Nella scuola, infine, viene introdotto l’insegnamento religioso a livello primario perché Gentile considera necessario che gli uomini, i cittadini abbiano una concezione religiosa della vita. Onde conseguire questo risultato ” è necessario insegnare la religione ai bambini. E dato che siamo in Italia, dove la religione cattolica è dominante, i bambini devono essere istruiti in essa “.
LO STATO ETICO E TOTALITARIO
La filosofia gentiliana, per la sua esigenza di collegare unitariamente tutti gli aspetti della vita pratica dell’uomo, oltre che per lo stretto legame mantenuto con il pensiero di Hegel e della destra storica, culmina in una dottrina etico-totalitaria dello stato . Lo stato è per Gentile il momento di unificazione della società. Davanti ad esso individui e gruppi sono il “relativo”, rispetto all'”assoluto”. La collettività nel suo insieme deve sentire e si deve ispirare agli stessi valori. Lo stato è la sorgente di elaborazione concreta di questi fini unitari della collettività: di qui il suo carattere morale. Alla luce di tale dottrina si comprende come il pensiero politico gentiliano possa essersi connesso strettamente col fascismo: con la visione autoritaria ed anti-individualistica dello stato, con la sua mistica della patria e della sua “missione” spirituale. Anche le ultime riflessioni del filosofo contenute in Genesi e struttura della società , pur abbozzando un “nuovo umanesimo del lavoro” che rivaluta in qualche misura il soggetto umano e l’interazione tra gli individui, rivelano che Gentile non esce mai dal quadro di una concezione centralistica e totalitaria della comunità politica.Una pur rapida menzione merita anche l’instancabile attività di Gentile come organizzatore di cultura. Tale attività si esplicò soprattutto in sede editoriale. Il padre dell’attualismo organizzò numerose collane (di contenuto prevalentemente filosofico) presso vari editori italiani. Inoltre fondò e diresse alcune importanti riviste, quali il “Giornale critico della filosofia italiana” (1920-1944), “Educazione fascista” (1927-1933) e “Civiltà fascista”. Attraverso queste attività Gentile tese a sviluppare la presenza dell’attualismo nella cultura filosofica italiana e a renderne espliciti i presupposti storici (da Vico a Gioberti) e le applicazioni nelle varie sfere della cultura (educazione, arte, religione). Ma la principale impresa culturale realizzata dal filosofo fu la promozione (con G. Treccani) e la direzione dell’Enciclopedia italiana, pubblicata dal 1929 al 1937 in 36 volumi. L’opera veniva in qualche modo a rappresentare la summa della cultura moderna, orientata secondo i princìpi dell’idealismo e dello storicismo. Attorno a questo ampio e ambizioso progetto culturale Gentile favorì la confluenza di intellettuali di vario orientamento (ivi compresi alcuni esponenti della cultura cattolica e perfino antifascista ) allo scopo non solo di realizzare un obiettivo di egemonia culturale, ma anche e soprattutto per promuovere il consenso degli intellettuali nei confronti del fascismo.
GLI STUDI SU MARX
Quello che può definirsi l’esordio filosofico di Gentile fu il suo studio sulla filosofia di Marx, una rielaborazione della sua tesi per l’abilitazione all’insegnamento secondario, dal titolo Una Critica del Materialismo Storico, che apparve a Pisa nel 1897. A questo testo seguì La filosofia della prassi che venne pubblicata , insieme al primo studio, nel 1899, nel volume, edito sempre a Pisa, dal titolo La filosofia di Marx. L’ incontro tra Gentile ed il pensatore tedesco si deve in gran parte alle sollecitazioni di Benedetto Croce, che in quegli stessi anni, sotto la spinta del suo maestro, Antonio Labriola, stava cercando di definire la sua posizione rispetto al dibattito sulla dottrina marxista, in un periodo in cui l’Italia era attraversata da forti tensioni sociali. La formazione del Partito Socialista nel 1892 e la diffusione dei testi di Marx e Engels all’interno della nuova componente politica avevano contribuito alla diffusione di studi e articoli sull’argomento. L’approccio di Gentile alla filosofia di Marx e alla “questione sociale”, fu però distaccato e, per alcuni versi, prevenuto (come ebbe modo di costatare lo stesso Croce); ciò dipese sia dalla noncuranza eccessiva nei confronti del clima che si respirava in Italia alla fine del secolo (peraltro dimostrata dagli scarsi accenni che Gentile fece nelle sue lettere) e sia dalla sua impostazione hegeliana, che gli fece vedere nella filosofia di Marx un mal riuscito tentativo di superamento della filosofia di Hegel. Il tono dei due studi appare ambivalente, perché, mentre entrambe le conclusioni risultano essere una stroncatura del marxismo, dal il corpo del testo, al contrario, si evince una certa ammirazione per le intuizioni filosofiche di Marx. Gentile rivendica, nel corso dei due saggi, la matrice hegeliana del pensiero di Marx contro l’interpretazione positivistica, e contro il dilettantismo filosofico di coloro che scrivono sull’argomento senza una reale preparazione filosofica. Il primo studio si occupa di rispondere alla domanda se il materialismo storico possa essere definito o no una filosofia della storia: secondo Gentile il pensiero di Marx può essere scisso in una visone storica, e quindi una filosofia della storia, e in una metafisica artificiosa su cui lo stesso Marx non insistette; mentre la seconda può considerarsi “una superfetazione del suo pensiero”, la prima ne rappresenta la vera essenza. La conclusione di Gentile è che la filosofia della storia di Marx sia mutuata da quella di Hegel, sia per quanto riguarda la forma, dialettica per entrambi, sia per quanto riguarda il contenuto: all’Idea hegeliana, Marx ha sostituito la Materia, ma facendo questo è incorso in una contraddizione, data l’impossibilità logica di una filosofia della storia del relativo, dell’ a posteriori; il materialismo storico quindi, secondo Gentile, altro non è se non “uno dei più sciagurati deviamenti dell’hegelismo”. Nel secondo studio, Gentile si sofferma su quello che giudica il maggior risultato della speculazione marxiana, e cioè il concetto di prassi, che elimina il dualismo tra teoria e pratica, conoscere e fare. Per il concetto di prassi la conoscenza non può mai essere disgiunta dell’esperienza, ogni conoscenza si scopre facendola. Ma questo concetto, come nota lo stesso Marx, è vecchio quanto l’idealismo stesso e Gentile ne traccia la storia partendo da Socrate fino a Hegel, passando per Platone e Vico. Il saggio gentiliano si sviluppa contro il materialismo dualista ( il testo si apre con le Undici Tesi di Marx a Feuerbach ed è un merito di Gentile averle pubblicate per la prima volta in Italia) e contro ogni metafisica dualista, rivendicando, come nel primo saggio, la paternità hegeliana del materialismo storico e, nella conclusione, asserendo la finale contraddizione di quest’ultimo. Malgrado il magro successo di pubblico che ebbero, e malgrado il fatto che solo nel 1932 furono pubblicati il Italia L’Ideologia Tedesca e I manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx ( due saggi importanti per l’interpretazione del pensiero marxiano), i due testi gentiliani offrirono un contributo importante al dibattito sul marxismo (Lenin ne terrà conto e lo giudicherà uno dei testi migliori di autori non marxisti), e offrono tutt’ora un importante spaccato sullo sviluppo del pensiero di Gentile, che in quel periodo, oltre agli scritti su Marx, pubblicava anche nel 1898 la sua tesi di laurea su Rosmini e Gioberti. Il testo La filosofia di Marx cerca di rispondere alla domanda se la concezione materialistica della storia sia o no una filosofia della storia: a questa domanda aveva risposto positivamente Labriola e negativamente Croce. Ad avviso di Gentile, come accennato, Marx desume da Hegel la forma dialettica, grazie alla quale si può determinare a priori il corso dello sviluppo storico nella sua necessità e formulare la previsione della sua direzione e dei suoi tratti generali essenziali. In questo consiste il carattere scientifico e non utopistico del materialismo storico, e così si può affermare, stando a Gentile, che, per quel che riguarda la forma, esso è una filosofia della storia. Ma, per Marx, quel che vi è di essenziale nel processo storico è la materia, cioè il fatto economico, non l’idea, come invece era per Hegel. Su questo punto, il marxismo, per Gentile, manifesta la sua inferiorità e insufficienza rispetto all’hegelismo: per Hegel, infatti, l’idea non è trascendente la materia, ma è l’essenza del reale, che comprende al suo interno la materia come un momento relativo. Ritenendo, invece, la materia, che è il relativo, diversa dall’idea, che è l’assoluto, e scambiando il relativo con l’assoluto, i marxisti hanno attribuito a quel che è relativo la funzione dell’assoluto e, dato che l’assoluto si sviluppa dialetticamente e questo sviluppo è determinabile a priori, come aveva dimostrato Hegel, sono giunti alla conclusione balzana di considerare determinabile a priori anche quel che è meramente empirico, cioè la materia, il fatto economico, e quindi a considerare prevedibile quel che non può esserlo e, così, non appartiene alla filosofia della storia. Il fatto è di pertinenza della storiografia, che si occupa del già accaduto, non della filosofia della storia. Dal punto di vista filosofico, il materialismo storico appare a Gentile una deviazione erronea del pensiero hegeliano (“uno dei più sciagurati deviamenti dell’hegelismo”), proprio perchè concepisce erroneamente “una dialettica, determinabile a priori, del relativo”. Certo Marx ha anche dei meriti, spiega Gentile: ha criticato il materialismo tradizionale poichè esso concepisce l’oggetto come un dato, non come un processo, e il soggetto come una visione o rappresentazione passiva di tale oggetto. Marx invece concepisce “l’oggetto intrinsecamente legato all’attività umana” : è la prassi umana che modifica e produce l’oggetto, il quale a sua volta modifica anche il soggetto, in modo che “l’effetto reagisce sulla causa e il loro rapporto si rovescia, l’effetto facendosi causa della causa, che diviene effetto pur rimanendo causa”. In questo consiste il cosiddetto rovesciamento della prassi: “la prassi che aveva come principio il soggetto e termine l’oggetto, si rovescia, tornando dall’oggetto (principio) al soggetto (termine)”. Per Marx reale è l’individuo sociale, che non può “sciogliersi dai vincoli della società che è effetto della sua prassi”, e lo studio della prassi è possibile a priori, in virtù del ritmo dialettico che la caratterizza: su questa base è appunto possibile determinare a priori lo sviluppo della storia, ossia costruire una filosofia della storia, cioè uno schema a priori. Lo sviluppo della prassi, infatti, non può non produrre divisioni nella realtà, cosicchè la lotta di classe non è un fatto accidentale ed ha, anzi, uno sbocco inevitabile: la filosofia della storia di Marx è dunque caratterizzata dal determinismo o teleologismo. Marx era stato “filosofo prima che rivoluzionario” e una filosofia è confutabile solo filosoficamente, a differenza di quel che pensava Croce, il quale voleva confutare empiricamente. Dal punto di vista filosofico, però, il marxismo presenta “il radical vizio” di un’indebita mescolanza di schema razionale a priori e di determinazione del contenuto della storia a posteriori, a partire dal fatto economico, che è puramente empirico. L’errore di Marx consisteva nell’aver preteso di trasportare la storia, che è propria dello spirito, nella materia, ma proprio il materialismo settecentesco stava a dimostrare l’inconciliabilità dei 2 princìpi, cioè della forma, identificata con la prassi, con la materia, che è inerte: il marxismo si configurava dunque come una concezione eclettica composta da elementi contradditori. L’errore di Marx era stato di considerare il pensiero “forma derivata e accidentale dell’attività sensitiva”. A questo Gentile opponeva una tesi, destinata ad essere il pilastro portante della sua filosofia: “il pensiero è reale, perchè e in quanto pone l’oggetto. O il pensiero è, e pensa; o non pensa, e non è pensiero. Se pensa, fa”. A ben vedere, il Marx teorico della prassi, a cui andava il consenso di Gentile, era già in qualche modo contenuta, e in forma migliore, nella tradizione idealistica di Fichte e di Hegel: il processo del reale tornava ad essere risolto nella coscienza che il soggetto ne ha. Il problema di Gentile, negli anni successivi, sarebbe stato di fare i conti con questa tradizione.
LA FILOSOFIA DI DANTE ALIGHIERI
I.
V’ha due modi d’intendere il pensiero d’uno scrittore: uno dei quali potrebbesi denominare classico, perché è il modo antico, tradizionale e corrispondente alla concezione dell’arte e della scienza propria dei classici; e l’altro, per antitesi, romantico, in quanto mette in rilievo, non pure nell’intelligenza e nel giudizio delle opere d’arte, ma anche nell’interpretazione delle dottrine l’elemento subbiettivo e individuale che è proprio e significativo della personalità dell’artista o dello scrittore, presente nell’opera sua, qualunque questa sia. A chiarimento di questo doppio metodo si possono ricordare due scrittori egualmente grandissimi, che sono per solito considerati come due voci assolutamente discordi dell’anima umana, anzi come espressione di due concetti opposti della vita: di ciascuno dei quali il significato s’inverte secondo che s’intenda con l’uno o con l’altro metodo: Platone e Leopardi. Platone è, senza dubbio, il massimo pensatore dell’ottimismo, il maestro di quanti, di là dalle apparenze mortali, in mezzo alle quali l’animo umano par condannato a disperdersi tra gli errori e i dolori, hanno concepito il mondo come ideale realtà, eterna infinita perfetta, in cui l’uomo sia quasi naturalmente portato dalla sua medesima natura a spaziare, mediante le sue facoltà superiori, libero da ogni limitazione di cose nate e periture, beato nel godimento di una vita divina. L’idealismo platonico è infatti soddisfazione di questo bisogno dell’uomo di liberarsi dalle angustie del mondo naturale, in cui egli nasce e vive come essere finito, e di partecipare a quella vita superiore dello spirito che s’espande nell’infinito. Filosofia, dunque, ottimistica per eccellenza. E a essa è tornato sempre lo spirito umano, rinnovandola variamente, ogni volta che è risorto nella coscienza profonda di cotesto bisogno e della propria natura immortale aspirante a librarsi al di sopra di tutte le cose mondane.
Ma la filosofia di Platone appaga questa aspirazione dell’uomo soltanto se si considera nel contenuto obbiettivo delle sue affermazioni, prescindendo dall’atteggiamento che Platone (o, piuttosto, lo spirito umano quale si attua nella personalità di Platone) assume di fonte alla dottrina in cui quelle affermazioni si conchiudono: che è come dire, rispetto a quel mondo che la dottrina stessa pone innanzi a Platone. A Platone, che non è l’uomo definito secondo la sua filosofia, ma l’uomo vivente nella sua filosofia: ossia a quel Platone, che solo è reale, nella ricerca ansiosa dell’idea, e poi nella celebrazione commossa di quel divino mondo che splende nell’idea e quindi nella polemica contro le avverse filosofie, e insomma nella professione attuale del proprio pensiero, quale si versa e si eterna ne’ suoi dialoghi. Lì è Platone, e lì veramente il suo pensiero, il suo idealismo. Ma quando si va a cercare lì questo idealismo, esso non apparisce così serenamente ottimistico, come parrebbe nell’astratta teoria delle idee. Lì il mondo, sì, è quello delle idee; ma in quanto veduto, e veduto nel suo valore (come Bene), e quindi desiderato, dall’uomo. Lì ci sono infatti le idee, ma c’è anche Eros, che è figlio di Penia; ed esso concentra in sé tutta la vita dell’universo, e culmina nello spirito umano che in tanto aspira alle idee, ed è filosofia, in quanto non le possiede, le idee. O almeno, non le possiede attualmente, e in sé e intorno a sé, nella coscienze e nella natura come tali, non vede e non sente quell’essere, a cui tende, anzi la mancanza di questo essere. Sicché tutta la vita, non quella a cui si aspira, sì quell’altra che si vive aspirando, è coscienza non pure di difetto di beatitudine, ma della ferrea necessità di tale difetto. E un’ombra di malinconia avvolge questa vita, misticamente concepita in fine come una costante «contemplazione della morte». E l’accento definitivo della dottrina platonica, quello che costituisce poi la grande bellezza dei suoi dialoghi immortali, non è la gioia d’una vita consapevole della propria potenza e del proprio valore, ma una profonda tristezza, quasi nostalgia della patria lontana: il dolore d’una vita che sente di non potersi giustificare.
Senza questa considerazione non s’intende Aristotele, che mira infatti a eliminare dalla concezione platonica il motivo di questa tristezza (la svalutazione della natura, e, in essa, dell’uomo); e quindi non s’intende neppure Platone nel concreto processo dello svolgimento storico, a cui esso realmente appartiene. Né s’intende, ripeto, la bellezza di quella poesia, in cui il suo pensiero si esprime. Giacché ogni filosofo ha la sua poesia, come ogni poeta ha pure la sua filosofia. E nessuno può dubitare della prima parte di questa sentenza leggendo Platone. La cui poesia consiste non nel sorriso ironico con cui Socrate guarda gli avversari (che sono, sotto vario nome, quelli di Platone); né nella ricchezza di umanità molteplice che ci si spiega innanzi nei vivi caratteri delle tante figure scolpite nei dialoghi; né in altri particolari, tutti bellissimi, perché tutti illuminati dalla bellezza di un’ispirazione centrale; ma nel profondo sentimento che anima tutto il mondo dei personaggi platonici, sgorgante dalla sua potente personalità religiosa, virilmente intenta a negare la vita dei sensi, in cui s’indugia l’uomo volgare, per affisarsi in un mondo trascendente, in cui l’animo posi sicuro.
In forza, al contrario, di questa considerazione noi non ci arrestiamo a un astratto concetto del platonismo, ma, entrando nel vivo di questa filosofia, lì dove essa è filosofia essendo pure poesia, l’intendiamo nella sua concreta unità di pensiero che non può individuarsi in una determinata forma obbiettiva senza esprimere un’anima: unità, cioè, di pensiero e pensante, verità e uomo; filosofia del filosofo.
Il caso del Leopardi è l’inverso. Egli è il poeta del pessimismo, perché il contenuto del suo pensiero, nelle sue prose e nelle sue poesie, sempre, è una dottrina opposta alla platonica. Platone idealista, Leopardi sensista e materialista. Per Platone il mondo è finalisticamente orientato verso una realtà che lo trascende; per Leopardi è un sistema chiuso, in cui tutta la vita è movimento, e ogni legge meccanismo. Il filosofo, secondo Platone, aspira con la sua dialettica alle idee, quindi a superare la natura; secondo Leopardi, l’apice della sapienza è la persuasione che conviene adattarsi («assuefarsi»): riconoscere il carattere illusorio di tutte le idealità, che traggono l’animo umano a opporsi alle leggi universali della natura. La conclusione è quella di Bruto minore: la virtù è un nome vano. L’«irrequieto ingegno», allontanando l’uomo dalla vita istintiva e quindi dalla legge universale della natura, pare promettergli, come pensò Platone, la beatitudine degli dèi immortali; ma infatti lo condanna a un immedicabile dolore. Queste convinzioni, attinte alla filosofia materialistica del secolo XVIII, formano un tutto ben saldo e compatto nel pensiero del Leopardi, e sono, si può ben dire, il concetto del mondo, com’egli lo vede e lo afferma: la verità, di cui egli non dubita menomamente; e che enuncia infatti non come una propria individuale opinione, della quale non sappia disfarsi, anzi come la dottrina filosofica, contro la quale si spuntino tutti gli argomenti delle altre, e della quale tutti i filosofi si renderebbero conto certamente, se sapessero sottrarsi ai preconcetti e agl’idoli di cui sono schiavi.
Ebbene, non è osservazione nuova, che l’effetto della poesia leopardiana è l’opposto di quello che una dottrina pessimistica dovrebbe produrre; e che la conclusione di Bruto minore non è veramente la conclusione che il poeta insinua e lascia nell’animo dei suoi lettori. La virtù, schernita sui campi dove giacque prostrata la romana libertà, risorge nell’animo e nella poesia del Leopardi cinta dall’aureola delle cose divine, in cui l’uomo sente il bisogno di credere:
|
Bella virtù, qualor di te s’avvede, Come per lieto avvenimento esulta Lo spirto mio … Alla bellezza tua ch’ogn’altra eccede, O nota e chiara, o ti ritrovi occulta, Sempre si prostra; e non pur vera e salda, Ma imaginata ancor, di te si scalda. (Paral. V, 47) |
Il suo animo dolcemente e virilmente umano ripugna al fato; di cedere inesperto, non s’arrende alla cruda legge di quella natura, che egli non riesce invero a rappresentarsi e a sentire muta e inconsapevole macchina, ignara dei dolori inflitti alle creature che stritola; anzi umanamente la raffigura priva di pietà «e de’ suoi figli antica E capital carnefice e nemica» (Paral. IV, 12). Esorta e incita gli uomini a unirsi per resisterle, ad amarsi, perciò, e a contrapporre alla spietata legge della necessità il regno dell’amore, in cui l’uomo può liberamente sottrarsi ai colpi del fato e al dolore. E nella dolcezza di questo senso profondo di cristiano amore del prossimo, nell’irriducibile forza della libertà di farsi un proprio mondo al di sopra di quel cieco meccanismo in cui si svolge la vita desolata della natura, in questa incoercibile coscienza dell’umanità vittoriosa anche sulle più crude rappresentazioni materialistiche della realtà, qui è la radice della vita e il motivo del fascino della poesia leopardiana, sublimante in una personalità superiore sostanziata di fede nell’amore e nella virtù dell’uomo un mondo in sé stesso cattivo e pur redento nello spirito che lo contempla (1).
La filosofia leopardiana pessimistica in quella sua astratta obbiettività, in cui si vuol vedere il pensiero d’ogni scrittore dal punto di vista classico, si converte invece in una delle più vigorose forme di ottimismo altamente umano, se si ricerca là dove essa vive la sua vita reale, pronta a comunicarsi a quante anime vi si appressino: nella poesia che sgorga dal sentimento dello scrittore, dal suo atteggiamento spirituale, ossia da quell’individualità, per cui egli grandeggia nella storia sul suo piedistallo.
II.
Non è questo il luogo per discutere quale di questi due metodi debba prevalere nella storia della filosofia. Basti qui avvertire che soltanto distinguendo l’uno dall’altro di questi metodi c’è modo di risolvere ragionevolmente una questione tante volte dibattuta a proposito del Leopardi e a proposito di Dante, come d’ogni altro poeta, dentro alla cui poesia non si può non vedere scorrere, quasi onda avvivatrice e fecondatrice, un pensiero. E poiché non c’è pensiero, ancorché incompiuto e particolare, che non sia un sistema e non postuli logicamente tutta una filosofia coerente, dove siano i motivi della sua verità e i fondamenti della fede con cui vien professato, – di quella fede, che non manca di certo ai poeti nell’intensità di vita spirituale che essi realizzano, – così di questo pensiero è naturale che si sia indotti a cercare e definire la forma sistematica, indagando la filosofia del poeta. Ma la poesia non è filosofia, né la filosofia è poesia: e la poesia filosofica come ogni poesia didascalica nasce morta. E quella di Dante invece è viva!
Per Dante, in particolare, non potendosi negare che una filosofia ci sia nella “Commedia”, s’è detto: «E qui è d’uopo che ben si distingua». Ci sono bensì nel suo Poema canti o brani in cui Dante troppo si ricorda di quei tristi e pur dolci anni della gioventù, quando, mortagli Beatrice, e cercando egli consolazione al suo dolore nella filosofia, cominciò «ad andare ov’ella si dimostrava veracemente, cioè nelle scuole de’ religiosi e alle disputazioni de’ filosofanti; sicché in picciol tempo, forse di trenta mesi, cominciò tanto a sentire della sua dolcezza che ‘l suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero» (Conv., II, 13); e si lascia andare a rimeditare concetti, che interrompono il corso del suo ingenuo fantasticare, donde zampilla la fresca vena della sua poesia. Ma il poeta non è in quei canti o brani, duri sassi, scogli immoti, intorno ai quali si agitano, si frangono e spumeggiano le vive acque della creazione spontanea. Dov’è il filosofo non è il poeta, e dov’è il poeta non è il filosofo. Di guisa che niente sarebbe men degno di una commemorazione sei volte centenaria, come quella che ora si celebra per l’Alighieri, che andar raccattando nel suo Poema e in tutta l’opera sua questa parte morta, a cui si ridurrebbe la sua filosofia. Morta rispetto alla sua poesia, che la respinse infatti dal proprio seno; morta rispetto alla storia dell’umano pensiero, tanto ormai dilungatosi da quello che Dante conobbe nelle scuole de’ religiosi e dalle disputazioni dei filosofanti contemporanei. Laddove è chiaro che il Dante che noi celebriamo, e che sarà sempre celebrato, non è quello che morì insieme co’ suoi contemporanei, sì quello che sopravvisse all’età sua, vive con noi, e vivrà eterno.
Ma il pensiero d’un poeta non è per vero intelligibile alla stregua del metodo che ho detto classico. Si credette già una volta che questo fosse appunto il metodo per giudicare integralmente del poeta, quando all’arte applicavasi l’estetica del contenuto. Ma oggi tutti convengono che l’arte è forma. Non tutti, per altro, riconoscono la verità del concetto formale dell’arte; che non intende già valutare una forma astratta, scissa dal contenuto, bensì quella forma in cui tutto si risolve (o si deve risolvere) il contenuto dell’opera artistica. Sì che il mondo che il poeta vide, non si mette già da parte come materia estranea e indifferente allo sviluppo di quel processo in cui la creazione estetica consiste; ma si considera, quale esso è infatti, illuminato dalla luce in cui fu dal poeta veduto in virtù della sua passione e però di quel certo atteggiamento spirituale, che costituì la sua precisa individualità poetica, espressa appunto in quel mondo avvolto in quella luce. Quale che sia cotesto contenuto, esso riflette e quasi incarna la personalità del poeta, in quanto reca in ogni sua fibra viva il fremito di quell’anima che gli dà vita.
Astrattamente concepita in sé, la materia dell’arte è natura o umanità: abisso tenebroso o firmamento stellato; quercia robusta che affonda nel suolo le radici tenaci e spande i suoi rami poderosi nel cielo, o tenue stelo che un leggiero venticello abbatte e uccide con le sue esili foglie e il suo fiorellino effimero; brivido della carne che restringe e chiude l’umana coscienza in un piccolo e fuggevole aspetto e quasi in un punto solo del mondo, o vasto concepimento in cui si raccoglie tutto quello che l’universale esperienza dei secoli ha accumulato a poco a poco nel pensiero umano, con tutti i relativi interessi e gli alti bisogni che ne sono stati a ora a ora suscitati dall’imo fondo dell’umana volontà: tutto l’essere, cui possa volgersi l’animo, e in cui possa affisarsi e fermarsi. E c’è posto anche per la filosofia, come per ogni altra forma assegnabile alla vita dello spirito umano. Ma, quale che sia in sé, cotesto contenuto è poesia in quanto trasfigurato nella vita concreta che esso vive nello spirito del poeta. Né dal complesso del mondo, che questi accolse in sé, può, “a priori”, staccarsi parte alcuna che in sé considerata apparisca impoetica; poiché ogni materia, a considerarla in sé, è fuori della poesia, essendo fuori dello spirito umano, e fuori della realtà. Né, infine, la filosofia d’un poeta può essere altro che la stessa sua poesia, dov’è pure la sua politica, la sua religione, e in generale tutto il suo mondo.
Il pensiero dunque d’un poeta non si attinge per altra via da quella che ci è additata dal metodo romantico; il quale non solo ci mette in grado di ricostruire il pensiero stesso, ma di scavare attraverso di esso fino alla scoperta del filo d’oro di quella vita immortale che è la poesia, in cui il pensiero fu assunto e assorbito.
III.
Dante, assoggettato a quell’analisi che distingue il contenuto dalla forma, ha una filosofia, della quale tante volte si è discorso, discusso e dissertato: quel sistema di pensiero che rinverga nelle sue linee principali con la dottrina scolastica, quale si costituì nella seconda metà del secolo XIII, per opera principalmente di Tommaso d’Aquino: quantunque Dante, con l’anima aperta a tutti i motivi spirituali e a tutti gli interessi umani e speculativi, con l’intelletto, potente non meno dell’alta fantasia, pronto a raccogliere e conciliare tutte le voci dei pensatori diversi, che parimenti gli facessero vibrare il cuore nell’ansia della ricerca d’una verità assoluta, non sia propriamente un tomista ortodosso, e accetti, – come gli studi recenti intorno ai particolari e agli accenni incidentali del suo pensiero speculativo vengono sempre più dimostrando (2) – dottrine e concetti d’altri indirizzi filosofici, e in alcune parti del suo pensiero, segnatamente nelle opinioni politiche, originalmente si spinga più in là della linea entro la quale s’era chiusa la filosofia scolastica. In una parola, Dante filosofo, interpretato e giudicato col metodo classico, è uno scolastico, il cui posto nella storia della filosofia è assai umile, se in lui non si guardi piuttosto allo scrittore sommo che primo trattò in volgare di filosofia traendola dalle scuole umbratili dei chierici, nel campo aperto della cultura laica e dentro al pensiero della nuova letteratura nazionale, da lui d’un tratto sollevata ad altissimo grado. Ma la scolastica di Dante, come or ora vedremo sommariamente, cercata nel suo Poema, dove Dante è veramente Dante, è, come tutti vedono, lo sfondo solo del quadro: materia di cui la fantasia del Poeta si serve per costruire il suo mondo, gettarvi dentro le sue creature, e dentro a esse il suo animo, che ogni lettore vede presente dal primo all’ultimo verso dei cento canti. La sua filosofia, come ogni altro elemento del mondo intorno a cui la mente di Dante lavora, è tutta una visione, un sogno. Com’è del resto la materia di ogni opera d’arte. Ma, al pari d’ogni sogno, non ha verità né realtà fuori della fantasia, che nel sogno spiega la sua attività e spazia nel mondo che essa si finge; né può intendersi perciò fuori dell’essere subbiettivo che è la personalità di chi sogna obbiettivando sé stesso in quella realtà che appartiene al comune dominio dell’esperienza e del pensiero umano.
Dante, quando compie nell’Empireo la sua visione per cui un mondo è stato creato dalla possa della sua fantasia, un mondo che egli ha contemplato attraversandolo e scrutandolo con occhio inquieto e animo bramoso di luce, eterno pellegrino in cerca di Dio, al conchiudersi del suo singolare pellegrinaggio lo vede, questo mondo, ormai completo e vivo di vita autonoma distaccarsi dalla matrice, che gli ha comunicato la vita: sente rompersi quell’unità per cui egli ha vissuto nella sua visione, e la sua visione è vissuta in lui. Tutto un mondo, sì, mirabilmente saldo, obbiettivo, e pure svolgentesi punto per punto nella stessa vita operosa e incessante del suo spirito creatore, ormai gli è divenuto estraneo. Ed egli allora esprime splendidamente, come nessun altro poeta mai, i due elementi dal cui indissolubile nodo trae vita e alimento ogni opera d’arte:
|
Qual è colui che somniando vede, E dopo il sogno la passione impressa Rimane, e l’altro alla mente non riede; Cotal son io: ché quasi tutta cessa Mia visione, ed ancor mi distilla Nel cuor lo dolce che nacque da essa: Così la neve al sol si dissigilla; Così al vento delle foglie lievi Si perdea la sentenza di Sibilla. (Par. XXXIII, 58-66) |
Visione, dunque, e passione: l’una materia, l’altra forma. Quella cessa, e non riede più alla mente; questa rimane impressa, come la dolcezza del cuore in cui subbiettivamente si trasmutò quel che si vide in sogno. Da una parte, il mondo del poeta; ma dall’altra, il poeta stesso, il quale finché quel mondo non cessi, non si sente diviso da esso, poiché la loro vita è una vita comune, unica. Finché la visione dura, essa è bensì un mondo, ma un mondo dentro al quale c’è una passione, un cuore, un uomo; c’è una filosofia, ma una filosofia non definibile in astratto, bensì conoscibile soltanto come vita di questo uomo, del suo cuore, della passione del suo cuore.
In certo senso, tutto quel mondo può dirsi non sia altro che una filosofia, esposta bensì in forma allegorica, ma non men manifesta; poiché attraverso questa forma, la mente di Dante, data la sua educazione e la sua cultura mistico-religiosa, vagheggia appunto e accarezza una filosofia. Infatti, si badi bene, a proposito di allegoria, a non confondere ciò che bisogna con ogni cura distinguere se non si vuol lasciare che sfugga tanta parte della poesia dantesca: l’allegoria posticcia e meccanica e l’allegoria costitutiva, organica e vivente, la quale non cade sotto la condanna a cui è fatta segno la prima; e rende infatti possibile a Dante, malgrado tutti i veli allegorici onde sono avvolte le sue creature, di levarsi in alto in un cielo luminoso, egli e le sue creature splendide di verità. L’allegoria, come ogni altra forma o figura onde la fantasia si rappresenti il suo obbietto, è legittima pur che osservi la legge essenziale della forma, di non restare fuori del suo obbietto, quasi veste che aderisca estrinsecamente, che copra e non sveli. Ma il pericolo di ogni allegoria che, raffreddando la fantasia, le impedisca di raggiungere la realtà che si vorrebbe raffigurare, è pure il pericolo che incombe sopra la più semplice e schietta parola, in quanto essa può essere trattata meccanicamente quale mezzo d’espressione che sia da accostare alla cosa, anzi che come la stessa forma viva della cosa nella vita di questa attraverso lo spirito umano. L’allegoria in verità non vuol essere altro che una parola: una parola espressiva, corpulenta, che s’apprenda alla fantasia e vi si scolpisca in alto rilievo. E se non piaccia dire «parola», dicasi «simbolo»: del quale pure in arte si abusa senza che l’abuso possa autorizzare ogni divieto, almeno finché non siasi dimostrato che ci sia o possa pensarsi qualcosa di cui l’uso è legittimo e desiderabile, e non sia possibile pure il più deplorevole abuso.
Intendere il pensiero o intendere la poesia di Dante rifiutandone ogni elemento simbolico o allegorico è impossibile, poiché a Dante tante cose di quelle che più lo appassionarono e gli stettero innanzi, anzi gli riempirono l’anima e la vita, raffigurate così come a lui veniva naturalmente fatto di vederle in conseguenza delle sue abitudini mentali e dei consueti modi di esprimersi e però di raffigurare a sé medesimo gli obbietti del suo pensiero, gli si presentarono in forma allegorica. Non fu arbitrio suo – tanto per addurre un esempio che qui particolarmente c’interessa – l’interpretazione della poesia virgiliana come adombramento di una dottrina morale; e spontanea nello sviluppo della sua personale cultura fu la genesi del concetto di Virgilio, simbolo della ragione naturale non rischiarata da lume di rivelazione divina. Per modo che quando dal lento segreto processo di formazione del nucleo primitivo del Poema sorse nel quadro che prese a spiegarsi innanzi al Poeta, questa figura viva e parlante del suo Virgilio, egli già incarnava la ragione quale Dante la vide dentro sé medesimo accamparsi laboriosamente in un sistema di concetti, noti agli antichi, al tempo degli stessi dèi falsi e bugiardi. E tanto per lui Virgilio s’immedesimò con questa realtà da lui stesso sperimentata, della speculazione naturale o razionale, e cioè della filosofia che i dotti medievali avevano ereditata dai grandi maestri dell’antichità, quanto riesce impossibile a un chirurgo pensare al ferro metallo quando pensa ai suoi ferri. Orbene, tutta la poesia che trema nel Poema intorno a Virgilio, svanirebbe se dal simbolismo di questa figura noi, contro l’intenzione del Poeta, volessimo prescindere.
Il «duol senza martiri» del Limbo, dove
|
Non avea pianto ma’ che di sospiri, Che l’aura eterna facevan tremare; (Inf. IV, 26-27) |
il «difetto» di quella «gente di molto valore» che non adorò debitamente Dio, e per ciò solo è perduta, e vive «in desìo sensa speme», sottratta quasi nel Limbo a ogni giudizio divino, mercé la grazia acquistata a lei dalla sua umana grandezza («l’onrata nominanza Che di lor suona su nella tua vita»), l’aspetto stesso di quelle grandi ombre:
|
Sembianza avevan né trista né lieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genti v’eran con occhi tardi e gravi, Di grande autorità ne’ lor sembianti: Parlavan rado, con voci soavi; (Inf. IV, 84, 112-114) |
tutto questo misto di reverente simpatia e di indicibile tristezza che spira da ogni parola di Dante per gli spiriti magni, dai quali è venuto a lui Virgilio; e l’intimità di affetto espressa verso di lui «dolce padre» e «più che padre», la quale prorompe dopo che l’opera di Virgilio è compiuta, e Dante non ha più bisogno della sua guida poiché «libero, dritto e sano è suo arbitrio» (Purg. XXVII, 140), e sopraggiunge, guida superiore a più alta meta, Beatrice, e Virgilio sparisce dal fianco di Dante:
|
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi Di sé; Virgilio, dolcissimo padre; Virgilio, a cui per mia salute die’mi; (Purg. XXX, 49-51) |
la commozione che vibra nelle parole di Virgilio stesso quando accenna al contrasto tra la propria e la sorte di Beatrice:
|
Tu la vedrai di sopra, in su la vetta Di questo monte, ridere e felice; (Purg. VI, 47-48) |
dove lo stesso contenuto e dignitoso affanno del desìo sensa speme si risolve e rasserena nella trionfante luce di questo riso sulla vetta del monte della purificazione; tutto ciò – per accennare ad alcuni dei tratti della ricchissima rappresentazione virgiliana -, evidentemente, non avrebbe nessun significato, se Virgilio non fosse agli occhi di Dante una persona sì, ma rappresentante, come «savio gentil che tutto seppe», quella ragione (Purg. XV, 76), che, secondo egli stesso dice, non può disfamare Dante, cui soltanto Beatrice potrà togliere ogni altra brama: o in altri termini, quella filosofia, che aveva saputo tutto ciò che l’uomo può sapere senza la fede: la filosofia degli antichi.
In verità, il disperato desiderio di Virgilio non è altro che il pessimismo platonico a cui si è di sopra accennato: quella conclusione, a cui pervenne prima dell’avvento del cristianesimo non pure la dottrina di Platone, che di tutto il pensiero antico si può veramente considerare l’espressione più caratteristica, ma ogni dottrina, la quale movesse dal punto di vista proprio, in generale, a tutta la speculazione greca.
Noi oggi vediamo chiaramente quello che Dante e i filosofi del suo tempo scorgevano pure sicuramente per quanto in confuso: che cioè la stessa posizione propria di tutta la filosofia pagana non consentiva la debita adorazione di Dio, il riconoscimento dell’identità di natura tra Dio adorato e l’uomo che l’adora, ossia della sua spiritualità. Quella filosofia si sforza tutta di concepire intellettualisticamente la realtà, come oggetto assoluto della conoscenza umana; e la realtà, quale si rappresenta all’intelletto che la presuppone come suo oggetto, concepita come molteplicità atomica o come cosmo intelligibile, come estensione o come pensiero, rimane sempre qualche cosa di chiuso in sé, che l’uomo non può riconoscere senza sentirsene fuori; che è come dire, senza svalutare sé stesso, e annientare idealmente nella realtà assoluta la propria personalità, la propria libertà, la coscienza della propria creatività. Se il mondo è tutto quello che dev’essere quando noi prendiamo a conoscerlo, questa vita che comincia a realizzarsi mercé l’attività del nostro spirito, non può non apparire illusoria, poiché rimane esclusa dalla totalità dell’essere concepibile; e non può quindi non svanire nel nulla. Donde quel travaglio disperato d’Amore, in cui Platone simboleggia non pur la vita del pensiero umano aspirante all’immortalità delle idee, ma della natura universale, tutta corrente, immensa fiumana, dal monte a una foce irraggiungibile. Da Parmenide, per cui la realtà è quell’Unità, in cui il pensiero deve immedesimarsi per essere, a Plotino che ripone l’apice supremo della vita spirituale nell’estasi in cui lo spirito deve uscir da sé per assorbirsi nell’Uno, il savio gentile s’affisa per otto secoli, anzi per tutto lo sviluppo della civiltà pagana, in una realtà esterna che è tutto, e non contiene in sé la stessa sapienza del savio; non ha posto per quella realtà, entro la quale l’uomo vive pensando e volendo. Il suo Dio è semplice natura. Quindi il pessimismo profondo radicale che è in Platone, e che non può ritrovarsi in Leopardi.
Per restituire la speranza all’uomo che naturalmente desidera, occorre che la posizione dell’uomo di fronte al mondo muti, e sia diverso perciò il suo atteggiamento verso Dio, principio assoluto dell’essere che costituisce il mondo. La conoscenza intellettuale deve cedere il luogo all’amore: a quell’atto spirituale che non presuppone, ma esso fa essere il termine reale, a cui s’indirizza; lo fa essere, s’intende, nell’ambito stesso della vita spirituale, nella coscienza. Occorre cioè che la realtà a cui ci si rivolge non sia questa natura, a cui noi pure naturalmente apparteniamo; ma quello spirito, in cui a noi non è dato penetrare se non in virtù, di un’attività che non è istinto, né, comunque, legge naturale, ma libertà: l’opposto, la negazione della natura. La divina realtà dev’essere intesa dunque come Spirito: spirito in sé (monotriade), spirito rispetto all’uomo (mediatore). Ecco una nuova sapienza, ecco, come dice Dante di Beatrice, la «loda di Dio vera» (Inf. II, 103): ecco quella «che lume fia tra il vero e l’intelletto» (Purg. VI, 45). Sapienza che, per Dante e per la filosofia cristiana come tutti al suo tempo l’intesero, non è opera di ragione; e non può infatti incontrarsi sulla stessa via per cui procede tutta la filosofia greca. Virgilio quando lì, sulla balza degli accidiosi, espone a Dante la scolastica dottrina del libero arbitrio – che è invero uno dei punti critici, in cui la filosofia cristiana doveva sentire il suo profondo distacco dalla pagana – premette:
|
Quanto ragion qui vede Dirti poss’io; da indi in là t’aspetta Pure a Beatrice, ch’è opra di fede. (Purg. XVIII, 46-48) |
IV.
Tra questi due termini, riassuntivi di tutta la filosofia per cui spazia il pensiero e il cuore di Dante – Virgilio e Beatrice – si svolge l’allegoria filosofica del Poema. Il divario tra questi due termini per Dante è un abisso: come si sente nell’energica protesta, tutta dantesca, messa in bocca a Virgilio nell’Antipurgatorio; protesta che si smorza infine e trapassa nel solito sospiro profondo dell’umanità consapevole de’ proprio confini:
|
Matto è chi spera che nostra ragione Possa trascorrer la infinita via Che tiene una sustanzia in tre persone. State contenti, umana gente, al quia; Ché, se potuto aveste veder tutto, Mestier non era partorir Maria; E disìar vedeste senza frutto Tai, che sarebbe lor disìo quetato, Ch’eternalmente è dato lor per lutto: Io dico d’Aristotile e di Plato, E di molt’altri. – E qui chinò la fronte, E più non disse, e rimase turbato. (Purg. III, 34-35) |
Si tratta di una dottrina comune a tutta la speculazione cristiana; e rispetto alla quale si può ben dire che Dante ripeta quello che s’insegnava in tutte le scuole. Ma in lui assume certi accenti ingenui, che mi paiono manifesti indizi d’una disposizione di mente personale. Quando a San Pietro, che nel Cielo stellato, lo esamina sulla sua fede, egli dice:
|
La larga ploia Dello Spirito Santo, ch’è diffusa In su le vecchie e in su le nuove cuoia, È sillogismo che la m’ha conchiusa Acutamente sì, che, inverso d’ella, Ogni dimostrazion mi pare ottusa;
|
quando, nella stessa prova d’esame, ribadisce che il suo credere non deriva da prove fisiche e metafisiche, ma glielo dà «la verità che quinci piove» nei due Testamenti divinamente ispirati (Par. XXIV, 91-96, 135-138); Dante, senza dubbio, non fa che attenersi al comune insegnamento. Ma, quando nel Cielo di Saturno si fa dire da Pier Damiani, a proposito del disperato problema della predestinazione:
|
sì s’inoltra nell’abisso Dell’eterno statuto quel che chiedi Che da ogni creata vista è scisso; (Par. XXI, 94-96) |
nonché affermare, senz’altro che
|
La mente che qui luce, in terra fuma; Onde riguarda come può laggiue Quel che non puote, perché il ciel l’assuma; (v.v. 100-102) |
che cioè non pure in terra, ma neanche in cielo la mente umana può giungere alla risoluzione de’ suoi più assillanti problemi; allora Dante, o io m’inganno, accentua a modo suo lo scetticismo proprio della filosofia cristiana circa i poteri della ragione umana. Di che un altro segno pare di scorgere nel commento che lo stesso Poeta fa seguire alla ragione messa in bocca ai dottori, i quali nel Cielo del Sole gli parlano della resurrezione dei corpi:
|
Come la carne gloriosa e santa Fia rivestita, la nostra persona Più grata fia per esser tutta quanta; (Par. XIV, 43-45) |
che non è certo la più forte e speculativa ragione che si possa trarre dall’insegnamento di Tommaso d’Aquino. Comunque, innanzi alla gioia dei beati che pregustano la maggior letizia a cui saranno abilitati dal corpo onde torneranno a vestirsi, Dante mette da parte gli arzigogoli della scienza teologica, e si rinchiude nel suo vigoroso senso d’umanità; restìo a barattarlo col concetto della vita dedotta speculativamente a forza di sottilissimi raziocinii:
|
Che ben mostrâr disìo dei corpi morti; Forse non pur per lor, ma per le mamme, Per li padri e per gli altri che fur cari Anzi che fosser sempiterne fiamme: (v.v. 63-66) |
dove si direbbe che l’uomo si scuota di dosso il peso inerte d’una dottrina accettata sì, ma non sentita.
Ma c’è di più. Guardate nel nobile castello, dove sopra il verde smalto s’adunano gli spiriti magni, e in alto attorno ad Aristotele, maestro, si vede riunita la famiglia dei filosofi, oggetto d’ammirazione e di alto rispetto pel Poeta. Vi sono non solo i rappresentanti di tutte le scuole antiche, che tutte Dante accoglie nel suo concetto della grande sapienza antica; ma c’è Avicenna, arabo; c’è perfino «Averroìs, che il gran commento feo»; e anche lui, nonostante la fosca leggenda che già l’avvolgeva nelle fantasie cristiane, nonostante le forti e giuste polemiche contro di lui e dei suoi seguaci che la scolastica ortodossa, a capo di essa l’Aquinate, combatteva nell’interesse della fede cristiana e degli alti interessi morali umani, a cui dalla nuova fede veniva conforto, anche lui grandeggia nell’animo di Dante, perché anch’egli è tra quei maestri, a cui gli uomini debbono quanto ragion vede. Guardate nel Cielo del Sole, dove si accolgono i Dottori cristiani, e parla Tommaso d’Aquino, il più grande che fra essi Dante conobbe. Tommaso, fra le luci che gli brillano accanto, si compiace non pur di nominare un Riccardo di San Vittore, antesignano d’una filosofia divergente dalla sua, ma di celebrare altresì in modo particolare quello spirito «che in pensieri gravi a morir gli parve venir tardo»; la luce eterna di Sigieri, che era stato addirittura processato per eresia, e la cui fama non pervenne di sicuro a Dante netta d’ogni macchia dottrinale. Ancora, alle «scuole dei religiosi» non poté egli non apprendere come tomisti e scotisti, domenicani e francescani, si contrastassero il campo; ma le lodi di San Francesco egli fa dire al maggiore di quelli, e dal maggiore di questi le lodi di San Domenico. Egli insomma non mette, non impegna tanto l’animo suo nell’insegnamento di una scuola, da partecipare alle passioni particolari ed esclusive di essa. In filosofia, non conosce intolleranza, egli che ferocemente nel Convivio si mostra pronto a brandire il coltello contro i detrattori del volgare. E in verità, non si schiera né con questa né con quella scuola; e non pare che sia attratto verso le questioni (a cui nella sua ricca e completa personalità pur s’interessa) per le quali gl’indirizzi filosofici si oppongono e pugnano tra loro.
Consideriamo più attentamente il processo entro il quale si svolge, nella visione dantesca, l’itinerario della mente a Dio dalla selva delle passioni, «tanto amara che poco più è morte» fino a «L’Amor, che muove il sole e l’altre stelle», e con cui la volontà dell’uomo, al termine dell’itinerario, s’immedesima. Questo processo, a rigore, non ha il suo primo principio nella selva. Dalla quale il Poeta non uscirebbe senza Virgilio. Ma Virgilio stesso non si moverebbe al suo soccorso, se non fosse chiamato da donna beata e bella, mossa da Amore, dalla Grazia (da Lucia, anzi da Maria). Il primo principio dunque è Dio. La grazia di Lui invia al soccorso dell’uomo la beatrice teologia, di cui è mezzo la ragione. La quale perciò non si sveglia da sé; e se naturalmente è potente a quella sapienza, che già fu in terra prima di Cristo, non è senza divino consiglio, che prepari di lunga mano l’avvento dello Spirito. Guidato da Virgilio, Dante vede il temporal foco e l’eterno; questo prima, e poi quello, fino al Paradiso terrestre, dove Virgilio non ha più nulla da insegnargli, e gli dice: «Non aspettar mio dir più, né mio cenno». E aggiunge anche: «Libero, dritto e sano è tuo arbitrio» (Purg. XXVII, 139-140). Ma è l’arbitrio dell’uomo razionale, non ancora rifatto e trasfigurato dalla grazia: non è tuttavia la vera libertà, che ricrea l’uomo nell’amore; quella libertà di cui parla Dante quando a colei che «all’alto volo gli vestì le piume», e gl’imparadisò la mente (Par. XV, 54, e XXVIII, 3), dirà infine, nel separarsi nell’Empireo:
|
Tu m’hai di servo tratto a libertate, (Pur. XXXI, 85) |
battendo con l’accento sul “tu” iniziale.
Dunque la vera libertà, a cui Dante aspira, e che è infatti il termine d’ogni umana aspirazione, non è opera di Virgilio se non in parte. Vi occorre anche Beatrice. La quale per altro non è semplice scienza speculativa che possa simboleggiare p. e. la Somma teologica di San Tommaso: giacché San Tommaso è un razionalista, che s’argomenta di raggiungere Dio per mezzo della filosofia, movendo dalla natura, oggetto dell’esperienza sensibile; e sdegna così le argomentazioni “a priori”, proprie dei platonizzanti, esposte al rischio di confondere in uno la creatura e il creatore, come la mistica contemplazione che s’affida unicamente all’amore. Dante, che apprezza tutti i motivi di vero espressi dalle varie tendenze e non si chiude in nessun sistema, non crede sufficiente né anche Beatrice:
|
A terminar lo tuo disiro Mosse Beatrice me del loco mio, (Par. XXXI, 65-66) |
gli dice San Bernardo, che ripone, a sua volta, la sua fede nella Regina del cielo, ond’egli «arde tutto d’amor»: in quella stessa Donna Gentile, che già aveva interceduto per Dante movendo Lucia, e per suo mezzo Beatrice. E sono «gli occhi da Dio diletti e venerati» (Par. XXXIII, 40) a operar il supremo miracolo, proprio per mezzo di quell’amore mistico, che una filosofia ben diversa dalla tomista raccomandava come metodo della cognizione di Dio.
Anche per Dante, in conclusione, l’uomo torna a Dio in quanto muove da lui; e l’amore supremo con cui l’uomo conosce e ama insieme Dio, non è se non lo stesso amore con cui Dio ama e conosce sé stesso. L’universo è un circolo, per cui l’azione divina scende per risalire, si moltiplica, come luce che piove di cosa in cosa, per raccogliersi nella sua unità eterna e infinita.
Questa, come quadro armonico in cui si compongono a unità gl’insegnamenti antichi e nuovi del sapere umano e divino, la visione, che Dante vagheggia come contenuto del sacro Poema «al quale ha posto mano e cielo e terra». Visione che, così sommariamente descritta, è, come ognun vede, una filosofia, ben diversa certamente dalla pagana, poiché dentro vi si muovono elementi nuovi, alla dottrina intellettualistica degli antichi affatto estranei. Nel suo complesso si riduce alla concezione del mondo propria della scolastica, pur tenendo conto dei diversi elementi che Dante vi concilia. I quali per altro non modificano le idee fondamentali di quella filosofia, in cui cercò il suo assetto, per diverse vie, il pensiero cristiano dopo i Padri che fissarono i dommi della nuova fede, e prima dell’Umanesimo, che segnerà l’inizio d’un’èra nuova d’indagine speculativa sulla stessa base dell’intuizione cristiana.
V.
Ma quando s’è definito il carattere della visione, non s’è giunti ancora al concreto della filosofia dantesca. La quale è visione, abbiamo visto, in quanto è insieme passione; e se Dante toglie dalle scuole del suo tempo la materia del suo pensiero, v’imprime sopra profondamente il suggello della sua potente personalità, trasfigurando pertanto la stessa filosofia in poesia.
La personalità di Dante è sì la personalità di un poeta, ma d’un poeta qual egli volle essere: profeta. Dopo la poesia giovanile, in cui egli non ha trovato ancora sé stesso, e che si conchiude con l’alta misteriosa promessa di dire della sua donna «quello che mai non fu detto d’alcuna», attraverso il Convivio e il De vulgari eloquentia matura il suo ideale, ed egli acquista chiara coscienza della missione, a cui consacrerà il Poema e la Monarchia.
Quale l’idea del Convivio? La stessa, nel primo disegno, della Commedia, non messa interamente in atto, perché non ancora matura. Dante, sentito l’artiglio della fortuna, e non soltanto sulla propria persona, guarda il mondo e la vita con altri occhi da quelli con cui negli anni giovanili poté vagheggiare gioiosamente un ideale meramente letterario di «rime d’amor dolci e leggiadre». Il mondo nei contrasti della fortuna e delle passioni politiche gli apparve cosa assai più seria e vasta: la vita, arte ben più difficile e ardua. «Legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertà»: peregrino «per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende», sentì crescersi tanto più nell’animo la coscienza virile della propria dignità e della propria responsabilità verso sé stesso, quanto più gli parve nel doloroso vagare che s’invilisse la sua persona agli occhi degli altri, poiché la piaga della fortuna «suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata». Laddove l’esperienza politica degli uomini e degli avvenimenti e l’abito speculativo appreso già negli studi filosofici gli vennero persuadendo, che il suo esilio e i disordini della sua città avessero la loro causa remota nel sistema stesso della vita non solo politica, ma altresì morale e religiosa non pur di Firenze, ma del complesso storico di cui essa faceva parte. E che bisognava correggere non già alimentando le piccole fazioni cittadine, come quelle in cui anch’egli era stato involto, ma mettendo la scure alle radici, come poteva fare soltanto chi avesse autorità da ciò, e non riparasse modestamente all’ombra di una scuola per quanto lodata e ammirata di rimatori, ma si levasse in alto nella stima e nella considerazione degli uomini, che, se concedono qualche momento dei loro ozi ai poeti, consacrano la loro vita, la loro volontà, il loro animo alla pratica, cioè al dominio del mondo. Non poeta dunque, ma uomo d’azione; anzi maestro di azione, pensatore.
Chi legga i primi capitoli del Convivio vede nel cuore, può dirsi, del grande esule le prime linee di questo nuovo ideale, a cui egli fin da quest’opera mira, proponendosi con un’interpretazione allegorica e dotta delle sue già note canzoni di trasfigurare sé stesso non solo dinanzi agli altri, nel cui concetto gli tarda di elevarsi, ma, quel che è più, dinanzi a sé stesso. Lo stesso sforzo ingenuo di dare forma laboriosamente tecnica e scientifica a verità semplici e ovvie, svela il proposito e la speranza dell’Autore, al loro primo nascere. E questo sforzo spiega anche perché l’opera è presto troncata e non più ripresa dall’Autore, che in essa non ha trovato ancora il modo di incarnare veramente il proprio ideale, quale attraverso questo primo tentativo già lo intravede: pensatore in quanto poeta: poeta che insegna come Virgilio, come i grandi scrittori del Vecchio Testamento, che poetarono senza svelare, anzi chiudendo nella parola l’ammaestramento, l’ammonimento, la verità. Non commentarono essi faticosamente, come aveva preso a fare Dante stesso qui nel Convivio, il loro canto; ma cantarono con voce così profonda che misteriosamente sapesse da sé cercare gli animi, scuoterli, illuminarli.
Dal Convivio, o insieme con esso, sorge il “De vulgari eloquentia” (cfr. Conv., I, 5): altra opera di pensiero, suggerita a Dante dal desiderio di esaltare quel volgare, che è lo strumento che nelle sue mani è diventato così potente, e del quale convien perciò che dimostri la nobiltà non inferiore a quella che vien riconosciuta al latino: lingua di dotti, di curia e di affari; come dire, delle persone serie, a cui Dante intende ora indirizzarsi. Egli sente di essere l’araldo di un nuovo mondo; e non esita sulla soglia dello stesso Convivio a dire del suo libro che «sarà luce nuova, sole nuovo, il quale sorgerà ove l’usato tramonterà, e darà luce a coloro che sono in tenebre» (Conv., I, 13). A nuovo pensiero lingua nuova: questo volgare, che Dante sente quasi nel profondo del suo stesso essere: «congiugnitore», com’egli dice, «delli miei generanti, che con esso parlavano!…, per che manifesto è lui essere concorso alla mia generazione, e così essere alcuna cagione del mio essere» e «introducitore di me nella via della scienza». E lo sente nella vita che si trasforma, specchio d’un mondo che non s’arresta, ma si rinnova, e deve perciò rinnovarsi; poiché il latino è «perpetuo e non corruttibile» – lingua morta, come poi si dirà – ma il volgare «a piacimento artificiato si trasmuta. Onde vedemo nelle città d’Italia, se bene volemo agguardare, a cinquanta anni da qua molti vocaboli essere spenti e nati e variati; onde se ‘l piccolo tempo così trasmuta, molto più trasmuta lo maggiore. Sicch’io dico, che se coloro che partiro di questa vita, già sono mille anni, tornassero alle loro cittadi, crederebbero quelle essere occupate da gente strana per la lingua da loro discordante» (Conv., I, 5).
È forse questo il primo sguardo gettato dal pensiero umano sulla vita, ossia sull’essenza storica, del linguaggio. In Dante s’accompagna con l’intuizione diretta e della nazionalità, cioè del carattere universale, della lingua e del suo carattere spirituale; concetto così difficile a mantenersi, che ancora tutto il secolo XIX si travaglia sulla questione dell’uso, come norma della lingua; che è concetto prettamente naturalistico. Già nelle ricordate parole il volgare come lingua viva è contrapposto al latino, in quanto si strasmuta perché «artificiato a piacimento», ossia trattato liberamente da quell’attività autocreativa, che è (oggi diciamo) l’essenza dello spirito. Ma nel De vulgari eloquentia il concetto di Dante si allarga, si articola, si organizza. Quel volgare, che anche qui sente come cosa propria, a cui sia legata, più che la propria grandezza, la stessa sua vita (“quantum vero suos familiares gloriosos efficiat, nos ipsi novimus, qui huius dulcedine gloriæ nostrum exilium postergamus”: De vulg. e., I, 17), non è lingua parlata di fatto: “in qualibet redolet civitate, nec cubat in ulla”. Volgare illustre, “cum de tot rudibus latinorum vocabulis, de tot perplexis constructionibus, de tot defectivis prolationibus, de tot rusticanis accentibus, tam egregium, tam extricatum, tam perfectum, et tam urbanum videamus electum, ut Cinus Pistoriensis et amicus eius ostendunt in cantionibus suis”. Illustre, per la potenza che esercita in quanto non preso dal volgo, ma foggiato dall’arte; “et quid maioris potestatis est, quam quod humana corda versare potest, ita ut nolentem volentem, et volentem nolentem faciat, velut ipsum et fecit et facit?”. Aulico, di corte, proprio della capitale, dove un popolo ritrova e realizza la propria unità, uscendo dai naturali particolarismi delle provincie, e delle città. Che se in Italia non è capitale, e non c’è unità, di questa ci sono le membra: le quali, se qui non sono unite da un principe che tutte le governi, pure “gratioso lumine rationis, unita sunt”. Corporaliter dispersa, l’Italia è una spiritualmente. Una la sua lingua (quella che Cino e il suo amico maneggiano), perché è lingua non di fatto esistente al pari della terra in cui si parla, bensì come libero prodotto dell’arte («artificiato a piacimento»); onde il poeta può dominare un popolo e crearne la volontà facendo volere chi non vuole, e disvolere chi vuole.
C’è bisogno di dire che queste intuizioni e questi concetti manifestano la personalità dell’Alighieri? Che ci fanno sentire dove batta il suo cuore? Dante si prepara al suo grande lavoro con questo animo pieno di fede nel proprio ideale morale, religioso, politico; di fede nella parte provvidenziale che è assegnata a lui pel trionfo di questo ideale. Sente di dover alzare il suo canto per trasformare la poesia, la parola, il volgare che è suo, la possanza invitta del suo genio sperimentato nel bello stile che gli ha fatto onore, in monito agli uomini che hanno in mano le sorti d’Italia, anzi di tutte le genti. Quindi la sua poesia sarà profezia, come era uso degli scrittori apocalittici aspiranti alla riforma dell’umanità.
Rispetto a questo ideale, che è l’unico, il sommo ideale dantesco, e l’argomento del Poema, massima e, in certo senso, unica espressione della personalità di Dante, il trattato latino Monarchia (qualunque ne sia la cronologia, certo scritto negli anni stessi in cui il Poeta veniva componendo la Commedia) può considerarsi come sorto in margine all’opera maggiore: opuscolo d’occasione, scritto in latino perché non diretto ai soli italiani, particolarmente indirizzato ai pubblicisti che della lingua dotta e curiale si servivano per necessità. Ma in margine alla Commedia il trattatello politico di Dante ne illumina i motivi più profondi, facendo quasi balzare innanzi al lettore del Poema, dritta, fiera nella sua gigantesca statura, l’energica persona dell’Autore. Il quale è sì presente sempre con la sua passione alla sua visione: ma qui nella Monarchia si stacca dalla visione in cui spazia la profezia del poeta, e si leva per gridare alto, in chiaro e aperto latino, la sua fede, l’idea che infiamma la sua anima, come la vera interna dottrina che s’asconde sotto il velame de’ suoi versi strani: la dottrina che è sua, la sua filosofia.
Dottrina politica? Politica, in quanto, in generale, filosofica: dottrina che investe tutta la sfera delle relazioni che legano l’uomo al mondo. Giacché la politica di Dante, è chiaro, non è la spicciola politica, che riflette e crea gl’interessi transeunti di un popolo, e risolve, pertanto, problemi particolari e determinati.
In mezzo ai problemi del tempo suo Dante passa come quel legno senza vela e senza governo, a cui egli si paragonò dolorosamente. Passa sognando, assorto non nella sua visione, ma nell’idea che egli in quella visione vuole rappresentare ed effondere. La sua politica è una concezione della massima realtà politica, visibile sull’orizzonte storico del tempo suo, coordinata a una concezione della Chiesa: è il concetto dell’uomo come membro dello Stato e membro della Chiesa, volontà che si spiega e manifesta nei rapporti mondani e nei rapporti con Dio. Perciò è una filosofia. La quale, lo sente subito chi appena legga la Monarchia, non divide, come mal si ripete, lo Stato dalla Chiesa; anzi dimostra i rapporti intrinseci onde sono distinti e congiunti, in guisa che buona Chiesa non sia possibile dove non sia Stato ben ordinato. E volgendosi alla riforma dello Stato, intende a riformare pure la Chiesa, liberandola da ogni elemento mondano, e ritraendola alle sorgenti della sua vita spirituale. Ma dello Stato, da cui dipende quindi il rinnovamento dello spirito, afferma l’autonomia assoluta (“dependet a Deo immediate”) come indirizzato a un fine riposto in “operatione propriæ virtutis”, senza bisogno di quel divino aiuto che occorre invece al conseguimento della felicità celeste (III, 16). Ci sono “documenta philosophica” e ci sono “documenta spiritualia”. Questi trascendono la ragione, e han d’uopo delle virtù teologali; per quelli basta l’uso di quella ragione umana “quæ per philosophos tota nobis innotuit”. Né con ciò si nega il valore dello Stato: gli elettori dell’impero, o quelli, in generale, che conferiscono la suprema autorità al capo dello Stato, sono, al dire di Dante, “denunciatores divinæ Providentiæ”. Questa filosofia dunque è un’affermazione, oscura bensì, ma energica della divinità dell’uomo nella sua attività provvidenziale: un’esaltazione della virtù propria della natura umana, operante nella consapevolezza della propria legge. Virtù vittoriosa, se conscia di sé; e contro la quale prevarrebbe, infatti, l’umana cupidigia (la morte di cui si parla nella Commedia: «Non vedi tu la morte che ‘l combatte?», Inf. II, 107), “nisi homines tanquam equi, sua bestialitate vagantes, in camo et freno compescerentur in via”. Virtù, che non è ancora quella di Leon Battista Alberti e del Machiavelli, ma vi accenna da lungi, e ci fa apparire Dante, all’estremo limite del Medio Evo, un precursore dei tempi che verranno.
VI.
In questa dottrina dell’umana virtù da svegliare affinché s’indirizzi al suo fine, e la cui radice è nella stessa umana natura, la filosofia della Commedia si rovescia. Virgilio non ha più bisogno di Beatrice; anzi questa ha bisogno di Virgilio. Giacché nel Poema c’è Virgilio, che sta tra «color che son sospesi», e non si moverebbe senz’esser chiamato dalla donna beata e bella; ma c’è pure Dante, il discepolo di Virgilio, che se n’è appropriata l’arte; il quale fa muovere Beatrice dal cielo per scendere fino all’inferno: e con quella ragione umana che si spiega nella filosofia (“per philosophos tota innotuit”) detta leggi alla teologia, mettendo in bocca ai teologi quel che occorre alla rinnovazione della loro Chiesa e alla restaurazione universale del mondo umano. Sì, essi posseggono la verità; e l’insegnano; ma sappiamo che quella verità è un momento di una verità superiore, parte di un sistema, a cui devono servire, e che ha il suo primo principio dentro alla volontà dell’uomo artefice del proprio destino. Senza questa veduta superiore, che della filosofia di Virgilio, della teologia di Beatrice, e di ogni verità professata nelle «scuole de’ religiosi» e discussa nelle «disputazioni de’ filosofanti» fa strumento, e non più che semplice strumento, della dottrina sua, Dante sarebbe il filosofo o il teologo, come tanti altri: non sarebbe quel che egli vuol essere, il poeta-profeta, che, semplice laico, non teme di giudicare la Chiesa e di fulminare dall’alto dei cieli creati dalla sua fantasia la condanna contro capi indegni di quella.
Dante può ripetere, alla meglio o alla peggio, quel che i teologi insegnano di grazia e libero arbitrio. Ma il suo pensiero, animatore del Poema, di questa cosa seria che egli intende di fare poetando non per i poeti, ma per gli uomini, se lo volete sapere, è quello che egli enuncia vibrante, sicuro come la fede che lo sostiene nella sua vita di apostolo, per bocca di Marco Lombardo:
|
Lume v’è dato a bene ed a malizia E libero voler; che, se fatica Nelle prime battaglie col ciel dura, Poi vince tutto … Però, se il mondo presente disvia, In voi è la cagione, in voi si cheggia. … la mala condotta È la cagion che il mondo ha fatto reo, E non natura che in voi sia corrotta. (Purg. XVI, 75-78, 82-83, 103-105) |
Che è quasi un’eresia, e a ogni modo contraddice a tutta la filosofia che Dante aveva appresa nelle scuole: non solo a quella prettamente intellettualistica, e però naturalistica, degli antichi; ma a quella altresì che, malgrado la nuova intuizione vitale del cristianesimo, ispirata dal concetto dell’amore e orientata perciò, come s’è accennato, verso la concezione spiritualistica del mondo, s’era tuttavia nella sistemazione aristotelica della scolastica congiunta strettamente all’intellettualismo greco, adottandone ed esagerandone la logica e comprimendo quindi la stessa realtà spirituale dentro i rigidi schemi del vecchio naturalismo. Anche per la scolastica, infatti, l’oggetto supremo, l’Assoluto a cui l’uomo aspira, è fuori di lui. L’unità della natura umana e divina non è originaria come germe che possa liberamente, spontaneamente svolgersi: è da instaurare, movendo da un dualismo originario, di cui lo spirito umano è un termine solo; e un termine che, restando fuori dell’Assoluto, è nulla; laddove l’altro è sì anch’esso un termine, ma un termine che è tutto. Sicché Virgilio, simbolo di quella ragione che, al dire di Dante, basta all’acquisto della terrena felicità “quæ per terrestrem Paradisum figuratur” (Mon., III, 16), in effetti, a tenore di quella filosofia sulla cui trama è intessuta la visione dantesca, dalla selva selvaggia al terrestre Paradiso, non condurrebbe Dante senza un divino cenno arrecatogli da Beatrice. E Dante perciò senza questo superiore intervento resterebbe abbandonato alla sua «morte»: l’uomo per sé sarebbe nulla, né varrebbe nulla.
Per Dante invece, per la filosofia che forma la sua personalità poetica, e il centro da cui s’irraggiano tutte le passioni avvitatrici del vasto mondo del Poema, l’intellettualistico concetto dell’essere è solo un elemento di un concetto più profondo, più veramente cristiano, più moderno: del concetto, che lo spirito umano non ha fuori di sé, già attuato, il suo mondo; ma deve produrlo egli stesso, faticando, durando nelle battaglie, con cui è destinato a vincer tutto. Questo concetto, questa fede di Dante è il rovente crogiuolo, in cui egli fonde l’immane materia accolta dalla vita e dalla storia universale nella sua vasta fantasia, per foggiarne la profezia (3), con cui egli non colpisce soltanto l’immaginazione, ma scuote e scoterà sempre i cuori degli uomini, per animarli alla vita.
1921
_______________
(1) Vedi il Proemio da me premesso alle “Operette morali” del L., Bologna, Zanichelli, 1918. (Poi riprodotto nel vol. “Manzoni e Leopardi”, Milano 1928; 2ª ed., Firenze 1960, pp. 103-57).
(2) Cfr. i miei “Problemi della Scolastica”, 2ª ed., Bari, Laterza, 1923.
(3) Per questo concetto della profezia come forma propria del pensiero e dell’arte dantesca mi sia consentito di rinviare alla precedente lettura “La profezia di Dante”.
IL CONCETTO DI CULTURA
Il tema della “cultura” appare centrale in Gentile, che soprattutto di essa fu un “organizzatore” sulla scena italiana; è necessario però esaminarne l’evoluzione in rapporto ai temi portanti del suo pensiero, senza considerarla una semplice conseguenza della sua adesione al fascismo. La prima espressione della convinzione di Gentile secondo cui “la cultura è l’uomo” si trova negli articoli con i quali da giovane collaborò alla rivista “Helios”. In essi s’interessa soprattutto della cultura popolare e delle sue radici regionali, e pur assumendo un concetto aristocratico di cultura come humanitas, ne propone una visione poliedrica che accoglie tutte le manifestazioni popolari e la rende autonoma dalle contingenze del momento. Il nesso tra cultura ed educazione viene messo in luce soprattutto all’indomani della Prima Guerra Mondiale, quando Gentile sottolinea la necessità di amalgamare in una sintesi superiore le diverse culture regionali in modo da creare una coscienza nazionale. L’adesione al fascismo è per Gentile uno sbocco quasi naturale ed è premessa per una maggiore sottolineatura dei nessi tra politica e cultura: quest’ultima deve ora diventare criterio dell’azione, e lo stesso fascismo viene vagheggiato come un promotore di cultura nel quadro dell’adesione ala nozione idealistica di “Stato etico”. Il contenuto della nuova cultura viene così esteso a tutte le componenti della civiltà, proponendo una visione totalitaria che tuttavia era anche in grado di integrare le nuove esigenze della formazione tecnica e scientifica.
” Che cos’è la cultura? Per tentare un primo orientamento possiamo dire che della cultura si possono avere due concetti: l’uno obiettivo, l’altro soggettivo. Il nostro è quest’ultimo […]. Come la verità noi la cultura la cerchiamo dentro l’uomo: diciamo anzi che la cultura è l’uomo. ” (Stato e cultura).
Questa non è che una delle definizioni di cultura che possono ricavarsi dagli scritti di Giovanni Gentile, ma essa riesce forse, più di altre, a sintetizzare in poche parole l’essenza che il filosofo dell’Atto intese attribuire a tale concetto. Affrontare il tema del concetto di cultura in Gentile, volendolo intendere come un concetto a sé stante, autonomo all’interno del suo sistema di pensiero, espone però al rischio su due fronti: il primo è quello di scrivere di un argomento così vasto da rendere inevitabile lo scadere nel già detto e sentito, nonché nel generico e nell’incompleto; il secondo è quello di dovere affrontare, appunto, un argomento così vasto da non poterlo suffragare con altrettante valide argomentazioni di sostegno alle tesi eventualmente esposte; giacché tutta l’opera del filosofo dell’attualismo è un’opera di cultura per eccellenza. Come ha ricordato E. Garin, Gentile fu molte cose ma soprattutto un “organizzatore di cultura” e la sua attività in questo senso fece sì “che le sue parole ed i suoi scritti pesassero non poco nella formazione culturale delle nuove generazioni, raggiunte […] sia direttamente che attraverso l’opera di educatori e studiosi […] che a lui si rifecero”. D’altro canto, anche di fronte alle periodiche “riscoperte” di Gentile, appare necessario compiere un’operazione di ridefinizione e nuova analisi del significato del suo pensiero, all’interno del quale il concetto di cultura venga considerato come un quid autonomo, che non “segue” ma “precede” la sua riflessione politica, filosofica e pedagogica; un qualcosa che muove, attraversa e conclude tutto il sistema gentiliano, dando luogo ad una serie di binomi che accompagnano e contraddistinguono quello stesso pensiero: binomi come cultura/Stato, cultura/scuola, cultura/scienza, cultura/politica, cultura/tradizione, cultura/fascismo, cultura/Risorgimento, cultura/formazione, cultura/etica. Ognuno di questi dualismi ha nel suo primo termine non soltanto un elemento di confronto ma anche qualcosa che lo esplicita fino a farlo diventare un cardine caratterizzante della riflessione gentiliana. L’argomento riguarda però da vicino anche il tema dell’interpretazione complessiva da dare della figura di Gentile e delle sue scelte di vita, in particolare l’adesione al fascismo con tutto quello che ne conseguì, comprese le polemiche ideologiche che da sempre hanno accompagnato lo studio del suo pensiero e delle sue opere; scelte e polemiche che lo accomunano in qualche modo al tedesco Heidegger. L’atteggiamento più facile, ma anche più miope, di fronte al “problema Gentile” è stato finora quello di difendere o di rifiutare a priori tutta la sua opera; bisognerà invece, forse, spiegare in modo più fruttuoso “quale rapporto sussista tra le sue scelte politiche, da un lato, e le intuizioni con cui […] ha illuminato il pensiero del nostro secolo dall’altro. E ancora: perché di fronte al volto demoniaco del potere la […] vigilanza critica […] venne meno”. Cercando di riassumere le varie tappe dell’attività di Gentile, M. Di Lalla ha parlato di una “polarizzazione” del suo messaggio nel contesto della cultura italiana individuando quattro periodi fondamentali: “Il primo periodo è quello del primo quindicennio del Novecento; il Filosofo è considerato come l’intellettuale più autorevole e indicativo di uno stuolo di studiosi maggiori e minori, che hanno al centro del loro dibattito il problema pedagogico […]. Il secondo periodo […] è già più delicato e più contestato. È il periodo che va dal 1915 al 1925 […]. La polemica sull’intervento, il contegno che gli uomini di cultura hanno avuto durante la guerra, le responsabilità che nel dopoguerra, di fronte all’avvento del fascismo, hanno finito per coinvolgere anche gli studiosi più restii, tutti questi elementi hanno avuto un ruolo fondamentale nell’itinerario di Giovanni Gentile […]. Il terzo momento, quello degli anni Trenta, accentua la posizione di centralità di Gentile nella cultura […]. Ma la divisione degli intellettuali soprattutto di matrice idealistica nel diverso modo di concepire l’impegno è oramai cosa fatta […]. Il quarto momento […] è il decennio che va dal 1930 al 1940 […]; la polemica tra Gentile, gentiliani e le varie forme consacrate della politica è un fatto inevitabile. ” Anche sulla base di questo itinerario è possibile ricostruire, almeno a grandi linee, un percorso nella interpretazione che Gentile dà della cultura e del suo significato non solo come strumento di formazione, ma anche come elemento fondamentale e caratterizzante l’essere umano e la sua realtà. 2. Tra cultura popolare, tradizione, folklore È l’autunno del 1895 quando a Castelvetrano, terra natale di Gentile, viene stampato il primo numero di una pubblicazione che dovrà avere una parte non marginale, seppur minima dal punto di vista della durata temporale, nel percorso culturale del giovane studente alla Normale di Pisa: si tratta di “Helios”, rivista d’arte, lettere e varietà, con la quale Gentile comincia a collaborare fin dai primi numeri fornendo articoli e contributi che sono importanti ed utili al fine di tracciare alcune linee guida nella formazione del suo concetto di cultura. Intanto la propensione del filosofo per una cultura che sia caratterizzata da “lunghe e pazienti ricerche, fatte con vero disinteresse e per solo vantaggio della storia”. “Helios” è per Gentile l’occasione per un primo, ufficiale confronto-scontro con la pubblicistica del tempo, ma anche occasione di formazione per lo studioso che è tra i suoi più assidui collaboratori con ampi articoli firmati o con dense notizie bibliografiche, siglate o anonime: cercando di mettere la cultura locale in contatto con quella nazionale, propone le tematiche dibattute nell’ambiente universitario e valorizza quegli studi folklorici che, unici, avevano permesso alla Sicilia di superare i limiti regionali della sua cultura. Sono interventi “minori” — negli stessi anni egli pubblica il lavoro su Rosmini e Gioberti e gli studi su Marx –, ma hanno il pregio di essere affidati, nel periodo tormentato della crisi di fine secolo, alle pagine di una Rivista non accademica in cui la vena critica e pedagogica di Gentile è più libera di esprimersi, rivelando alcuni tratti della sua biografia intellettuale e del suo orientamento politico. “Helios” è, inoltre, uno dei rari luoghi in cui “è possibile rintracciare direttamente, prima della Grande Guerra, le sue convinzioni politiche maturate nell’ambiente pisano”. Nel periodo preso in esame Gentile ha occasione di confrontarsi e scontrarsi, anche se indirettamente, con figure come quelle di Napoleone Colajanni e Felice Cavalotti e di conseguenza con la parte più viva del pensiero positivista e socialista in genere. Ma l’attenzione maggiore va forse puntata sui temi che egli sembra privilegiare nella “sua” rivista: perché accanto alle note ed ai contributi di critica letteraria, ai commenti su personaggi e fatti dell’attualità culturale siciliana e non, Gentile si occupa anche della cultura popolare intesa come tradizione, leggende, dialetti, folklore, e più in generale di quella demopsicologia come scienza degli usi popolari, che proprio in quegli anni andava sviluppandosi, ad opera di studiosi come Giuseppe Pitrè, Salvatore Salomone Marino, Gaetano Amalfi, Stanislao Prato, tutti nomi che si ritrovano sulle pagine di “Helios” e con i quali Gentile si confronta, anche criticamente, ma mostrando comunque interesse ed attenzione per i “riflessi civili delle loro ricerche e delle loro materie”. In “Helios” si ritrova la radice della concezione di cultura in Gentile, di una cultura intesa a tutto campo come trasmissione e formazione integrale dell’uomo a partire innanzitutto dalle proprie origini che sono poi la base della formazione umana.11 Egli apprezza e promuove per questo quelle figure, anche di suoi concittadini, i quali hanno dedicato la loro vita a ricostruire il passato, mostrando attenzione per tutti quegli studi e quelle ricerche che, pur non avendo un fine immediatamente utilitaristico, erano di aiuto alla storia e alla conoscenza delle proprie origini e del proprio Io. Commemorando la figura di R. Bonghi nel 1895, Gentile ne approfitta, ad esempio, per richiamare ancora una volta l’impostazione di una cultura unitaria quale base della forza e della grandezza di una nazione: ” Il tempo dei nostri padri e il nostro è stato ed è tutto un periodo di transizione per l’Italia, che si è andata ricostituendo nella forma e prosegue sempre a farsi nella sostanza: periodo, che per il suo carattere stesso ha destato nelle menti più vigorose il vitale bisogno della scienza e delle lettere, le quali, consapevoli o inconsce, si sono addossate il carico di dare al nuovo Stato libero gli uomini liberi, che ne fossero degni. E i più generosi e i meglio dotati da natura non si sono contentati del movimento politico o del morale o intellettuale; ma solleciti dell’avvenire, a tutto han voluto dar mano, e fra i torbidi della vita, non han saputo smettere giammai il pensiero degli studi “. L’ideale di cultura che emerge dalle pagine di “Helios” è molto più complesso di quanto non appaia ad una prima analisi, ed in questo senso il periodico di Castelvetrano può essere anche la chiave di interpretazione del concetto di cultura in Gentile: se da una parte, infatti, questa è intesa come paideia o humanitas e quindi, secondo l’accezione classica, in senso aristocratico, come lo strumento che contraddistingue l’uomo libero e scevro dall’attività pratica, dall’altro la cultura include in sé una serie di accezioni che la rendono “poliedrica” e non riassumibile in un solo significato: l’aristocraticità della cultura gentiliana, così come è stata presentata anche da più di qualcuno dei suoi studiosi, non è un qualcosa che tende a isolare, ad emarginare, a dividere tra colti ed incolti, ma è qualcosa che serve a proteggere e purificare tale concetto dalle contaminazioni e dalle contingenze del momento o peggio ancora dalla convenienza e dall’opportunità politica ed ideologica. Ecco allora che la cultura gentiliana diventa le “culture”; non solo quelle regionali italiane ma anche le tradizioni, le leggende, i dialetti che oggi come ieri hanno caratterizzato le tanti parti del “villaggio” umano. Da qui muove anche l’interesse di Gentile per i veicoli di trasmissione e discussione culturale, quali appunto sono le Riviste in genere. In “Helios” viene maturando, dunque, quella idea di cultura policentrica che vede come risultato la valorizzazione della filosofia, della letteratura, della storia, della politica come componenti diversificate di una nuova visione del rapporto tra storia e filosofia, tra idealità e realtà, tra universale e particolare; è un passaggio importante attraverso il quale Gentile maturerà la consapevolezza di un rapporto inscindibile tra cultura e Stato, tra formazione umana e identità nazionale. Una consapevolezza che caratterizzerà il periodo precedente e seguente la prima Guerra mondiale per approdare poi all’incontro con il fascismo. Il dibattito interventisti-neutralisti e la Grande Guerra rafforzeranno così quel concetto “militante” di cultura che fin dalla giovinezza Gentile era venuto maturando, accentuando ancora di più il binomio cultura/politica, cultura/formazione che si risolverà a sua volta nella definitiva accettazione della teoria dello Stato etico. ” Lavoriamo, vogliamo lavorare per noi e per gli altri […], facendo il nostro mestiere di operai del sapere, compiendo così anche il nostro dovere di cittadini e di uomini ” (Proemio, in “Giornale Critico della Filosofia Italiana”, a. I, gennaio 1920). Con queste parole, scritte nell’ottobre del ’19, Gentile aveva concluso il Proemio di presentazione di quella che doveva essere una delle creature più preziose della sua attività culturale: il “Giornale Critico della Filosofia Italiana”. Siamo all’indomani della conclusione del primo conflitto mondiale e nella sua riflessione sono già stabilizzati alcuni punti fondamentali. Intanto la necessità di una riforma dell’istruzione che consacri definitivamente la scuola e in essa l’insegnamento della cultura filosofica, come strumento di realizzazione di un piano per l’educazione nazionale che era già stato a suo tempo oggetto di discussione nel Paese;19 in secondo luogo la priorità della esigenza di dovere fare della riflessione filosofica uno strumento concreto per la realizzazione di una coscienza nazionale unitaria, così da reinserire l’Italia nel novero di quelle Nazioni degne di chiamarsi tali, portando a compimento nel frattempo l’opera iniziata dagli uomini del nostro Risorgimento senza disperdere la vittoria appena conseguita a Vittorio Veneto. Si tratta, per Gentile, di amalgamare fino a fonderle insieme le singole culture regionali, le quali da sole non avrebbero nessun valore né filosofico, né storico. Era un concetto che egli aveva continuamente espresso in quegli anni, in particolare nel lavoro, considerato riassuntivo della sua riflessione su questo tema, dedicato alla cultura della sua terra natia: il carattere regionale della cultura siciliana era infatti per lui dovuto al fatto che ” nascendo essa dal ripiegarsi dell’anima siciliana, su di sé medesima, nel rispecchiare il proprio passato, dove era la sua storica individualità di fronte alle altre regioni d’Italia, doveva esser condotta fino allo studio delle tradizioni popolari […] e fermarvisi […]. Giacché tutta la storia potrebbe tenersi in nessun conto e sarebbe infatti una semplice astrazione se non si concretasse e radicasse in un modo di sentire e di pensare e in un certo carattere popolare che era nel caso nostro la vera realtà siciliana da incorporare e fondere nell’Unità nazionale ” (Il tramonto della cultura siciliana). Veniva rafforzandosi così, attraverso la riflessione tra cultura locale e quella nazionale, la componente di “attivismo” pedagogico che caratterizza tutta la filosofia gentiliana e che diventa un tutt’uno con la sua idea di cultura come formazione e quindi come insegnamento. È stato notato, a tal proposito, che “è essenziale cogliere il nesso della filosofia con la scuola gentiliana, perché molte delle modalità di insegnamento della filosofia sono derivate dal concetto di cultura sotteso alla scuola stessa e al ruolo a questa assegnato in rapporto alla società”. La formulazione o per meglio dire l’accettazione definitiva, in onore ad Hegel, del concetto di Stato etico passa evidentemente per tutte le tematiche sin quì descritte e si pone come punto di raccordo per esse; una strada che partiva dunque da lontano se si considera il fatto che da parte sua Gentile, fin dal 1902, assegnando allo Stato il compito dell’emancipazione morale e civile dei cittadini, indicava la via degli studi scientifici che chiamava “disinteressati” in quanto non direttamente finalizzati a qualsivoglia professionalità. Certo, a Gentile stava a cuore soprattutto la formazione di quelle élites capaci di assicurare continuità allo Stato liberale e borghese; per il filosofo siciliano si trattava, pur sempre, di contrastare la richiesta di una società democratica, volta alla massificazione della cultura e a cui “bisognano gli automi dell’industria e le volpi del commercio; le pecorelle dei partiti politici e della chiesa e i famelici lupi delle amministrazioni e delle sacre gerarchie, tutt’al più qualche topo erudito da biblioteca e qualche ragno faticone intento a tessere e ritessere le penelopee tele sociologiche”. Ma è pur vero che a distanza di quasi vent’anni, Gentile, insistendo sulla funzione emancipatrice dello Stato, fondata sullo “sviluppo autonomo della scienza”, ancora una volta evidenzia un modello pedagogico, peraltro operante in tutta la sua produzione scientifica, di tipo “politico e sociale, rivolto alla costruzione della coscienza nazionale e che vede nel risveglio della vita spirituale e nella scuola come agenzia delegata a realizzare tale risveglio gli strumenti fondamentali ed insostituibili della rinascita collettiva”. È il tema dell’educazione nazionale che caratterizza l’interesse gentiliano, tanto più in un’ora come quella presente nella quale l’esigenza di una cultura “nazionale” sembra essere più che mai urgente, sia per ricostruire il Paese che per non farlo mancare ad un appuntamento di trasformazione e di rinnovamento che per il filosofo siciliano è oramai irrinunciabile. Anche per la sua terra vede una luce di speranza se “negli ultimi anni i giovani scrittori siciliani si sono venuti affrancando da quello spirito regionalista per aprirsi alla cultura nazionale […]. Chi fa storia regionale si confonde con l’oggetto stesso che vuole ritrarre; e invece di spiegare i fatti diventa egli stesso una parte di questi”. La Grande Guerra rappresenta all’interno del pensiero di Gentile un ulteriore punto di svolta che lo porta a rielaborare e a chiarire ulteriormente le forme e i contenuti del suo concetto di cultura; e riflettendo proprio sul significato dell’evento bellico scrive che “il problema della guerra era un problema superiore alla guerra stessa, e tale da impegnare tutto l’avvenire della vita italiana […]; il bisogno di non guardare al passato […] ma di rivolgere piuttosto lo sguardo all’avvenire, all’ideale, alla meta […]. Problema politico che è problema morale”. Su questa strada, quella serie di binomi di cui abbiamo parlato all’inizio si fondono tra loro, giungendo alla constatazione che il problema della cultura è anche e soprattutto un problema dello Spirito e quindi dell’educazione; di conseguenza non questione di forma ma di sostanza. L’esperienza della Guerra è stata dunque l’atto concreto che ha trasformato le riflessioni teoriche del periodo precedente in un decalogo di azioni da intraprendere per portare a termine l’opera del Risorgimento, far iniziare un nuovo periodo della storia italiana e creare quella salda coscienza nazionale necessaria premessa per fare della Nazione uno Stato; opera questa che non si realizza se non attraverso una convinta azione educativa, che deve avere al suo centro soprattutto la cultura umanistica, giacché, come aveva ricordato un decennio prima, ” all’uomo è essenziale la coscienza dell’esser suo, quale la cultura umanistica può darla. E poiché gli è essenziale, questa coscienza è condizione, questa cultura è preparazione così alla vita come alla scienza: così al mondo delle relazioni civili e politiche come all’umbratile speculazione delle università. Senza siffatta coscienza non c’è moralità vera, intelligente, non c’è economia sagace, non c’è politica chiaroveggente; come non c’è la scienza […]; la cultura che si richiede non può essere altro che educazione dello spirito ” (La riforma della scuola media). Il coniugarsi dell’elemento pedagogico-educativo, primario nella riflessione gentiliana, con la sua propensione ad un “nazionalismo culturale” come elemento necessario alla costruzione di una nuova Italia finisce per rafforzare, in una ben determinata direzione, anche la sua visione politica, diventando il motore di quello che egli vedrà come uno sbocco quasi naturale, anche della sua esperienza e della sua azione culturale: l’adesione al fascismo. In quest’ottica, la stessa critica al concetto di democrazia, propria del Gentile di questi anni, si ricollega alla critica del concetto di cultura così come la stessa democrazia lo propone, “al suo materialismo plebeo, a quello della scienza naturalistica e positivistica, dell’industrialismo, del socialismo, del cosmopolitismo, del femminismo”. Il tema dell’unità tra politica e cultura non era del resto nuovo nell’impianto speculativo di Gentile. “Quando il 14 maggio 1915 all’annuncio delle dimissioni di Salandra manifesta […] la propria angoscia perché noi “non siamo uno Stato” se non in apparenza […] Gentile esprime con formule più nette […] quella riflessione culturale sullo Stato e sulla Nazione che era iniziata, in coincidenza con la crisi di fine secolo e in rapporto a prese di posizione politica di segno conservatore, sulle orme di Bertrando Spaventa fin dal Rosmini e Gioberti in cui aveva sostenuto la necessità di dare forma nazionale a una cultura che fosse universale nel contenuto”.30 Ma a partire da questo momento il binomio politica/cultura assume un significato prioritario e ben più chiaramente determinante rispetto al passato; le premesse culturali diventano per lui inscindibili dal progetto politico; cominciava così con il ricordare che “la cultura è il centro del mondo che ci interessa, […] e per far politica l’uomo non ha altro mezzo che la cultura, intorno alla quale il mondo gira, si articola, si organizza. La civiltà che è il complesso in cui si viene dispiegando la potenza dell’uomo come trionfo della libertà, ossia dominio dello spirito nella natura, ha la sua base ed il suo principio nella natura: La cultura è svolgimento e formazione dello spirito, o dell’umanità dell’uomo […].” La cultura non poteva restare chiusa nei recessi dell’intelletto puro, ma doveva calarsi nella realtà, anzi era essa stessa realtà consapevole: era insomma criterio dell’azione. Sintomatica, da questo punto di vista, la polemica che egli conduce dalle pagine dei quotidiani sul finire del 1918, contro il concetto della Kultur di stampo tedesco e che si ricollega direttamente all’affermazione, ma si direbbe alla definitiva scoperta della sua scelta nazionalista, legata strettamente ad una visione etica dello Stato. Non è dunque possibile scindere l’uomo e quindi lo Stato dalla “sua” cultura che ne è l’espressione genuina e sincera e lo caratterizza: la cultura che fa l’uomo colto è la stessa infatti che “fa l’uomo […] giacché, è troppo chiaro, l’uomo è davvero uomo […] in quanto ha coscienza di essere, e però di esistere e di agire”. Negli anni Venti e Trenta, con la sua adesione al fascismo, Gentile sembra dunque esplicitare e mettere in pratica quello che era un ideale di cultura meditato e maturato nel periodo precedente. In particolare nel 1925, la nascita dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura e l’avvio del lavoro per la realizzazione del progetto dell’Enciclopedia Italiana rappresentano ai suoi occhi l’occasione propizia per concretizzare proprio quell’ideale di cultura. Questo è sicuramente un momento di rivelazione di alcuni “equivoci giovanili” (la rottura del rapporto con Croce proprio di quel periodo è un evento traumatico e indicativo) ma anche l’occasione per crearne dei nuovi (e la vicenda dei rapporti travagliati, per non dire confusi ed equivoci, di Gentile con il fascismo ne sono una testimonianza). Si dovrebbe forse partire, in questo senso, da un nodo della questione che egli stesso sente come irrisolto e che viene esplicitato in occasione di un discorso tenuto a Bologna nel marzo del ’25 in cui dichiara che “non bisogna che ci preoccupiamo tanto della cultura del fascismo quanto piuttosto del fascismo della cultura […]. Noi fascisti […] non vogliamo lo Stato agnostico e perciò vogliamo lo Stato educatore ed insegnante”. E conclude affermando che bisogna portare “non la cultura nel fascismo bensì il fascismo nella cultura”. Puntuale appare a questo proposito l’affermazione di Turi, secondo il quale “lo stesso appello al “fascismo della cultura”, a un fascismo che si confonda con la nazione e non si identifichi con i tesserati, è frutto di una visione culturale e politica solo apparentemente duttile, talvolta scambiata per tale solo perché non si identifica con quella di altri esponenti del fascismo. È quindi naturale che la politica di “conciliazione” condotta da Gentile in questo campo tra il 1925 ed il 1926 registri, assieme ad un notevole successo, alcune resistenze fra gli intellettuali che avevano subito e continuavano a subire, il suo fascino, e nel circolo dei suoi stessi allievi, e produca quindi i primi distacchi”. La questione viene affrontata direttamente da Gentile nel discorso di inaugurazione dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura il 19 dicembre 1925, con riferimento alla vicenda dei Manifesti:
” I giornali liberali e democratici come era stato preveduto, fecero coro, plaudendo clamorosamente all’antimanifesto pettegolo e stizzoso, e proclamando con quella loro proverbiale sincerità l’antitesi tra fascismo e cultura […]. Tante volte si è detto che la dottrina del fascismo è nella sua azione. Non è un’ideologia, non è un sistema chiuso, non è neanche veramente un programma […]. La parola del fascista è fatto […]. La cultura non è contenuto, ma forma: non è una certa quantità di istruzione concentrata o diffusa, ma potenza spirituale; non è materia ma stile; […] esiste una cultura strumentale che è mero sapere, organizzazione di cognizioni bene accertate, critica, erudizione, dottrina […]. Noi del fascismo […] abbiamo raggiunto quella piena libertà di spirito, con cui possiamo spogliarci di certe passioni della prima ora, e riconoscere pertanto il valore nazionale di certe forme di cultura ” (Politica e cultura).
Gli anni Trenta sono sicuramente un altro spartiacque da tenere presente nella concezione culturale di Gentile; il Concordato, i nuovi rapporti Stato-Chiesa, ma anche i temi derivanti dalla nuova discussione sul nazionalismo e sulla razza che sfoceranno nelle leggi del 1938, rappresentano delle forti “deviazioni” della sua impostazione e mettono a dura prova la sua stessa capacità di “mediatore culturale”. Il risultato è una perdita di posizioni sia verso il sistema politico di riferimento, sia verso quel mondo intellettuale che, avverso o insofferente nei confronti del fascismo, cercava ancora in Gentile un punto di riferimento. Significativo di un certo malessere del Filosofo ma anche di un suo smarrimento quanto scrive nel ’36:
” La cultura è il centro, vorrei dire l’essenziale di questa vita in cui lo spirito immortale viene realizzando il suo mondo: questo mondo civile che che è scienza ed arte, ed è società etica e Stato […]. La civiltà che è il complesso delle forme in cui si viene dispiegando la potenza dell’uomo come trionfo della libertà ossia dominio dello spirito sulla natura, ha la sua base ed il suo principio nella cultura […]. I popoli selvaggi o incivili che non hanno storia perché non progrediscono […] sono i popoli in cui l’umanità rimane come rattrappita e chiusa nel guscio primitivo di una coscienza […] non formata nella cultura […]. Progresso è sinonimo di pensiero e di cultura […]. La cultura è formazione e svolgimento dello spirito, ossia della umanità dell’uomo […]. L’ideale della cultura oggi, per noi, è quello della cultura formatrice dell’uomo […], poiché la vita dell’Italia è pur la vita dell’Europa e cioè del mondo, e la nostra cultura non è grettamente razzistica né angustamente, cioè geograficamente mediterranea, ma intelligentemente universale ed umana. ” (L’ideale della cultura e l’Italia presente)
Che nel programma culturale gentiliano vi fossero già una componente nazionalistica e conservatrice è cosa, ci sembra, fuori dubbio; quello che dovrebbe rappresentare un elemento di problematizzazione della sua storia di intellettuale è invece capire fino a che punto queste componenti siano state consapevolmente rafforzate dalla sua adesione al fascismo e dalla condivisione piena e convinta degli ideali di quest’ultimo e quanto invece siano da considerarsi peculiari del suo pensiero e quindi da interpretarsi e analizzarsi in modo indipendente da quella scelta politica. Quello che è certo, e questo può essere considerato un ulteriore elemento di discussione, è che nel Gentile “fascista” fu viva l’esigenza di trovare un punto di incontro tra il suo concetto di cultura ed il movimento politico a cui si era legato: la creazione dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura rappresentava in questo senso un valido strumento di azione, affinché lo stesso PNF si facesse assertore convinto “della sua fede nella cultura […] che stimolasse le energie intellettuali a non rinchiudersi in astratte speculazioni remote da ogni azione sulla vita nazionale, economica, morale e politica, anzi tutte le rivolgesse a illuminare e formare la coscienza della nuova Italia che i fascisti vagheggiano, fiera del suo passato glorioso ed insieme possente per rinnovato fervore di lavoro e di pensiero nella disciplina dello Stato consapevole degli alti destini nazionali”. Anche sul piano politico, l’impostazione teoretica di Gentile riguardo al problema della cultura sembrava dunque trovare nel fascismo un elemento con cui interagire, corregendolo e depurandolo, per realizzare e affermare quel suo programma politico-filosofico inteso come un sistema di idee che rappresentassero la nuova linfa vitale della Nazione. In questo senso “cultura è universalità, o se si vuole, umanità […]. Dire educazione fascista è […] dire educazione nazionale; con questa avvertenza, che […] la nazione non è un dato naturale ma un processo storico”. Secondo Gentile l’educazione non può non essere politica, soprattutto quella fascista; giacché l’educazione politica ” deriva ed attinge le sue energie da una mentalità già spoglia di ogni concezione individualistica e astrattamente universalistica della vita […]. Questo è ideale di cultura […]. Ma è l’ideale di una cultura che ha la sua radice nella rinnovata coscienza politica e si protende verso la nuova politica italiana. Arte, storia, letteratura, scienza, scuola e istituzioni giuridiche, vita morale e religiosa, preparazione militare, movimento sociale, finanziario, economico, sono elementi diversi ma tutti essenziali al contenuto della nuova cultura “. In queste parole sembra sintetizzato ante litteram quel concetto di cultura, totalizzante e totalitario, che il fascismo si occuperà di attuare, proprio mentre, però, il suo intellettuale più rappresentativo cominciava a perdere posizioni all’interno di quello stesso sistema. Nel 1930, ancora di fronte al pubblico dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura di Roma, egli esprimeva una posizione che sembra essere un ulteriore tentativo di pacificare le diverse e precedenti componenti politico-filosofiche del pensiero gentiliano sull’argomento con la nuova realtà politica: in quell’occasione parla di una cultura “animata da un pensiero politico, in quanto c’è un pensiero politico attuale che deve essere meditato, chiarito, svolto,fecondato nelle menti, difeso dalle critiche degli avversari, cimentato con le opposte e divergenti dottrine; un pensiero che consiste innanzitutto in un certo orientamento e atteggiamento dello spirito, in una certa fede, in una certa passione, che è e deve essere l’anima di tutta la concezione della vita del nostro tempo e quindi di tutta la nostra cultura”. I temi della tradizione, della Nazione e della sua educazione, della storia patria, vengono in questa occasione fatti confluire tutti in una dimensione politica, nell’ottica del nuovo Stato etico, il quale “così concepito può essere un principio unificatore di tutta la cultura”. Quasi a chiudere un percorso aperto con gli studi giovanili, nel 1943 arriva l’opera ultima di Gentile, Genesi e struttura della società, opera che, come per altre tematiche del suo pensiero, rappresenta un punto di riflessione e di rielaborazione rispetto alle tesi svolte precedentemente; ma è al tempo stesso la realizzazione di quella sintesi, cui Gentile aveva alacremente lavorato, “tra l’impostazione attualistica e l’esperienza del fascismo; Gentile amplia il suo concetto di cultura che nel discorso del 1922 agli operai di Roma aveva identificato con quella umanistica, per includervi ora tutte le forme del lavoro manuale e tecnico imposte dallo sviluppo dell’industria”. Tuttavia, nonostante la nuova apertura, egli ribadisce che
” la cultura è sapere; ma non è sapere determinato, dommatico, informativo; è critica di ogni sapere che come sapere positivo s’accampi nell’uomo senza dimostrarglisi utile, necessario, costruttivo della sua vita e della sua personalità […]. C’è un sapere strumentale che l’uomo può acquistare e far suo; e può trascurare […]. In concreto non c’è istruzione per grama e gretta e materiale che sia, che non influisca sull’avviamento dello spirito, e non riesca, in qualche guisa, impegnativa del suo avvenire. Si può […] essere dotti e incolti. Sapere molto e non farne sangue, e non capire più dell’ignorante. La cultura è sapere che forma l’uomo schiarendo e allargando la coscienza che ogni uomo deve avere di sé, ed esercitando perciò la riflessione sul contenuto del suo pensiero […]. Tale la cultura a cui lo Stato mira in quanto esso stesso coscienza che l’uomo ha di sé e della sua via per cui tale coscienza si sviluppa. La quale cultura tutto abbraccia e nulla respinge, se il sapere si informa a questa coscienza di sé, che è l’unità e il centro di tutta la sfera del sapere “. (Genesi e struttura della società)
Ritorna e si rafforza, nonostante tutto, anche in questo ultimo scritto, quel concetto di cultura come strumento rigeneratore dell’uomo e dello Stato, che Gentile aveva maturato in gioventù e accettato organicamente dopo l’incontro con il fascismo, e che ribadirà, quasi come un testamento morale, in quella che sarà la sua ultima apparizione in pubblico nel 1943, in occasione del discorso pronunciato in Campidoglio, in cui i temi della tradizione italiana, dal Rinascimento al Risorgimento, i riferimenti ai padri della Patria, da Dante a Mazzini e Garibaldi, nonché l’accenno alla “sua Sicilia” e a Giuseppe Pitrè, sembrerebbero stare lì a rappresentare l’estremo tentativo di riaffermare la propria autonomia di uomo e di intellettuale, “giacché altro è la persona, altro l’idea che alla persona conferisce valore ed autorità”.
Teoria generale dello Spirito come atto puro
A cura di Edoardo Dallari
Nel 1916 Giovanni Gentile scrive la “Teoria generale dello Spirito come atto puro”, gettando le fondamenta del proprio pensiero, in cui confluiscono il pensiero hegeliano e il pensiero marxista riformati.
Il primo capitolo, intitolato la “Soggettività del reale”, si apre con un’analisi dell’idealismo di Berkeley, che già nel 1910 era stato fortemente criticato da Bertrand Russell, in “I problemi della filosofia”. Berkeley ha evidenziato come l’essere consista nel suo essere percepito (“esse est percipi”): i dati dei nostri sensi non possono esistere indipendentemente da noi e sono l’unicum di cui le nostre percezioni possono garantirci l’esistenza. Conoscere è percepire, e in quanto le uniche cose di cui possiamo avere conoscenza sono i dati sensibili che esistono solo nella misura in cui ne siamo coscienti, essere conosciuto significa essere nella mente, e venendo conosciuto il qualcosa è. “All’infuori delle menti e delle loro idee, dunque, nel mondo non esiste nulla e non è possibile conoscere nulla, poiché tutto ciò che si conosce è necessariamente un’idea”. In quanto le cose sono conosciute mentalmente esse sono anche di natura mentale. L’argomento principale adottato da Berkeley è che “non possiamo sapere se esiste qualcosa che non conosciamo”, “we cannot know that anything exists which we do not know”, e su questo si scatena la critica di Russell: bisogna distinguere i significati di due parole che sembrano sinonime, ma che in realtà non lo sono, che Berkeley mescola nell’utilizzo del verbo “to know”. Sapere è la conoscenza del vero, si riferisce alla conoscenza di verità dei giudizi, alla conoscenza per descrizione; conoscere “significa avere delle cose un’esperienza diretta”, con cui conosciamo i dati sensoriali. La conoscenza delle cose è la conoscenza per esperienza diretta (acquaintance). Secondo Russell è necessario distinguere tra “la cosa appresa e l’atto dell’apprendere”, momenti distinti e separati: la cosa non è mentale, è un oggetto concepito come mera presenza che il soggetto nell’atto apprensivo deve rispecchiare, adeguandosi ad essa. La conoscenza è una relazione fra la mente e ciò che è altro da essa.
Per Giovanni Gentile l’idealità del reale non è assolutamente da mettere in discussione. Il concetto di una sostanza materiale, corporea ed estesa è un concetto di per sé contraddittorio, siccome possiamo parlare solo di cose che percepiamo e che quindi sono oggetto di pensiero, idee. Berkeley ha il merito di avere mostrato “che la realtà non è pensabile se non in relazione con l’attività pensante per cui è pensabile; e in relazione con la quale non è solamente oggetto possibile, ma oggetto reale e attuale di conoscenza”. La critica gentiliana si muove nella direzione di una contraddizione interna al pensiero di Berkeley, che giunge a negare la stessa idealità del reale quando arriva a sostenere che la realtà non è oggetto del pensiero umano, bensì è “l’insieme delle rappresentazioni che corrispondono a una Mente oggettiva, assoluta, presupposto della stessa mente umana”. Poiché pare evidente che il pensiero umano non pensi tutto il pensabile, limitato da spazio e tempo, che possa esistere qualcosa che non è mai stata pensata e che ciò che ora non è oggetto del pensiero potrà esserlo in un altro momento, è lecito, dalla prospettiva di Berkeley, porre una distinzione tra il pensiero che pensa il mondo e un Pensiero assoluto, trascendente quello umano, che è Dio. “Dio pertanto è la condizione che rende possibile pensare il pensiero dell’uomo come esso stesso realtà, e la realtà come essa stessa pensiero”. Ma pensare il pensiero umano come condizionato dal pensiero divino significa affermare il Pensiero assoluto come presupposto del pensiero stesso, una realtà che non si sviluppa nel pensare: anche Dio deve essere oggetto del pensiero: affermarlo come presupposto significa escludere ciò che rende la realtà tale, cioè il pensiero, perché la realtà di Dio non è pensata ma presupposta. Il pensiero umano si trova in questo modo esautorato dalle sue competenze e trova davanti a sé un muro che egli non ha creato, che è reale indipendentemente dall’essere pensato. Secondo Gentile Berkeley ricade quindi in quel naturalismo che Russell sosteneva in opposizione all’idealismo, perché porrebbe una realtà esterna al pensiero, presupposta ad esso. In Berkeley il pensiero si annulla, “perché in tanto il pensiero pensa, in quanto quello che pensa è già pensato; in quanto il pensiero umano non è altro che un raggio del pensiero divino, e quindi niente di nuovo, niente di più del pensiero divino. (…) non solo non è realtà oggettiva, ma neppure realtà soggettiva. Se esso fosse qualche cosa di nuovo, il pensiero divino non sarebbe esso tutto il pensiero”. Il pensiero umano pensa ciò che è già stato pensato da Dio essendone una derivazione, da soggetto diventa oggetto: il suo idealismo è quindi un idealismo empirico.
Secondo Gentile bisogna abbandonare il punto di vista dell’io empirico e innalzarsi a quello della soggettività trascendentale, in cui il pensiero non si considera come atto compiuto, ma come atto in atto. “Atto che non si può assolutamente trascendere, poiché esso è la nostra stessa soggettività, cioè noi stessi; atto che non si può mai e in nessun modo oggettivare. Il nuovo punto di vista infatti a cui conviene collocarsi è questo dell’attualità dell’Io, per cui non è possibile mai che si concepisca l’Io come oggetto di se medesimo”. Gentile distingue tra pensiero astratto e pensiero concreto, che identifica con il pensare in atto: nulla esiste se non nell’atto che lo pensa, in cui viene pensato. “Lo spirito, si badi, non è mai propriamente quella pura attività teoretica che si immagina in opposizione all’attività pratica: non è mai θεορια, contemplazione della realtà, che non sia intanto azione, e però creazione di realtà.” Bisogna qui fare un passo indietro per vedere quali sono le basi su cui il pensiero di gentile si sviluppa: Hegel e Marx.
Nell’idealismo tedesco, in particolare quello hegeliano, l’oggetto è nella misura in cui è pensato dal soggetto. L’ente è nella misura in cui è un το λεγομενον, è posto in quanto mediato dall’attività del soggetto. La coscienza soggettiva media la realtà e la pone come tale. La realtà è sempre il nostro sapere della realtà: la coscienza nella certezza sensibile percepisce il mondo, l’oggetto, come qualcosa di indipendente dal soggetto pensante. Soggetto e oggetto sono percepiti come autonomi e irrelati e il soggetto si limita a render ragione dell’oggetto rispecchiandolo. Questo costrutto è destinato tuttavia a non durare perchè erroneo: soggetto e oggetto esistono sempre mediati: l’oggetto è nella misura in cui il soggetto sa di esso, è mediato dal soggetto. Possiamo infatti fare esperienza di un percepire sensibile che non sia anche qualcosa di più di un mero percepire? Nel momento in cui io so di sentire sono già oltre la dimensione passiva della sensibilità: io sono cosciente di essere cosciente, sono cosciente del fatto che è vero che sento. La coscienza del vero della percezione mi porta oltre la dimensione della percezione stessa, mi porta cioè nella dimensione dell’autocoscienza, in cui il soggetto è consapevole di essere costitutivo della percezione. L’oggetto è percepito da un soggetto che è cosciente di percepire l’oggetto stesso: al di fuori della coscienza non esiste nulla, il mondo è nella misura in cui è pensato, abbiamo sempre a che fare con dei pensati, mai con degli oggetti che ci stanno davanti come ostacoli.
Il sapere non è mai sapere puro, è sempre volontà di potenza come volontà di sapere, ovvero il sapere è il potere, un poter-fare. L’ente è proprio ciò che è saputo-fatto dalla coscienza. L’ente per la coscienza è ciò che sappiamo e facciamo, è un πραγμα, realizzato attraverso tutto il viaggio della coscienza, in cui tutti i momenti sono ricompresi nel risultato:i risultati vengono sempre ricollocati su piano superiori, mai dimenticati, ma sempre ricordati. Progressivamente la coscienza diviene sempre più universale, fino al sapere assoluto, absolutus, in cui la coscienza è absolta, sciolta dai legami con la propria individualità. Il sapere assoluto è un sapere della totalità dell’ente, che ricomprende in sé, nell’interezza del movimento processuale, le determinatezze oppositive riconciliate dallo Spirito, che le innalza, comprendendole in sé, non le nega, e anzi è consapevole di tutti i momenti che hanno portato al risultato. L’ente è ora saputo come πραγμα, come fatto creato dalla coscienza, non come puro dato irrelato alla coscienza medesima. La coscienza è giunta nel pensiero ad una forza, capacità, potenza, tale da potersi fare altro: l’ente, l’oggetto, è un prodotto della soggettività cosciente. Il soggetto si fa altro, pone l’oggetto e in esso si ritrova. Percepisce l’oggetto come proprio prodotto. Il soggetto diviene cosciente di sé nel proprio esser altro. Fichtianamente l’io deve porre un non io cui si contrappone per diventare cosciente di sé.
Il soggetto si riconosce nell’oggetto e dopo essersi fatto altro ritorna in sé arricchito. Noi quando percepiamo l’oggetto lo percepiamo sempre attraverso il nostro io e come contrapposto al nostro io: tutto ciò che è è altro dall’io, ma mediato dalla coscienza che si fa altro per riconoscersi come sé.
Per comprendere la riforma gentiliana della dialettica hegeliana è indispensabile vedere come gentile interpreti la filosofia di Marx. Gentile infatti ritrova in Marx una filosofia della prassi: è la prassi umana a produrre e modificare l’oggetto, il quale a sua volta viene a modificare anche il soggetto. Il mondo in Marx è sempre frutto della prassi, la realtà si vien formando tramite il fare, l’oggetto è sempre l’esito di un porre da parte del soggetto. La prassi è il modo in cui viene posto il rapporto soggetto-oggetto nel divenire. Anche la natura è opera dell’attività prassistica del soggetto, anche se l’errore di Marx secondo Gentile consiste proprio nel riconoscere il mondo come prodotto di un’azione e di ammettere una materia data sottratta a quell’azione.
Attraverso dunque una rielaborazione del pensiero di Marx e una riforma prassistica della dialettica di Hegel, Gentile dà vita alla propria posizione filosofica che egli chiama attualismo.
La prima differenziazione fondamentale è quella tra dialettica del pensiero pensato e dialettica del pensiero pensante. Secondo gentile da Platone a Hegel la tradizione filosofica ha compiuto un errore cruciale: ha inteso il pensiero come un oggetto e ha studiato le relazioni tra concetti come se fossero oggetti dati anziché intendere il pensiero il pensiero come atto. Le dialettiche del pensiero pensato pensano il mondo, che è pensiero, come statico, mentre la dialettica del pensare è la dialettica della vita, che pensa che il mondo esista sempre e solo nell’atto del pensare in atto che lo pone, è una dinamica sempre rigenerantesi.
La prima forma di dialettica è quella platonica, grazie a cui il filosofo può comprendere la totalità del reale, cogliendo le differenze tra gli enti ad armonizzandole tra loro al fine di giungere alla verità. “Dialettica infatti per Platone è la ricerca del filosofo, non già in quanto egli aspira alle idee, ma in quanto le idee, alla cui cognizione aspira, formano tra loro un sistema; sono cioè connesse tra loro da mutui rapporti in guisa che la cognizione del particolare sia cognizione dell’universale, la parte implichi il tutto, e la filosofia insomma sia una sinossi”. Ma questa capacità della filosofia dipende dai rapporti che le idee intrattengono tra di loro, non dalla capacità del pensiero umano. Il pensiero è già stato pensato ab aeterno nel sistema di rapporti con cui le idee sono legate tra di loro, il pensiero non si vien facendo pensando, ma è già tutto pensato. Il filosofo coglie sì l’universale archetipico nel particolare, comprende sì che l’ente è sintesi di essere e di non essere, che partecipa dell’identico e delle differenze, ma fa questo adeguandosi alle idee fisse ed immutabili che devono essere colte dal pensiero umano che intenda spiegare la realtà. “La dialettica platonica è solo un’apparente dialettica: perché essa è bensì sviluppo dell’unità attraverso la molteplicità, se si considera per rispetto alla mente dell’uomo che non possiede il sistema e aspira a possederlo, e ne viene indefinitamente realizzando l’unità dialettica mercè l’indagine sempre più larga dei rapporti onde sono tra loro connesse le idee. Ma poiché il valore di questa indagine presuppone la dialettica eterna immanente al mondo ideale, la verità dialettica, alla cui stregua è possibile concepire quella della mente, non è come si è detto, la dialettica della mente, bensì quella delle idee. La quali non realizzano l’unità ma sono unità; né realizzano la molteplicità, perché sono molteplicità: e né per un verso, né per l’altro hanno in sé alcun principio di mutazione e di movimento. Perciò la vera dialettica è quella che non è più tale”. La natura stessa in Platone è un presupposto del pensiero: la φυσις nessun dio la crea, è plasmazione della χωρα ad opera del demiurgo che imprime su di essa i rapporti tra le idee. Il pensiero, ritrovando nella natura gli archetipi ideali eterni, irrigidisce ipso facto la natura stessa: essa “s’irrigidisce ed impietra pel fatto stesso di essere oggetto del pensiero”.
Non solo Platone, ma anche Aristotele, pur considerando la natura come sinolo di materia e forma riuscì a sfuggire alla dialettica del pensato. Il divenire è l’evidenza suprema ed è passaggio dalla potenza all’atto; tuttavia in base al concetto dell’ex nihilo nihil l’atto è prioritario, ed essendo contraddittorio il regressus ad infinitum è necessario che esista l’Ente Sommo, l’atto puro, motore immobile che è causa efficiente del movimento in quanto causa finale. Dice Gentile “il mondo pensò mole animata da movimento eterno a recare in atto l’eterno pensiero. Ma anche per lui il pensiero pensa la natura come suo antecedente: quindi come realtà già realizzata che come tale si può pertanto definire, e idealizzare in un sistema di concetti fissi e immutabili”.
Lo stesso Hegel non ha pensato fino in fondo il divenire ed è rimasta legato ad una visione troppo oggettivista del reale, che pensa l’identità di essere e pensiero come se fosse statica. Non ha colto che questa identità è un atto, non un risultato compiuto. Il massimo merito di Hegel secondo Gentile è stato quello di aver posto un Λογος a fondamento di tutto il reale, ma separando “l’intelletto che concepisce le cose dalla ragione che concepisce lo spirito”, l’uno che distingua analiticamente, l’altra che coglie l’unità, il ritmo dialettico rimane incastrato in “concetti astratti e quindi immobili, che sono affatto privi di ogni dialettismo, e di cui perciò non è dato intendere come possano, per se stessi, passare l’uno nell’altro e unificarsi nel reale continuo moto logico”. L’identità di pensiero ed essere è pensata come se si avesse a che fare con concetti astratti e quindi immobili, mentre il pensiero per Gentile non è qualcosa di oggettivato, di statico e cristallizzato, ma il pensiero è sempre pensare in atto, un movimento che si sta realizzando, è l’atto in atto del pensare. E’ sempre all’opera un pensiero pensante in atto di pensare. Il pensiero non si può mai oggettivare, non è mai compiuto, e non si può mai trascendere perché è la nostra stessa soggettività, “poiché nel definire come oggetto determinato di un nostro pensiero la nostra stessa attività pensante, dobbiamo sempre ricordare che la definizione è resa possibile dal rimanere la nostra attività pensante, non come oggetto, ma come soggetto della nostra stessa definizione, in qualunque modo noi si concepisca questo concetto della nostra attività pensante. la vera attività pensante non è quella che definiamo, ma lo stesso pensiero che definisce”. “Per noi invece il vero pensiero non è il pensiero pensato, che Platone e tutta l’antica filosofia considerano per sé stante, presupposto del pensiero nostro che aspira ad adeguarvisi. Per noi il pensiero pensato suppone il pensiero pensante; e la vita e verità di quello sta nell’atto di questo. Il quale nella sua attuosità, che è divenire o svolgimento, pone bensì come suo proprio oggetto l’identico, ma appunto mercè il processo del suo svolgimento, che non è identità, cioè unità astratta, ma unità e molteplicità insieme, identità e differenza.” Il pensiero non è inerte e il pensato non esiste indipendentemente dall’atto in atto del pensare, perché la realtà è posta dal pensiero che pensa sempre in atto.
In questo senso è necessario riformare la dialettica hegeliana, che prende avvio dall’essere vuoto e indeterminato invece che dall’atto del pensiero. Dire essere è dire nulla: il puro essere è indeterminato e pensandolo, determinandolo come indeterminato, lo si pensa come nulla. Bisogna parlare del dasein non del sein, del divenire dell’essere come unità di essere e di non essere, cioè diviene l’essere che non è. “Ma, dice gentile, è stato osservato, se l’indeterminatezza assoluta dell’essere lo ragguaglia davvero al nulla, noi non abbiamo così quell’unità di essere e di non essere, in cui consiste il divenire: non c’è quella contraddizione tra essere e non essere di cui parla Hegel e che genererebbe il concetto del divenire. (…) in tal caso l’essere come puro essere sarebbe estraneo al non essere come puro non essere, e non ci sarebbe quell’incontro e quell’urto dei due, da cui Hegel vede sprizzare la scintilla della vita. In conclusione siamo da una parte e dall’altra innanzi a due cose morte le quali non concorrono in un movimento”.
La realtà è sì un positum della coscienza, ma un positum del pensare sempre in atto, posta in essere dal pensiero pensante. Il pensato è posto dal pensiero stesso, non c’è un pensato se non c’è un pensare in atto perché è nell’atto del pensare che si pone la contrapposizione di soggetto e oggetto e la si supera. La molteplicità dei pensati è già sempre posta e risolta nell’unità del pensare in atto. Il principio e la forma della realtà in divenire è l’atto del pensiero pensante, che istituisce l’identità di soggetto e oggetto. Si configura dunque una dialettica dell’immediatezza e della staticità di contro ad una dialettica della processualità e del dinamismo.
“L’essere, che Hegel dovrebbe mostrare identico al non essere nel divenire, che solo è reale, non è l’essere che egli definisce come l’assoluto indeterminato; ma l’essere del pensiero che è soggetto del definire, e in generale pensa: ed è come vide Cartesio in quanto pensa, ossia non essendo (perché, se fosse, il pensiero non sarebbe quello che è, un atto), e perciò ponendosi, divenendo”. Dobbiamo dunque ora capire cose significa quel “non essendo”.
Dice gentile “chi dice soggetto dice insieme oggetto. Nella stessa autocoscienza il soggetto oppone sé come oggetto a sé come soggetto: e se nel soggetto è l’attività della coscienza, l’oggetto suo, nella stessa autocoscienza, gli si oppone come negazione della coscienza, ossia come realtà inconsapevole”. L’unità della coscienza istituisce e supera la contrapposizione del soggetto all’oggetto per riconoscersi in esso. Il logo astratto considera necessariamente pensiero ed ente separati, autonomi, irrelati, contrapposti, ma è lo stesso soggetto a porre questa contrapposizione. Per divenire cosciente di sé come io e per esercitare la propria libera attività creatrice l’io è necessitato a oggettivarsi a se stesso, cioè a porre la dualità per risolverla superandola nel pensare in atto: la coscienza deve cioè continuamente negarsi, farsi altro, e superare quella negazione, negare la propria negazione x affermarsi, divenire cosciente di sé come di colui che pone l’ente, divenire cosciente di essere il produttore del mondo. La coscienza dell’oggetto è la coscienza della propria produzione dell’oggetto: l’io è cosciente di essere lui colui che pone la cosa e nel porre la cosa altro da sé è cosciente di sé, riconoscendosi in essa. Ma nell’attualismo gentiliano l’oggetto è posto continuamente dal pensare pensante in atto: il soggetto per scoprirsi autoctico deve farsi oggetto a se stesso, l’io è cosciente di sé per contrasto con qualcosa che è non io. Solo negandosi e superando la negazione diviene cosciente di sé. “e sempre l’oggetto si contrappone al soggetto in guisa che, quantunque concepito come dipendente dalla stessa attività di questo, non gli sia dato partecipare alla vita ond’è animato il soggetto. Giacchè questo è attività, ricerca, movimento verso l’oggetto; e l’oggetto, sia che si consideri come oggetto di ricerca, sia che si consideri come oggetto di scoperta e di conoscenza attuale, è inerte, sta”.
Ma il pensato con cui il soggetto, cioè il pensiero pensante, ha a che fare, che è chiamato da gentile fatto o natura, come risultato dell’attività spazializzatrice e temporalizzatrice del pensiero pensante, è continuamente superato nell’atto del pensare. Questo errore che è la natura, in quanto riconosciuto e pensato come errore è già di fatto superato. Lo spirito deve superare ogni volta le sue oggettivazioni. Dice Gentile:“intendere, anzi conoscere la realtà spirituale, è assimilarla a noi che la conosciamo. È una legge si può dire della conoscenza della realtà spirituale, che l’oggetto si risolva nel soggetto. Niente per noi ha valore di spirito, se non finisce con l’essere risoluto in noi che lo conosciamo”. L’oggetto è soggettività in quanto spirito, e lo spirito è nella misura in cui si concretizza, nel suo farsi risiede la concretezza. La distinzione tra spirito e fatto spirituale è fallace, perché è tutto spirito inteso come pura attività di creazione del mondo, attività sempre in atto, non si ferma mai. Per spiegare meglio questo concetto Gentile fa riferimento alla lingua e dice: “la verità è che la lingua, quando la si voglia conoscere in concreto, si presenta come lo svolgimento della lingua, ed è la lingua che suona sulla bocca degli uomini che la usano. La quale lingua non si stacca più dal soggetto, non è un fatto spirituale che si possa distinguere dallo spirito in cui avviene. Quest’atto spirituale che si chiama linguaggio, è appunto lo spirito nella sua concretezza(…) distinguiamo pure la divina commedia da dante che la scrisse e da noi che la leggiamo; ma avvertiamo poi che questa divina commedia, che così distinguiamo da noi, è da noi ed in noi, dentro la nostra mente, pensata come distinta da noi. È cioè essa stessa in noi, malgrado la distinzione: in noi in quanto la pensiamo. Sicchè non è nulla di estraneo a noi che la pensiamo”.
Dire fatto è come dire spirito, cioè “individualità concreta, storica: soggetto che non è pensato come tale ma attuato come tale. Lo spirito come soggetto è la realtà spirituale, la cui oggettività è posta dal soggetto che la pensa attualmente, si risolve nell’attività del soggetto, che ponendola continuamente la ri-supera: “la sua oggettività si risolve nell’attività reale del soggetto che la conosce”. L’io, lo spirito, è per sua essenza pura attività che agisce sulle proprie oggettivazioni, e per questo è puro, inoggettivabile, è in quanto si vien facendo. Lo spirito è auto-creazione di se e totalmente immanente a se stesso. Anche l’altro propriamente non esiste come altro, perché mediato dalla coscienza.
“Il mondo spirituale è concepibile soltanto come la realtà stessa della mia attività spirituale”. Questa proposizione, dice Gentile, non ha alcun senso se si guarda all’io empirico, perché quest’ultimo è contrapposto a tutte la cosa materiali e a tutti gli individui cui è assegnato valore spirituale. Il soggetto del pensare in atto non può essere l’io empirico, perché è un fatto, è natura, ed è quindi posto dal pensiero pensante come altro da sé come oggetto, non soggetto dello spirito. Il soggetto del pensiero pensante non può essere una sostanza ma è il processo creativo in cui consiste l’io trascendentale, che è tutto sempre da fare. Il soggetto del pensiero in atto coincide con l’atto stesso del pensare e il pensato non può esistere se non c’è un atto del pensiero pensante che lo pone come pensato. “Affinchè si possa intendere la natura di questo stesso oggetto che risolve sempre ogni oggettività degli esseri spirituali, e non è possibile che si arresti dinnanzi a un essere spirituale diverso da sé, e non ha perciò dinanzi a sé se non se medesimo, bisogna prima di tutto considerare che questo soggetto unico e unificatore non è un essere o uno stato, ma un processo costruttivo”. La soggettività trascendentale è un’attività creatrice per cui verum et factum convertuntur, come disse Vico nel “De antiquissima italorum sapientia”, cioè il concetto della verità coincide con quello del fatto. La verità è un fare, è una sviluppo necessario che collega soggetto e oggetto in una fare che è anche conoscere: fare ed essere sono la stessa realtà, ma teoria e prassi sono sostanzialmente identici: il conoscere non è pura contemplazione passiva, ma pensiero in atto, prassi. L’idealismo non nega la realtà, ma la deduce dalla prassi: il soggetto liberamente pone l’oggetto. Ogni atto spirituale è sempre anche pratico e questa praticità si manifesta nella storia, “cioè una realtà che si realizzi con un processo che non sia vana dispersione di attività, ma creazione continua della realtà stessa, o incremento del suo essere”. La conoscenza è azione, prassi, attività in atto del soggetto che pensa, del pensiero pensante. Ritornando all’esempio della lingua gentile afferma: “la lingua vera non è εργον(opus), ma ενεργεια: non è il risultato del processo linguistico, ma appunto questo processo, che è sviluppo in atto. Dunque, la lingua, qualunque essa sia, non si conosce, nel suo essere definitivo (che non ha mai), ma a grado a grado nel suo concreto svolgimento. E come la lingua, tutto che sia realtà spirituale; e che voi conoscerete sì, come s’è detto, risolvendolo nella vostra attività spirituale, ma a grado a grado instaurando quella medesimezza o unità, in cui la cognizione consiste(…) vero è che il fatto, con cui si converte il vero, essendo la stessa realtà spirituale che realizza (o che intende realizzando) se stessa, non è propriamente un fatto, ma un farsi. Sicchè piuttosto dovrebbe dirsi: verum et fieri convertuntur”, oppure come si dice in seguito verum est factum quatenus (qualora) fit. Il processo costitutivo tramite cui il soggetto risolve in sé l’oggetto è dinamico, mai concluso. “Il soggetto che risolve in sé l’oggetto, almeno quando questo oggetto è realtà spirituale, non è essere, né stato dell’essere: non è niente di immediato, come dicemmo, ma processo costruttivo. Processo costruttivo dell’oggetto in quanto processo costruttivo dello stesso soggetto(…) il soggetto è sempre soggetto di un oggetto, in quanto si costituisce soggetto del suo atto rispettivo”. Lo spirito non è mai essere, è sempre un farsi attuale, è essenzialmente uno svolgimento che si attua, è attualmente se stesso. Non esiste spirito fuori dal suo manifestarsi in svolgimento. Tutto è sempre da fare, nulla è mai staticamente concluso, fatto, la natura viene ad oltranza ri-superata, mediata dalla coscienza. Lo spirito è eterno divenire. “noi non conosciamo nessuno spirito che sia di là dalla sue manifestazioni, e consideriamo queste manifestazioni come la sua stessa interiore ed essenziale realizzazione”. Lo spirito si realizza dunque come coscienza di sé progressivamente, senza mai arrivare al traguardo, mai raggiunto ma raggiungibile.
Ogni determinazione dell’ente è solo in relazione alla totalità delle determinazioni che si concretizzano progressivamente, in cui consiste lo spirito nella sua attualità. “Ma, come la molteplicità è da subordinare e unificare nell’unità, così la determinatezza deve intendersi nella concretezza del sistema di tutte le determinazioni, che è la vita attuale dello spirito. Anche la menzionata verità, dell’equivalenza degli angoli interni d’un triangolo a due retti, soltanto per astrazione è un che di chiuso e per sé stante: in realtà si articola nel processo della geometria attraverso tutte le menti, in cui questa geometria nel mondo si attua”.
L’Io trascendentale è unitario, la sua è un’unità “immoltiplicabile e infinita”. Il pensiero non ha limiti: ogni oggetto conosciuto è un pensato ed è quindi interno alla coscienza, che di conseguenza non avendo oggetti che le si contrappongono in quanto ad essa interni, non ha limiti, non ha nulla contro cui arrestarsi: è cioè infinita, ed essendo essa tutto il pensiero, non può essere una parte della realtà che è la totalità pensata, ed è quindi unica. “La coscienza infatti non si pone se non come una sfera il cui raggio è infinito: e qualunque sforzo si faccia per pensare o immaginare altre cose o coscienze al di là della nostra coscienza, quelle cose e coscienze rimangono dentro di essa, per ciò appunto che sono poste da noi, sia pure come esterne a noi. Questo fuori è sempre dentro. Designa cioè un rapporto tra due termini, che esterni l’uno all’altro sono tuttavia interni entrambi alla coscienza. Niente c’è per noi, senza che noi ci se n’accorga, e cioè che si ammetta, comunque definito (esterno o interno), dentro alla sfera del nostro soggetto”. L’oggetto si risolve sempre nella coscienza. Già Spinoza riconosceva che la res è objectum mentis, contenuto della coscienza. “Movendoci col pensiero lungo tutto il pensabile, noi non troviamo mai né il margine del pensiero stesso, né l’altro che sia di là dal nostro pensiero, e innanzi a cui il nostro pensiero si arresti. Di guisa che lo spirito non solo è uno psicologicamente, in se stesso, ma è uno anche gnoseologicamente e metafisicamente considerato, non potendo riferirsi ad un oggetto che gli sia esterno, né potendo perciò concepirsi reale tra i reali, come una parte cola della realtà”.
Abbiamo detto che il soggetto oppone a sé come soggetto sé come oggetto, si nega, si fa altro: prescindere dalla sintesi che il soggetto imprime all’oggetto significa opporre al soggetto la molteplicità del reale: conoscere e creare sono sempre un determinare, cioè un distinguere. Il non io che l’ io si autoppone, per essere conosciuto e posto in essere deve essere determinato e sarà quindi molteplice: la molteplicità si risolve nell’unità che è originaria, a priori e senza di cui la molteplicità stessa non sarebbe, e l’unità a sua volta per riconoscersi come unità deve moltiplicarsi. L’io oppone a se un non io, si nega e quindi dà vita ad una molteplicità che è già da sempre unita nell’io. La molteplicità dell’oggetto si risolve perché è già da sempre risolta nel soggetto, che pone in essere l’oggetto opponendo a sé un non io e riconoscendo se stesso come fonte dell’opposizione, riconoscendosi così nell’opposto che dalla propria negazione deriva. Nel conoscere l’oggetto il soggetto si riconosce come il suo autore, supera l’alterità dell’oggetto che esso stesso ha posto per divenire cosciente di sé. “Ne consegue che all’unità realizzata dall’attività del soggetto si oppone nell’oggetto la molteplicità propria del reale, appena si prescinda dalla forma sintetica che gl’imprime il soggetto. La cose infatti nella loro oggettività, termine presupposto dall’attività teoretica dello spirito, sono molte: essenzialmente molte in guisa che una cosa sola non sia pensabile se non come risultante dalla composizione di molti elementi. Una cosa unica e infinita non sarebbe conoscibile; perché conoscere è distinguere una cosa da un’altra: omnis determinatio est negatio. E tutta la nostra esperienza si libra tra l’unità del suo centro, che è lo spirito, e la infinita molteplicità dei punti costituenti la sfera dei suoi oggetti(…) ma la molteplicità delle cose non sta accanto all’unità dell’Io; essa appartiene alle cose in quanto queste sono oggetto dell’Io, ossia in quanto tutte vengono raccolte nell’unità della coscienza. Le cose sono molte in quanto sono insieme, raccolte nell’unità della sintesi(che è a priori). Spezzata la sintesi, ognuna è soltanto se stessa, senza riferimento di sorta alle altre. (…) quindi in tanto c’è molteplicità, in quanto c’è sintesi di molteplicità e di unità. La molteplicità, per essere quella molteplicità che è propria dell’oggetto della coscienza, implica la risoluzione della molteplicità stessa; implica cioè l’unificazione di questa nel centro a cui tutti i raggi infiniti della sfera convergono.” La molteplicità viene riassorbita originariamente, aprioristicamente nell’unità, che è unità della realtà in quanto spirituale. Lo spirito, l’io trascendentale è svolgimento unitario. Il logo astratto concepisce unità e molteplicità irrelate e pone lo spirito o all’inizio o come risultato del processo, ma “la realtà si vien moltiplicando in diverse forme restando sempre una”, perché molteplicità e unità sono la stessa cosa, cioè lo svolgimento concreto della vita. Il logo concreto infatti è quello che “non lascia concepire l’unità se non attraverso la molteplicità, e viceversa: quello, che nella molteplicità mostra la realtà e la vita dell’unità. La quale, appunto perciò non è ma diviene, si forma: non è come abbiamo detto, una sostanza, un’entità fissa e definita, ma un processo costruttivo, uno svolgimento. La realtà è “infinita unificazione del molteplice, com’è infinita moltiplicazione dell’uno(…) lo svolgimento è moltiplicazione che è unificazione, ed è unificazione che è moltiplicazione”.
Il pensiero pensante è eternamente atto in atto, lo spirito è essenzialmente il suo farsi, il suo svolgimento che non giunge mai ad un risultato, ma è esattamente il processo che esso compie: è un’unimolteplicità, un’unità molteplice. Unità e molteplicità sono relati e si risolvono riguardandosi reciprocamente nell’atto del processo del farsi dello spirito. La sintesi non è mai risultato, ma continua rideterminazione. “ Esso né fu in principio né sarà alla fine, perché non è mai: diviene. Il suo essere consiste appunto nel suo divenire, che non può avere né un antecedente né un conseguente, senza cessar di divenire. Ora questa realtà che non è né fine né principio di un processo, ma, appunto, processo, non si può concepire come unità che non sia molteplicità: perché come tale non sarebbe svolgimento, cioè non sarebbe spirito. La molteplicità è necessaria alla stessa concretezza, alla stessa realtà dialettica dell’unità. E la sua infinità, che è l’attributo essenziale dell’unità, non è negata, anzi è confermata o per meglio dire si realizza attraverso la molteplicità: la quale ne è infatti il dispiegamento lungo il cammino in cui l’unità si attua”.
PIERO GOBETTI

VITA E OPERE
Piero Gobetti nacque a Torino il 19 giugno del 1901. Dopo le scuole elementari frequenta il liceo-ginnasio “Gioberti” e lì conosce Ada Prospero, figlia di un commerciante come lui, che diventerà sua moglie. Studente universitario di acuta intelligenza, pubblica a diciassette anni la sua prima rivista, “Energie Nove”, nel novembre del 1918, ricca di riferimenti a Prezzolini, Gentile, Croce e con la quale diffuse le idee liberali di Einaudi. Si appassiona ai bolscevichi, studia il russo e scrive in cirillico alla fidanzata. Definisce subito il fascismo “movimento plebeo e liberticida”, l’antifascismo “nobilità dello spirito”, l’Italia un Paese senza un vero Risorgimento, una Riforma protestante, una Rivoluzione liberale. Interpreta la rivoluzione di Lenin e Trotzky come rivoluzione liberale, perché è azione, movimento e tutto quello che si muove va verso il liberalismo. Apprezza i bolscevichi in quanto élite, detesta lo statalismo e il protezionismo della vecchia Italia giolittiana. Esponente della sinistra liberale progressista, collegata con l’intellettuale meridionalista Gaetano Salvemini. Estimatore di Antonio Gramsci e del giornale socialista e poi comunista Ordine Nuovo, Gobetti si avvicina al proletariato torinese, divenendo attivo antifascista. Nel maggio del 1919 viene bollato da Togliatti sulle pagine di “Ordine Nuovo” come “parassita della cultura”. Ma nell’autunno del 1920 il sostegno di Gobetti all’occupazione delle fabbriche e i suoi frequenti incontri con gli operai e comunisti torinesi migliorano molto i rapporti, tanto che Gramsci gli affida la rubrica di teatro della rivista. La classe operaia, in particolare quella torinese dei consigli di fabbrica, che frequenta insieme ai socialisti di Ordine nuovo, diventa per lui la leva che innoverà il mondo: non verso il socialismo, ma verso “elementi di concorrenza”. Togliatti non lo ama, Gramsci lo apprezza, i liberali Salvemini e Croce sono incuriositi dall’intelligenza del ragazzo. A vent’anni, il 12 febbraio del 1922, fa uscire il primo numero della rivista “La Rivoluzione Liberale” che via via diventa centro di impegno antifascista di segno liberale, collegato ad altri nuclei liberali di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Vi collaborano intellettuali di diversa estrazione, tra cui Amendola, Salvatorelli, Fortunato, Gramsci, Antonicelli e Sturzo. Più volte arrestato nel ’23-24 dalla polizia fascista, la sua rivista è ripetutamente sequestrata. Lo stesso Mussolini si interessa di lui e telegrafa al prefetto di Torino: “Prego informarsi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore”. Nel ’24 fonda la rivista letteraria “Il Baretti”, alla quale collaborano Benedetto Croce, Eugenio Montale, Natalino Sapegno, Umberto Saba ed Emilio Cecchi. Il 5 settembre del ’24, mentre sta uscendo di casa, è aggredito sulle scale da quattro squadristi che lo colpiscono al torace e al volto, rompendogli gli occhiali e procurandogli gravi ferite invalidanti. Costretto a espatriare in Francia, mai più riavutosi dalle ferite, muore esule a Parigi nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1926. Non aveva nemmeno venticinque anni, che avrebbe compiuto il 19 giugno di quell’anno. È sepolto nel cimitero di Père Lachaise. Saggista e autore di numerosi scritti culturali e politici pubblicati in Italia e all’estero, simbolo del liberalismo progressista sensibile al riscatto delle classi lavoratrici, la sua opera fu raccolta e pubblicata postuma: Opere critiche (1926); Paradosso dello spirito russo (1926); Risorgimento senza eroi (1926).
IL PENSIERO
A diciott’anni Gobetti fonda “Energie nuove”, rivista quindicinale sulla scia dell’ “Unità” di Gaetano Salvemini e, dopo una breve infatuazione per i liberisti come Einaudi, matura la sua concezione della politica come forma di educazione e della cultura come coscienza storica. Dopo un anno, nel 1920 la rivista finisce le pubblicazioni; nel ’22 Gobetti fonda il settimanale “La Rivoluzione liberale”, con molti collaboratori della cessata “Unità salveminiana” affiancata da una rivista letteraria, “il Baretti” e da una piccola casa editrice. A 23 anni, nel 1924, raccoglie, elaborandoli, molti articoli apparsi sulla rivista e, con lo stesso titolo, “Rivoluzione Liberale”, pubblica il “Saggio sulla lotta politica in Italia”. Era il mese d’aprile: nel giugno viene ucciso Matteotti e il 3 gennaio 1925 Mussolini trasforma il suo governo in regime. Per tutto l’anno si susseguono i sequestri della rivista, finchè il 1° novembre Gobetti deve pubblicare la diffida del prefetto di Torino contro il periodico, accusato di mirare “alla menomazione delle istituzioni monarchiche, della Chiesa, dei poteri dello Stato, danneggiando il prestigio nazionale”. Una settimana dopo, esce l’ultimo numero della rivista, che segue il destino de “Il Caffè” pubblicato a Milano da Riccardo Bauer, con Parri, Gallarati Scotti, Arpesani, Borsa e Sacchi (chiuso in maggio), del fiorentino “Non Mollare” di Salvemini, Ernesto Rossi e dei fratelli Rosselli (finito in ottobre), e di tante altre voci libere invise al nuovo regime dittatoriale. Riletto oggi, il libro di Gobetti sorprende per le molte notazioni originali sul Risorgimento e sulla lotta politica del tempo. Per esempio, la considerazione di Cavour come autore di una grande rivoluzione liberale rimasta incompiuta, e dello stesso Risorgimento come incompiuto e non come “rivoluzione mancata” (come l’aveva invece letto Gramsci); la rivalutazione del Piemonte settecentesco e ottocentesco come di un paese contraddistinto dall’assenteismo dell’aristocrazia, dallo spezzettamento della grande proprietà agraria e dalla diffusione degli affittuari, dalla laicità dello Stato e dalla presenza di una singolare cultura moderna ” in questo vecchio Stato nemico della cultura “. A differenza di tanti intellettuali di trenta o quarant’anni dopo, Gobetti riconosce il valore della fabbrica che ” educa al senso della dipendenza e della coordinazione sociale, ma non spegne le forze di ribellione, anzi le cementa in una volontà organica di libertà ” e riconosce altresì il valore positivo della città moderna, ” organismo sorto per lo sforzo autonomo di migliaia d’individui “. In Gobetti appare per la prima volta il concetto di fascismo come ” autobiografia della nazione “: ” né Mussolini né Vittorio Emanuele hanno virtù da padroni, ma gli italiani hanno bene animo di schiavi “. E fin dalla prima pagina del libro fa una dichiarazione fulminante e valida più che mai oggi: ” il contrasto vero dei tempi nuovi come delle vecchie tradizioni non è tra dittatura e libertà, ma tra libertà e unanimità “. Ci sono, in Gobetti, anche curiosità che fanno pensare:
” la sua figura di ottimista sicuro di sé, le astuzie oratorie, l’amore per il successo e per le solennità domenicali, la virtù della mistificazione dell’enfasi…..L’ordinaria amministrazione con la sua monotonia è un altro fiero nemico del presidente; se egli non avesse un piacevole divertimento nelle trovate sportive che gli riconciliano la popolarità, il compito quotidiano sarebbe snervante e senza risorse “.
Di chi parla? Di Mussolini certamente, allora. E oggi? Ma ci sono soprattutto analisi acute e ancora valide della storia e del carattere italiani e molti concetti innovatori. Nel capitolo su “Liberali e democratici”, premesso che la più grave deficienza del liberalismo italiano si potrebbe cercare ” nella lunga mancanza di un partito politico francamente conservatore “, Gobetti scrive: ” insomma la parola d’ordine dei liberali in Italia a partire dal secolo scorso fu: “tutti liberali”. La nuova critica liberale deve differenziare i metodi, negare che il liberalismo rappresenti gli interessi generali, identificarlo con la lotta per la conquista della libertà, e con l’azione storica dei ceti che vi sono interessati “. Posto che i veri liberali sono una minoranza, ” bisogna convincersi che non erano e non potevano essere, come non sono, liberali i nazionalisti e i siderurgici, interessati al parassitismo dei padroni, né i riformisti che combattevano per il parassitismo dei servi, né gli agricoltori latifondisti che vogliono il dazio sui grani per speculare su una cultura estensiva di rapina, né i socialisti pronti a sacrificare la libertà di opporsi alle classi dominanti per un sussidio dato alle loro cooperative“. Gobetti vede il carattere arretrato e illiberale della borghesia italiana, che chiede favori e una politica protezionista, una non-borghesia se confrontata con i ceti dirigenti conservatori di altri paesi. Riconosce che in Italia ci sono due borghesie, ma quella weberiana (come la chiama Flores D’Arcais) resta in minoranza, mentre domina il ” ceto dirigente contento di sé “. Gobetti riconosce la necessità storica e i valori della civiltà capitalistica, ma vede i suoi limiti nelle nazioni più povere, la Russia e l’Italia. Nel nostro Paese, si contrappongono l’individualismo regolato dalle leggi e una tradizione ” istintivamente individualista ” che ha prodotto un popolo ” in perenne atteggiamento anarchico “. Per Gobetti, ” il liberalismo ha elaborato un concetto della politica come disinteresse dell’uomo di governo di fronte al popolo interessato… Solo attraverso la lotta di classe il liberalismo può dimostrare le sue ricchezze…Essa è lo strumento infallibile per la formazione di nuove élites, la vera leva, sempre operante, del rinnovamento popolare “. Certo, l’errore di Gobetti è stato di vedere in Gramsci e nei consigli di fabbrica, promossi da “Ordine nuovo”, aspetti e valori liberali; da qui, la sua illogica simpatia per Lenin, benchè riconosca il carattere ” accentratore, autoritario, monopolistico della rivoluzione russa “. Ciò non toglie che egli si era reso conto, sulle orme di Salvemini, degli errori della sinistra, in particolare del riformismo e del ” parassitismo cooperativistico “. Ancora più importante, e decisivo per la valutazione di Gobetti, è il riconoscimento del fatto che il primato dell’uguaglianza rispetto alla libertà è la causa delle degenerazioni del movimento operaio. A questo proposito, commenta Flores D’Arcais: “ pure, la convinzione gobettiana che se l’ossessione dell’eguaglianza sociale governa e comanda la politica operaia, umiliando le libertà a strumento tattico nella lotta per il potere, sono a repentaglio gli stessi interessi dei lavoratori – interessi nel senso più pieno e materiale del termine “. E infatti Gobetti aveva sostenuto con grande chiarezza: ” il problema del movimento operaio è un problema di libertà e non di uguaglianza sociale “. Qui merita citare ancora Flores D’Arcais: contro la “disponibilità ”moderata” di massa al tradimento del liberalismo”… “Contro questo rischio di populismo, perciò sempre più irrinunciabile si dimostra l’intuizione di Gobetti, che ai lavoratori dipendenti e alle forze politiche che li rappresentavano vada innanzi tutto affidata la difesa, la cura e il radicamento del liberalismo. Sono gli unici, infatti, ad avere un interesse intrattabile ad una convivenza civile fondata sul governo delle regole e non sulle regole di chi governa”. In “Destra e sinistra”, Norberto Bobbio ha scritto che il valore “eguaglianza” è quello che contraddistingue la sinistra. Ma un conto è constatare che nella storia del movimento operaio l’eguaglianza sia sempre stato il valore dominante; altro è riconoscere con Gobetti che la sottovalutazione della libertà è stato un errore. Rileggendo Gobetti, non è utopistico pensare che la bandiera della minoranza intellettuale antifascista, rappresentata dal partito d’azione, possa diventare adesso la connotazione di una sinistra popolare, non socialdemocratica né limitatamente migliorista. Giustizia e libertà: eguaglianza come mito, come direttrice per una società migliore, e libertà nella pratica di ogni giorno, nelle istituzioni, nelle regole del vivere civile e politico, libertà significa anche eguaglianza di fronte alle leggi, negazione di ogni favore e privilegio, negazione del familismo in tutti i suoi aspetti, fino alla connivenza camorristica e mafiosa, e quindi è educazione a un costume di convivenza civile e tollerante. Senza l’appoggio e la convinzione di un grande movimento politico popolare, l’educazione alla libertà non può divenire patrimonio comune. E, come aveva intuito Gobetti, i lavoratori a reddito fisso e gli imprenditori non speculatori e non protezionisti hanno interesse comuni: l’equità fiscale, innanzi tutto, che è un problema di eguaglianza e anche un aspetto del libero mercato, se si volesse tentare di farlo esistere almeno in parte; e la lotta alla corruzione e alle clientele politico-affaristiche, che è un problema di giustizia. Nessuno di questi grandi obiettivi potrà essere raggiunto se la libertà sarà ancora vista come “formale” o “borghese”, oppure come una condizione già raggiunta. La libertà va realizzata nelle coscienze, nell’educazione, nelle regole della vita civile e politica, essa è la condizione per ogni sforzo di eguaglianza. La rivoluzione liberale, mai realmente attuata in Italia, dev’essere una rivoluzione di giustizia, che necessita sia di una profonda educazione etica, sia di un’azione politica di grandi orizzonti.
LA RIVOLUZIONE LIBERALE
Gobetti era un rivoluzionario liberale. Inevitabile, nel rievocarne la figura, partire dall’ossimoro, tanto più insolito e singolare, se calato nella storia politica italiana che ha fatto del liberalismo- oltre le benemerenze risorgimentali – una tradizione conservatrice o al più moderata. Intanto quell’ossimoro non è definizione arbitraria o affibbiata dall’esterno a Gobetti. E’ un’autodefinizione. Che fa corpo col programma stesso che il giovane uomo di pensiero attribuì via via a se stesso, negli anni che vanno dalla prime prove editoriali – “Energie Nuove”, la collaborazione a l’Unità di Salvemini – fino alla più matura opera destinata a divenire rivista e infine saggio nel 1924: “Rivoluzione liberale”. Ma cos’era questa Rivoluzione? Di quali obiettivi, soggetti storici e speranze si nutriva? Per capirlo occorre, per un momento, fuoriuscire dal cielo dottrinario delle idee. E sforzarsi di intravedere prima ancora, un carattere, una biografia, un clima ben preciso. Parliamo di un certo mondo vitale. Quello della Torino pre-bellica e post-bellica, nel primi decenni del novecento. Indubitabilmente quella Torino è crogiolo avanzato di industria e cultura, piazzaforte del piccolo “Stato-Fiat” (la definizione sarà di Gobetti stesso) che piegava tutta l’industria circostante a sé, imprimendo ritmo e dinamismo nuovo all’ex capitale subalpina. E’ un sommovimento profondo, che suscita da un lato le energie di un vasto proletariato industriale ben presto organizzato attorno ai suoi apostoli e filantropi borghesi, alle sue cooperative e al suo sindacato. E che dall’altro muove forze intellettuali diffuse. Sulla scia della nascente civiltà industriale. Di un mercato allargato e del ventaglio di funzioni e professioni evocato dalla modernizzazione giolittiana. Torino, è epicentro di tutto questo, e interpreta il suo ruolo mescolando fierezza di capitale declassata a sentimenti di rivincita industrialista sul resto del paese. Ecco, Gobetti, studente prodigio del Gioberti, giornalista in erba, ragazzo che si rivolgerà da pari a pari a Salvemini, Einaudi, Croce, Prezzolini, Gentile, cresce in quel clima. Figlio di contadini piemontesi inurbati e gestori di una drogheria, incarna perfettamente le Energie nuove del momento. Il tumultuoso passaggio da una società censitaria – ancorché cavourianamente inventiva – a un mondo di aspri conflitti tra ceti e generazioni. E’ Gobetti, nella sua prodigiosa e acerba vitalità venata di puritanesimo, l’esplosione stessa a Torino e in Italia, di una questione cruciale. La questione intellettuale. Non già intesa come contrasto tra i colti e gli umili, tra romantica élite minoritaria e filistei privilegiati, come la Germania di primo ottocento ce l’ha tramandata. Bensì come questione politica nazionale. Sociale certo, quanto a dimensione e moltiplicazione delle funzioni intellettuali moderne. Ma, ancor, più politica. Cioè come problema della selezione e dell’ascesa delle classi dirigenti. Delle élites, per evocare un termine centrale nella riflessione di Gobetti. Qui, è impossibile non registrare una consonanza rivelatrice: Gramsci. Anche lui, a modo suo “contadino”. Figlio di un piccolo impiegato comunale, e “isolano” inurbato nella medesima Torino di Gobetti. Anche lui, critico del fatalismo positivista, e vittima del fascismo. E del pari ossessionato dagli intellettuali. Coesivo e mastice simbolico – nella riflessione dei Quaderni del Carcere – senza cui nessun ricambio sociale, nessuna riproduzione economica, né baricentro egemonico di forze o di senso generale, era possibile nel moderno. Certo il demiurgismo intellettuale, di cui Gobetti fu interprete emblematico, ebbe nell’Italia di allora un significato oscillante e ambiguo. Sino a culminare col fascismo – sulle scie dell'”attivismo”- in una capillare integrazione dei colti nel regime, e di segno conservatore. Almeno fino ai tempi della fronda antifascista. Del resto, lo stesso Gobetti convisse, smarcandosene da ultimo, con protagonisti culturali della rivoluzione conservatrice. Dall'”Apota” Prezzolini a Gentile, idolatrato all’inizio, poi respinto come esponente di una scolastica autoritaria. Eppure, sul crinale di quest’insorgenza intellettuale di massa a cavallo della grande guerra, Gobetti rappresentò acutamente una grande possibilità, innervata da analisi di straordinaria attualità. La spinta ad un ricambio profondo di classi dirigenti. Oltre la chiusura oppressiva del vecchio ceto liberale che nell’unificare il paese dall’alto aveva escluso i ceti subalterni dallo stato e dal recinto della società civile. Cristallizzando assetti da civiltà pre-capitalista, privilegi corporativi e territoriali, ineguaglianze di classe. E’ qui che il bisturi di Gobetti scava. Delineando, sulla scia di Salvemini, il quadro di quello che Gramsci definirà il “patto scellerato” tra nuova borghesia industrialista del nord, protetta dallo stato e vecchie classi parassitarie del sud, acquiescenti ad un progetto di unificazione nazionale che condannava il mezzogiorno a mercato passivo di manufatti e a serbatoio di manodopera. Mentre la proiezione geometrica di questo assetto diventava la convergenza al centro di partiti notabilari e incapaci di incarnare grandi correnti nazionali di interessi. C’è, in questa denuncia di Gobetti, l’analogo di consimili vedute weberiane. Le stesse con cui Max Weber nella Germania guglielmina metteva sotto accusa il parlamentarismo degli junker, nonché l’assenza di un vero partito liberale di massa capace di allargare la cittadinanza oltre il privilegio censitario e assicurare base parlamentare salda all’esecutivo. E tuttavia, in Gobetti, oltre l’attenzione ai limiti del liberalismo italiano, c’è la ricerca di un altro protagonista: il movimento operaio. Da riscattare dai vincoli di una mentalità fatalista e messianica, e da inserire a pieno titolo nel processo di rinnovamento dell’Italia liberale. Su questo punto l’utopia gobettiana si fa più affascinante e ambigua da decifrare. Infatti da un lato il giovane rivoluzionario liberale sembra puntare ad un rinnovamento dei partiti, concependoli come partiti di massa, finalmente liberati dai “partiti personali” costruiti sul maggioritario (Gobetti era proporzionalista). E in tal senso gioca un ruolo il richiamo energetico al ruolo del “mito” soreliano, che fonde in blocchi classi fondamentali e alleanze su opposte sponde. Dall’altro però gli impulsi di rivoluzione muovono in lui dalle autonome cerchie della società civile. Dal mondo della cultura e dalle sue ramificazioni capillari specialistiche. Dal mondo dell’industria e dal mondo della fabbrica. Come quando, nel 1920, egli guarda ammirato al soviet della Fiat e all'”Ordine Nuovo” di Gramsci, corrispettivo italiano di quel moto di “rivoluzione liberale” che Gobetti scorgeva nella rivoluzione bolscevica. Difficile capire se per Gobetti, dalla personalità sperimentale e in divenire l’epilogo di quell’Italia sospesa tra progresso e reazione e in piena bufera post-bellica, dovesse essere la rivoluzione sociale. Con gli operai promossi a rango di borghesi intraprenditori nelle fabbriche occupate. Oppure se per lui si trattasse solo di uno scossone salutare, destinato a mutare le élites al potere degli opposti schieramenti rinnovati dal fuoco dello scontro. E secondo uno schema “conflittualista” debitore più all’elitismo sociale di Mosca che non a quello “naturalistico” di Pareto. Ma a troncare il dilemma intervenne il fascismo. Quando, sulle ceneri della divisione tra le forze democratiche – liberali, cattoliche e socialiste ferite dalla scissione di Livorno – si incaricò di fornire la sua risposta. Eccola: un moderno regime reazionario di massa. Che lascia filtrare al vertice ceti medi emergenti, nel quadro di un compromesso storico con industria, monarchia e Chiesa. E che spacca e comprime in basso i ceti subalterni. Prima di morire, schiantato da un attacco cardiaco successivo all’aggressione squadristica a Torino, Gobetti individuò i tratti salienti di quella “modernizzazione reazionaria”. Descrivendola come “autobiografia di una nazione”: una micidiale miscela di populismo, antiparlamentarismo e tradizionalismo retrivo. Rassodata da un nuovo ceto medio risentito ed estraneo alle istituzioni, percepite come nemiche. Fu l’ultima fiammata di intelligenza di quel giovane acerbo, le cui intuizioni ante-litteram ridimensionano alquanto l’originalità di tante polemiche “revisionistiche” molto più tarde.
EDMUND HUSSERL

BIOGRAFIA
1859 Edmund Husserl nasce a Prossnitz, Moravia, l’8 aprile del 1859.
1878 Dopo aver studiato due anni prima astronomia all’Università di Leipzig, si trasferisce a Berlino per studiare matematica. Egli segue i corsi di algebra di Weirstrass.
1883 Conclude gli studi di matematica con una tesi sul calcolo delle variazioni.
1884 Il 24 aprile muore il padre. Si trasferisce lo stesso anno a Vienna, dove segue le lezioni di Brentano.
1887 Sposa il 6 agosto Malvine Steinschneider.
1891 Pubblica la Filosofia dell’aritmetica .E nel settembre dello stesso anno si trasferisce a Göttingen dove viene nominato professore nell’Università dell’omonima cittadina.
1906 Dopo aver pubblicato nel 1901 le Ricerche logiche , diviene professore a tutti gli effetti, ricopre la cattedra di filosofia.
1913 Husserl mantiene uno stretto rapporto con Jaspers. Sono di quest’anno le Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica.
1916 Il 5 gennaio si trasferisce a Friburgo per ricoprire la cattedra di filosofia. Lì avrà come allievo Heidegger.
1918 Inizia un’assidua corrispondenza con i fisici di Gottinga.
1926 Heidegger presenta al maestro, Husserl, una copia di Essere e tempo .
1927 Lavora all’Enciclopedia Britannica.
1928 Venne obbligato dal regime nazista a lasciare l’insegnamento in quanto ebreo. Egli si ritira così a vita privata. Pubblicherà nel 1929 la Logica formale e trascendentale .
1938 Muore il 27 aprile del 1938.
VITA, OPERE E CONTESTO STORICO
Edmund Husserl nacque nel 1859 a Prossnitz, in Moravia, da famiglia ebrea, studiò matematica e fisica, prima presso l’università di Lipsia e poi, dal 1878, in quella di Berlino, dove seguì i corsi dei matematici Kronecker e Weierstrass, laureandosi con quest’ultimo nel 1833. Nel 1884 ritornò a Vienna, dove si avvicinò a Brentano e, nel 1887, sostenne l’esame per la libera docenza ad Halle. In questo stesso anno, dopo essersi convertito alla confessione evangelica, sposò Malvine Charlotte Steinscheider, anch’ella ebrea convertita. Nel 1891 pubblicò la sua prima opera Filosofia dell’aritmetica , poi nel 1900 e 1901 i due volumi di Ricerche logiche . Nominato nel 1901 professore straordinario all’università di Gottinga, vi rimase fino al 1916, quando divenne professore a Friburgo. In questo periodo fondò la rivista che poi divenne l’organo del movimento fenomenologico, lo ‘Jahrbuch für Philosophie und phanomenologische Forschung’ (Annuario di filosofia e di ricerca fenomenologica), in cui compariranno anche scritti importanti dei suoi primi discepoli, quali Scheler e Heidegger, e pubblicò alcuni dei suoi scritti più significativi, quali Filosofia come scienza rigorosa (1911) e il primo tomo delle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica (1913). Nel dopoguerra, la filosofia di Husserl cominciò ad essere conosciuta anche fuori dalla Germania: nel 1922 tenne una conferenza a Londra sulla fenomenologia e, nel 1929, altre conferenze alla Sorbona di Parigi, poi ripetute a Strasburgo, il cui testo fu trascritto in francese, sotto la guida di A. Koyré, da G. Pfeiffer ed E. Lévinas, comparendo nel 1931 con il titolo Meditazioni cartesiane . Intanto, nel 1928, sulla cattedra di Friburgo gli era successo l’allievo Heidegger, mentre egli si dedicava alla composizione di altre opere, come Logica formale e trascendentale (1929) e una Postilla alle Idee , da apporre come premessa alla traduzione inglese di quest’opera, uscita nel 1931: in essa, egli prendeva posizione tra l’altro contro la filosofia dell’allievo Heidegger. Con l’avvento del nazismo nel 1933 arrivarono tempi duri per Husserl: fu radiato dall’università di Friburgo in quanto ebreo, proprio nel periodo in cui Heidegger ne era rettore; stessa sorte toccò al figlio, professore di Diritto, che nel 1936 emigrò negli USA. In alcune conferenze, tenute a Vienna e a Praga nel 1935, Husserl rilanciò il programma fenomenologico come via di salvezza dai pericoli di disumanizzazione e irrazionalismo che incombevano sulla cultura europea: esse costituiscono l’abbozzo della sua ultima opera, incompiuta, che sarà pubblicata postuma col titolo La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1954) . Nel 1938 Husserl morì a Friburgo; i suoi numerosi manoscritti, grazie a H. L. van Breda, poterono essere salvati dalla distruzione ed essere trasferiti all’università di Lovanio, dove costituiscono il fondo degli ‘Archivi Husserl’. A partire dal 1950 ha preso avvio, sotto il titolo di ‘Husserliana’, la pubblicazione di questi inediti: tra essi vanno ricordati i volumi secondo e terzo delle Idee (1952) , Filosofia prima (1956) e Sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo (1966) . Altri scritti sono stati pubblicati dal suo allievo L. Landgrebe ( Esperienza e giudizio del 1939) e da G. Brand ( Mondo, io e tempo del 1955).
ARITMETICA E LOGICA
La prima opera di Husserl, Filosofia dell’aritmetica (1891), é dedicato a Brentano, dal quale Husserl riprende il concetto di intenzionalità come carattere costitutivo degli atti psichici che ‘tendono’ sempre necessariamente verso il loro oggetto. Su questa base, Husserl considera la genesi del concetto di numero : esso a suo avviso deriva da un atto unitario della mente, che dirige intenzionalmente la sua attenzione su molteplicità di oggetti riuniti in ‘aggregato’ specifico (ad esempio un insieme di mele). A partire da questo, esso procede a ricavare per astrazione il concetto generale di aggregato, concepito come collegamento collettivo delle unità costitutive di una molteplicità; procedendo a contare tali unità, si arriva al concetto di numero. Husserl riconosce l’ esistenza autonoma dei numeri come forme generali, cioè come strutture rappresentative costanti del soggetto, le quali condizionano l’attività conoscitiva, ma nella misura in cui descrive tali strutture nella loro genesi e organizzazione mentale, resta ancora vincolato allo psicologismo . In seguito ad una recensione critica di Frege, apparsa nel 1894, che Husserl rimprovera di confondere ancora il piano logico con quello psicologico, e alla lettura di Bolzano, Husserl si allontano a poco a poco dallo psicologismo. Riconosce che la logica per compiere ragionamenti o deduzioni corrette, ma ha a che fare anche con il significato dei concetti e, quindi, con il loro contenuto oggettivo. Si pone dunque la necessità di affrontare il problema delle relazioni tra logica e psicologia e Husserl lo fa con lo scritto Ricerche logiche . Le leggi che descrivono i processi psicologici sono generalizzazioni che partono dall’esperienza e pertanto non hanno validità necessaria, ma sono modificabili o correggibili in base all’accertamento di fatti empirici. I princìpi logici e matematici, invece, sono necessariamente veri e la verità stessa é atemporale, cosicchè il rapporto fra premesse e conclusione nei ragionamenti non é riducibile all’accertamento empirico di relazioni di coesistenza o di successione di atti psichici. Una logica pura non é quindi fondabile su basi empirico-psicologiche, ma non può nemanco avere un carattere meramente formale; essa invece deve essere la teoria di ogni possibile tipo di ragionamento, in grado di determinare le condizioni ideali di possibilità della scienza in generale. Su questa base, Husserl analizza il concetto di significato ; egli é del parere che l’unità minima di significato sia non il termine linguistico singolarmente preso, ma la proposizione , la quale in generale enuncia che qualcosa o é o non é. La logica studia la proposizione a prescindere dal fatto che essa sia vera o falsa oppure che sia formulata verbalmente o pensata da qualcuno; sotto questo profilo, dunque, essa é pienamente indipendente dalla psicologia e non si configura come scienza del pensiero. Per proposizione però Husserl intende non i singoli enunciati, ma l’unità o l’ essenza di tutti gli enunciati con lo stesso significato. Questa essenza ha esistenza autonoma rispetto ai singoli enunciati, allo stesso modo degli universali (ad esempio la bianchezza), i quali non sono entità singole, ma l’insieme o l’essenza di una molteplicità di cose singole (in questo caso le singole cose bianche). Di queste essenze, secondo Husserl, abbiamo un’esperienza autoevidente, caratterizzata da una certezza superiore a ogni certezza data dalle scienze empiriche: egli chiama questa esperienza intuizione categoriale, per distinguerla dalla semplice intuizione empirica, che carpisce solamente oggetti individuali. La logica pura consiste nella descrizione di queste essenze, che sono alla base di ogni tipo di indagine e scienza: si tratta di un’analisi fenomenologica, che mostra come le leggi logiche appaiono ed operano nel vissuto (in tedesco Erlebnis ) concreto della conoscenza. Partendo dalla considerazione dell’oggetto intenzionale dei vari atti psichici, essa descrive come tali leggi, indipendenti dall’esperienza, si realizzano soggettivamente in riferimento agli oggetti, che sono intenzionali negli atti conoscitivi.
LA FENOMENOLOGIA
Per Husserl l’ideale della vera filosofia consiste nel realizzare l’idea della conoscenza assoluta, basandosi su un fondamento certo, e la fenomenologia é il metodo che permette di raggiungere questo obiettivo. Questo programma Husserl lo delinea e lo svolge negli scritti successivi alle Ricerche logiche , nella Filosofia come scienza rigorosa e, specialmente, nelle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica . Per costituirsi come scienza rigorosa, la filosofia non deve assumere nulla come ovvio e indiscutibile, ma deve raggiungere criticamente un fondamento dotato di evidenza assoluta. A questo scopo, essa non può partire dall’ atteggiamento naturale , che assume il mondo come un insieme di fatti ovvi: le stesse scienze empiriche si fondano su questo presupposto e identificano la conoscenza con l’accertamento dei fatti ritenuti oggettivi e indiscutibili. La scienza, secondo Husserl, analizza il mondo in maniera ingenua, accettandolo acriticamente come esistente e limitandosi ad accumulare sapere su sapere. Ma l’esperienza delle cose é variabile e cangevole e, dunque, non può garantire l’ oggettività e la validità della conoscenza, cosicchè le scienze della natura non possono propriamente risolvere i problemi di una teoria della conoscenza. Dunque Husserl può affermare, nella Filosofia come scienza rigorosa , che ‘ ogni scienza della natura é ingenua nei suoi punti di partenza: la natura che essa vuole prendere in esame, per essa esiste semplicemente ‘ . Bisogna invece liberarsi da ogni presupposto, sia dalle credenze comuni, sia da quelle proprie di tali scienze, così come dai contenuti dottrinali di tutte le filosofie precedenti. A questo provvede quella che Husserl definisce, con un termine mutuato dallo scetticismo antico, epochè , che letteralmente vuol dire ‘sospensione del giudizio’ . L’ epochè consiste nel mettere tra parentesi l’atteggiamento naturale e tutto quel ch’esso comporta: ad esempio, l’assunzione dell’esistenza del mondo o la distinzione di soggetto e oggetto quali dati ovvi. Essa però non ha un compito meramente distruttivo nei confronti delle credenze o dei pregiudizi diffusi e, in questo senso, non coincide con il dubbio scettico. La sua finalità é invece costruttiva ed é correlata all’assunzione di un atteggiamento fenomenologico che raggiunge la consapevolezza che la conoscenza di questi dati, che appaiono ovvi all’ atteggiamento naturale, é possibile solamente in riferimento alla soggettività. ‘ Io non nego questo mondo, quasi fossi un sofista, non revoco in dubbio il suo esserci, quasi fossi uno scettico, ma esercito in senso proprio l’epochè fenomenologica, cioè: io non assumo il mondo che mi é costantemente già dato in quanto essente, come faccio, direttamente, nella vita pratico-naturale ma anche nelle scienze positive, come un mondo preliminarmente assente e, in definitiva, come un mondo che non é un terreno universale d’essere per una conoscenza che procede attraverso l’esperienza e il pensiero. Io non attuo più alcuna esperienza del reale in un senso ingenuo e diretto ‘ ( Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica libro I, sez. II, cap. I, § 32) . Sospendendo l’affermazione della realtà del mondo, il mondo stesso diviene un insieme di fenomeni che si danno alla coscienza e ai quali la coscienza si rapporta come ad oggetti che essa intenziona nei propri atti. Si tratta di apprendere a guardare le cose nel loro costituirsi come fenomeni in relazione agli atti di rappresentazione, di percezione, di ricordo e così via, cioè in relazione alle esperienze vissute (Erlebnisse), in cui esse si danno. Si capisce allora il significato del programma di Husserl di tornare alle ‘cose stesse’ : messa tra parentesi l’esistenza del mondo come un dato ovvio, verso il quale si prova interesse, l’atteggiamento fenomenologico diviene l’atteggiamento meramente teoretico di uno spettatore disinteressato. Lo sguardo di questo spettatore però é diretto non già verso le cose empiriche nella loro accidentalità, bensì verso le essenze . L’atteggiamento fenomenologico assume come criterio di validità l’ evidenza , con la quale i contenuti intenzionali dalla coscienza si danno nella loro essenza in specifici atti intenzionali. Questo vuol dire che l’analisi fenomenologica mette tra parentesi l’oggetto naturale nella sua singolarità e opera quella che Husserl definisce riduzione eidetica (dal greco eide , ‘forme’ , ‘idee’ o ‘essenze’), che porta appunto alle essenze quali si danno nell’intuizione della coscienza. Recuperando il progetto di Cartesio, Husserl si propone dare una fondazione assoluta alla conoscenza: e ritiene di poterlo fare con la fenomenologia (che è scienza dei puri fenomeni), grazie alla quale egli dice di essere approdato in un “mondo nuovo”. Anche Cartesio era approdato in tale mondo, scoprendo la soggettività su cui poggia l’Età moderna, ponendo la realtà tra parentesi e sottoponendo a indagine il modo in cui avviene la conoscenza: solo che, alla stregua di Colombo, non s’era accorto di essere giunto in un mondo nuovo e aveva finito per intendere il “cogito” come un mero “io psicologico”. La prima mossa della fenomenologia dev’essere, secondo Husserl, la messa tra parentesi delle esistenze, ossia dell’esistenza reale di ciò che continuamente ci si dà alla coscienza. Messe le esistenze “sotto indice di questionabilità”, si studiano i puri fenomeni di coscienza, a prescindere dalla loro reale esistenza: la coscienza è sempre una “coscienza di”, è cioè caratterizzata da intenzionalità: si tratta appunto di studiare tutto ciò a cui tende la nostra coscienza: le essenze o, come Husserl ama esprimersi, le “singolarità eidetiche”. Portiamo un esempio concreto del metodo fenomenologico: vedo di fronte a me un tavolo; in opposizione al procedere della scienza, metto tra parentesi l’esistenza reale del tavolo (che, come giustamente notava Cartesio, non è certa), e lavoro sull’essenza del tavolo (infatti, sul fatto che io stia percependo un tavolo non c’è dubbio). Anche Cartesio era, a suo modo, giunto fin qui: solo che, troppo affrettatamente, aveva preteso di dimostrare la reale esistenza del mondo esterno, per di più passando dalla dimostrazione dell’esistenza di Dio. La fenomenologia è, come Husserl ama esprimersi, un “puro guardare” che va contro la tendenza naturale (e in questo senso essa è un atteggiamento “innaturale”) a concepire le cose come esistenti: posso (e devo) dubitare che il tavolo esista, ma non posso dubitare del fatto che lo sto vedendo. Proprio la percezione così intesa (che Cartesio aveva chiamato “clara et distinta perceptio”) è quello che Husserl chiama il “principio dei principi” della fenomenologia. Il programma di Husserl di fondazione della conoscenza non può però arretrarsi alla riduzione eidetica: le essenze infatti sono i correlati intenzionali degli atti della coscienza, i quali possono, a loro volta, essere fatti oggetti di riflessione. La riflessione é una proprietà fondamentale del vissuto: grazie ad essa ogni Erlebnis (vissuto) é coglibile e analizzabile. In altre parole si può dirigere uno sguardo riflessivo sugli atti stessi della coscienza e del pensiero: in questo modo, essi diventano oggetti di quella che Husserl definisce percezione immanente , la quale é fornita di evidenza assoluta. Si può infatti sospendere il giudizio sull’esistenza del mondo, ma é evidente che esso appare alla coscienza: non posso sospendere il giudizio sul fatto che io sto pensando. Questo vuol dire che, mentre il mondo naturale e le cose che gli appartengono possono essere o non essere, la percezione immanente garantisce necessariamente l’esistenza del suo oggetto, cioè del vissuto intenzionale della coscienza. La coscienza é dunque il risultato ultimo e indubitabile della riduzione, non ulteriormente riducibile ad altro: Husserl la chiama residuo fenomenologico . Non si tratta però della coscienza empirica dei singoli individui: anche questa, infatti, é sottoponibile ad una riduzione, che la liberi dai suoi caratteri meramente empirici. Il residuo fenomenologico é invece la coscienza pura o trascendentale , che non necessita di altre condizioni antecedenti per esistere: tutto é neutralizzabile e riducibile a riduzione, il mondo e Dio, le scienze e la teologia, ad eccezione dell’io puro, che però non é una sostanza ma é la funzione originaria e universale della coscienza che costituisce il mondo. Rispetto ad essa, il mondo naturale é trascendente, ma esiste e ha senso solo tramite gli atti della coscienza: quest’ultima infatti é intenzionalità, cioè é sempre coscienza di qualcosa. La nozione di intenzionalità della coscienza consente dunque a Husserl di tenersi alla larga dalle forme di naturalismo e positivismo, per le quali la scienza basata su dati oggettivi, indipendenti dalla coscienza, rappresenta il modello della conoscenza, sia dalle forme di spiritualismo, che, ravvisando nella pura introspezione la via di accesso privilegiata agli atti della coscienza, smarriscono appunto il carattere intenzionale della coscienza, garante dell’oggettività della conoscenza stessa. Husserl definisce la fenomenologia come eidetica , cioè ‘scienza di essenze’: a differenza dei fatti empirici, esistenti nello spazio e nel tempo, che possono essere diversi da come sono, le essenze sono necessarie ed universali. Ed é per questo motivo che spesso gli interpreti hanno di vero e proprio ‘platonismo di Husserl’ . Ogni scienza empirica racchiude anche conoscenze eidetiche, ma solo la fenomenologia, al pari della logica e della matematica pura, é esente da dati di fatto e riguarda anche essenze. Esse rappresentano le strutture a priori, costanti e generali, dell’esperienza, le quali hanno per correlato il mondo come insieme degli oggetti di un’esperienza possibile. Il mondo e la realtà hanno senso solo se riferiti alla coscienza, la quale ha appunto la proprietà di conferire senso ad essi. Ogni vissuto intenzionale é costituito da un aspetto soggettivo, chiamato noesi (che letteralmente vuol dire ‘l’operazione del pensare’), cioè dall’atto intenzionale che conferisce senso (il percepire, il ricordare, il desiderare, ecc.) e da un aspetto oggettivo, chiamato noema (che letteralmente vuol dire ‘ciò che é pensato’), cioè il percepito, il ricordato, il desiderato, ecc. Nel noema é dato il mondo intenzionato dalla coscienza nelle sue differenziazioni regionali, cioè nei diversi modi di essere in cui le cose si danno alla coscienza. In base a queste differenziazioni si costituiscono le cosiddette ontologie regionali , dove per regione si intende ‘ la complessiva e superiore unità di generi pertinenti a un concreto ‘ . A ciascuna ontologia regionale appartengono dunque specifiche essenze regionali: in virtù di esse si può ricavare la costituzione fondamentale di ogni conoscenza possibile e il fondamento ontologico di tutte le scienze empiriche. La fenomenologia però é diversa dall’ontologia classica, la quale assume le unità, di cui essa si occupa, nella loro identità, come se si trattasse di qualcosa di fisso e definito; la fenomenologia invece assume le varie unità, cioè le essenze, nel flusso che le correla al vissuto della coscienza ed é finalizzata a stabilire non una dottrina delle varie realtà, ma della costituzione delle realtà oggettive a partire dalla coscienza dell’io puro. Husserl dedica alla trattazione di queste tematiche la terza parte delle Idee , pubblicata postuma. Nella seconda parte, anch’essa pubblicata dopo la morte del pensatore ebreo, Husserl fornisce un’analisi fenomenologica dei modi in cui si costituiscono i tre strati della realtà mondana. Il primo é quello delle cose materiali , cioè il campo delle realtà trascendenti spaziotemporali, oggetto della percezione e delle scienze naturali e rette dalla pura causalità. Il secondo strato é quello del corpo proprio , cioè della totalità liberamente mobile degli organi di senso, e delle nature animali, soggette a condizionamenti e oggetto della somatologia, alla quale scorrettamente é collegata la psicologia, dal momento che non ha senso per Husserl parlare di parallelismo psico-fisico. Il mondo che sta di fronte al soggetto dipende per Husserl dal corpo proprio e dalle peculiarità della psiche. E proprio il terzo strato é costituito dalla psiche , uno strato caratterizzato dalla storicità, in quanto flusso di Erlebnisse collegati tra loro e copn il corpo proprio: a partire dalla psiche, si costituisce il vero, che non trasuda negli Erlebnisse. L’io però per Husserl richiede il tu, il noi, l’altro, il mondo: su questa base poggia il mondo spirituale, in cui la persona, nell’associazione con le altre persone, è centro di un mondo circostante che si configura come orizzonte aperto ai dati oggettivi naturali e sociali che possono offrirsi. La vita spirituale ha la sua legge fondamentale nella motivazione, cosicchè in tale mondo l’io si configura come io libero: questo conferisce al mondo spirituale un primato ontologico su quello meramente naturale.
L’IO E IL MONDO DELLA VITA
Husserl sapeva bene che la sua esigenza di un nuovo, radicale inizio e di una nuova, radicale fondazione della conoscenza presentava analogie con il programma perseguito tre secoli addietro da Cartesio. Proprio su questo punto Husserl ritorna nelle Meditazioni cartesiane : Cartesio ha inaugurato una filosofia di specie nuova, il passaggio dall’oggettività ovvia e spontanea al soggettivismo trascendentale, e su questa linea si colloca pure la fenomenologia. Anche oggi infatti é andato perduto, a parere di Husserl, il senso dell’unità della scienza a causa della carenza di chiarezza sui princìpi di essa e i filosofi non collaborano più in vista di questo fine, cosicchè bisogna rievocare in vita il radicalismo di Cartesio. La scienza é in cerca di verità valide per tutti, ma non può pretendere ad alcuna validità definitiva se manca l’ evidenza assolutamente certa, scevra di ogni dubbio, del suo fondamento. Questa non é ricercabile nel mondo quale appare all’esperienza comune e alle stesse scienze naturali, perchè, come aveva dimostrato Cartesio, quel mondo potrebbe essere solo un sogno o una serie di immagini virtuali inviate al nostro cervello da un genio maligno. Mettendo il mondo tra parentesi, però, io raggiungo non un puro nulla, ma me stesso come io puro o coscienza pura, in cui e per cui l’intero mondo oggettivo é per me. Infatti io possiedo, in quanto io, un mondo continuativo che é ‘per me’ ed io stesso sono dato a me stesso in un’esperienza evidente. Il tempo , come coesistenza e successione dei momenti di vita, é la forma universale che sta alla base di ogni genesi dell’io. Affiora qui l’evidenza apodittica dell’io sono, erroneamente trasformato da Cartesio in una sostanza pensante: si tratta invece dell’ io o ego trascendentale , che é indisgiungibile dalle sue esperienze vissute, é il polo identico dei momenti di vita della coscienza e l’universo delle possibili forme che essi possono assumere. Questa é l’evidenza originaria: e Husserl dice che ‘ non ha senso voler cogliere l’universo dell’essere vero come qualcosa che stia al di fuori dell’universo della cosa possibile ‘ . Il mondo e le cose assumono un significato e un senso solo attraverso l’io, cosicchè si può affermare che la soggettività trascendentale é ‘ l’universo della possibilità di senso ‘ . La fenomenologia, avendo il suo fondamento nell’evidenza dell’io trascendentale, é definita da Husserl come idealismo trascendentale , differente dall’idealismo psicologico alla Berkeley , ma anche da quello kantiano, il quale persevera nel mantenere un mondo di cose in sè come concetto limite. A differenza dell’idealismo tradizionale, quello trascendentale non nega l’esistenza del mondo, ma ha come unico fine il chiarimento del senso di questo mondo . Su questa base, Husserl può asserire che la filosofia può solo rivelare il senso del mondo, non mutarlo. Il rischio del primato accordato all’io può consistere in una forma di solipsismo, che rinchiuda il soggetto in se stesso e lo renda irraggiungibile agli altri e incapace di accedere lui ad essi. Sempre nelle Meditazioni cartesiane Husserl si prende la briga di mostrare che l’ intersoggettività é costitutiva della soggettività trascendentale; per il pensatore ebreo, infatti, io originariamente ho esperienza del mondo come intersoggettivo, cioè come ‘ un mondo che é per tutti ed i cui oggetti sono disponibili a tutti ‘. Entro questa sfera comune io tento di delimitare la sfera specifica di quel che é ‘mio proprio’, ma questo presuppone il concetto di ‘altro’. In questo modo, si dirada l’apparenza di solipsismo, pur continuando a valere il principoio secondo cui tutto quel che é per me, compresi gli altri soggetti, possono attingere il loro senso esclusivamente dalla mia sfera di coscienza. Le filosofie della vita, e anche filosofi che facevano proprio il metodo fenomenologico (Scheler ed Heidegger), biasimavano Husserl per un eccesso di intellettualismo, per un’insistenza unilaterale sul problema della conoscenza e, quindi, per l’incapacità di pervenire alla soggettività pratica e attiva e di affrontare i problemi dell’esistenza. Contro queste critiche Husserl rivendic, nella Postilla alle Idee (1930), il carattere universale della fenomenologia, avente un metodo in grado di far fronte a tutti i problemi della filosofia e, per questa strada, anche a ‘ tutte le domande che l’uomo concreto può porre ‘ . Forse proprio in risposta a queste accuse di distrattezza e alla nozione di essere-nel-mondo di Heidegger, Husserl pone al centro della propria riflessione, negli ultimi anni di vita, il concetto di mondo-della-vita , che svolge una mansione di primo piano nell’opera intitolata La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (pubblicata postuma). Le scienze contemporanee, nonostante i loro evidenti successi, sono tormentate da paradossi e da problemi di fondazioni e attraversano una crisi profonda, espressione della crisi radicale della vita dell’umanità europea. In discussione é non tanto il valore delle conoscenze specifiche conseguite dalle singole scienze, quanto il significato che la scienza nel suo complesso ha e può avere per l’umanità. Alla base della crisi c’é la riduzione dell’idea della scienza a scienza di fatti, la quale prescinde da qualunque riferimento al soggetto che effettua l’indagine scientifica. Questo vale anche per le cosiddette scienze dello spirito, in cui l’avalutatività, in quanto salvaguardia da giudizi arbitrari meramente soggettivi, diviene l’ideale da perseguire. Escludendo in linea di principio i problemi del senso dell’esistenza e del mondo in generale, la scienza finisce con l’estraniarsi dagli uomini; ne consegue per Husserl che ‘ le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto ‘ . L’origine della crisi di oggigiorno delle scienze va scorta per Husserl nella crisi dell’idea di filosofia, come scienza onnicomprensiva della totalità dell’essere, di cui le singole scienze costituiscono ramificazioni specifiche. L’umanità europea si era costituita come autonoma grazie a questa concezione della filosofia, affiorata nel Rinascimento, la quale tendeva a dare alla vita regole basate sulla ragione, al fine di rendere liberi. A partire da Settecento, la possibilità di una metafisica era divenuta problematica ed era franata la fede in una filosofia universale in grado di guidare l’uomo e, quindi, la fede in una ragione che fosse capace di dare un senso alla totalità della natura e della storia. Per capire la crisi che investe il presente, per Husserl, si deve riconsiderare la storia dell’umanità, rendendosi conto che le battaglie spirituali dell’umanità europea sono lotte tra filosofie: ‘ le uniche battaglie davvero significative del nostro tempo sono battaglie tra un’umanità che é già franata in se stessa e un’umanità che é ancora radicata su un terreno, e che lotta proprio per questo inserimento o per uno nuovo. Le vere battaglie spirituali dell’umanità europea sono lotte tra filosofie, cioè tra le filosofie scettiche- o meglio tra le non filosofie, che hanno mantenuto il nome ma che hanno smarrito la coscienza dei loro compiti- e le vere filosofie, quelle ancora vive ‘ ( La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale parte I, § § 6-7). Grazie a questa riconsiderazione storica ci si può rendere conto che ‘il senso dell’umanità’ autentica consiste in una umanità ‘ fondata sulla ragione filosofica e sulla coscienza di non poterlo essere che così ‘ . Questa nuova nozione di umanità fa la sua comparsa, stando a Husserl, in Grecia con la nascita della filosofia come attività teoretica puramente disinteressata e condotta dalla ragione, volta ad un sapere universale dotato di fondamento assoluto. Si é originato in questo modo un §telos , un fine, consistente nella realizzazione di un’umanità pienamente razionale: questo fine, al tempo stesso, é un compito infinito, che ha i suoi funzionari e garanti nei filosofi, responsabili per il vero essere dell’umanità. Per uscire dalla crisi imperante nel presente bisogna dunque recuperare il senso originario di questo ‘fine’, proseguendo l’eredità trasmessa dai primi filosofi greci, la quale é scivolata nei meandri dell’oblìo, originando la crisi delle scienze stesse: questo é possibile solo tramite la filosofia fenomenologica, in grado di volgere uno sguardo pienamente disinteressato verso le cose stesse e, quindi, di ravvisare nella soggettività trascendentale il fondamento di ogni sapere possibile; il liberare l’umanità dalla crisi é compito dei filosofi: ‘ L’umanità in generale é per essenza un essere uomini entro organismi umani generativamente e socialmente connessi, e se l’uomo é un essere razionale, lo é solo se tutta la sua umanità é un’umanità razionale […] Noi siamo riusciti a comprendere, anche se solo nelle linee più generali, come il filosofare umano e i suoi risultati non abbia affatto il significato puramente privato o comunque limitato di uno scopo culturale. Noi siamo dunque- e come potremmo dimenticarlo?-, nel nostro filosofare, funzionari dell’umanità […] E’ chiaro (e che cosa altrimenti ci potrebbe aiutare?) che occorrono esaurienti considerazioni storiche e critiche per giungere, prima di qualsiasi decisione, a un’autocomprensione radicale, che occorre indagare su ciò che originariamente si perseguiva con la filosofia, ciò che tutte le filosofie e tutti i filosofi, storicamente intercomunicanti, hanno perseguito; e tutto questo attraverso una considerazione critica di ciò che nella propria finalità e nel proprio metodo rivela quell’aderenza ultima e autentica alla propria origine che, penetrata, lega a sè apoditticamente la volontà ‘ . Per Husserl, la crisi delle scienze incomincia già con Galileo e con la sua idea della matematizzazione della natura, che ha portato a considerare la natura stessa come un mondo di corpi realmente circoscritto in sè e, quindi, a far proprio l’atteggiamento naturale, che assume il mondo come un dato ovvio, distinto e non dipendente dal soggetto che lo conosce e grazie al quale riceve un significato. In questo modo, si prepara il dualismo cartesiano tra natura e mondo psichico, che é la premessa per la specializzazione delle varie scienze e per la costruzione di una psicologia oggettivistica. Sotto questa prospettiva, la stessa soggettività, l’anima o la mente, diviene un’entità analoga alle cose naturali, indagabile con i metodi presi a prestito dalle scienze della natura. Questo ha portato a dimenticare il fondamento che conferisce senso alle stesse operazioni delle scienze naturali, cioè quello che Husserl definisce il mondo-della-vita (in tedesco Labenswelt ) , cioè la vita che ha esperienza del mondo prima di qualsiasi formazione di categorie e giudizi. In questo senso, essa é prescientifica e precategoriale, ma é al tempo stesso il fondamento e la fonte delle conoscenze stesse delle scienze. Questo non vuol dire che essa fornisca i dati della sensibilità come dati ovvi a partire dai quali esse si costruiscono. Il mondo della vita é piuttosto definito da Husserl come ‘ un regno di evidenze originarie ‘ , esperite nella loro immediatezza e comuni a tutti gli uomini in quanto soggetti conoscenti. Ad esso si perviene tramite la riduzione fenomenologica, che permette di vederne il centro nella soggettività che, sia nei modi prescientifici, sia in quelli scientifici, tende a raggiungere il senso ultimo del mondo. Il primo in sè non è, dunque, l’essere del mondo nella sua ovvietà, come presumono le scienze naturali, ma la soggettività, che nelle sue forme prescientifiche pone ingenuamente l’essere del mondo e poi, nelle varie scienze, l’obiettivizza. La fenomenologia invece, in quanto riflessione da parte del soggetto conoscente su se stesso e sulla propria vita conoscitiva, può ritornare a questa fonte ultima di tutte le informazioni conoscitive e, su questa base, costruire una filosofia universale fondata in maniera pura e definitiva. Tramite la fenomenologia, la filosofia può dunque recuperare il ‘telos’, il fine, già insito nella sua origine greca, della ricerca e realizzazione di un’umanità interamente e liberamente fondata sulla ragione. Indicando nella fenomenologia la prosecuzione più adeguata dell’ideale di una libera indagine razionale, scevra di presupposti e tendente ad una validità universale, Husserl intendeva opporsi all’irrazionalismo, che ormai egli vedeva minacciare la visione spirituale e materiale dell’Europa e soprattutto della Germania e al quale le scienze, a suo parere, non erano più in grado di opporre alcun attacco. Sotto questa prospettiva, la filosofia riacquisiva il compito etico di salvaguardare il significato autentico dell’idea di umanità.
MAX SCHELER
 “I valori e i loro ordinamenti brillano non già nella «percezione interna» o nella introspezione (che ci dà solo elementi psichici), ma nello scambio vivo col mondo (sia esso psichico, fisico o altro ancora), nell’amore, nell’odio, ossia nella pienezza di quegli atti intenzionali. Ed è in ciò che è dato in questa forma che consiste il contenuto apriorico” (Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, I, II, A).
“I valori e i loro ordinamenti brillano non già nella «percezione interna» o nella introspezione (che ci dà solo elementi psichici), ma nello scambio vivo col mondo (sia esso psichico, fisico o altro ancora), nell’amore, nell’odio, ossia nella pienezza di quegli atti intenzionali. Ed è in ciò che è dato in questa forma che consiste il contenuto apriorico” (Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, I, II, A).
Il metodo fenomenologico inaugurato da Edmund Husserl incise molto sulla filosofia tedesca della prima fase del Novecento: in particolare, si avvertiva l’esigenza di estendere l’applicazione del metodo fenomenologico anche ad altri ambiti dell’esperienza umana oltre a quello della conoscenza, in particolare alla vita emotiva e all’etica. E proprio di questo ambito si interessò Scheler. Max Scheler nacque a Monaco nel 1874, da padre protestante e da madre ebrea; per ben due volte si convertì al cattolicesimo e altrettante volte se ne discostò. Nel 1911 fu a Gottinga, dove insegnava Husserl, e nel 1912 dimorò a Berlino, dove legò amicizia con lo storico del capitalismo Werner Sombart. In quello stesso anno pubblicò un saggio Sul risentimento e l’anno successivo la prima parte della sua opera Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori . Al termine della guerra, nel 1919, divenne professore di filosofia all’università di Colonia. Negli ultimi anni della sua vita, terminata nel 1928, Scheler compose numerosi scritti: Essenza e forme della simpatia (1923), Problemi di una sociologia del sapere (1924), Le forme del sapere e la società (1926), La posizione dell’uomo nel cosmo (1927). Scheler è convinto, con Husserl, del carattere intenzionale della coscienza umana (la coscienza umana è sempre coscienza di qualche cosa: non c’è coscienza senza oggetto): con Husserl concorda anche nel sostenere che gli atti intenzionali della coscienza sono sottoponibili ad un’analisi fenomenologia che riguardi le loro essenze, e nell’ammettere l’irriducibilità reciproca degli atti intenzionali (da ciò scaturisce l’autonomia dell’etica rispetto alla logica). Scheler era convinto che il neokantismo della Scuola di Marburgo, trascurando l’esperienza vissuta, non fosse in grado di cogliere la peculiarità della vita spirituale e culturale dell’uomo. Per Scheler anche la sfera dei sentimenti, non solo quella conoscitiva, è caratterizzata dall’ intenzionalità . Quello del sentimento costituisce un ambitoautonomo dal conoscere, in quanto è dotato di contenuti originari propri, dati a priori e non derivati dalle conoscenze di dati di fatto. Gli atti del sentimento sono infatti correlati intenzionalmente ai valori, che sono qualità inerenti alle cose e sono oggetto di un’intenzionalità conoscitiva, distinta dalle forme di conoscenza proprie della percezione o dell’intelletto: si tratta dell’ intuizione emozionale, dotata di un’evidenza, che non è minore dell’evidenza che gli atti del percepire o del ricordare e così via hanno dei loro oggetti. I valori costituiscono dunque un mondo oggettivo caratterizzato da proprie leggi a priori che è compito dell’etica mettere in luce e descrivere. Con queste considerazioni Scheler poneva fine al primato del problema della conoscenza sostenuto da alcuni neokantiani e, in qualche modo, ancora condiviso da Husserl. Al problema della fondazione dell’etica, Scheler dedicò una delle sue opere più importanti, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori . L’obiettivo polemico di essa è costituito dal formalismo etico, proprio della teoria kantiana. Kant aveva eliminato il sentimento e le emozioni dalla vita morale ed aveva scorto il fondamento della morale in una legge universale della ragione, puramente formale e priva di contenuti, la quale comanda incondizionatamente, a prescindere da ogni esigenza di felicità. Secondo Scheler, invece, la vita morale include costitutivamente sentimenti ed emozioni: soltanto essi, infatti, ci consentono di accedere ai valori. L’etica dunque non è puramente formale ma è dotata di un proprio contenuto a priori dato dall’intuizione dei valori: in questo senso essa può essere definita come etica materiale. I valori sono oggettivi e universali e non possono essere derivati dall’esperienza che è sempre variabile e mutevole ma sono intuiti direttamente. Detto altrimenti: in rottura col kantismo, per Scheler sono possibili intuizioni a priori che siano universali e al tempo stesso materiali; sicchè i contenuti materiali dell’etica, cioè i valori, vengono ad essere il frutto di un’intuizione a priori. Se per Kant il discorso morale era universale proprio in quanto formale, in Scheler diventa universale in quanto materiale. I valori sono dunque essenze che vengono colte a priori da un sentire che nulla ha a che vedere col sapere discorsivo. Scheler distingue tra valori e beni: mentre i primi sono qualità assiologiche, i secondi sono le singole cose concrete mediante le quali vengono veicolati i valori (ad esempio: l’amicizia è un valore; l’amico è un bene). E mentre i valori sono assolutamente universali, i beni sono contingenti: se infatti l’amicizia è e resta tale, l’amico può tradire. A Kant Scheler imputa l’aver confuso indebitamente beni e valori. Il sentire intenzionale rivela inoltre l’esistenza di leggi a priori che determinano una gerarchia oggettiva tra i valori, appresa attraverso l’atto del preferire, sul quale si fondano le scelte e correlata a gradi diversi del sentimento. Scheler scrive espressamente che “il regno dei valori, tutt’intero, è sottomesso a un ordine che gli è costitutivo”. I v,alori sono più alti quanto più si allontanano dal sensibile: il che implica che, non di rado, essi comportino sacrificio e rinuncia ai valori utilitari e sensoriali (nell’avversione all’eudemonismo Scheler può concordare con Kant, e anzi si rivela ancora più radicale rispetto a lui rigettando il valore della felicità, poiché troppo imparentata col sensibile). Esaminiamo in concreto la gerarchia dei valori: 1) i sentimenti sensibili o della sensazione, a cui sono correlati i valori sensibili compresi nella gamma tra gradevole e sgradevole; 2) i sentimenti corporei, legati allo stato del corpo, correlati ai valori del nobile e del volgare, dell’utile e del dannoso, su cui si fonda anche la vita associata, e i sentimenti vitali, legati alle funzioni del corpo, ai quali sono correlati i valori vitali come la generosità, il coraggio e così via; 3) i sentimenti legati all’anima o all’io, a cui sono correlati i valori spirituali e conoscitivi del vero e del falso, del bello e del brutto, del giusto e dell’ingiusto; 4) i sentimenti propri della persona ai quali sono correlati i valori religiosi del sacro. Questi sono i valori più alti e appaiono soltanto “in oggetti dati intenzionalmente come oggetti assoluti”: si tratta quindi di valori assoluti intuibili soltanto attraverso un atto di amore. Gli atti di amore hanno infatti la prerogativa, stando a Scheler, di essere intenzionalmente diretti sempre verso persone, e la persona si colloca ad un livello superiore rispetto all’io ed è legata alla sfera del sacro; in questa sfera il valore è fondamentalmente personale. La gerarchia dei valori è disposta secondo strati che vanno dal livello corporeo a quello spiritualmente più puro della persona. Su questa base Scheler può criticare Husserl per aver posto al vertice l’io trascendentale che è una funzione universale puramente conoscitiva e impersonale: ciò significa, per Scheler, non riconoscere il primato della persona, ridotta a pura esemplificazione empirica di questa funzione conoscitiva universale. La vita morale consiste, invece, nella piena realizzazione della persona umana e, quindi, include costitutivamente sentimenti ed emozioni, in particolare la simpatia e l’amore. La persona è, per usare le parole di Scheler, “l’unità immediata del vivere per l’esperienza vissuta”: è, detto altrimenti, una “unità immediata covissuta”, ossia un’immediatezza unitaria avvertita tramite le molteplici esperienze che il soggetto vive rapportandosi agli altri. Anche nella definizione del concetto di persona, Scheler si oppone a Kant, per il quale la persona era riducibile all’Io ed era contraddistinta da una totale aseità trascendentale. Per Scheler, al contrario, il concetto di persona dev’essere distinto da quello di anima, la quale implica il dualismo anima/corpo: la persona è una “unità bio-psichica”, dice Scheler, ma poi finisce inavvertitamente per far prevalere il momento spirituale su quello fisico. Essendo essenzialmente attività, la persona è soprattutto spiritualità: e tra le varie persone sussistono differenze irriducibili le une alle altre. Ogni persona ha il suo destino, il suo carattere, i suoi compiti. Scheler precisa però che “lo spirito è impotente”, da solo non può creare alcunché: deve penetrare la dimensione fisica e dominarla secondo la gerarchia dei valori. Perché ciò possa avvenire, occorre appoggiarsi alla collaborazione delle altre persone, alla luce del fatto che sussiste un’ineludibile comunanza spirituale tra gli uomini. Sicché l’azione morale è tanto più facile quanto più si avverte tale comunanza e c’è immedesimazione (Einfühlung): tale immedesimazione simpatetica implica un “sentire dentro” e, al contempo, un “sentire insieme”. La persona, come abbiamo visto, è l’uomo nella sua totalità ed individualità, nell’unità di tutti i suoi atti ed ha per correlato costitutivo il mondo e la partecipazione emotiva alla vita delle altre persone: in questo consiste propriamente la simpatia. La simpatia è un fenomeno originario, una funzione innata, grazie alla quale si va oltre se stessi e si riconosce l’altro a partire da una partecipazione affettiva. La partecipazione affettiva può assumere vari aspetti, che vanno dal contagio o fusione emotiva all’identificazione o all’immedesimazione: sull’immedesimazione intenzionale e cosciente si fonda la simpatia. La simpatia, tuttavia, non deve essere confusa con l’amore, che rappresenta un momento più avanzato: la simpatia, infatti, è meramente reattiva e cieca di fronte al valore dell’altro e quindi si differenzia dall’amore, che è attivo e poggia sul riconoscimento della persona altrui nella sua diversità e irripetibilità. Senza amore la persona è soltanto un animale sociale, un’entità oggettiva e sostituibile, mentre nell’amore ciascuno è veramente sé stesso e l’io diventa propriamente persona. Essere persona comporta l’essere aperti alla totalità delle cose e delle persone reali e possibili: in questo senso l’amore è sempre amore della persona in quanto incarna un valore anche quando essa lo nega. Ogni persona ha come correlato un mondo proprio che non coincide con l’idea di un mondo unico e identico: questo rinvia all’idea di una persona infinita e perfetta, della quale è a sua volta il correlato. Nel riconoscersi come entità finita e nell’aprirsi alle altre persone l’uomo ritrova il proprio fondamento in questa persona infinita e assoluta, ossia in Dio, concepito come il luogo dei valori. In tal modo l’etica di Scheler trova il proprio compimento in una forma di teismo, fondato sul riconoscimento di Dio come persona, oggetto di amore da parte degli uomini. In L’eterno nell’uomo (1921), composto da Scheler quando era vicino al cattolicesimo, l’esperienza religiosa è vista come il luogo in cui si rivela il divino, cioè la persona di Dio nella sua sacralità. Solo nel cristianesimo, secondo Scheler, ha fatto la sua comparsa l’amore della persona spirituale di tutti i propri simili in Dio, ma il mondo moderno ha dimenticato e nascosto la simpatia e l’amore. Scheler riprende da Nietzsche il concetto di risentimento , ma, a differenza del folgorante profeta del superuomo, lo considera il contrassegno non della morale cristiana, bensì delle morali moderne: è il risentimento infatti che porta a ritenere la natura soltanto come un ambito da dominare e gli altri uomini soltanto come strumenti o addirittura ostacoli in vista del raggiungimento del benessere economico. L’invidia, matrice del risentimento, genera lo spirito di concorrenza, che è alla base dell’economia moderna e del mondo borghese. Come rimedio alla lotta e alla competizione, la morale borghese ha elaborato, in sostituzione dell’amore cristiano, l’umanitarismo, che però isola l’umanità da Dio, riguarda soltanto i contemporanei e continua a fondarsi, in ultima analisi, sul risentimento stesso. A questa situazione storica e sociale corrisponde una precisa teoria della conoscenza che privilegia la materia rispetto alla vita e allo spirito e adotta come modelli di spiegazione della natura e dello stesso mondo spirituale il meccanicismo e l’evoluzionismo. Il presupposto di queste considerazioni di Scheler è che le teorie della conoscenza sono espressioni delle trasformazioni sociali, culturali, politiche ed economiche di un’epoca; su questa base egli elaborò una sociologia della conoscenza alla quale dedica molte indagini nei suoi ultimi anni. Per un verso, essa richiama la teoria marxista secondo la quale le produzioni ideologiche e intellettuali dipendono, anche per via mediata, dalla struttura economica, ma per un altro se ne allontana in quanto, sulla scia di Weber, riconosce il peso determinante del fattore religioso nella formazione dello spirito del capitalismo e più in generale la funzione che le trasformazioni dei sentimenti e delle preferenze emozionali per i valori svolgono nei mutamenti sociali. Gli eventi storici nascono infatti dall’incontro e dallo scontro tra fattori ideali, cioè tra le forze della creatività artistica, filosofica e religiosa, e fattori reali, cioè gli interessi economici e politici: i primi sono propri della sfera spirituale della persona umana, mentre i secondi rientrano nelle potenze biologiche e vitali. Contrariamente a Karl Marx, Scheler ritiene che il proletariato non sia la forza destinata ad abbattere il capitalismo , dal momento che esso condivide gli stessi valori materialistici, propri della mentalità borghese. Durante il conflitto mondiale, pur indicando nella guerra lo strumento capace di rivitalizzare la nazione e quindi di contribuire al suo miglioramento morale, Scheler aveva invitato a sostituire l’idea della comunità cristiana, fondata sull’amore, alla società borghese capitalistica. Nel saggio Socialismo profetico o socialismo marxista? (1919), egli auspicava una forma di socialismo cristiano , capace di superare sia l’individualismo, sia il collettivismo. In questa prospettiva il lavoro veniva interpretato non solo come castigo inflitto da Dio all’uomo a causa del peccato originale, ma anche come un mezzo con il quale l’uomo stesso collabora alla creatività divina. Nell’ultima fase della sua attività, dopo essersi di nuovo allontanato dal cattolicesimo, Scheler elaborerà, soprattutto in La posizione dell’uomo nel cosmo, una specie di antropologia dualistica, fondata sulla polarità fra spirito e impulso irrazionale e concepirà una forma di panteismo dinamico, in cui il cosmo è interpretato come la divinità stessa che aspira progressivamente a diventare la divinità. Con la sua concezione dei valori, Scheler ha inoltre dato l’abbrivio all’antropologia filosofica: egli infatti chiarisce come la tavola dei valori abbia una precisa data di nascita e resti costantemente legata allo sviluppo storico. Dapprima i valori più alti erano quelli vitali e utilitari, poi, poco alla volta, la gerarchia è andata sempre più raffinandosi, in uno sviluppo che però Scheler non considera come lineare e irenico.
NICOLAI HARTMANN

La vita di Nicolai Hartmann fu interamente consacrata all’insegnamento; nato a Riga nel 1882, fu professore nelle università di Marburgo, Colonia, Berlino e Göttingen; morì a Gottinga nel 1950. Di impostazione fenomenologica, fu autore di numerosissime opere, tra le quali vanno ricordate, senz’ombra di dubbio, Princìpi di una metafisica della conoscenza (1921), Etica (1926), Filosofia sistematica (1931), Il problema dell’essere spirituale (1933), La fondazione dell’ontologia (1935), Possibilità e realtà (1938) e La struttura del mondo reale (1940). La formazione di Hartmann avvenne nell’ambito della Scuola di Marburgo di Cohen e Natorp, ma successivamente si accostò alla fenomenologia di Husserl, da lui intesa come un correttivo all’idealismo logico dei suoi primi maestri. Egli, però, ritenne che la fenomenologia fosse solamente il primo stadio della ricerca filosofica, la fenomenologia, infatti, descrive fedelmente i fenomeni intenzionali della coscienza, ma si arresta ad essi, senza andare avanti, credendo di aver in questo modo raggiunto l’essenza delle cose. Allo sguardo disinteressato tipico della fenomenologia sfuggono così i problemi presenti nei fenomeni, cioè di qualcosa che in essi rimane incompreso: questi problemi diventano oggetto del secondo stadio della ricerca filosofica, che Hartmann definisce aporetica ( dal greco aporia , ‘difficoltà apparentemente senza via d’uscita’). Il terzo e ultimo stadio è dato dalla teoria , che consiste non nella soluzione delle aporie, ma nel tentativo di risolverle. Tutte queste teorie Hartmann le illustra nei Fondamenti di una metafisica della conoscenza (1921): egli sostiene che la filosofia non può prescindere da ‘ una descrizione fedele dei fenomeni ‘, deve svelare le contraddizioni interne del reale (funzione aporetica) e risolvere queste aporie (funzione della teoria). Ad avviso di Hartmann, è finito il tempo dei sistemi filosofici con pretese di definitività: la storia, infatti, sorpassa e rende superati i sistemi, che via via sono costruiti; quel che permane, invece, è il pensiero sistematico, cioè il pensiero che muove dai problemi, i quali in eterno si ripresentano nella storia, per cercarne la soluzione e, per questa strada, mira al sistema come meta ultima, non come anticipazione di soluzioni. La teoria consiste proprio in una trattazione delle aporie, basata su una concezione in grado di oltrepassare la visione ingenua e banale delle cose: il suo campo d’azione è dato dai perenni problemi metafisici . La loro perennità è data dal fatto che essi non sono mai risolubili una volta per tutte, ma si presentano però come inevitabili. Hartmann considera come grave errore il ritenere che nella scienza si debbano ammettere solamente i problemi risolubili, perchè in generale non si può mai sapere in anticipo che cosa sia risolvibile e che cosa no. I problemi metafisici nascono non solo dalla teologia o dalla cosmologia; infatti, pure le scienze positive sollevano problemi metafisici, come quelli riguardanti la validità degli assiomi matematici o dei fondamenti fisici. Nella stessa teoria della conoscenza, osserva Hartmann, che in linea di principio si ritiene che debba servire ad anticipare la metafisica, si celano in realtà caterve di questioni metafisiche. La conoscenza , infatti, ad avviso di Hartmann, non è un puro fenomeno della coscienza; la sua caratteristica è l’intenzionalità, consistente nel trascendere verso l’oggetto. Ma l’oggetto della conoscenza non è integralmente risolubile nel suo essere oggetto, cioè l’oggetto non si riduce alla sua rappresentazione, quale è data ad un soggetto conoscente. La conoscenza si configura dunque come ‘relazione trascendente’ tra soggetto e oggetto, per cui l’oggetto esiste indipendentemente dal soggetto e non è mai del tutto conoscibile. Il modo di essere dell’oggetto Hartmann lo definisce iperoggettivo : questo vuol dire che quel che esso è in sè, non è modificato dal suo entrare in rapporto col soggetto conoscente. Il cambiamento concerne solamente il soggetto, il quale, entrando in rapporto con l’oggetto, diventa rappresentazione del medesimo. L’errore dei neokantiani e di Husserl in persona, stando ad Hartmann, sta nell’aver risolto l’oggetto nella rappresentazione, nel suo darsi alla coscienza. La posizione hartmanniana porta invece ad una rivendicazione del carattere realistico della conoscenza: la conoscenza trascende verso l’oggetto, che però essa non riesce mai a governare totalmente, dal momento che rimane sempre in esso un residuo inaccessibile ed invalicabile. Sotto questo profilo, Hartmann definisce la propria posizione un’ ontologia critica , radicalmente distinta dalle vecchie ontologie, che non ammettevano questi limiti intrinseci alla conoscenza umana e l’esistenza di problemi irrisolvibili. Questi si presentano anche nella dottrina della conoscenza: di questo tipo è, ad esempio, la questione di come sia possibile confrontare la rappresentazione con l’oggetto, se l’oggetto è dato solo nella rappresentazione e quel che esso è in sè contiene sempre un residuo inaccessibile alla conoscenza. Questo, per Hartmann, rimane un enigma, che però è inevitabile, cioè si ripresenta incessantemente alla riflessione filosofica, che deve convivere con esso come con tutti i problemi metafisici. I mondo si presenta in modo evidente come una stratificazione di piani, ognuno dei quali è diverso dagli altri in base ai contenuti: natura inorganica, natura organica, piano psichico e piano spirituale. Ogni strato superiore contiene in sè forme e proprietà appartenenti a quello inferiore, ma al tempo stesso presenta forme e leggi nuove, cosicchè tra l’uno e l’altro non avviene un passaggio graduale. In questo panorama, ogni stato superiore rappresenta una soprastruttura rispetto all’inferiore, da cui è sì condizionato, ma non determinato. Così, ad esempio, il piano psichico è una soprastruttura rispetto a quello organico, in quanto in esso è abbandonata la categoria di spazio dominante a livello organico. E’ quindi sbagliato applicare categorie e modelli esplicativi, pertinenti ad un piano, ad altri piani: in questo senso, non si può parlare di meccanicismo in relazione ai fenomeni psichici o di finalismo in relazione al mondo inorganico. Lo strato più alto è dato dall’ essere spirituale , cui Hartmann attribuisce caratteristiche che fanno venire in mente lo spirito oggettivo illustrato da Hegel. Esso, infatti, non può essere confuso con la coscienza dei singoli individui, in quanto è impersonale ed universale, anche se non esiste al di fuori degli esseri finiti: esso coincide con la vita spirituale, nelle sue svariate manifestazioni storiche, artistiche, religiose, filosofiche e via discorrendo. in definitiva, l’ontologia deve giustificare l’oggettività degli enti esterni alla coscienza, cogliendo il loro fondamento nell’essere, descrivendolo nelle sue diverse sfere. Sempre a proposito dell’ontologia, Hartmann stabilisce, in Possibilità e realtà , che la realtà è possibile e necessaria nella misura in cui è ‘effettuale’: il modo fondamentale dell’essere è l’ effettualità , cioè una assoluta e necessaria capacità di determinare il reale. La stessa posizione è rinvenibile anche in ambito morale: dato che la realtà è necessaria per il fatto stesso di darsi in un modo determinato, la libertà di scelta risulta impossibile. Al di sopra della storia esistono i valori in sè , quel che nella storia nasce e decade è solo la coscienza di tali valori. Richiamandosi esplicitamente a Scheler, Hartmann definisce il bene etico come ‘ un insieme di valori che si rivelano tutti all’uomo con la pretesa di venire realizzati ‘ e, dunque, non sono oggetto di conoscenza disinteressata, ma implicano una relazione emozionale con essi. Dal momento che la coscienza non ha la conoscenza dei valori nel suo insieme, la realizzazione di essi può avvenire solo storicamente, grazie alla mediazione degli uomini. Ne consegue che ogni morale positiva, in vigore in una data società, sarà sempre e comunque necessariamente unilaterale, dato che non è possibile conoscere una volta per tutte cosa sia il bene. Il mondo dei valori è dunque un insieme di entità ontologiche ideali e indipendenti dal soggetto, che ne diventa consapevole tramite un sentimento immediato. Nella sua Etica Hartmann sostiene la necessità di fondare l’etica sullo spiritualismo oggettivo (il diritto, la moralità, l’eticità) operante nella storia, di derivazione hegeliana.
KARL JASPERS
“L’esistenza é ciò che non diventa mai oggetto, l’origine partendo dalla quale penso e agisco, quel che si rapporta a se stessa e, in ciò, alla sua trascendenza. “
Karl Jaspers nacque a Oldenburg, in Germania. Iniziò gli studi in giurisprudenza, poi li abbandonò in favore di medicina, studiò quindi a Berlino, Gottinga e Heidelberg laureandosi nel 1908. Fino al 1915 lavorò presso la clinica psichiatrica di Heidelberg grazie alla specializzazione in psicologia e psichiatria. Nel 1916 gli venne assegnata la cattedra di professore straordinario di psicologia presso l’Università di Heidelberg, nel 1921 quella di filosofia. Nel 1932, con l’avvento del nazismo, gli venne tolta la cattedra e gli venne proibito di pubblicare i suoi scritti. Nel 1945, finita la guerra, gli fu restituita la cattedra e nel 1948 si trasferì a Basilea dove svolse attività di insegnamento fino al 1961. Opere principali: Psicopatologia generale (1913); Psicologia delle visioni del mondo (1919); Filosofia (1932); Ragione ed esistenza (1935); Nietzsche (1936); La filosofia dell’esistenza (1938); La fede filosofica (1947); Sulla verità (1948); La fede filosofica davanti alla rivelazione (1970); Cifre della trascendenza (1970). La filosofia di Karl Jaspers si inserisce nel filone della riflessione esistenzialista sull’essere e ha senz’altro punti in comune con l’ontologia di Heidegger. Jaspers giunge alla filosofia dalla psicologia, e questo influenza necessariamente il modo in cui viene considerato L’essere, non un ente immutabile che risponde a rigide leggi logiche oggettive e deterministiche, ma un’ulteriorità, un qualcosa che sempre si arricchisce di significati, che si mostra, ma nel mostrarsi comunque si allontana dalla possibilità di una definizione definitiva. Jaspers nota subito come l’essere, nella forma del “Tutto che avvolge” (ovvero della totalità della manifestazione degli enti) è nominato e compreso storicamente da diverse culture: in Occidente il “Tutto che avvolge” è L’essere di Parmenide, L’apeiron di Anassimandro, il logos di Eraclito, in oriente questo concetto trova invece forma, ad esempio, nel Nirvana del buddhismo o nel Tao del taoismo. Nel corso dello sviluppo della filosofia occidentale, l’essere è diventato però simile agli enti, non è più ciò che comprende la totalità degli enti, ma è l’ente eterno e immutabile posto in posizione di privilegio rispetto agli enti terreni corruttibili (le idee di Platone, Dio stesso). La scienza moderna non si occupa dell’essere in quanto “Tutto avvolgente”, essa si rivolge solamente al meccanismo che determina il “gioco” degli enti entro il mondo, ma il “Tutto che avvolge” rimane come distante, non abbracciato nella sua totalità. Solo la filosofia può abbracciare l’essere avvolgente, ovvero abbracciare non solo il meccanismo che determina il funzionamento oggettivo della realtà (è il compito che spetta alla scienza moderna), ma anche ogni aspetto ulteriore che sfugge all’oggettività, una comprensione trasversale, spirituale ed esistenziale della totalità. L’essere, mentre “ci si rivela, mentre ci viene incontro in ogni oggetto e in ogni orizzonte”, pure “sempre indietreggia e si allontana”. L’essere sfugge a qualsiasi definizione oggettiva e definitiva, rappresenta il fondo oscuro da cui ogni ente sembra emergere inspiegabilmente e venirci incontro nella forma degli oggetti, dei concetti e di tutto ciò che il mondo esprime, sia oggettivamente che soggettivamente. Se l’essere sfugge a qualsiasi definizione oggettiva, rappresentando il fondo oscuro che sempre si affaccia alla comprensione ma sempre sfugge, l’essere stesso è Trascendenza. Ovvero, l’essere rappresenta ciò che l’uomo non può mai abbracciare totalmente, ma solo avvicinare, come alla ricerca di qualcosa che giustifichi e chiarisca lo spettacolo del mondo, ma che non potrà mai darsi alla conoscenza dell’uomo nella sua totalità. Proprio per questo, per questa “inarrivabilità”, l’essere è Trascendenza, ovvero totale “Altro” dal mondo. La Trascendenza è quindi sottoposta all’illogico, proprio perché non può essere compresa come presenza oggettiva e deterministica. Il mondo è quindi principalmente divenire, lo scaturire illogico e senza alcun senso apparente di ogni cosa dal fondo oscuro dell’essere che trascende ogni possibilità di comprensione definitiva. In questo senso, il mondo intero (il mondo dei fenomeni) è un naufragio, ovvero non un navigare certo nell’immutabile che da sempre è per la filosofia consolazione, ma un continuo essere in balia delle onde della Trascendenza, imprevedibili e non determinabili. ll naufragio è la figura filosofica che Jaspers usa per definire il senso ultimo dell’esistenza umana: l’esistenza è il divenire, ovvero il naufragio (il tentativo fallito) di concepire qualcosa di immutabile, mentre tutto è mutevole e diveniente. Il tentativo di concepire l’immutabile è certamente quel sentimento di riparo, quel rimedio, che ogni uomo cerca di instaurare per sentirsi salvo dal naufragio ultimo e supremo della morte. Al naufragio non si può sfuggire: anche se l’uomo si libera di quegli stessi apparati intellettuali che gli permettono di concepire il naufragio, ovvero si libera, nell’affermazione della sua libertà, della conoscenza scientifica e filosofico-metafisica, anche in questa condizione (e soprattutto in questa), il naufragio si ripresenta al suo culmine, poiché la negazione di ogni apparato scientifico e filosofico porta necessariamente a concepire la vita come divenire supremo, come mancanza certa di senso e immutabilità. Il naufragio è quindi “naufragio nel tempo”, “annientamento di tutte le cose e di tutte le certezze, di ogni stabilità e immutabilità”. Proprio per questo la condizione della vita dell’uomo è scacco, ovvero impossibilità di andare oltre il suo annientamento. L’uomo non può diventare assolutamente padrone di sé e della realtà, proprio perché vi è quella Trascendenza che sfugge a qualsiasi oggettivazione e ad ogni logica dalla quale scaturiscono tutti gli enti, e lo stesso uomo è un ente, non è l’essere (ovvero la Trascendenza), l’uomo è un “esserci”. L’esserci è la situazione propria dell’uomo e di ogni cosa di essere “situati” entro una determinata realtà, “situazioni come quella di dover essere sempre in una situazione, di non poter vivere senza lotta e dolore, di dover assumere inevitabilmente la propria colpa, di dover morire”. Queste situazioni sono “situazioni limite”, ovvero un muro contro cui l’uomo ed ogni cosa sbattono inevitabilmente senza possibilità di attuare un superamento, il muro della realtà, infatti, è invalicabile. Infine, per concludere, la verità dell’essere, secondo Jaspers, risiede nella stessa condizione del naufragio infinito, ovvero è proprio il naufragare certo di ogni verità e di ogni immutabilità a garantire quella libertà del divenire che è la condizione stessa di ogni cosa, ovvero la verità che rende possibile il mutamento e l’annientamento di ogni cosa, come si mostra evidente nella realtà dell’uomo e del mondo. Il naufragio non conduce al “sì” alla vita di cui parla Nietzsche: naufragare è una condizione inalterabile che non si può evitare in alcun modo. Anche nel “sì” alla vita o nel “sì” all’annientamento (che siano pronunciati da Nietzsche o da quelle forme di nichilismo che intendono affermare la nullificazione di tutto come principio rilevante) vi è una sorta di “perversione”, ovvero la volontà di voltare le spalle alla Trascendenza come possibilità aperta che “grava” sull’uomo necessariamente. Nel nichilismo, nella sua forma più radicale e non solo morale, l’uomo afferma il nulla, ma il nulla non è cosa di questo mondo, perché comunque l’uomo, naufragando, vive, e il rapporto con il naufragio non si può evitare, perché l’esistenza stessa dell’uomo è un rapportarsi necessario con il naufragio. In sostanza, anche il dire “sì” alla vita si o il vedere in essa “solamente” l’annientamento di tutto, costituisce, secondo Jaspers, pur sempre un tentativo di permanere entro la vita e negare la condizione radicale dell’esistenza, che è mutamento e divenire. Si può notare quindi come la vita dell’uomo sia “volontà di eternare”, ovvero allontanare il più possibile il naufragio, il “deperirsi” e il mutare radicale di ogni cosa. La durata e l’oggettività sono una condizione imprescindibile dall’esistenza degli uomini: in sostanza, da un lato la vita è mutare radicale, dall’altro, l’uomo non può esimersi nel dare un minimo di durata a ciò che pensa e ciò che vive, e in quest’ottica che anche il “sì” o il “no” alla vita rientrano nel percorso della durata e non del puro divenire, impossibile per l’uomo. Alla luce di quanto scritto, quale comportamento esistenziale risulta più autentico in rapporto alla necessità del divenire? L’essere si rivela solo nel naufragio dell’esserci, ovvero dell’ente, quindi anche nell’uomo. L’uomo può solo giungere al silenzio di fronte alla domanda sulle ragioni dell’essere, l’angoscia che produce in noi il sentimento del percepire l’essere solamente nel naufragio (“nel finire”) della nostra vita, trova soluzione solo nel silenzio che considera l’essere per ciò che è, senza alcuna possibilità di dire nulla e senza possibilità di trovare un’autentica soluzione a questo scacco. Tuttavia, dopo il silenzio, può anche subentrare la pace della rassegnazione, ma non un rassegnazione passiva. La rassegnazione è quella condizione di pace della coscienza che finalmente abbraccia l’essere per ciò che è, ovvero quella condizione in cui percepiamo che non vi è alcuna soluzione e mai potremmo comprendere l’oscurità dell’essere trascendente da cui tutto deriva come dal fondo di un abisso. Anche la rassegnazione e la pace sono condizioni transitorie per la coscienza inquieta dell’uomo, ma quando vi è questo stato egli è sicuramente nel rapporto più autentico con l’essere. La rassegnazione quieta e pacifica concepisce finalmente l’essere per ciò che è e non si pone alcuna domanda sul senso, vivendo l’esserci e nulla più. Alla luce di tutto questo, per Jaspers la filosofia autentica non è quella che intende matematizzare ed oggettivizzare un qualsiasi aspetto della realtà, sia fisicamente che metafisicamente, ma è la filosofia che si pone nei confronti della realtà come apertura alla possibilità dell’essere trascendente, ovvero apertura al divenire radicale e ad ogni accadimento del mondo, i quali non hanno alcun significato determinato, eterno, immutabile e prevedibile. La scienza, come funzione propria, prepara in definitiva solo la struttura oggettiva entro la quale ogni fenomeno verrà “ingabbiato” in senso deterministico. La metafisica, dal canto suo, continuerà ad indagare l’eterno come riflesso della volontà propria dell’uomo di eternare la sua vita e allontanare quanto più possibile il suo naufragio, la religione continuerà nel solco della metafisica a concepire Dio come essere immutabile nel quale si cerca la salvezza. Ma, in definitiva e come più volte ribadito, per Jaspers l’essere è pura trascendenza, ovvero il puro essere “altro” dagli enti e dalle cose, per cui mai l’uomo potrà afferrare nulla di definitivo, ogni oggettivazione dell’essere è, per contro, tentativo fallimentare e inautentico di proporre una qualche forma di anticipazione o di previsione sugli accadimenti del mondo, il quale è, radicalmente e assolutamente, puro divenire, pura imprevedibilità.
” Insensibile, né benevolo, né spietato, sottomesso a leggi rigorose o affidato al caso, il mondo non sa di sé. Non lo si può capire perché si presenta impersonalmente, se lo si riesce a chiarire in qualche particolare, resta comunque incomprensibile nella sua totalità. Ciò non toglie che io conosca il mondo anche in un altro modo. Un modo che me lo rende affine e che mi consente di sentirmi, in esso, a casa mia, al sicuro. Le sue leggi sono quelle della ragione, per cui, sistemandomi in esso, mi sento tranquillo, costruisco i miei strumenti e li conosco. Mi è familiare nelle piccole cose e in quelle che mi sono presenti, mentre mi affascina nella sua grandezza; la sua vicinanza mi disarma, la sua lontananza mi attira. Non segue i sentieri che attendo, ma anche quando mi sorprende con insospettate realizzazioni o inconcepibili fallimenti, alla fine conservo, anche nel naufragio, un’indefettibile fiducia in esso. ” (Jaspers, “Filosofia”, libro II, cap.1)
GEORGE EDWARD MOORE

“Se mi si chiede: che cosa é bene?, la mia risposta é che bene é bene e null’altro. O se mi si domanda: come si deve definire il bene? la mia risposta é che esso non si può definire, e questo é tutto quel che ho da dire sull’argomento” ( Principia ethica cap. I, §§ 6-7).
La filosofia di George Edward Moore (1873-1958) rappresenta un attacco frontale, ben più potente di quello sferrato dal pragmatismo, contro il neo-idealismo. Moore fu uno dei massimi rappresentati del realismo, a cui aveva dato l’avvio Bertrand Russell, con cui Moore fu in rapporto. Le strade percorse da Russell e da Moore ad un certo punto si divisero dato che il primo si orientò verso l’atomismo logico e il secondo realizzò un recupero della filosofia del senso comune. Essi però, coetanei e compagni di scuola a Cambridge, seguirono inizialmente lo stesso percorso, caratterizzato soprattutto dalla comune polemica contro l’idealismo di Bradley. Nel 1903 uscirono quasi contemporaneamente i loro contributi in difesa del realismo, i Princìpi di matematica di Russell e la più specifica Confutazione dell’idealismo di Moore, comparsa su ‘Mind’, la rivista che, diretta per molto tempo da Moore in persona, diventerà l’organo filosofico del realismo inglese. In La confutazione dell’idealismo Moore, avvalendosi di un metodo che prefigura quell’analisi del linguaggio a cui egli darà un importante contributo, analizza a scopo critico quello che ai suoi occhi é l’assunto fondamentale di ogni posizione idealistica: il principio di Berkeley per cui “essere é essere percepiti” ( esse est percipi ). Moore osserva che questa proposizione é estremamente ambigua, dal momento che pretende di asserire l’identità di due termini, ‘essere’ e ‘essere percepiti’, che non sono per niente identici. La loro diversità risulta evidente se si pensa alla differenza che intercorre tra il ‘giallo’ (essere) e la mia ‘sensazione del giallo’ (essere percepito): dove é chiaro che nella seconda é contenuto qualcosa che nella prima era assente, ossia l’elemento della coscienza. La confutazione del principio di Berkeley risulta ancora più evidente se si confrontano tra loro sensazioni diverse, ad esempio la ‘sensazione del blu’ e la ‘sensazione del rosso’: entrambe le sensazioni, in quanto tali, contengono un elemento comune, quello della coscienza; mentre il ‘blu’ e il ‘rosso’ non hanno nulla in comune. Dunque gli oggetti della sensazione (il ‘giallo’, il ‘blu’, il ‘rosso’) sono altra cosa rispetto alle sensazioni del giallo, del blu e del rosso che noi proviamo nella nostra coscienza. Nella Confutazione dell’idealismo Moore considera oggetto della coscienza tanto le qualità (il giallo, il blu, il rosso) quanto gli oggetti fisici (la mia mano, quel tavolo, questa casa); in un successivo saggio su La natura e la realtà degli oggetti di percezione (1905) Moore effettua una netta distinzione tra i dati sensoriali (sense-data), che ci vengono forniti dalla percezione attuale, e gli oggetti fisici tridimensionali, che non ci sono forniti da questo tipo di percezione. Ci si trova di fronte a due tipi di problemi; il primo é: che cosa dimostra l’esistenza degli oggetti fisici, cioè l’esistenza di un mondo a noi esterno? A questo quesito Moore risponde recuperando e rivalutando la dottrina del senso comune del settecentesco Thomas Reid e della Scuola scozzese in due opere di fondamentale importanza (Difesa del senso comune, del 1925, e La prova di un mondo esterno del 1939). Non abbiamo bisogno di dimostrare l’esistenza degli oggetti esterni, spiega Moore, perchè ‘sappiamo già’ che esistono: ossia, alla base della certezza dell’esistenza di un mondo esterno vi é un atto intuitivo, una conoscenza immediata e spontanea, poggiante sul senso comune. Il secondo problema che viene ora ad affiorare é invece quello di chiarire la relazione che intercorre tra i dati sensoriali e gli oggetti esterni, cioè tra quel che percepiamo immediatamente e quel che conosciamo immediatamente; come posso dire che il giallo fa parte del cavallo che mi sta di fronte? Su che fondamento si basa l’assunzione secondo la quale il bianco, il morbido, il liscio (che percepisco attualmente) sono parte della superficie della mia mano (che conosco immediatamente grazie al senso comune)? Questa relazione, secondo Moore, resta problematica dal momento che esistono difficoltà a sostenere sia che le qualità percepite siano parte della superficie della mano, sia che ne costituiscano una semplice ‘apparenza’, sia che la superficie della mano sia una sorta di termine ‘compendioso’ che raccoglie le diverse qualità della mano. Queste ultime riflessioni mettono in luce come Moore proceda con grande prudenza e cautela nella sua indagine filosofica, facendo attenzione a non introdurre affermazioni che non siano dimostrabili più che ad estendere l’ambito di quel che si può affermare. Lo strumento più adeguato per portare avanti questa indagine, con tutte le cautele che essa comporta, é l’ analisi del linguaggio ordinario , dato che proprio in esso trova l’espressione migliore quel senso comune che sta a fondamento della nostra conoscenza. Il duplice riferimento al senso comune e all’analisi del linguaggio ritorna anche nella dottrina morale di Moore, esposta nei celeberrimi Principia ethica (1903) e nell’ Etica (1912); l’obiettivo centrale dell’etica di Moore é la definizione del bene e, in maniera subordinata, la determinazione di una ‘buona’ condotta umana. Il ‘bene’ é un concetto semplice, e per questo non può essere spiegato, dato che ogni spiegazione implica una risoluzione dell’oggetto in altri termini. Il bene é paragonabile al ‘giallo’: così come non si può spiegare che cosa sia il giallo a chi non lo ha visto e, d’altra parte, chi lo ha visto non ha bisogno di spiegazione, nello stesso modo “ognuno é costantemente consapevole della nozione del bene”. La posizione di Moore può dunque essere definita come intuizionismo etico: “se mi si chiede: che cosa é bene?, la mia risposta é che bene é bene e null’altro. O se mi si domanda: come si deve definire il bene? la mia risposta é che esso non si può definire, e questo é tutto quel che ho da dire sull’argomento” ( Principia ethica cap. I, §§ 6-7). Moore si oppone pertanto alle dottrine che intendono definire il bene tramite una conoscenza di tipo fisico (cioè scientifico), oppure metafisico (cioè filosofico). In ambo i casi, si scambia il bene con un oggetto esterno, descrivibile appunto tramite gli strumenti della scienza o della filosofia; a questo errore Moore attribuisce il nome di fallacia naturalistica: con questa critica egli voleva confutare sia l’utilitarismo, che riducendo il bene al piacere ne faceva un oggetto fisico, misurabile e indagabile scientificamente, sia l’idealismo, che considerava il bene come una realtà metafisica trascendente il mondo: Platone in primis aveva parlato di un vero e proprio ‘bene in sè’. Il bene é una nozione relativa alla sfera dell’uomo e della storia. Sebbene escluda la riconduzione del bene all’oggettività fisica o metafisica, Moore é del parere che l’etica sia una disciplina oggettiva, che consente di determinare univocamente quale condotta umana può essere definita ‘buona’ e quale ‘cattiva’. Dal momento che tutti sanno che cosa é il bene, il dovere etico consiste nella sua realizzazione e, più precisamente, nella promozione del comportamento “che causerà nell’universo più bene di ogni altra possibile alternativa”. Azioni buone saranno dunque l’amore per le persone e per le cose belle: ambo queste condotte sono infatti disinteressate e quindi non solo non introducono alcuna forma di conflittualità, ma promuovono l’estendersi della compatibilità e dell’armonia tra le diverse esigenze presenti. Essendo un elemento semplice e non scomponibile (al pari del giallo), il bene non può essere soggetto a definizioni: per capire che cosa esso sia, si dovrà ricorrere alla stessa intuizione che ci fa cogliere che cosa sia il giallo. Le tante proposizioni sintetiche che usualmente formuliamo circa il bene (dicendo che esso “è il piacere” oppure che “è il giusto”) non lo colgono nella sua essenza, né hanno valore universale (che il bene sia il piacere varrà per alcuni individui, ma non per tutti): qualcosa di analogo accade allorché definiamo un “mobile giallo” o un “cavallo giallo”, senza cogliere con ciò che cosa sia il giallo. Come abbiamo visto, l’indebita operazione con cui si congiunge il bene con una proprietà estrinseca che lo definisca (ad esempio, “il bene è il piacere”), è etichettata da Moore come “fallacia naturalistica”: essa consiste appunto nel “confondere il bene con una proprietà naturale o metafisica”, senza accorgersi che la bontà di una cosa non è separabile dalla cosa stessa e, per ciò, non è mai definibile. L’errore sta proprio nell’illudersi che il bene abbia proprietà e che esse si configurino come parti distinguibili dal bene stesso: l’ulteriore illusione è che si possano stabilire relazioni tra il bene e le sue parti. Tale “fallacia” può essere naturalistica in senso stretto, se si definisce il bene come un oggetto di natura (ad esempio, “il bene è il piacere”); ma può anche essere metafisica, se si definisce il bene come un oggetto sovrasensibile (ad esempio “il bene è la giustizia” o “il bene è ciò che Dio comanda”): nel primo caso, ne deriva un’etica riducibile a scienza empirica: caso emblematico è quello dell’utilitarismo, che identifica il bene col piacere. Nel secondo caso, ne deriva un’etica metafisica: esponenti ne sono tanto la religione (per la quale il bene è ciò che Dio comanda), quanto Spinoza e Hegel (per i quali il bene è in riferimento alla perfezione dell’universo) o Kant (per cui il bene è ciò che la ragione comanda). Le assurdità in cui scivola la fallacia (nella sua doppia veste, metafisica e naturale) sono secondo Moore denunciabili con un criterio logico: quello della “questione aperta”. Esso consiste nel mostrare come la scelta di una soluzione non possa del tutto escludere le altre: così, perché mai il piacere dovrebbe consistere nell’ordine dell’universo anziché nel verbo di Dio? E perché nel verbo di Dio anziché nelle prescrizioni della ragione? Optando per una soluzione, non si spiega perché non potrebbe essere vera quella opposta. A tale contraddizione si sfugge adottando la soluzione intuizionistica di Moore per cui il bene è intuito al pari del giallo: in tal maniera, si sa che cosa esso sia e non sussistono soluzioni alternative. Ben presto Moore si accorse che la sua soluzione, in forza dell’intuizionismo che la animava, poteva portare a derive soggettivistiche: egli scongiurò questo rischio ponendo l’accento sul fatto che il bene ha carattere assoluto, esprime un valore intrinseco e universale. Per questa via, ogni possibile soggettivismo è azzerato in partenza. Si parava però dinanzi un nuovo problema: posto che il bene sia universale, assoluto e autonomo, quale è la sua natura? Non può certo avere natura empirica, perché se così fosse si ricadrebbe nella fallacia naturalistica; ma non può neppure avere natura metafisica, ché sennò si riproporrebbe la fallacia metafisica. La soluzione di Moore sta allora nel riconoscere che il bene ha uno statuto ontologico pari a quello delle idee platoniche e dei numeri, che sono assoluti e oggettivi senza però essere né empirici né metafisici: in questo senso, il bene è ma non esiste, proprio come il numero quattro. Negli scritti successivi, Moore ammorbidirà la sua posizione, arrivando a sostenere che il bene dipende dalla natura intrinseca delle cose: in questo modo, dal platonismo egli si accosterà all’aristotelismo. Al cuore della riflessione etica di Moore, come abbiamo visto, sta la distinzione tra il bene (assoluto e colto in via intuitiva) e i tanti concetti morali (il giusto, il dovere, ecc), i quali non hanno una definizione autocentrata: infatti, non si potrà mai dire che cosa sia il giusto; tutt’al più si potrà dire che esso è finalizzato a realizzare il bene. Tutti i concetti morali vengono allora a configurarsi come altrettanti strumenti per raggiungere il bene. In questo modo, diventa possibile un’etica in cui si dica argomentativamente che cosa sia giusto o doveroso fare in vista del bene (il quale continua però ad essere indefinibile). Sicché l’etica di Moore fa salvi alcuni aspetti normativi in riferimento al dovere, al giusto, ecc, senza mai recedere dall’idea che tali aspetti normativi costituiscano solo un aspetto secondario dell’etica: quest’ultima ha, come obiettivo primario, il bene. In Etica (1916), Moore cambia decisamente rotta, poiché sente l’esigenza sempre più forte di costruire un’etica normativa: sicché arriva a far convergere il bene e il dovere. Nella conferenza del 1921 su La natura della filosofia morale, egli arriva addirittura ad attribuire la priorità al dovere, sostenendo che il bene deriva dal dovere o che, per lo meno, i due concetti sono paritetici. Del resto, irrisolvibili problemi riguardanti la sua iniziale teoria del bene erano già affiorati nei Principia ethica del 1903, allorché Moore si era domandato che cosa fosse il bene: essendo esso assoluto, autonomo, oggettivo, come se ne può cogliere il contenuto? A tale domanda, Moore risponde con la tecnica dell’isolamento assoluto: per vedere se una cosa è buona, basterà provare ad isolarla da tutto ciò che la circonda: se continuerà ad essere buona, allora sene potrà inferire che essa è il bene. A superare questa prova sono, secondo Moore, l’amicizia, il rapporto sociale tra uomini colti e il rapporto estetico che ne scaturisce. In questa prospettiva, Moore tratteggia l’ideale di un’estetica aristocratica per la quale il bene è godimento artistico non individuale, ma realizzato nei rapporti amicali e consistente nel “piacere dei rapporti umani” e nella “fruizione delle cose belle”.
RICHARD MERVYN HARE

BREVE INTRODUZIONE AL PENSIERO
Richard Mervyn Hare (1919-2001), autore di ” Il linguaggio della morale ” (1952), ” Libertà e ragione ” (1963) e ” Il pensiero morale ” (1981), si è soprattutto posto il problema del significato e della razionalità del discorso morale. Secondo Hare, è necessario porsi il problema del significato delle nozioni morali, se non ci si vuole affidare solamente all’intuizione, che è meramente soggettiva; solo elaborando una teoria del significato dell’etica è possibile evitare il relativismo e sfuggire all’ammissione di una equivalenza tra tutti i discorsi etici. Ciò può avvenire non affrontando direttamente questioni normative, cioè che cosa è bene o che cosa è male, ma investigando sulle forme specifiche del discorso morale: il compito di quest’indagine appartiene ad una disciplina, chiamata meta-etica . Il linguaggio della morale, secondo Hare, è costituito da “proposizioni prescrittive” o “imperativi”, ovvero proposizioni che comandano ciò che si deve o non si deve fare. Infatti, valutare un’azione come buona o cattiva equivale a prescrivere che essa sia o non sia eseguita. Gli imperativi si distinguono dalle “proposizioni descrittive”, le quali descrivono uno stato di cose e sono suscettibili di essere vere o false. Essi, tuttavia, accanto ad un elemento propriamente prescrittivo, detto “neustico” (dal greco neuein , “inclinare”), contengono un elemento che appartiene anche al linguaggio descrittivo, ed è detto “frastico” (dal greco frazein , “dichiarare”). Per esempio, l’imperativo “chiudi la porta!”, il quale non è né vero né falso, ha in comune con la proposizione descrittiva “stai chiudendo la porta” l’elemento frastico, “chiudere la porta”. Hare condivide la cosiddetta “legge di Hume”, secondo cui il dovere non può essere dedotto dall’essere, ovvero, da premesse descrittive non è possibile dedurre logicamente conclusioni imperative, che prescrivano ciò che si deve o non si deve fare. All”biezione che la meta-etica, limitandosi a descrivere le proprietà del linguaggio morale, lascia in realtà le cose come stanno, Hare risponde mostrando che le proposizioni morali implicano un principio di “universalizzabilità”: chi enuncia una proposizione prescrittiva, infatti, se non vuole contraddirsi, la farà prevalere per tutti coloro che si trovano nella situazione prevista dall’imperativo. In questo senso, la scelta dell’azione non è abbandonata solamente all’intuizione o alle emozioni meramente individuali, ma può essere fondata su argomentazioni che si richiamano esplicitamente a questo principio. In base a questa premessa, Hare può ripescare all’interno della meta-etica anche l’ “etica normativa”, che investiga su che cosa si debba o non si debba fare, in particolare l’etica dell’utilitarismo, in netta ripresa negli anni del dopoguerra in Inghilterra, e dalla quale Hare riprende la nozione di “preferenza”. L’impegno proprio del discorso morale di esprimere prescrizioni universalizzabili impone che si tenga conto delle preferenze di tutte le altre persone coinvolte nei casi in esame, senza stabilire differenze pregiudiziali fra tali preferenze, in modo da massimizzare le preferenze di tutti. Se è favorevole a una ripresa dell’utilitarismo, Hare è invece radicalmente contrario al “neocontrattualismo”, che ai suoi occhi ha il difetto di ripiombare nell’intuizionismo, ossia di fondarsi su concetti non adeguatamente definiti; è significativo, a suo avviso, che due autori che si richiamano entrambi al contrattualismo, come Rawls e Nozick, pervengano a conclusioni diametralmente opposte tra loro.
VITA, OPERE E PENSIERO
Richard Mervyn Hare è nato il 21 marzo 1919 a Blackwell. Studiò alla Rugby School ed al Balliol College di Oxford. Durante la seconda guerra mondiale fu arruolato nel 1940 nella Royal Artillery, fu tenente dell’Indian Mounted Artillery nel 1941 e prigioniero di guerra a Singapore e lungo la Burma-Thailand Railway dal 1942 al 1945. Sposò, nel 1947, Catherine Verney, dalla quale ebbe quattro figli. Ha svolto presso l’Università di Oxford i seguenti incarichi: Fellow e Tutor in filosofia al Balliol College; Lecturer in filosofia; Wilde Lecturer in Natural and Comparative Religion; White Professor in filosofia morale e Fellow del Corpus Christi College. E’ stato poi Graduate Research Professor di filosofia all’Università della Florida. E’ stato membro de: National Road Safety Advisory Council; Church of England Working Parties on Ethical Questions; Church of England Board for Social Responsibility; Presidente della Aristotelian Society. All’età di 82 anni si è spento ad Oxford. Il pensiero di Hare viene solitamente suddiviso in due fasi: una prima costituita dalla teoria metaetica del prescrittivismo universale e una seconda caratterizzata, invece, dal predominare dell’ interesse etico-normativo e improntata all’elaborazione prima e alla difesa poi di un particolare tipo di utilitarismo dell’atto. Si è molto discusso in merito a tale suddivisione: sono due momenti distinti ed eventualmente in contraddizione o vanno visti come due fasi collegate e senza soluzione di continuità? La posta in gioco è alta: ne va della coerenza del pensiero di Hare, ma vengono anche messi o, meglio, rimessi in discussioni temi fondamentali come la possibilità di qualsivoglia rapporto tra la metaetica, l’etica normativa e l’etica applicata o come la legittimità della cosiddetta ‘terza via in etica’ (di cui Hare si fa sostenitore) in contrapposizione all’emotivismo e al naturalismo. Cerchiamo di analizzare nel modo più obiettivo possibile alcune metodologie e alcuni concetti propri del pensiero di Hare tentando di capire che ruolo rivestano all’interno del suo pensiero.
IL PRESCRITTIVISMO UNIVERSALE : IL METODO CRITICO-RAZIONALE : la costante più importante di tutta la produzione hareana rimane il metodo analitico di rilevare, discutere e, possibilmente, risolvere i problemi. ” Sorprendentemente, molti filosofi, appena si dedicano a una questione pratica, dimenticano tutto del loro sapere specifico e ritengono che i problemi della piazza del mercato possano essere risolti soltanto dai metodi della piazza del mercato, vale a dire da una combinazione di pregiudizio (chiamato intuizionismo) e retorica. Il contributo di ogni filosofo a tali discussioni consiste nella capacità che egli deve possedere di chiarire i concetti impiegati (principalmente i concetti morali stessi) e, mostrando le loro proprietà logiche, di portare alla luce gli errori e porre, al loro posto, argomentazioni valide ” (Moral thinking: its level, method and point). Al di là dei termini coloriti e simpatici che caratterizzano molte delle pagine di Hare, va sottolineato un punto fondamentale: egli adotta il metodo proprio della filosofia analitica del linguaggio applicandolo al linguaggio morale, e tentando di scoprire il ‘significato’, le proprietà logiche fondamentali che regolano i termini propri di tale linguaggio (‘buono’, ‘dovere’, giusto’…).
LA PRESCRITTIVITÀ : Hare afferma: ” la prescrittività dei giudizi morali può essere descritta formalmente come la proprietà di comportare almeno un imperativo […]. Formuliamo un enunciato prescrittivo se e solo se, per qualche atto A, qualche situazione S e qualche persona P, se P assente (oralmente) a ciò che diciamo e non fa A in S, è logicamente necessario che l’assenso di P sia insincero ” (Moral thinking: its level, method and point). Una proprietà formale, dunque. Il primo dei due poli del prescrittivismo universale risulta così essere un elemento squisitamente legato alla filosofia analitica del linguaggio, e specificamente del linguaggio morale che viene, così, assimilato ad una sorta di linguaggio prescrittivo. Ciò testimonia innanzitutto l’importanza attribuita a tutti quegli aspetti logici e di significato dei termini morali che costituiscono il contesto filosofico all’interno del quale Hare si muove soprattutto nei primi anni della sua carriera.; in secondo luogo è indice del tentativo di percorrere la ‘terza via in etica’, distaccandosi parimenti dall’ “emotivismo” (per il quale le nozioni etiche sarebbero delle realtà oscure e soggettive, tranquillamente rimpiazzabili da un particolare tono di voce o da alcuni punti esclamativi) e dal “naturalismo” (che vedrebbe, invece, nelle nozioni etiche delle realtà con proprietà assolutamente riconducibili alle proprietà delle realtà naturali).
L’UNIVERSALIZZABILITÀ : tra le varie spiegazioni dell’universalizzabilità, Hare propone la seguente come la più completa: ” è contraddittorio dare giudizi morali diversi su situazioni di cui ammettiamo l’identità per quanto riguarda le loro proprietà descrittive universali. Per giudizi ‘diversi’ intendo ‘tali che, se fossero riferiti alla medesima situazione, sarebbero reciprocamente incompatibili’ ” (Moral thinking: its level, method and point). Ancora una volta il confronto con il contesto filosofico nel quale Hare si muove risulta assolutamente necessario e funzionale alla comprensione del suo stesso pensiero. Egli riconosce che nei giudizi etici nei quali compaiono termini morali (ad esempio ‘buono’) è presente una componente descrittivistica che permette di collegare, in modo variabile, tali termini a criteri diversi; questa mutevolezza è determinata dalla diversità delle classi di oggetti giudicate. Quando diciamo che una mela è ‘buona’ abbiamo in mente qualità del tutto diverse rispetto a quando diciamo che questa è una ‘buona’ esecuzione della quinta sinfonia di Beethoven; cambiano i criteri del nostro giudizio, rimane invariata l’intenzione di lodare ed eventualmente raccomandare ciò che abbiamo giudicato ‘buono’. Facendo così proprie alcune istanze del “descrittivismo”, Hare torna ad attaccare i suoi due nemici principali: al contrario di quanto afferma l’emotivismo i nostri giudizi morali non sono immotivati, non esprimono soltanto un nostro stato d’animo ma sono il risultato di un processo razionale volto al reperimento, nell’oggetto giudicato, di alcuni criteri che giustificano il giudizio stesso; il fatto che il significato descrittivo di un termine possa legittimamente variare permette di svincolare un termine morale (il ‘buono’ dell’esempio) da un insieme fisso e immutabile di proprietà cui il naturalismo lo vorrebbe invariabilmente collegato. Dopo aver esaminato questi primi tre elementi, è necessario fare alcune considerazioni. Sia la prescrittività sia l’universalizzabilità (che confluiscono nella dottrina da Hare stessa chiamata “prescrittivismo universale”), sia il metodo critico-razionale (caratteristico dell’ambito analitico all’interno del quale Hare prende le mosse) sono elementi formali, metaetica, analitici. È però possibile e doveroso evidenziare il legame che unisce questi elementi ad altri aspetti decisamente meno metaetici e più normativi. In altri termini è Hare stesso a mettere in risalto i punti di unione tra le due fasi del proprio pensiero. Iniziamo da alcune considerazioni metodologiche. Se è vero che il metodo analitico è una costante, è però anche vero che la facoltà di chiarire i concetti morali mediante l’analisi delle loro proprietà logiche non è, da sola, sufficiente allorché lo scopo delle proprie riflessioni sia l’elaborazione di una dottrina normativa e non solo un tipo di pensiero rigorosamente metaetico. ” La razionalità è una qualità del pensiero diretto a rispondere alle questioni, e la determinazione di quali procedure siano razionali dipenderà da quali sono le questioni. Se tentiamo di rispondere a questioni fattuali, è ovvio che la razionalità ci obbliga ad accertare i fatti, proprio perché le questioni sono fattuali. Dobbiamo quindi chiederci perché occorra fare lo stesso quando rispondiamo a questioni morali, le quali non sono interamente fattuali, ma hanno una componente prescrittiva ” (Moral thinking: its level, method and point). Il passaggio da questioni metodologiche a questioni sostanziali viene da sé. La ‘sostanza’ che Hare prende in considerazione è costituita dalla “preferenze”. Queste sono strettamente collegate, identificate quasi, con le prescrizioni. ” Il requisito di universalizzare le nostre prescrizioni, il quale a sua volta è un requisito logico, posto che ragioniamo moralmente, ci chiede di trattare le prescrizioni degli altri (vale a dire, i loro desideri e predilezioni, e in generale le loro preferenze) come se fossero le nostre ” (Moral thinking: its level, method and point). Vale la pena di fare un breve accenno alla componente descrittivistica delle prescrizioni di cui si diceva più su. Quando si esprime un giudizio morale si esprime un giudizio prescrittivo arricchito da un elemento descrittivo che permette, come s’è visto, di collegare i termini morali (buono) a criteri diversi a seconda delle classi d’oggetti che vengono giudicate (la mela piuttosto che la quinta sinfonia di Beethoven). Preferenze ed elementi descrittivi richiedono e ad un tempo giustificano la commistione di forma e sostanza, di metaetica ed etica normativa propria del pensiero di Hare. A fare da sfondo a metodi e sostanze il centralissimo concetto dell’universalizzabilità, che permea di sé il pensiero di Hare conferendogli coerenza ed eleganza. Anticipando alcune nozioni che verranno illustrate in seguito, pare possibile tracciare una sorta di planimetria del pensiero di Hare. Vi sono due piani nettamente distinti (seppur non radicalmente separati) costituiti dall’approccio metaetico e normativo alla filosofia morale. All’interno di ciascuno di essi, poi, sembra riscontrabile un’ulteriore duplice divisione: una forma (le nozioni di prescrittività ed universalizzabilità) e un elemento assimilabile ad un contenuto (le preferenze) per la parte metaetica; una forma (l’universalizzabilità dei princìpi) e un elemento decisamente contenutistico (i fatti attinenti al mondo) per la parte normativa.
L’UTILITARISMO DELL’ATTO
Prima di esaminare nel dettaglio la dottrina utilitaristica di Hare, è necessario soffermarsi brevemente sul contesto filosofico entro il quale egli opera, passando in rassegna alcuni tratti tipici dell’utilitarismo con i quali si trova a dover fare i conti nel momento dell’elaborazione della propria teoria normativa.
LA RIDUZIONE : ” la riduzione è l’artificio di considerare tutti gli interessi, ideali, aspirazioni e decisioni sullo stesso piano, e tutti rappresentabili come preferenze, forse di diverso grado di intensità, ma per il resto da trattare nello stesso modo “. Costante indispensabile di tutte le teorie utilitaristiche, la riduzione non è che il primo di tre importanti artifici dei quali l’utilitarismo si avvale per appianare, raffinare e localizzare il campo dal quale attingere i propri elementi sostanziali. Essa assume un’importanza fondamentale soprattutto nel contesto di quelle forme di utilitarismo che propongono come principio di utilità la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei danni o a prevenire danno, dolore, male o infelicità alla parte il cui interesse è preso in considerazione: e se la parte è la comunità in generale, allora si tratterà della felicità della comunità “. Nel contesto del pensiero di Hare, la riduzione assume una connotazione del tutto particolare: dall’artificio di considerare e trattare allo stesso modo tutti i desideri e gli interessi, essa diventa il principio di ” attribuire il medesimo valore agli eguali interessi di tutti “. Lasciando da parte benefici e danni, Hare si rifà piuttosto ad una concezione simile alla regola aurea veterotestamentaria (“non fare a nessuno ciò che non piace a te”) e più ancora alla sua formulazione in positivo presente nei Vangeli (“quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti”). In base a queste premesse, Hare è in grado di formulare il proprio principio di utilità nei seguenti termini: ” ciò che il principio di utilità mi richiede è di fare per ogni individuo interessato alle mie azioni ciò che vorrei fosse fatto per me in circostanze ipotetiche in cui io fossi precisamente nella sua situazione; e se le mie azioni interessano più di un individuo (come accade quasi sempre) il principio mi richiede di fare ciò che vorrei, in tutto e per tutto, fosse fatto per me in circostanze ipotetiche in cui mi trovassi in tutte le loro situazioni (naturalmente, non nello stesso tempo, ma, come dire, in ordine casuale) “. Risulta evidente il legame tra principio di utilità e prescrittivismo universale: il richiamo alla possibilità di occupare casualmente tutte le posizioni delle parti eventualmente interessate dagli effetti della mia azione richiama da vicino la proprietà formale della prescrittività (che prevede la sottoscrizione dell’imperativo singolare rivolto a se stessi ‘fa x’ allorché si sia enunciato il giudizio morale ‘si deve fare x’) e della universalizzabilità (secondo la quale dalla prescrizione ‘si deve fare x’ discende l’ulteriore prescrizione ‘chiunque, in situazioni simile per gli aspetti rilevanti, deva fera x’).
L’IDEALIZZAZIONE : interrogandosi sulla natura dei propri oggetti, lontano dalla tentazione di restringere arbitrariamente il campo di ciò che può dirsi una preferenza (interessi, ideali, aspirazioni…) e parimenti lontano dall’ostinarsi a considerare tali elementi come tutti assolutamente uguali, l’utilitarismo opta per una sorta di diversificazione qualitativa e riconosce di dover prendere in considerazione solo determinate preferenze. L’idealizzazione è dunque l’artificio che consente di tener conto solo di quelle preferenze che rispondono a determinati requisiti, manipolando la nozione stessa di utilità alla quale si rivolge la scelta di un individuo. Hare si trova a dover affrontare un problema analogo a quello che interessa le teorie utilitaristiche. La componente sostanziale della propria dottrina normativa gli richiede di determinare con esattezza quali siano le preferenze ideali, ovvero quali classi di fatti sia necessario tener presente allorché si esprime un giudizio morale, e quali siano le modalità per determinare tale classe. La compresenza di elementi prescrittivi e descrittivi nei giudizi morali ha un significato ben preciso: al pari delle asserzioni fattuali, prima di esprimere le quali è necessario accertare i fatti perché esse sono una ‘pretesa di verità’, anche i giudizi morali necessitano di un simile accertamento sui fatti prima che possano essere pronunciati su di essi; è evidente che l’analogia tra le asserzioni di fatto e i giudizi morali non si fonda tanto sulla possibilità che questi ultimi possano valere, grazie all’accertamento fattuale, come pretese di verità, quanto, piuttosto, sul richiamo stesso all’attenzione per i fatti: ” anche se i giudizi morali non possono essere chiamati pretese di verità senza ulteriori qualificazioni […], essi sono soggetti ad un analogo requisito di accertare i fatti, prima di pronunciarsi moralmente su di essi. La funzione dei principi morali è quella di fornire una guida pratica universale per tutte le situazioni di un certo tipi […]. Tutto ciò si dissolverebbe nel nulla se i nostri giudizi morali fossero privi di ogni relazione con i fatti attinenti alle situazioni che stiamo commentando “. Si impone dunque ad Hare la necessità di determinare un criterio per selezionare i fatti a cui prestare attenzione. Attraverso una metodologia propriamente ‘induttiva’ egli giunge alla formulazione dei giudizi di rilevanza: partendo dall’ipotesi che una certa caratteristica situazionale potrebbe essere rilevante si mettono alla prova i principi che menzionano questa caratteristica; se tali principi risulteranno accettabili altrettanto accettabile sarà la caratteristica situazionale e sarà possibile formulare un giudizio di rilevanza. La più ovvia candidata a ricoprire il ruolo di caratteristica situazionale rilevante è, secondo Hare, la classe dei probabili effetti sortiti da possibili azioni sulle persone (noi stessi e gli altri) che si trovano in certe situazioni. Infine egli ritiene che una conoscenza degli altrui stati d’animo derivanti da determinate azioni sia raggiungibile a partire dalla conoscenza delle mie esperienze presenti e delle relative preferenze. Di ciò si dirà più specificamente in seguito. L’ASTRAZIONE : con questo terzo artificio il discorso si sposta dall’analisi del mondo e dei bisogni in esso contenuti alla ricerca di un luogo più o meno fisico nel quale poter rinvenire informazioni in merito agli elementi sostanziali dell’utilitarismo. I pensatori che si muovono all’interno di questa dottrina sono soliti caratterizzare il luogo di reperimento di queste informazioni come trascendente rispetto al mondo sociale. L’impossibilità di trattare tutte le preferenze allo stesso modo, la necessità di escludere addirittura dal calcolo determinate classi di preferenze (quelle cosiddette “antisociali”) hanno spinto la maggior parte degli utilitaristi a prediligere come luogo di reperimento dell’elemento sostanziale un individuo ideale, provvisto di alcune caratteristiche particolari (ad esempio, un livello altissimo di informazione, una conoscenza arcangelica per usare la terminologia di Hare) che fanno sì che le sue preferenze siano al di sopra di ogni sospetto e di ogni obiezione. Hare si è servito dei due artifici precedenti per trattare il tema del rapporto tra l’utilitarismo e la società; si avvale ora dell’astrazione per esaminare il tema dell’individuo. La richiesta della riduzione di fare ciò che vorrei fosse fatto a me è intimamente collegato alla richiesta dell’idealizzazione di formulare giudizi di rilevanza sulla base della classe di fatti di cui s’è detto. Tale procedura implica una concezione dell’io secondo la quale sia possibile immedesimarsi il più completamente possibile con le preferenze (ed eventualmente con il dolore) delle persone interessate alle nostre azioni. Emerge subito una profonda divergenza tra Hare e l’utilitarismo: questo, come s’è detto, tende ad astrarre dalla concretezza e a trascendere l’individuo reale per reperire le proprie informazioni; Hare, all’opposto, è profondamente attento alla concretezza e ai fatti e ciò non deve stupire se si tiene presente l’ormai noto elemento descrittivo che fa capolino ogniqualvolta si parli di giudizi morali prescrittivi. Se astrazione deve esserci, deve essere dunque limitata al campo delle preferenze, ovvero alla classe di fatti irrinunciabile per qualsiasi argomentazione morale. La concezione dell’io elaborata da Hare rappresenta un contributo fondamentale per comprendere i tre artifici nell’economia del suo pensiero. Egli ritiene che io sia un termine ” non interamente descrittivo, ma in parte prescrittivo ” e spiega: “ identificandomi realmente o ipoteticamente con un’altra persona, io mi identifico con le sue prescrizioni. In termini più chiari pensare alla persona che sta per andare dal dentista come a me stesso significa avere ora la preferenza che egli non soffra come io penso che stia per soffrire. Nella misura in cui io penso si tratti di me stesso, precorro ora la medesima avversione che, secondo me, egli avrà “. La caratteristica prescrittiva del temine io permette di prendere a cuore il soddisfacimento delle preferenze dalla persona con la quale mi immedesimo; permette poi anche di evitare tanto l’altruismo (ovvero l’attribuire alle preferenze altrui un peso maggiore di quello attribuito alle nostre) quanto l’egoismo (ovvero l’attribuire alle nostre preferenze un peso maggiore di quello attribuito alle preferenze altrui). Alla luce di queste considerazioni pare dunque possibile affermare che il dilemma “etica formale o etica sostanziale?” per il prescrittivismo universale va sicuramente risolto a favore del primo dei due poli, a patto che ciò non porti a trascurare l’importanza che il secondo di essi, con i suoi limiti ma soprattutto con la sua peculiarità, riveste all’interno dell’economia del pensiero di Hare.
ERICH FROMM

A cura di Antonino Magnanimo
” Il guaio della vita di oggi è che molti di noi muoiono prima di essere nati pienamente .”
Erich Fromm nacque a Francoforte sul Meno nel 1900. Figlio di un ricco commerciante israelita di vini, fu educato in un’ atmosfera rigidamente religiosa. Dopo aver completato la sua educazione secondaria, nel 1922, a 22 anni, si laurea a Heidelberg in filosofia con una tesi ” Sulla funzione sociologica della legge ebraica nella Diaspora “. Mentre prepara la sua dissertazione, Fromm è ancora un ebreo ortodosso che si interroga sui timori che suscitava “negli uomini semplici” la figura dell’ebreo. Tenta quindi di offrire delle spiegazioni., individuando nella legge la forza che garantisce al corpo sociale ebraico di permanere nel suo scontro con corpi storici estranei. Utilizzando gli strumenti concettuali di Max Weber, Martin Buber e Hermann Cohen, propone una ricostruzione sociologica delle origini della diaspora, del rabbinismo, dei rapporti con il cristianesimo e con l’islam con un excursus storico sul crinale di quella legge che evita l’autodistruzione e permette il compromesso con i non ebrei, preservando l’identità nel corso del tempo. Fromm concentra la sua analisi su alcuni momenti della storia religiosa che ritiene esemplari. Negli anni Settanta, sull’onda del successo dei suoi libri, la tesi viene pubblicata. In seguito studiò psicanalisi a Monaco svolgendo anche attività di psicanalista presso l’Istituto psicanalitico di Berlino e di Francoforte. Non si laureò in medicina. Cominciò a praticare la psicoanalisi nel 1925 e divenne presto famoso. Dal 1929 al 1932 fu assistente nell’Università di Francoforte, e nel 1930 la sua prima tesi sulla funzione delle religioni, fu pubblicata in “Imago”, una rivista edita da Freud. Invitato all’Istiituto di psicoanalisi di Chicago, visitò gli Stati Uniti nel 1933. Nel 1934, per opposizione al nazismo, lasciò la Germania per stabilirsi permanentemente negli Stati Uniti. Tenne lezioni all’ Università di Columbia dal 1934 al 1939 e in altre università americane. Nel 1951 divenne professore del dipartimento di psicanalisi dell’ Università nazionale del Messico. Nel 1955 fu nominato Direttore del dipartimento di psicologia della stessa Università del Messico col compito di dirigere l’addestramento di psicoanalisi e di psichiatria. Nel 1962 diventa titolare di una cattedra di psichiatria a New York. Erich Fromm è considerato uno dei maggiori rappresentanti della psicologia post-freudiana . La sua posizione propositiva è stata definita “Socialismo umanistico”, utopia di un mondo umano che sappia realizzare le istanze sociali e superare l’alienazione dell’uomo, le spinte a fuggire dalla libertà, che sappia vivere l’amore per la vita. Le opere più importanti di Fromm sono : ” Fuga dalla libertà ” (1941); ” Psicoanalisi e religione ” (1950); ” Il linguaggio dimenticato ” (1951); ” Psicoanalisi della società contemporanea ” (1955); ” L’arte di amare ” (1956); ” Buddismo, zen e psicoanalisi ” (1960); ” Marx e Freud ” (1962); ” Il cuore dell’uomo ” (1964 ); ” La rivoluzione della speranza ” (1968); ” Anatomia della distruttività umana ” (1973); ” Avere o essere ” (1976); ” Grandezza e limiti della psicoanalisi di Freud “(1979). Fromm insieme a Adorno, Horkheimer e Marcuse diventa uno dei maggiori esponenti della Scuola di Francoforte , che nei primi anni del secondo dopoguerra si afferma nella cultura tedesca. La nuova corrente di pensiero, fortemente influenzata dal marxismo, si ispira a diverse matrici culturali: la dialettica e la fenomenologia hegeliana, il nichilismo di Nietzsche e di Heidegger, la psicoanalisi di Freud. La Scuola con il marxismo ha un rapporto tormentato e complesso per motivi sia teorici che pratici poiché respinge il concetto cardine del marxismo del progresso sociale che conduce al consumismo e alla tecnocrazia. La Scuola si oppone ai regimi totalitari di ispirazione marxista degli anni Cinquanta e Sessanta. Il nucleo originario si costituisce a partire dal 1922 presso l’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte, destinato a diventare particolarmente importante quando, nel 1931, ne prende la direzione Max Horkheimer. Dopo l’avvento del nazismo i componenti della Scuola sono costretti a trasferirsi all’estero, soprattutto negli Stati Uniti d’America e solo alcuni di loro torneranno in Germania alla fine della guerra. Il compito che la Scuola si prefigge è quello di svolgere ricerche collettive e interdisciplinari, tenendo presenti i metodi della sociologia, della ricerca storica, dell’economia politica e del marxismo. Oggetto di studio sono le società industriali e i modi di vivere che in esse tendono a realizzarsi. L’indagine è volta ad analizzare l’autoritarismo, il conformismo, l’alienazione che si presentano in forma più o meno latente nelle società industrializzate ed è condotta prendendo in considerazione anche le manifestazioni culturali e in particolare le avanguardie artistiche del Novecento. La contestazione giovanile del 1968 sembra ispirarsi alla Scuola di Francoforte che in questo periodo suscita pertanto un rinnovato interesse nel mondo della cultura. Di orientamento socialista e materialista, la Scuola ha elaborato le sue teorie e svolto le sue indagini alla luce delle categorie di totalità e dialettica: la ricerca sociale non si dissolve in indagini specializzate e settoriali; la società va indagata come un tutto nelle relazioni che legano gli ambiti economici con quelli culturali e psicologici. E’ qui che si instaura il nesso tra Hegelismo, Marxismo e Freudismo che tipicizzerà la Scuola di Francoforte. La teoria critica si prefigge di far emergere le contraddizioni fondamentali della società capitalistica e punta ad uno sviluppo che conduca ad una società senza sfruttamento. Con la presa del potere da parte di Hitler il gruppo francofortese emigra prima a Ginevra, poi a Parigi e infine a New York. Dopo la seconda guerra mondiale Marcuse, Fromm, Lowenthal e Wittfogel restano negli Stati Uniti, mentre Adorno, Horkheimer e Pollock tornano a Francoforte, dove nel 1950 rinasce L’Istituto per la ricerca sociale. Nella scuola di Francoforte si propone e sviluppa la teoria critica della società che avversa il tipo di lavoro della sociologia empirica americana. Per i francofortesi la sociologia non si riduce né si dissolve in indagini settoriali e specialistiche, in ricerche di mercato (tipiche, queste, della sociologia americana). La ricerca sociale è, invece, per loro, la teoria della società come un tutto, una teoria posta sotto il segno delle categorie della totalità e della dialettica e tesa all’esame delle relazioni intercorrenti tra gli ambiti economici, psicologici e culturali della società contemporanea. Siffatta teoria è critica in quanto da essa emergono le contraddizioni della moderna società industrializzata e in particolar modo della società capitalistica. Per maggior precisione il teorico critico ” è quel teorico la cui unica preoccupazione consiste in uno sviluppo che conduca ad una società senza sfruttamento “. Il primo lavoro di rilievo della Scuola di Francoforte è il volume collettivo “Studi sull’autorità e la famiglia” (1936): la famiglia, come anche la scuola o le istituzioni religiose, viene vista quale tramite dell’autorità e dell’insediarsi di questa nella struttura psichica degli individui. Un lavoro analogo verrà successivamente progettato in America: i suoi esiti sono pubblicati nel volume “La personalità autoritaria”. L’analisi più significativa compiuta da Fromm è quella relativa al tema della fuga dalla libertà che caratterizza la civiltà moderna. La storia dell’umanità è storia della libertà e ha inizio quando l’uomo, diventato consapevole della propria esistenza, spezza il legame che lo lega alla natura entro la quale era immerso, così come la storia individuale ha inizio con la separazione dalla madre. L’esistenza umana comincia quando l’adattamento alla natura perde il suo carattere coercitivo; quando il modo di agire non è più fissato da meccanismi ereditari. In altre parole, sin dall’inizio l’esistenza umana e la libertà sono inseparabili. Lo sviluppo della storia ha determinato una serie di conquiste quali il dominio sulla natura, la crescita della ragione, lo sviluppo della solidarietà verso altri uomini, ma ha causato anche isolamento, insicurezza, solitudine. Dalla fine del Medioevo in poi è cresciuta la libertà degli uomini rispetto alla natura e ai legami della tradizione e delle consuetudini del passato. Questa accresciuta libertà ha determinato, però, una perdita di significato dell’esistenza: l’uomo si sente solo, anonimo, impotente. Vive in modo spersonalizzante il lavoro e, ridotto al ruolo di consumatore, avverte la propria limitatezza anche di fronte alle scelte politiche. Tale insicurezza e precarietà determinano alcuni comportamenti di fuga dalla libertà che investono la società in tutti i suoi aspetti, anche quelli politici. Pertanto lo sviluppo dei regimi totalitari del fascismo e del nazismo non ha spiegazione solo a carattere economico e sociale ma anche psicologico poiché ha a che fare con questa tendenza dell’uomo moderno a fuggire dalla libertà che diventa dolorosa e a rinunciare alla responsabilità e all’autonomia delle scelte, rendendolo disponibile a sottomettersi a un regime politico autoritario. Altro punto fondamentale dell’analisi di Fromm in “Fuga dalla libertà” è quello relativo al tema dell’ autorità , dove viene operata una distinzione molto chiara tra autorità e autoritarismo, indicati con i termini di “autorità razionale” e “autorità inibitoria”. L’autorità non è una qualità ma si riferisce a un rapporto interpersonale, in cui una persona considera un’altra superiore a se stessa. Nel caso dell’autorità razionale, assistiamo a un processo in cui un rapporto si basa su una differenza gerarchica (come avviene per esempio tra insegnante e alunno): la parte inferiore riconosce all’altra una superiorità effettiva che non opera però nei suoi confronti in termini di sfruttamento. E’ un rapporto in cui la parte superiore offre all’altra una serie di strumenti che le consentono di avvicinarsi al suo livello e in questo senso si tratta di un rapporto di scambio reciproco su una base affettiva positiva. Si parla invece di autorità inibitoria quando il rapporto di sudditanza viene mantenuto e consolidato da chi ha potere. Fromm prende in considerazione anche le diverse forme di autorità come quelle che si realizzano nel rapporto tra padrone-operaio, padre-figlio, moglie-marito, ecc. L’importanza di Fromm risiede proprio nel tentativo di analizzare i grandi temi della vita sociale in un’ottica psico-sociologica che dà conto dell’importanza dei fattori culturali e sociali nello sviluppo della personalità. Anche il conformismo dilagante nella società moderna, l’assunzione acritica e automatica dei modelli di comportamento proposti dalla società comportano l’annullamento della personalità dell’individuo. In sostanza, si tratta di un meccanismo psicologico di difesa messo in atto per fuggire dalla paura e dalla solitudine, in ultima analisi per fuggire dalla libertà. L’uomo cessa di essere un atomo isolato attraverso la libertà positiva con la realizzazione spontanea e completa della sua personalità e dei rapporti d’amore che lo legano agli altri uomini e al lavoro come creatività. Solo la libertà positiva garantisce la possibilità di un’ autentica democrazia . L’analisi della società contemporanea porta all’individuazione del suo carattere fondamentale e cioè dell’ alienazione come effetto del capitalismo sulla personalità umana. L’alienazione caratterizza i rapporti dell’uomo con il lavoro, con gli altri uomini, con le cose, con se stesso. In “Psicoanalisi della società contemporanea” viene esaminata con estrema lucidità la situazione dell’uomo moderno in una società la cui principale preoccupazione è la produzione economica più che l’aumento della produttività creativa dell’uomo: una società dove l’uomo ha perduto il predominio. L’uomo moderno è estraniato dal mondo che egli stesso ha creato, alienato dagli altri uomini, dalle cose che usa e consuma, dal suo governo, da se stesso. Egli è ora ” una personalità fittizia “. Se si lascerà che le tendenze attuali si sviluppino senza controllo, ne risulterà una società malata, costituita da uomini alienati. Fromm presenta in questo modo una completa e sistematica concezione della psicoanalisi umanistica e propone un’ipotesi di società “mentalmente sana” in cui l’uomo sia il centro dell’interesse delle attività economiche e produttive, evidenziando così l’alternativa tra il sistema capitalistico e la dittatura totalitaria. In “Psicanalisi e religione”, Fromm discute il bisogno dell’uomo di una struttura di orientamento con cui egli può superare la sua alienazione e stabilire relazioni con gli altri. Questo bisogno può essere soddisfatto da un’ ideologia, da una religione, o persino da una nevrosi mentale. Fromm confronta questo tipo di psicoanalisi che chiama cura dell’anima con le religioni che accentuano il potere e la forza dell’individuo: ” la cura dell’ anima è quella di mettere un uomo in contatto col suo subcosciente aiutandolo così ad essere libero di stabilire relazioni d’ amore “. Il metodo normale per superare l’isolamento è stabilire spontaneamente relazioni col mondo attraverso l’amore e lavorare senza sacrificare l’indipendenza e l’integrità del processo. Nel suo lavoro di analista Fromm scopre una grande varietà di altri meccanismi d’evasione che sono alternativi all’amore: masochismo, sadismo, distruttività, conformismo. Essi producono una riduzione dell’alienazione e dell’ansia ma solo al caro prezzo della rinuncia della propria individualità. L’uomo alienato diventa estraneo a se stesso, non si riconosce come centro del suo mondo e come protagonista delle sue scelte, ma i suoi atti diventano i suoi padroni e a questi si sottomette. Nella società dominata dal denaro e dal consumo, l’uomo concepisce se stesso come una cosa in vendita. Nella società capitalista il consumo diventa fine a se stesso, fa nascere nuovi bisogni e costringe all’acquisto di nuove cose, si perde di vista l’uso delle cose e l’uomo è schiavo del possesso. Si può uscire dall’alienazione solo costituendo un tipo di società organizzata secondo il ” socialismo comunitario ” con la partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione del mondo del lavoro. Il socialismo comunitario prospettato da Fromm è vicino alle posizioni dei socialisti utopistici ed è influenzato dal sindacalismo e dal socialismo corporativista. In “Avere o Essere” Fromm propone all’uomo contemporaneo la scelta netta tra due categorie, due progetti di uomo: o quello dell’avere, dominante nella società capitalistica dei consumi, o quello dell’essere, della realizzazione dei bisogni più profondi dell’uomo. L’analisi di Fromm individua due modi di determinarsi dell’esistenza dell’uomo nella società:
- avere, modello tipico della società industrializzata, costruita sulla proprietà privata e sul profitto che porta all’identificazione dell’esistenza umana con la categoria dell’avere, del possesso. Io sono le cose che possiedo, se non possiedo nulla la mia esistenza viene negata. In tale condizione l’uomo possiede le cose ma è vera anche la situazione inversa e cioè le cose possiedono l’uomo. L’identità personale, l’equilibrio mentale si fonda sull’ avere le cose.
- essere è l’altro modo di concepire l’esistenza dell’uomo ed ha come presupposto la libertà e l’autonomia che finalizza gli sforzi alla crescita e all’arricchimento della propria interiorità. L’uomo che si riconosce nel modello esistenziale dell’essere non è più alienato, è protagonista della propria vita e stabilisce rapporti di pace e di solidarietà con gli altri.
Fromm ritiene necessario attuare una nuova società, fondata sull’essere, liberata dalla categoria dell’avere , che garantisca, a livello politico e nell’ambito del lavoro, la partecipazione democratica di tutti gli uomini. Il rapporto tra l’uomo e la società differisce da quello di Freud per il quale l’uomo è fondamentalmente antisociale e deve essere addomesticato dalla società. Sia la psicoanalisi che il marxismo hanno parzialmente fallito nel loro intento, spiega Fromm in “Marx e Freud”. Né l’una né l’altro sono in grado di produrre sostanziali cambiamenti della condizione umana: la psicoanalisi e il marxismo sembrano aver perso la loro carica liberatrice e non sono in grado di fornire la comprensione dei processi in atto. C’è bisogno di una revisione sia per l’una che per l’altro. Della psicoanalisi freudiana, oltre a criticare l’impianto meccanicistico, retaggio di una cultura positivista, Fromm denuncia il carattere borghese proprio dell’epoca e dell’ambiente in cui Freud viveva. Freud non ha espresso nella sua psicoanalisi la vera natura umana, ma solo quella di una società capitalistica, egoista e maschilista riducendo i rapporti tra uomo e mondo solo in termini di soddisfacimento libidico. Nella società alienata del capitalismo non sono, però, i bisogni e le potenzialità umane ad essere realizzati, ma i bisogni socialmente indotti dal mercato. Il marxismo d’altra parte non ha colto il peso che le forze psicologiche, attraverso i meccanismi di riproduzione sociale, hanno sulla personalità degli individui. In “Fuga dalla libertà” Fromm analizza i meccanismi che hanno operato nella storia dell’uomo, in particolar modo analizzando la storia moderna dell’Occidente, che ha spesso visto gli uomini fuggire dalla libertà, cedere la libertà mantenendo l’appartenenza alla società, luogo di sicurezza contro la solitudine. Anche il totalitarismo nazista può essere spiegato con questi meccanismi. Famosa è l’analisi psicoanalitica che egli fa di Hitler, descritto come sadico con il popolo tedesco, che domina e sottomette e masochista nei confronti del destino. Non sembra, però, che Fromm attribuisca a un processo rivoluzionario la possibilità di superamento dell’alienazione. La psicoanalisi può compiere la necessaria critica dell’alienazione dell’uomo contemporaneo e della sua infelicità. Mentre la società capitalista preferisce personalità ferme a stadi pregenitali, demandando alla famiglia il compito della repressione sessuale, Fromm guarda ad una sessualità genitale, che egli vede come simbolo di libertà, creatività, socievolezza. E’ stata notata in Fromm una lettura di Marx nella quale i valori della vita, del lavoro liberato, dell’utopia e del Socialismo vengono contrapposti ai valori della morte, dello sfruttamento, dell’alienazione e del capitalismo. In particolare, fra i valori che nella lettura di Fromm vengono esaltati, fondamentale è quello dell’amore. In “L’arte di amare”, che è la sua opera più nota e più popolare, discute cinque tipi di amore : amore fraterno, amore tra genitori e figli, amore erotico, amore per se stessi, amore per Dio. Tutte queste forme di amore hanno elementi comuni e devono essere basati sul senso di responsabilità, rispetto e conoscenza. Per ogni individuo l’amore è il modo normale di superare il senso di isolamento e, come desiderio di unione con gli altri, assume una forma specificamente biologica tra l’uomo e la donna. Fromm afferma che è errato interpretare l’ amore come una reciproca soddisfazione sessuale poiché una completa felicità sessuale si raggiunge soltanto quando c’è l’amore. La concentrazione sulla tecnica sessuale come se questa rappresentasse la via alla felicità è, egli afferma, una delle molti ragioni per cui l’amore è diventato così raro nella moderna società capitalistica. Fromm crede che l’amore sia l’unica e soddisfacente risposta al problema dell’esistenza umana. L’amore non può essere insegnato, bensì deve essere acquisito tramite uno sforzo continuo, disciplina, concentrazione e pazienza, tutte cose che sono difficili per la pressione continua della vita moderna. Il più importante contributo di Fromm sta nell’ accentuazione della dignità e del valore dell’individuo . A differenza degli psicologi del comportamento, egli non riduce l’uomo ad un comune denominatore di istinti e considera il sesso molto meno importante dell’amore. Le sue idee sulla teoria della pratica dell’amore sono della massima importanza poiché dimostrano che uomini e donne possono superare le pressioni della vita quotidiana e le difficoltà che essi incontrano quando vogliono formare mature relazioni d’amore. Dal punto di vista strettamente psicanalitico, Fromm è noto per aver approntato una teoria della personalità . Formatosi innanzitutto come sociologo, Fromm ha saputo coniugare il pensiero di Freud con molti altri grandi filoni culturali, da Marx alla tradizione ebraica. All’interno di questa vasta sintesi dottrinale, si trova anche una teoria della personalità ed una caratterologia, nata come tipologia causale, studiata empiricamente con indagini sul campo e con uso di test proiettivi. La tipologia di Fromm è centrata sul concetto di produttività. Il carattere “produttivo” è quello pienamente sviluppato, non alienato, maturo e ricco di amore per la vita; questo è il punto di riferimento, cui tendono gli altri tre tipi principali, che sono il “ricettivo”, l’ “appropriativo” e il “mercantile”. I tre tipi non costituiscono categorie fisse, ma piuttosto, come in tutti i sistemi caratterologici moderni, delle tendenze presenti in una certa proporzione in ogni carattere. E’ significativo quindi non solo il caso in cui una tendenza appare più sviluppata delle altre, ma anche il caso contrario, in cui una tendenza appare appena accennata. Inoltre, la produttività non esclude che il carattere possa essere classificato come appartenente ad uno degli altri tipi; il pieno sviluppo delle potenzialità umane può essere raggiunto attraverso vie differenti. In “Analisi della distruttività umana”, Fromm ha descritto anche un altro tipo interamente negativo, il “necrofilo”, amante della morte e nemico della vita; questo rappresenta un caso limite, patologicamente lontano dai valori del carattere produttivo. E’ raro, fortunatamente, che il necrofilo possa incontrarsi allo stato puro, ma può presentarsi allo stato di tendenza nelle persone troppo affascinate dalla tecnica e dall’ordine.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

L’antropologo Claude Lévi-Strauss è stato colui che, con la sua utilizzazione del modello della linguistica strutturale nelle indagini sulle strutture della parentela e sui miti e con le sue teorie generali sul concetto di struttura, ha più contribuito alla formulazione e alla diffusione di quello che è stato chiamato strutturalismo . Nato nel 1908 a Bruxelles da genitori francesi, è vissuto a Parigi, dove si è laureato in filosofia nel 1931; nel 1935 si trasferisce in Brasile, dove rimane sino al 1939, compiendo spedizioni in Amazzonia e nel Mato Grosso. Nel 1939 torna in Francia, ma si rifugia poi negli Stati Uniti, dove insegna a New York, entra in contatto con l’ antropologia americana e stringe amicizia con Jakobson. Rientrato in Francia nel 1948, nel 1950 insegna all’ Ecole Pratique des Hautes Etudes e dal 1954 Antropologia sociale al Collège de France; nel 1973 è stato eletto all’ Accademia di Francia. Le sue opere principali sono: Le strutture elementari della parentela (1949), Tristi tropici (1955), Antropologia strutturale (1958), Il totemismo oggi(1962), Il pensiero selvaggio (1962, dedicato a Merleau-Ponty), Mitologiche ( Il crudo e il cotto , 1964, Dal miele alle ceneri , 1966-67; L’ origine delle buone maniere a tavola , 1968; L’ uomo nudo , 1971), Antropologia strutturale due (1973) e Lo sguardo da lontano (1983). Secondo Lévi-Strauss, la linguistica di Saussure rappresenta ” la grande rivoluzione copernicana nell’ ambito degli studi dell’ uomo “, ma sullo sfondo dei suoi studi di antropologia è la tradizione della scuola di Durkheim. Questi aveva mostrato che i fenomeni socio-culturali non sono spiegabili come espressioni di istinti o di scelte individuali volontarie e consapevoli, ma in termini di rappresentazioni collettive. I concetti basilari della religione, come Dio, anima, spirito o totem, hanno la loro origine nell’ esperienza con cui gli uomini avvertono la forza e la maestà del gruppo sociale e sono il prodotto di una sorta di mente collettiva. Sulla linea dello studio delle rappresentazioni collettive, l’ allievo e nipote di Durkheim, Marcel Mauss (1872-1950), aveva individuato, nel Saggio sul dono (1924), alla base dello scambio arcaico il triplice obbligo, radicato nella mente umana, di dare, ricevere e restituire, ossia un principio di reciprocità, da cui dipendono le relazioni di solidarietà tra individui e gruppi, mediante lo scambio di doni pregiati. A questi problemi si collega l’ opera fondamentale di Lèvi-Strauss, Le strutture elementari della parentela . L’ obiettivo di essa è di individuare la logica sottostante a tutti i sistemi di parentela al di là della loro varietà, ossia la struttura invariante rispetto a cui essi sono tutti trasformazioni. Alla base di tutti i sistemi matrimoniali è, secondo Lèvi-Strauss, la proibizione dell’ incesto, la quale impedisce l’ endogamia: l’ uso di una donna, vietato all’ interno del gruppo parentale, diventa disponibile ad altri. Grazie alla proibizione dell’ incesto è reso allora possibile lo scambio di un bene pregiato, le donne, tra gruppi sociali e quindi lo stabilimento di forme di reciprocità e di solidarietà che garantiscono la sopravvivenza del gruppo. Sono queste le relazioni invarianti necessarie in ogni società, alla luce delle quali diventa possibile studiare le varie forme che assumono le relazioni di parentela, individuando due categorie essenziali di sistemi matrimoniali, quello a scambio limitato, tra cugini, di tipo prescrittivo, e quello a scambio generalizzato, di tipo preferenziale. L’ antropologia, alla pari della geologia, della psicanalisi, del marxismo e soprattutto della linguistica, diventa in tale modo scienza capace di cogliere le strutture profonde, universali, a-temporali e necessarie, al di là della superficie degli eventi, che è sempre ingannevole, e al di là dell’ apparente arbitrarietà degli elementi che costituiscono ogni società. A queste strutture si accede non attraverso la descrizione puramente empirica delle varie situazioni di fatto, ma mediante la costruzione di modelli. Essi sono sistemi di relazioni logiche tra elementi, sulle quali è possibile compiere esperimenti, ossia trasformazioni, in modo da individuare ciò che sfugge all’ osservazione immediata. I modelli non hanno mai perfetta rispondenza alla realtà, ma non sono neppure semplici costrutti puramente soggettivi o dotati soltanto di valore metodologico: essi hanno valore oggettivo, perchè mettono in luce le strutture che formano l’ ossatura logica della realtà. A queste strutture si accede non attraverso la descrizione meramente empirica delle varie situazioni di fatto, ma mediante la costruzione di modelli. Essi sono sistemi di relazioni logiche tra elementi, sulle quali è possibile compiere esperimenti, ossia trasformazioni, in modo da individuare ciò che sfugge all’ osservazione immediata. I modelli non hanno mai perfetta rispondenza nella realtà, ma non sono neppure semplici costrutti puramente soggettivi o dotati soltanto di valore metodologico: essi hanno valore oggettivo, perchè mettono in luce le strutture che formano l’ ossatura logica della realtà. La struttura, infatti, non è una pura e semplice forma, ma “è il contenuto stesso colto in una organizzazione logica concepita come proprietà del reale”. Una disposizione di parti costituisce una struttura, quando è un sistema retto da una coesione interna, che si manifesta nel momento in cui sene studiano le trasformazioni, non storiche, ma secondo regole logiche: grazie a questo studio è infatti possibile rintracciare proprietà simili in sistemi apparentemente diversi. Per definire una struttura occorre collocarsi, come fa la linguistica, sul piano delle regole grammaticali e sintattiche, non su quello del vocabolario, ossia degli elementi singoli. In questo senso, la struttura di cui parla Lévi-Strauss, si distingue nettamente dalla struttura sociale, di cui parlano gli antropologi britannici, in primo luogo Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955), per i quali essa è l’ insieme di relazioni sociali, empiricamente osservabili, tra gli individui, che ne consentono il funzionamento e la stabilità. Secondo Lévi-Strauss, invece, il fenomeno empirico è soltanto una combinazione logicamente possibile di elementi: per poterlo spiegare occorre ricostruire preliminarmente il sistema globale di cui esso è soltanto una variante. Dalla scuola durkheimiana, Lévi-Strauss riprende l’ idea della natura psichica dei fatti sociali: questi sono sistemi di idee oggettive, ossia di categorie che nel loro insieme costituiscono lo spirito umano nella sua universalità, ma questi sistemi non sono elaborazioni consce, bensì inconsce. Il fondamento ultimo è dato dallo spirito umano inconscio, che si rivela attraverso i modelli strutturali della realtà. Obiettivo dell’ antropologia diventa allora la contemplazione dell’ architettura logica dello spirito umano, al di là delle sue molteplici manifestazioni empiriche. Ormai diventato una celebrità, Lévi-Strauss trascorre la seconda metà degli anni sessanta alla realizzazione di un grande progetto, i quattro volumi di studi dal titolo Mythologiques. In esso, Levi-Strauss analizza tutte le variazioni dei gruppi del Nord America e del Circolo Artico esaminando, con una metodologia tipicamente strutturalista, le relazioni di parentela tra i vari elementi. Nel 1971, Lévi-Strauss completa l’ultimo volume di Mythologique e nel 1973 viene eletto dall’Académie Française, uno dei più grandi onori per un intellettuale francese. “Il triangolo culinario” di Lévi-Strauss. Diagramma di analisi strutturale nella preparazione dei cibi. Adattato da Le Cru et le cuitEgli è anche membro dell'”American Academy of Arts and Letters”. Nel 1973 ha ricevuto l’Erasmus Prize, nel 2003 il Meister Eckhart Prize per Filosofia e ha ricevuto la laurea ad honorem dalle Università di Oxford, di Harvard e dall’Università della Columbia. Egli è anche stato onorato della Grand-croix de la Légion d’honneur, e gli è stato attribuito il merito di “Commandeur de l’ordre national du Mérite” e di “Commandeur des Arts et des Lettres”. Pur essendosi ormai ritirato egli continua a pubblicare occasionalmente meditazioni sull’arte, sulla musica e sulla poesia, e se intervistato racconta le reminiscenze della sua vita. L’ attività inconscia collettiva tende per Lévi-Strauss a privilegiare una logica binaria, ossia una logica che costruisce categorie mediante contrasti o opposizini binarie. Per quanto riguarda la lingua, la fonologia ha messo in luce che alla base del sistema dei suoni significativi, c’è un piccolo numero di sistemi di contrasto. Questo stesso tipo di logica presiede anche alla costruzione dei miti. I miti secondo Lévi-Strauss, non sono espressioni di sentimenti o spiegazioni pseudoscientifiche di fenomeni naturali o riflessi di istituzioni sociali, ma non sono neppure privi di regole logiche. Come è possibile spiegare il fatto che i contenuti dei miti sono contingenti e appaiono arbitrari, eppure presentano forti somiglianze nelle diverse regioni del mondo? La risposta secondo Lévi-Strauss, sta nel fatto che il mito è l’ espressione dell’ attività inconscia dello spirito umano e si struttura come un linguaggio. Come la funzione significativa di una lingua non è direttamente collegata ai suoni, ma al modo in cui i suoni sono combinati tra loro, così anche i miti sono formati di unità costitutive minime, le cui combinazioni avvengono secondo precise regole e danno luogo a unità significanti. In questo senso, i miti non sono creazioni puramente individuali e il compito di uno studio scientifico dei miti consiste nel mostrare non come gli uomini pensano e costruiscono i miti, ma “come i miti si pensano negli uomini, e a loro insaputa”. Gli elementi della riflessione mitica si collocano a metà tra le immagini connesse alla percezione e i concetti, cosicchè il pensiero mitico resta legato a immagini, ma, lavorando con analogie e paragoni, può dare origine a generalizzazioni e costruire nuove serie combinatorie degli elementi di base, che restano costanti. Di tali strutture, il pensiero mitico si serve per produrre un oggetto che abbia l’ aspetto di un insieme di eventi, ossia un racconto. In particolare, il sistema mitico e le rappresentazioni che esso suscita stabiliscono correlazioni tra condizioni naturali e condizioni sociali ed elaborano un codice che permette di passare da un sistema all’ altro di opposizioni binarie pertinenti a questi piani. Il materiale è fornito dalle classificazioni, per esempio di animali e vegetali, che hanno tanta parte nel pensiero primitivo: esse non sono solo legate all’ esigenza pratica di permettere un miglior soddisfacimento dei bisogni, ma nascono dall’ esigenza intellettuale di introdurre un principio di ordine nell’ universo. In questo senso, Lévi-Strauss rivendica, ne Il pensiero selvaggio, l’ esistenza di un autentico pensiero anche nei primitivi, il quale è alla base di ogni pensiero e non è una mentalità pre-logica, come aveva sostenuto Lucien Lévi-Bruhl (1857-1939), esclusivamente caratterizzata da una partecipazione affettiva e mistica con le cose, nettamente distinta dal pensiero logico. L’ unica differenza, secondo Lévi-Strauss, è data dal fatto che il pensiero “selvaggio”, quale si esprime anche nei miti, è più legato all’ intuizione sensibile e, quindi, più attento a salvaguardare la ricchezza e la varietà delle cose e a memorizzarla. L’ ultimo capitolo de Il pensiero selvaggio è una polemica contro la Critica della ragion dialettica di Sartre. Definendo l’ uomo in base alla dialettica e alla storia, Sartre ha di fatto privilegiato, secondo Lévi-Strauss, la civiltà occidentale, isolandola dagli altri tipi di società e dai popoli “senza storia”. In Razza e storia, Lévi-Strauss aveva riconosciuto che ogni società vive nella storia e muta, ma che diversi sono i modi in cui le varie società reagiscono a ciò. Le società primitive hanno subito trasformazioni, ma in seguito resistono a tali modificazioni : in questo senso, esse sono società fredde, ossia con un basso grado di temperatura storica, e la loro storia è fondamentalmente stazionaria. Esse si distinguono dunque dalle società calde, come quella occidentale, perennemente in divenire e caratterizzate da una stria cumulativa, le quali hanno come costo della loro instabilità i conflitti. In prospettiva, Lévi-Strauss auspica una integrazione tra questi due tipi di società e le corrispondenti forme di cultura e di pensiero. Egli rifiuta, dunque, ogni forma di etnocentrismo, in quanto ogni cultura realizza soltanto alcune delle potenzialità umane. Questo significa abbandonare ogni forma di umanesimo e di stoicismo, ossia respingere l’ equivalenza, dominante nel mondo occidentale, tra le nozioni di storia e di umanità: la storia è soltanto una delle scelte possibili che gli uomini possono compiere.
HANS JONAS
BREVE INTRODUZIONE AL PENSIERO
Nato in Germania nel 1903, dove compì gli studi, ebreo, fu costretto dal nazismo ad emigrare, prima in Inghilterra e poi, in Palestina e in USA, Hans Jonas, morto nel 1993, è autore di importanti opere filosofiche. Allievo di Heidegger, profondamente turbato dalla non opposizione del maestro al nazismo, iniziò a riflettere criticamente sulla filosofia esistenzialistica e su tutta la filosofia occidentale, per individuare i motivi culturali che avevano indotto persone di grande valore scientifico a non assumere atteggiamenti responsabili, in momenti storicamente cruciali. Per Jonas il pensiero occidentale è stato caratterizzato dalla separazione tra uomo e natura, separazione che può spiegare lo scarso interesse per il mondo che ci circonda. Jonas ritiene urgente la formulazione di una nuova teoria etica, in tempi come i nostri in cui le morali religiose sono in crisi e lo sviluppo delle scienze pone problemi di scelte totalmente nuove. Perché l’etica valga universalmente deve, per Jonas fondarsi metafisicamente; si deve individuare nella struttura stessa dell’essere un bene, un valore che consenta di colmare il divario tra essere e dover essere. L’uomo deve adoperarsi per negare il non-essere, agendo in favore della vita e delle generazioni future. Jonas non ritiene la scienza negativa in quanto tale, ma nelle sue applicazioni con effetti non prevedibili, si devono temere catastrofi dovute a mancanza di controllo umano. Proprio la paura per la distruzione del genere umano deve indurre gli uomini ad agire responsabilmente. Jonas coglie bene la questione di fondo dei nostri sistemi politici , in quanto le nostre democrazie teorizzano la politica in termini di diritti, che hanno una prospettiva universalistica, però poi la praticano in termini di utilità, e quindi in modo particolaristico, perché le utilità o sono sempre le utilità di un gruppo nazionale contrapposto agli altri oppure, all’interno di un gruppo, determinate categorie che dicono di voler difendere i propri interessi. Jonas si spinge addirittura a sostenere la prospettiva di una tirannia ben intenzionata, di un governo di custodi che costituisca un problematico ma praticabile esito del tentativo di coniugare insieme una prospettiva universalistica con il relativismo politico. La sua non vuol essere affatto un’apologia dei governi tirannici quanto cercare una soluzione compatibile con i governi liberali e democratici odierni: un governo capace di dare risposte, competenze tecniche sorvegliate e controllate da un progetto universalistico ai problemi che rischiano di travolgere non soltanto le istituzioni esistenti ma addirittura le condizioni di sopravvivenza del genere umano. L’ uomo di Jonas è costruito sulla tradizione teologica ebraica: per un verso è un’immagine del Dio sofferente e che si prende cura, per l’altro è l’immagine di un Dio che ha rinunciato all’onnipotenza e che accetta per questo l’ambiguità. L’ambiguità è il dato fondamentale dell’uomo così concepito. Ambiguità vuol dire poter scegliere tra il bene ed il male, di essere buono o cattivo, voler eliminare questa ambiguità specifica significa per Jonas, eliminare la libertà dell’uomo. Questa antropologia dell’autolimitazione dell’uomo è polemica nei confronti delle moderne antropologie che sottolineano la centralità dell’uomo, o meglio il dominio dell’uomo sulla natura. Jonas pone al centro della sua posizione filosofica la questione della sopravvivenza , in base alle minacce specifiche che si affacciano all’orizzonte contemporaneo. Triplice è la natura del rischio: in primo luogo la catastrofe nucleare, in secondo luogo il collasso ecologico, in terzo luogo il rischio di una manipolazione genetica che può condurre ad una perdita dell’unità e dell’integrità del genere umano, attraverso la creazione di sottoclassi biologiche tra loro differenziate. Così il problema fondamentale diventa l’obbligo nei confronti delle generazioni future che non possono avanzare diritti, anche se Jonas ci ricorda che è vero che le generazioni future non possono sostenere i loro diritti ma è altresì vero che non possono corrispondere i loro doveri, e quindi la relazione di reciprocità è incompiuta. Spetta comunque a noi decidere per le generazioni future.
LA FILOSOFIA
Nasce a Monchengladbach nel 1903 e studia filosofia in diversi atenei tedeschi (Friburgo, Berlino, Heidelberg, Marburgo), sotto la guida di Martin Heidegger e Rudolf Bultmann i suoi interessi si orientano su questioni religiose, in particolare il cristianesimo antico e la filosofia ellenistica, che analizza utilizzando schemi di ermeneutica heideggeriana. Nel 1928 discute la sua tesi di dottorato Augustin und das paulinische Freiheitproblem . Nel suo pensiero possiamo distinguere tre tappe:
a) studi giovanili a carattere filosofico- religioso;
b) studi di filosofia della natura (secondo dopoguerra);
c) studi di etica (tarda maturità).
a) L’opera che caratterizza principalmente il primo periodo è Gnosis und spatantiker Geist , uno studio tuttora fondamentale sullo gnosticismo, alla quale Jonas lavorò per quasi trent’anni. La genesi di tale lavoro è legata ad una relazione tenuta al seminario teologico di Bultmann, ma il primo volume esce solo nel 1934 e il secondo vedrà la luce venti anni dopo. In un saggio del 1952 Gnosticism and modern Nihilism Jonas ha spiegato come l’interesse per il pensiero gnostico derivi dalla problematica nichilistica dell’esistenzialismo, la condizione specifica dell’uomo gnostico è quella propria di chi ha consapevolezza dell’ “essere-gettato”, cioè di vivere in un mondo in cui ci si sente estraniati. Di mezzo tra i due volumi che compongono il suo lavoro sullo gnosticismo ci sono gli anni difficili della persecuzione nazista (sua madre morì ad Auschwitz), dell’emigrazione in Inghilterra e in Palestina, dell’arruolamento come volontario dell’esercito inglese nelle file del Jewish Brigade Group, della II Guerra mondiale (fu anche sul fronte italiano). Nel 1949 Jonas si stabilisce in Canada, sei anni più tardi si trasferisce negli Stati Uniti. Il fondamento del nichilismo antico e contemporaneo è il dualismo uomo/mondo, natura/spirito, e la seconda fase delle ricerche di Jonas concerne proprio gli studi sulla natura che rimandano sempre al riferimento heideggeriano. L’autore di Essere e tempo aveva indagato la natura dell’essere lasciando inesplorato l’essere della natura, su questo campo si muove ora la riflessione di Jonas i cui approfondimenti più significativi sono contenuti nella raccolta del 1966 The Phenomenon of Life. Towards a philosophical Biology . Lo studioso tedesco di contro il dualismo idealismo/meccanicismo propone di restaurare l’unità psicofisica dell’organismo biologico. Il percorso filosofico di Jonas ha il suo punto di arrivo conclusivo nella fondazione di una macroetica per la civiltà tecnologica e nell’analisi dei problemi di bioetica che ne sono il corollario. Con Das Prinzip Verantwortung ( Il principio responsabilità ) del 1979 Jonas sviluppa la tematica della vita sul piano dell’azione pratica avendo di mira un’etica globale per il mondo attuale. È un’opera ancora al centro del dibattito filosofico contemporaneo per l’attualità di alcune tesi concernenti la portata delle trasformazioni tecnologiche, la responsabilità verso le generazioni future, la critica dell’utopismo marxista ma anche per l’arretratezza e l’inattualità di alcune posizioni e in particolare l’impianto concettuale “quasi – aristotelico” fatto rilevare da Apel, il ritorno alla metafisica (nella concezione etica jonasiana c’è una significativa ispirazione teologica), la ripresa di problemi quali il rapporto spirito-corpo, finalità-causalità, essere-dover essere. Nel 1985 Jonas ha fatto seguire a Das Prinzip Verantowortung il volume di etica applicata, concernente soprattutto tematiche di bioetica, Technick, Medizin un Ethik. Zur Praxis des Prinzips verantwortung ( Etica, medicina e tecnica. Sulla prassi del principio responsabilità ). Hans Jonas muore a New York nel 1993. La conoscenza in Italia di Hans Jonas tra i non specialisti è relativamente recente, basti dire che Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica è stato tradotto solo nel 1990 da Einaudi, la stessa casa editrice che nel 1997 ha tadotto Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità. Alla diffusione del suo pensiero ha contribuito in certa misura anche la traduzione nel 1989 presso l’editore Il Melangolo del testo della nota conferenza jonasiana Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica (1984). La nota tesi del filosofo tedesco è che Dio non ha impedito la tragedia di Auschwitz ” non perché non lo volle, ma perché non fu in condizione di farlo. Creando il mondo e donando all’uomo la libertà Dio ha rinunciato ad uno dei suoi attributi: l’onnipotenza “.
IL PRINCIPIO RESPONSABILITA’
Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica pubblicato da Jonas nel 1979 si inserisce nel contesto della Rehabilitierung der praktischen philosophie. Come è noto, dopo una profonda fase di “crisi” dell’etica sotto i colpi, per citare solo alcuni orientamenti, di quelli che Paul Ricoer ha definito i “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud), dell’emotivismo neopositivistico, del divisionismo weberiano, del pensiero postmoderno etc., negli anni ’70 si è assistito ad una rinascita dell’etica normativa la cui tesi di fondo afferma la possibilità di fondare razionalmente criteri, norme e principi in grado di orientare l’agire umano. La particolarità della posizione jonasiana è che egli recupera una concezione “forte” della razionalità pervenendo, di contro il divisionismo (separazione di Sein e Sollen) e la concezione avalutativa della natura, ad una fondazione metafisica dell’etica che molto ha fatto discutere. L’influenza della cosiddetta “responsabilità jonasiana”, concetto che preciseremo in seguito, sull’etica contemporanea è stata straordinaria si pensi soltanto alla Diskursethik nelle versioni di Jurgen Habermas e di Karl Otto Apel, che pure non accettano il senso che Jonas dà alla razionalità, e all’importanza del concetto di responsabilità nel dibattico bioetico.
Jonas presenta la sua opera come un Tractaus tecnologico-ethicus che sviluppa le proprie tesi secondo un impianto concettuale rigoroso e sistematico, ciò che colpisce il lettore per quanto concerno lo stile dell’opera è comunque in primo luogo l’ “arcaicità” del linguaggio utilizzato che rende faticoso seguire il ragionamento. Lo stesso Jonas nella Prefazione ci ricorda che egli si era cimentato con la lingua tedesca dopo quasi cinquan’anni di frequentazione dell’inglese e ciò non poteva non avere una ricaduta sulla struttura complessiva della sua esposizione.
Il principio responsabilità è suddiviso in sei capitoli:
- La mutata natura dell’agire umano.
- Questioni relative al fondamento e al metodo.
- Sugli scopi e la loro posizione nell’essere.
- Il bene, il dover essere e l’essere: la teoria della responsabilità.
- La responsabilità oggi: il futuro minacciato e l’idea di progresso.
- La critica dell’utopia e l’etica della responsabilità.
Il primo capitolo approfondisce le caratteristiche dell’etica antica per evidenziare la sua inadeguatezza rispetto alle nuove dimensioni dell’agire umano poste in essere dallo sviluppo della tecnica. Di qui la necessità di fondare un’etica della civiltà tecnologica.
Ambiti dell’etica tradizionale:
Premesse dell’etica tradizionale:
Jonas vuole mostrare che tali premesse non sono più valide. I “nuovi poteri” della tecnica hanno trasformato “la natura dell’agire umano” e ciò esige anche un “mutamento dell’etica”.
Nell’antichità l’uomo con la sua azione non riusciva a scalfire l’ordine cosmico immutabile (Jonas procede qui ad una personale interpretazione del coro dell’Antigone di Sofocle), la città delimitava il campo della libertà e della responsabilità poiché la natura non era oggetto di responsabilità. Il problema etico ineriva il solo mondo sociale.
Alcune caratteristiche dell’etica tradizionale
- il bene e il male si manifestavano nella prassi stessa o nella sua portata immediata e non era oggetto di pianificazione a distanza (etica del “qui e ora” o della sincronia):
“Nessuno era ritenuto responsabile per le conseguenze involontarie di un suo atto ben intenzionato, ben ponderato e ben eseguito” – Hans Jonas, Il Principio Responsabilità, Einaudi, p.9)
Nuove dimensioni della responsabilità legate allo sviluppo della civiltà tecnologica:
1. Vulnerabilità della natura
Attualmente la responsabilità umana si è estesa alla natura, la restrizione della prossimità e della contemporaneità è cessata, le serie causali attivate dalla tecnica si presentano come irreversibili e cumulative, le condizione iniziali dell’agire umano non sono mai le stesse, l’esperienza non giova a nulla (ciò significa nella sostanza che una azione iniziata in un qualsiasi punto della terra, pensiamo alle immissioni di gas nell’atmosfera o ad una fuga radioattiva, ha conseguenze per l’ecosistema e quindi anche per l’umanità durevoli nel tempo e coinvolgono tutta l’estensione spaziale del pianeta).
Di conseguenza
2. Nuovo ruolo del sapere
Il sapere “diventa un dovere impellente” oggi sono in gioco “la condizione globale della vita umana” e “il futuro lontano”, anzi la sopravvivenza, della specie che rendono necessario un autocontrollo del potere e una dottrina etica compiuta.
3. Diritti della natura
I fondamenti dell’etica vanno ripensati in considerazione del fatto che anche la natura ha dei diritti, non è sufficiente cioè ripensare soltanto alla dottrina dell’agire (aspetto etico) poiché è indispensabile anche ripensare la dottrina dell’essere (aspetto ontologico).
4. Etica della collettività
Al centro dell’agire c’è oggi non l’individuo ma la collettività per cui la moralità è penetrata nella sfera produttiva sotto forma di politica pubblica, il che deve determinare l’esigenza di nuovi imperativi
5. Assioma generale della nuova etica:
In avvenire deve esistere un mondo adatto ad essere abitato (Ivi, p. 15)
6. Nuovo imperativo etico:
Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra.
Non è facile dare una fondazione teoretica al perché non abbiamo il diritto di scegliere o anche solo rischiare il non essere delle generazioni future in vista dell’essere di quelle attuali, anzi abbiamo un dovere rispetto a ciò che non esiste, perché in quanto non esistente, non ne avanza la pretesa. Tale fondazione rappresenterà il cuore della trattazione jonasiana, per ora egli assume come un assioma ciò che dovrà dimostrare in seguito.
Il nuovo imperativo etico a differenza di quello kantiano, “evoca ” una coerenza, di tipo metafisico e non logico, non dell’atto in sé, ma dei suoi “effetti ultimi con la continuità dell’attività umana nell’avvenire”, e l’ “universalizzazione” non è più ipotetica (” se qualcuno facesse così…”), “al contrario, le azioni sottoposte al nuovo imperativo, ossia le azioni della collettività, si universalizzano di fatto nella misura in cui hanno successo” (Ivi, p.17).
7. L’uomo stesso è diventato oggetto della tecnica :
Nella nuova situazione che si è determinata con lo sviluppo tecnologico l’uomo interviene sulla propria vita ad esempio con la manipolazione genetica, con il controllo del comportamento, prolungando la vita.
II. Questioni relative al fondamento e al metodo.
Principio fondante la nuova etica:
Non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza dell’uomo una posta in gioco nelle scommesse dell’agire (Ivi, p. 47).
Questa non è da considerarsi come la scommessa pascaliana, poiché non ammette la possibilità di puntare sul nulla, obbliga invece di optare per l’essere.
L’agire umano ha sempre un elemento del gioco d’azzardo o della scommessa ma non si può scommettere su ciò che non ci appartiene né per i grandi rischi della tecnica vale “la garanzia della causa condizionale” per cui in alcuni casi, quando ne va del futuro, è possibile mettere in gioco la totalità degli interessi altrui.
Nell’etica della responsabilità viene meno la reciprocità, non ha valore l’argomento secondo cui il non-essente non può avanzare le pretese per cui non ha diritti e se non ci sono diritti non ci sono doveri.
La nuova etica della responsabilità o etica del futuro implica un dovere verso l’esserci dell’umanità futura e un dovere verso il suo essere-così che deve essere fondato.
Il primo dovere sembra non necessitare di fondazione perché la sopravvivenza è data per scontata, in realtà il secondo dovere si basa sul diritto dell’esistenza che significa riconoscimento che all’altro deve essere garantita la possibilità di assolvere al proprio dovere di autentica umanità.
La responsabilità jonasiana è unilaterale.
1° imperativo categorico: che ci sia una umanità
Tale imperativo è insito non nell’etica ma nella metafisica in quanto dottrina dell’essere il che “contraddice i dogmi più consolidati del nostro tempo: che non esista una verità metafisica e che dall’essere non sia deducibile nessun dovere essere” (Ivi, p. 55-57).
Il dover essere ha dunque un fondamento metafisico. Qui Jonas infrange il dettato della cosiddetta “legge di Hume”.
Questione :
L’uomo deve essere? Che cosa significa che qualcosa deve essere? Deve esserci qualcosa o il nulla ?
Una condizione umana può essere giudicata migliore di un’altra e costituire così un dover essere per la scelta, ma rispetto ad entrambe si può optare per il non essere dell’uomo che mette a riparo da ogni obiezione.
Jonas ritiene “che si può scegliere il non essere in luogo di tutte le alternative dell’essere se non è riconosciuta un’assoluta priorità dell’essere rispetto al nulla. Quindi la risposta alla questione generale assume un importanza reale per l’etica” (p. 58).
Perché esiste qualcosa e non il nulla ? Perché qualcosa deve avere la priorità sul nulla, qualunque sia la causa, per cui viene all’esistenza?
La domanda sul dover essere diventa così una domanda di valore.
Essere = valore
Non essere = né valore né disvalore
La questione etico-metafisica del “dover essere dell’essere ” (Seinsollen) si sposta su quella logica relativa alla teoria del valore:
“Soltanto dalla sua oggettività (del valore) potrebbe essere dedotto un oggettivo ‘dover essere dell’essere’ e quindi un’obbligazione alla sua salvaguardia, una responsabilità verso l’essere” (Ivi, p. 62).
III. Sugli scopi e la loro posizione nell’essere.
Rapporto valori/ scopi
Lo scopo è ciò per cui una cosa esiste e per la cui realizzazione o conservazione si svolge un processo o si intraprende un’azione.
Il giudizio di valore concerne l’adeguatezza degli esseri rispetto agli scopi.
Si può parlare di finalità per gli oggetti naturali “involontari”?
Secondo Jonas la natura, proprio perché ha degli scopi ha dei valori (non è avalutativa), il problema è dimostrare che tali valori sono oggettivi (in-sé), legandoli al concetto di bene e rendendoli quindi vincolanti per noi (doveri). Qualora difatti tali scopi fossero soltanto soggettivi potremmo non riconoscerli sulla base della nostra libertà (Ivi, p. 97-98).
IV. Il bene, il dover essere e l’essere: la teoria della responsabilità
Fondare il “bene” o il “valore” nell’essere significa colmare il presunto ” divario tra essere e dover essere” (Ivi, p. 101), respingere la “legge di Hume”.
Se il bene o ciò che vale è tale a partire da se stesso allora lo possiamo definire come quella cosa la cui possibilità richiede l’esigenza della sua scelta (dover essere) posto che ci sia una volontà in grado di percepire e di tradurre in atto , quell’esigenza.
L’imperativo non può scaturire soltanto da una volontà che comanda (ad esempio Dio – persona), ma anche “dalla pretesa immanente di un bene-in-sé alla propria realtà”.
Per Jonas la natura prefiggendosi negli scopi o dei fini pone anche dei valori e ciò è ammissibile sulla base di un “assioma ontologico”:
“Nella capacità di avere degli scopi in generale possiamo scorgere un bene-in-sé, la cui infinita superiorità rispetto ad ogni assenza di scopo dell’essere è intuitivamente certa” (ivi, pag. 102).
Tale superiorità si avvale di una propria intuizione evidente: in ogni scopo l’essere dichiara in senso assoluto di essere migliore del non essere. Il riconoscimento come assioma è oggetto di una scelta metafisica che non può legittimarsi oltre.
Il si alla vita è un no al non-essere, mediante tale negazione “l’essere diventa l’istanza positiva, cioè la scelta permanente di se stesso. La vita in quanto tale, nel pericolo del non-essere che è immanente alla sua essenza, è l’espressione di quella scelta. Quindi in modo soltanto apparentemente paradossale, è la morte, ossia il poter morire, in quanto possibilità data in ogni momento e la cui dilazione si verifica anch’essa ogni momento nell’atto dell’autoconservazione – ciò che pone il suggello all’autoaffermazione dell’essere: per il suo tramite quest’ultima passa attraverso i singoli sforzi di esseri individuali” (Ivi, p. 104).
Nell’uomo il si alla vita che opera ciecamente acquisisce una forza vincolante nella sua libertà cosciente. L’uomo deve far sua questa affermazione ed imporre alle proprie facoltà la negazione del non-essere poiché è in grado di distruggere il lavoro teleologico della natura.
Il passaggio dal volere al dovere rappresenta il punto critico di ogni teoria etica. Perché limitare l’arbitrio dell’ uomo il cui esercizio illimitato costituisce il suo fine naturale come può diventare dovere ciò che è da sempre volontà dell’essere?
Jonas rileva come ogni scopo che mi pongo è legittimamente come “valore” soltanto perché vale la pena perseguirlo (o rinunciarvi qualora non sia perseguibile), egli postula perciò che ci sono scopi forniti o meno di valore indipendentemente dalla realizzazione o meno dei nostri desideri.
E’ in tale ambito che si può parlare di dovere, di scelta e di bene in sé, cioè indipendente dalla volontà. Il “segreto” o il “paradosso” della morale è che l’io deve essere dimenticato a favore della causa ( il bene in sé) affinché diventi un sé superiore (che è bene in-sé).
Ciò che motiva l’agire morale non è la legge etica (formalismo), ma l’appello intramondano del bene-in-sé possibile che si contrappone alla mia volontà e pretende ascolto, in conformità alla legge etica” (contenuto).
E’ evidente che io devo essere “permeabile” a tale appello ed è qui che entra in gioco il “lato emotivo” e precisamente il “senso di responsabilità” necessario per poter mettere in moto la volontà che vincola “questo soggetto” determinando un’azione conseguente.
Teoria etica della responsabilità
La responsabilità può essere intesa in due modi
Fino a che punto la responsabilità politica si inoltra nel futuro considerato che, a differenza di quella dei genitori, non conosce un termine fissato dalla natura dell’oggetto ?
Ogni arte di governo è responsabile per la possibilità della politica futura. Oggi il sapere analitico-causale applicato metodicamente al dato permette orizzonti più ampi rispetto al passato, d’altro canto però la nostra è una realtà estremamente dinamica e perciò sfuggevole all’uomo.
Essendo la responsabilità un “correlato del potere” la nuova etica ribalta il detto Kantiano “puoi, dunque devi” nel “devi, dunque fai, dunque puoi” (Ivi, p. 159-160).
Gli ultimi due capitoli de Il principio responsabilità (V. La responsabilità oggi: il futuro minacciato e l’idea di progresso e VI. La critica dell’utopia e l’etica della responsabilità) affrontano il problema della traduzione pratica della nuova etica in una politica di salvaguardia della natura e dell’uomo. Ciò da modo a Jonas di impegnarsi in una acuta analisi della società capitalistica (figlia dell’ “ideale baconiano” e madre della tecnica) e in un confronto con quella marxista, nel contesto di tali analisi egli si sofferma in modo particolare sulla versione blochiana dell’utopia marxista (principio speranza). Molte dei percorsi aperti dal filosofo tedesco in questi capitoli conclusivi risentono del clima storico-politico della fine degli anni ’70 e oggi, nella fase post ’89, sono superate, ciò non toglie che molte osservazioni mantengono la propria validità.
In sintesi le conclusioni jonasiane rilevano:
- la necessità di un controllo del potere distruttivo della tecnica demandato ad una élite che sappia dominare la tecnica e riequilibrare lo sviluppo dei popoli ricorrendo anche a forme di coazione con lo scopo di affermare il bene collettivo;
- un vantaggio teorico del marxismo sul capitalismo nel portare a realizzazione tale controllo (concetto di elite, spirito di sacrificio, uguaglianza etc.) che non ha però un riscontro nel socialismo reale che non è esente dall’economia dei bisogni e dal culto della tecnica;
- un altro limite del marxismo, e in modo particolare del pensiero blochiano, è rappresentato dalla prospettiva utopica (ontologia del non essere ancora), per Jonas non ha più senso prospettare il meglio quando è in gioco la necessità di preservare il presente (il pianeta per altro non reggerebbe un aumento della pressione produttiva):
“Qui è insito l’errore fondamentale dell’intera ontologia del non-essere-ancora e del primato della speranza che vi è legato. A suscitare in noi un senso di dovere è la semplice verità, né esaltante né sconfortante, che l’ “uomo autentico” è già sempre esistito con tutti i suoi estremi, nella grandezza e nella meschinità, nella felicità e nel tormento, nell’innocenza e nella colpa; in breve, in tutta l’ambiguità che gli è connaturata. Volerla eliminare significa voler eliminare l’uomo e la sua incommensurabile libertà” (ivi, p. 278).
MERLEAU-PONTY

Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer 1908- Parigi 1961) è, insieme a Sartre, il principale esponente dell’ esistenzialismo francese: il motivo di fondo del suo pensiero (anche se la riflessione politica ne è una componente importante) è l’ esistenza quale essenza dell’uomo . Come l’amico Sartre, egli nutrì inizialmente interessi per la psicologia e guardò con interesse alla fenomenologia. Nato a Rochefort-sur-Mer, studio all’Ecole Normale Supérieure e successivamente, grazie ai suoi lavori, La struttura de comportamento (1942) e La fenomenologia della percezione (1945), divenne professore dell’università di Lione. Diversamente da Sartre, con il quale collaborò alla direzione della rivista “Les temps modernes” dal 1945 al 1953, l’attività di Merleau-Ponty si svolse principalmente all’interno del mondo accademico: nel 1950 fu nominato professore alla Sorbona di Parigi e nel 1952 al Collège de France. Dapprima si avvicinò al marxismo , pubblicando Umanismo e terrore (1947) e la raccolta di saggi Senso e non senso (1948). Nel 1953 ruppe i suoi rapporti con Sartre, allontanandosi al tempo stesso dal marxismo, come emerge da Le avventure della dialettica (1955). Altre opere sono la raccolta di saggi Segni (1960), un’indagine sull’arte intitolata L’occhio e lo spirito (1960) e il volume postumo Il visibile e l’invisibile (1964). Anche per Merleau-Ponty il punto di partenza è l’ abbandono del dualismo cartesiano tra anima e corpo , tra coscienza e mondo. Studiando a Lovanio gli scritti inediti di Husserl, egli scopre la rilevanza dei concetti di intenzionalità e di mondo-della-vita, i quali consentono di sfuggire alla falsa alternativa tra idealismo e realismo, che insistono unilateralmente sulla priorità del soggetto o dell’oggetto, dell’io o del mondo. A suo avviso, la riduzione fenomenologia non mette capo a una coscienza pura, come aveva preteso lo stesso Husserl, bensì ad un mondo della vita, antecedente ad ogni riflessione, nel quale soggetto e oggetto si presentano indistinti. Qui il rapporto originario con il mondo si costruisce attraverso il corpo , la cui dimensione fondamentale è data dall’esperienza vissuta della percezione . Il mondo è ciò che percepiamo e la fenomenologia si configura essenzialmente come descrizione delle modalità di percezione. Il corpo, infatti, è anteriore e irriducibile alla contrapposizione, costruita a posteriori dalla riflessione e dalle scienze fisiologiche, tra soggetto e oggetto, tra coscienza e mondo. Esso è l’unità indistinta e naturale di questi poli: una mano che tocca è al tempo stesso toccata e viceversa, ossia il soggetto del sentire è al tempo stesso oggetto sentito e viceversa. Merleau-Ponty non può, quindi, condividere la contrapposizione sartriana di in se e per-sé, che ha come conseguenza la concezione dell’intersoggettività come conflitto tra coscienze. L’ ambiguità originaria dell’esperienza, quale si mostra nella percezione attraverso il corpo, impedisce di accogliere una concezione per la quale il vero soggetto è unico e non lascia posto all’altro e a una pluralità di coscienze. In questo senso Merleau-Ponty può affermare ” io sono un campo intersoggettivo “. La percezione, infatti, in quanto inscindibilmente connessa alla corporeità e non riducibile a coscienza pura, attesta che ” il corpo altrui e il mio sono un tutto unico “, cosicché il conflitto tra le coscienze non è la dimensione originaria del rapporto intersoggettivo, ma è la rottura di questa unità e comunicazione originaria, che ha le sue radici nel mondo della vita antecedente a ogni riflessione. L’esistenza viene concepita come incessante ripresa della situazione di fatto (caratteriale, familiare, sociale, ecc.) che la condiziona senza però predeterminarne lo svolgimento; l’esistenza è infatti libera, si svolge sotto il segno della possibilità perché può sempre modificare il suo punto di partenza, riassumendolo entro un progetto inaugurato da un atto di appropriazione della propria vita che le dà il suggello di autenticità; ne consegue che la realizzazione della libertà esige l’impegno e la prassi, giacchè il senso dell’esistenza, ovvero il significato della condizione umana, si rivela solo nel suo essere nel mondo. Ma il suo costitutivo radicarsi nel mondo fa sì che il senso dell’esistenza sia opaco e che la misura umana della libertà non sia un incondizionato potere della coscienza sulle cose, bensì si esplichi entro un limitato campo di possibilità. La libertà non può impedire che il mondo imprima anche all’esistenza il carattere proprio di tutto quanto sta nel suo orizzonte, che è la precarietà e la contingenza: proprio per questo il senso non può mai esorcizzare il non-senso. L’ambiguità dell’esistenza nasce dal fatto che la sua libertà si rivela in effetti l’altro lato del suo essere conficcata nella vita sensibile della percezione. Lungo questa via la fenomenologia esistenzialista e dialettica di Merleau-Ponty incontra la psicoanalisi nella convinzione che l’inconscio non è solo una struttura antropologica, ma anche una fonte di verità. Questa impostazione consente a Merleau-Ponty di respingere le concezioni sartiane del nulla e della libertà. E’ vero che il nulla appare nel mondo grazie alla soggettività e alla possibilità di trascendere il mondo e di annullare i propri progetti in ogni attimo, ma questa possibilità è sempre al tempo stesso quella di cominciare qualcos’altro, cosicché ” noi non rimaniamo mai in sospeso nel nulla “, bensì ” siamo sempre nella pienezza, nell’essere “. Allo stesso modo, egli rifiuta la nozione di il libertà assoluta, sganciata da ogni condizionamento, la quale porta alla conclusione della equivalenza delle scelte. La libertà assoluta è incompatibile con la nozione di situazione, ossia con l’essere-al-mondo, attraverso la corporcità e la percezione, che è proprio dell’uomo: ” io non sono mai una cosa e non sono mai una coscienza nuda “, cosicché la libertà è sempre incontro di esteriore e interiore, è sempre condizionata e inserita in un orizzonte di possibilità. L’alternativa tra libertà assoluta e determinismo è, dunque, meramente fittizia. Libertà per Merleau-Ponty significa nascere e precisamente nascere dal mondo in quanto campo già strutturato di possibilità, ma al tempo stesso nascere al mondo, in quanto il mondo non è mai una totalità chiusa e definitiva ma è un orizzonte aperto al quale possono essere conferiti significati. In questo modo acquistano senso ed efficacia le scelte, l’impegno e la responsabilità umana all’interno della storia, come insieme contingente dei progetti umani. Il problema della storia porta Merleau-Ponty ad una riflessione sul il marxismo , in Umanismo e terrore (1947) egli ravvisa nei processi staliniani un’espressione dell’ambiguità costitutiva dei progetti umani e del divario che ancora caratterizza il piano dei mezzi da quello dei fini. All’interno di una storia contingente, nella quale si scontrano prospettive soggettive, e in una situazione ancora rivoluzionaria, la violenza ed il terrore sono inevitabili e, tuttavia, orientati a realizzare il comunismo, inteso come piena trasparenza dei rapporti umani e ripristino del rapporto adeguato tra mezzi e fini. In questa situazione, secondo Merleau-Ponty, non si può essere né comunisti, né anticomunisti, ma bisogna assumere una posizione di attesa nei chiarimenti che la storia potrà apportare. Ma all’inizio degli anni cinquanta, nel clima della guerra fredda, egli abbandona il mito, che considera proprio del marxismo, di un significato totale della storia, affidato al potere del proletariato. Al cuore di questa concezione vi è la nozione di il dialettica , che egli critica in Le avventure della dialettica (1955). Invano il marxismo del Novecento, a partire da Lukács, ha tentato di superare Weber, per il quale è impossibile una conoscenza globale del significato ultimo della storia. Contro l’ultrabolscevismo, manifestato in quegli anni da Sartre, Merleau-Ponty sostiene che l’instaurazione in Urss di un partito unico, depositario e interprete del processo oggettivo della storia, è la confutazione dell’idea di dialettica e di rivoluzione. Secondo Merleau-Ponty, infatti, non c’è dialettica senza opposizione e senza libertà, ma queste non durano a lungo in una rivoluzione, che inevitabilmente degenera nella dittatura: ” le rivoluzioni sono vere come movimenti e false come istituzioni “. Egli descrive allora il proprio itinerario come un passaggio dell’attendismo marxista all’a-comunismo: più che pretendere di rifare la storia da zero, si tratta di cambiarla all’interno di una società e di un quadro di istituzioni che salvaguardino la libertà. In quest’ottica, nell’opera pubblicata postuma Il visibile e l’invisibile , Merleau-Ponty elabora il concetto di il iper-dialettica , ossia di una dialettica non caratterizzata (a differenza di quella di Marx e di Hegel) dalla sintesi finale definitiva e da una concezione lineare e unidirezionale dello sviluppo della realtà e della storia, ma aperta alla molteplicità di rapporti e alla polivalenza di significati che contrassegnano l’esperienza umana nel mondo. Negli anni Cinquanta Merleau-Ponty approfondisce la sua interpretazione fenomenologica del linguaggio aprendosi allo strutturalismo : il senso che promana dai segni linguistici non è solo frutto dell’intenzione consapevole del soggetto, e non è neppure solo il prolungamento della gestualità corporea, ma ha un’origine intrinseca al linguaggio stesso, poiché si trova pure nell’intervallo tra un segno e l’altro, incastonato negli interstizi tra le parole. Il concetto di struttura insegna così a Merleau-Ponty un nuovo modo di vedere l’essere, come un ‘sistema a più entrate ‘ , in cui il centro è ovunque e in nessun luogo. Il linguaggio è pensato, con una certa sintonia con l’ultimo Heidegger, come parola dell’essere.
MIGUEL DE UNAMUNO

A cura di Giorgia Baldin
VITA, OPERE E PENSIERO
Di famiglia borghese e cattolica, Miguel de Unamuno nasce a Bilbao il 29 settembre 1864, e qui frequenta la scuola primaria e secondaria. Tre anni più tardi muore la sorella Maria Jesusa e due anni più tardi la sorella Maria Mercedes, all’età di appena un anno, a cui seguirà il padre, nel 1870, quando Unamuno aveva sei anni. La sua casa era un focolare femminile che, in un modo o nell’altro influenzò molto il suo comportamento. A dieci anni assiste all’assedio della sua città durante la seconda guerra carlista. A soli venti anni (nella Spagna di allora gli studi universitari duravano solo tre anni) è dottore in lingua basca e si dedica per alcuni anni all’insegnamento privato nella sua città natale. Nel 1891, anno del suo matrimonio con Concha Lizàrraga, donna di cui era innamorato sin da bambino, viene assunto come professore di greco all’Università di Salamanca, dopo aver vinto un concorso a cui si preparò per tutto l’inverno. In questa città visse fino alla morte, a parte la parentesi forzata o volontaria del suo esilio. Nel 1897 soffre una profonda crisi religiosa: momento cruciale della sua vita, fungerà da spartiacque nel suo pensiero e nella sua produzione letteraria. Descritta da Unamuno stesso come una ” scarica fulminante ” in una notte, il giorno seguente si recò nel convento dei frati domenicani di Salamanca, dove rimase tre giorni dedito alla lettura di Blaise Pascal. Seguirono quindi molte letture religiose, soprattutto di natura protestante, che alimenteranno sempre più il suo pensiero antidogmatico e anticlericale. Questa profonda crisi, introdusse nel suo pensiero quella che sarà la sua caratteristica principale: l’ agonìa . Unamuno scriverà nel 1907: ” la mia religione è cercare la verità nella vita e la vita nella verità […]; la mia religione è un lottare incessante con il mistero “. Nel 1901 viene eletto rettore dell’Università di Salamanca, carica da cui verrà destituito nel 1914 dal ministro dell’Istruzione Pubblica (per ragioni politiche) pur conservando la cattedra fino al 1924, anno del suo arresto a causa dei suoi attacchi al re Alfonso XIII e al dittatore Primo de Rivera, che aveva assunto il potere a seguito di un colpo di stato nell’anno precedente. Portato al confino nelle Canarie (isola di Fuerteventura), evade alla volta di Parigi e poi di Hendaye, sulla costa basca, città in cui divise il suo volontario esilio. Con la caduta della dittatura, nel 1930 torna a Salamanca e gli viene restituita la cattedra. Lo stesso anno, scrive Antonio Machado su Unamuno politico:
” è la figura più alta dell’attuale politica spagnola […] è un uomo orgoglioso di esserlo, che parla agli altri uomini in un linguaggio essenzialmente umano. Si dirà che questa non è politica. Io credo che è la più originale. […] Non basta invocare la cittadinanza. E’ un concetto pagano e già superato per la storia. Un cittadino può essere un uomo libero che vive sopra una massa di schiavi. L’ultima grande rivoluzione politica non invocò i diritti del cittadino; proclamò i diritti dell’uomo. Perché lo si dimentica tanto frequentemente? Unamuno non lo scordò mai. Ma Unamuno pensa che l’uomo può malamente invocare i suoi diritti senza una previa coscienza della sua umanità. L’ingente opera politica di Unamuno consiste nell’illuminare questa coscienza, con la sua parola e con il suo esempio, nelle viscere del suo popolo “.
Il 1931 è l’anno della proclamazione della Repubblica, ed Unamuno è nominato deputato. Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola e il filosofo non nasconde la sua scelta franchista. Muore il 31 dicembre dello stesso anno, sentendo passare sotto la sua finestra le truppe naziste. Così lo commemora Ortega y Gasset: ” Unamuno è già da sempre in compagnia della morte, la sua perenne amica-nemica. L’intera sua vita, tutta la sua filosofia, sono state, come quelle di Spinoza, una ‘meditatio mortis’. Oggi una ispirazione del genere trionfa dappertutto, ma bisogna dire che fu Unamuno ad esserne il precursore“. Tra le sue opere meritano di essere menzionate: ” En torno al casticismo ” (1902), ” La vita di don Chisciotte e Sancio ” (1905), ” La mia religione ed altri saggi ” (1910), ” Il sentimento tragico della vita ” (1913), ” Nebbia ” (1914), ” Agonia del cristianesimo ” (1925), ” San Manuel Bueno ” (1933). La filosofia unamuniana parte dall’uomo (” l’uomo in carne ed ossa, che nasce, soffre e muore “) e in questo rivela saldi legami con l’esistenzialismo.. E’ l’uomo concreto ed esistente, l’uomo vivente, soprattutto, ” il soggetto e il supremo oggetto di tutta la filosofia “, perché il vivere è ciò che più importa: per questo si filosofa per vivere. Non si tratta, dunque, di ragione pura, di dogmatismo sistematico, per il motivo che Unamuno pone ragione e vita in due piani opposti su cui è necessario decidere. O si razionalizza la realtà, e in questo caso la si devitalizza, vista la sua linfatica prospettività; oppure la si vive irrazionalmente. Perché la realtà è vita, esiste, è dinamica e difficilmente imbrigliabile entro la morsa oggettivizzante di una ragione che astrae. In questo senso Unamuno ribalta la sentenza hegeliana: si legge nel ” Sentimento tragico della vita ” che ” tutto ciò che è vitale è irrazionale, mentre tutto ciò che è razionale è antivitale “. Si tratta non di meno di una chiara presa di posizione contro le definizioni teoretiche e le concettualizzazioni, che vogliono fissare ciò che ” è assolutamente instabile, assolutamente individuale “. Quindi la scienza, figlia della ragione, cosa può dire sui nostri dubbi, sui nostri più profondi bisogni e turbamenti? Cosa può dire sul senso autentico della vita individuale e sull’angoscia? La scienza è un cimitero di idee. Come bene afferma R.M. Albérès, infatti, il pensiero, la ragione e l’intelletto sono troppo ristretti per com-prendere totalmente tutto ciò che vogliono abbracciare; non per questo Unamuno rinunciò ad essi: li rese ‘tragici’ e ‘agonistici’, vale a dire, secondo l’ etimologia greca, ‘in lotta’ . Non si pensa, insomma, solo con la testa, ma con il corpo tutto: per questo il pensatore spagnolo oppone il conoscere per conoscere al sentimentalismo agonico e tragico della vita. E in questo senso Unamuno è romantico. Ma è anche nel filone esistenzialista , alla stregua di Kierkegaard, di cui lesse le pagine e di cui si dichiarò “fratello”, perché ” in perpetua disperazione interiore “. La ragione, fabbricatrice di certezze schematiche, deve perciò essere vista nella sua limitatezza, nella sua finitezza; solamente se l’uomo, individualmente, si consapevolizza e accetta i limiti del proprio intelletto, se riesce a rendersi conto che molte realtà oltrepassano le capacità intellettive umane, allora l’uomo si troverà in lotta contro le arroganti pretese dell’intelletto e lottando metterà un peso alla ragione, perché non si stacchi da terra oltre al necessario e oltre il necessario. Unamuno sembra tornare agli esiti filosofici di Cusano e alla “dotta ignoranza” come consapevolezza della sproporzione, dell’alterità insita tra la mente umana e la verità assoluta, tra il finito dell’uomo e l’infinito a cui si anela. Non è possibile raggiungere la coincidenza. E se fosse possibile sarebbe solo un traguardo povero, alla San Bonaventura, perché al di là dell’assoluto astratto, perdiamo il prospettivismo del concreto, in cui peraltro viviamo. Unamuno, dunque, è diffidente nei confronti dei sistemi filosofici, in linea con il pensiero filosofico spagnolo, per esempio di Ortega y Gasset o di Maria Zambrano, per citare solo il XX secolo. In effetti, i nostri desideri, i nostri affetti, i nostri timori, non provengono dalla ragione, ma sono a posteriori, così come ogni altra dottrina filosofica. Persino dietro la scienza si nasconde la fede nella ragione, e ” la fede nella ragione è destinata ad apparire, sul piano razionale, tanto insostenibile quanto qualsiasi altra fede “. L’esistenza dell’uomo, la realtà tutta, è contraddittoria: le lotte, soprattutto, sono le viscere ( ” entran?as “) della vita stessa: ” la vita è lotta “, lotta come agonìa greca. La nostra esistenza vitale è edificata su una lotta (” lucha “) tra il cervello e il cuore, tra la ragione e la fede. Unamuno vuole costruire con la fede ciò che ha distrutto con la ragione, di qui il suo tragicismo , che si radica in un abbraccio tra deismo sentimentale e scetticismo razionale. Ma un abbraccio, osserva il francescano Miguel Oromì, che non è ” di pace e di concordia, ma di lotta disperata, da cui procede il dubbio, non metodico, ma passionale, vitale, fondato sulla disperazione sentimentale e lo scetticismo razionale; è l’eterno conflitto tra la ragione e il sentimento, la scienza e la vita “. Un ruolo importante nel sentimento tragico della vita è giocato dall’abisso, nel cui fondo si è lacerati dall’angoscia e non si trovano sicurezze, certezze: ” tutto è nell’aria…la certezza assoluta e il dubbio assoluto non sono ugualmente vietate. Galleggiamo in un luogo incerto tra due estremi, come tra l’essere e il nulla “. Ma Unamuno non vuole arrivare ad un estremo, non vuole acquietarsi ma preferisce avvicinarsi senza giungere alla meta: è un continuo affannoso tendere che non trova esaurimento, perché la pace e l’appagamento, per lui, sono la morte. Torna dunque la lotta come cifra di vita, come sintesi dinamica entro cui muoversi e trovar respiro, in una vitale ricerca. Molto spazio è dedicato dal filosofo spagnolo alla figura di don Chisciotte. Secondo Unamuno, don Chisciotte è una figura mitica positiva per la Spagna. La cavalcata contro i mulini a vento non è un gesto di follia, anzi:
” aveva ragione il Cavaliere: la paura, e solo la paura, faceva vedere a Sancio, e fa vedere a noi semplici mortali, mulini a vento nei prepotenti giganti che seminano il male sulla terra. Quei mulini macinavano pane, e di questo pane mangiavano gli uomini induriti nella cecità. Oggi non ci appaiono più come mulini, ma come locomotrici, turbine, piroscafi a vapore, automobili […] mitragliatrici […] ma cospirano per il medesimo male. La paura, e solo la paura sanciopanzesca, ci ispira culto e venerazione per il vapore e l’elettricità […] ci fa cadere in ginocchio davanti ai prepotenti giganti della meccanica e della chimica, a implorare misericordia “.
Don Chisciotte, divenne folle ” unicamente per maturità di spirito “. Il don Chisciotte di Unamuno è lo stesso Unamuno che si scaglia contro il gigantismo del nozionismo , del dogmatismo, della ragione pura che crea sistemi che si arrogano il potere di contenere una verità universale. I libri cavallereschi contro le pretese del razionalismo supersemplificatorio, che in realtà non arricchisce la vita, ma la riempie di formule astratte inservibili. Don Chisciotte è l’uomo che si scaglia contro ” la peste del buon senso che ci tiene tutti soffocati e compressi “. Contro i vantaggi di un progresso non solo tecnologico, ma anche intellettualistico-nozionistico, Unamuno preferisce di gran lunga l’ignoranza, che ” è più che scienza, è saggezza “. Proprio perché così estremamente antisistematico e rivolto all’individuo in tutta la sua singolarità e concretezza esistenziale, canta e ricorda la vita reale della gente, che va a sbattere non solo contro ogni nazionalismo di sorta, ma anche contro la visione che della Spagna hanno intellettuali e politici. Loro vedono un popolo a tinta unica, una macchia indifferente e non vanno oltre, non entrano nella diversità di ogni singolo spagnolo, che si alza al levar del sole e compie il suo ” compito sicuro e silenzioso, quotidiano ed eterno “. Non vi è l’idea della Spagna: a Unamuno interessa il singolo, che esula ogni tentativo di generalizzazione. E’ tuttora ancora viva la polemica sul caso religioso di Unamuno. C’è chi lo ritiene un ateo (Antonio Sànchez Barbudo); chi lo vede come un razionalista luterano intriso di romanticismo kierkegaardiano, perché alla ricerca di un Dio immanente e non trascendente, un Dio dentro l’uomo (Hernàn Benitez). Ma è certo che il Dio di Unamuno è un Dio che parla al cuore , la sua è una cristologia poetica che non rientra nella tradizionale teologia religiosa o filosofica. Al contrario del razionalismo teologico tomista, l’esistenza di Dio, per il nostro filosofo, non è provabile con una prova razionale a posteriori, tanto meno aprioristica. La prova dell’esistenza di Dio è data dalla nostra istintiva volontà di sopravvivenza, dall’incapacità di rassegnarsi di fronte alla morte, dal desiderio di immortalità. Credere è creare ciò che vogliamo: ” la fede crea, in una certa maniera, il suo soggetto. E la fede in Dio consiste nel creare Dio; come è Dio che ci dà la fede in Lui, così è Dio stesso che si sta creando di continuo in noi “. Il sentimento tragico, la lotta, arriva fino a Dio stesso: Dio stesso soffre, ma ” soffre in me e io soffro in Lui “, questa è l’angoscia religiosa. Del resto la sofferenza, l’angoscia della morte, la passione per la vita è un costitutivo della vita del singolo. E’ ineludibile il problema di Dio, non è ammissibile un atteggiamento agnostico, non si può fermarsi a dire ” non so. E’ vero, forse non potrò mai sapere, ma voglio sapere. Lo voglio, e questo mi basta! “: la tensione mai spenta compare in ogni tratto del pensiero unamuniano. La fede di cui ci parla, non ha niente a che vedere con la grazia divina, in questo ambito la convinzione metafisica fondamentale di Unamuno, se di metafisica si può parlare, è il potere dell’immaginazione: è la fede che crea il suo oggetto, per desiderio e volontà di immortalità. Dio è il suo dialogante, ma un aneddoto della sua vita, può forse evidenziare meglio il suo rapporto non solo con Dio, ma con la vita stessa, cifra della sua filosofia: si sporge guardando il fondo del pozzo e urla Dio, aspettando che l’eco restituisca la parola-soggetto di tutta la sua vita: “Io”.
ANEDDOTI
“Se si fonderà in spagna il partito unamunista, io sarò il primo antiunamunista”
Si racconta che sul bavero usava mettere uno scudo con due iniziali: P.U.
-“Cosa significano quelle iniziali, don Miguel?”
-“Partito Unico”
-“E chi fa parte di questo partito?”
-“Per il momento solo io: e il giorno in cui entrerà nel partito qualcuno in più, rinuncio”.
Un giorno, quando ancora era un bambino, arrivò in ritardo nella classe di disegno e si scontrò con don Antonio che gli chiese spiegazioni:
-“Da dove vieni?”
-“Da casa”
-“Per dove sei venuto?”
-“Per la strada”
-“Ma come sei venuto?”
-“Camminando”
“Erano i segni prematuri della mia vocazione filosofica”.
UGO SPIRITO

Vera trasformazione è data dalla sostituzione del soggetto sociale a quello singolo, e la sostituzione non può non ingigantire le possibilità della conoscenza e dell’azione.
Nato ad Arezzo nel 1896, Ugo Spirito è morto a Roma nel 1979, dove insegnava da molti anni filosofia teoretica. Dopo aver aderito assai giovane all’ attualismo gentiliano, di cui fu uno dei più brillanti interpreti, se ne distaccò gradualmente negli anni ’30, pur senza rinnegarne alcuni principi di fondo. Andò così elaborando una concezione speculativa che volle chiamare ” problematicistica “, consegnata alle sue opere maggiori: Scienza e filosofia (1933), La vita come ricerca (1937), La vita come arte (1941), Il problematicismo (1948), La vita come amore (1953). Nell’ ultima fase del suo pensiero, approfondì gli assunti del problematicismo nella direzione di una dottrina definita ” onnicentrismo “: una visione filosofica radicalmente immanentistica che da un lato sottolineava l’ infinita pluralità e relatività del mondo e dall’ altro valorizzava la “positività del tutto” e la “centralità di ogni cosa”, approfondendo insieme il principio (cruciale in Spirito) della “ricerca”, vista come lo strumento più adeguato per appropriarsi di questa realtà polimorfa e contradditoria. Le opere più tarde di Spirito – Significato del nostro tempo (1955), Inizio di una nuova epoca (1961), Nuovo umanesimo (1964), Dal mito alla scienza (1966) – se non ne modificano sostanzialmente le tesi essenziali, offrono la testimonianza di un pensiero sempre assai vivace e aperto. Nella prima fase del proprio lavoro Spirito, fu essenzialmente, come è stato scritto, ” un divulgatore entusiasta ed un apologista instancabile dell’ attualismo “. Tale fase fu avviata già con la prima opera (Il pragmatismo nella filosofia contemporanea , 1921), e proseguita col più importante volume L’ idealismo italiano e i suoi critici (1930), in cui veniva riconosciuto a Gentile il ruolo di massima guida filosofica, perchè in lui, il “concetto di filosofia” si esplica “nella sua piena dialetticità” e “lo spirito annulla ogni alterità e si afferma nella sua infinità creatrice”. Tuttavia, già con Scienza e Filosofia , Spirito delineava una prospettiva per più versi originale e autonoma rispetto all’ attualismo, collocandosi con Guido Calogero ed altri su quel fronte che fu detto della “sinistra attualistica”. Il principale obiettivo di questi pensatori era di mantenere sì il primato gentiliano del fare (dell’ Atto) ma, insieme, di demetafisicizzarlo: di ancorarlo al concreto agire degli uomini entro il concreto orizzonte mondano. Mentre però Calogero svilupperà questo programma in direzione essenzialmente etica, considerando esaurita e conclusa quella che chiamava “la filosofia del conoscere”, Spirito si impegnerà intensamente proprio nell’ ambito della problematica gnoseologica, pervenendo a risultati assai diversi da quelli cui erano giunti un Gentile e un Croce. Così, in particolare, egli sottolinea con forza la non inferiorità della conoscenza scientifica rispetto alla conoscenza filosofica, l’ impossibilità di sopprimere la scienza nella filosofia e la necessità di stabilire tra esse un’ organica collaborazione. Si tratta, insomma, di ” fare sul serio scienza che sia filosofia e filosofia che sia scienza “, in un costante nesso dialettico. In questa prospettiva Spirito chiama la propria concezione ” attualismo costruttore “, in quanto vede il pensiero chiamato ad un’ elaborazione attiva (“costruttrice” appunto), a un perseguimento di sapere e di certezze (pur mai definitive) da condursi non lontano ma dentro le scienze positive. A questo proposito, non è un caso che il filosofo abbia studiato (benchè sempre in modo assai “speculativo”) i fondamenti teorici e la storia di alcune di queste scienze. Autore, negli anni della maggior militanza attualistica, di una significativa Storia del diritto penale italiano (1925), negli anni ’30 si occuperà di scienze economico-sociali ( I fondamenti dell’ economia corporativa , 1932; Dall’ economia liberale al corporativismo , 1939), inserendosi così nel dibattito promosso dal fascismo sul corporativismo e sull’ organizzazione di una nuova società. Come ben s’ intende, la prospettiva teorica accennata sopra esigeva non solo un nuovo concetto di scienza ma anche un nuovo concetto di filosofia. Ed è proprio tale esigenza, congiunta con un’ interpretazione estremamente mossa e complessa del rapporto conoscenza-realtà e uomo-mondo, che stà alla base del “problematicismo” di Spirito. “Problematicistica” la concezione del pensatore romano lo è anzitutto per l’ abbandono dei fondamenti metafisico-assoluti cari alla tradizione idealistico-attualistica. La sostituzione del concetto gentiliano di Atto con quello di “vita” e di “prassi” vuole appunto esprimere in prima istanza il privilegiamento di un orizzonte dotato di una terrena, concreta, imprevedibile (e proprio per ciò problematica) pluralità di forme e di valori. “Problematicistica” tale concezione lo è poi anche (e soprattutto) per l’ insistita e appassionata interpretazione della filosofia come ” problema e non soluzione, apertura e non conclusione; processo di dubbio che tende a diventare sempre più radicale “. Alla luce di tutto ciò non sorprende che Spirito accentui il modus operandi della “ricerca” quale carattere peculiare della filosofia. La “ricerca” pone infatti in luce la struttura costitutivamente aperta, complessa , problematica, anzi addirittura “antinomica” della vita. Pensare la vita (questo, per Spirito, è uno dei compiti primari della filosofia) significa accettare la sfida dell’ “antinomia sempre risorgente” e che “non dà tregua” sollevata appunto dalla vita. Da questo punto di vista né il razionalismo metafisico, né il positivismo, né l’ irrazionalismo offrono adeguate soluzioni, perché tendono a superare o a dissolvere l’ antinomia. Solo lo storicismo ha imboccato la strada giusta, quella della ” soluzione dialettica dell’ antinomia “, ma non l’ ha portata ad una realizzazione completa, esasperandone invece l’ aspetto “intellettualistico”. Per Spirito si tratta invece di articolare ulteriormente questa “soluzione dialettica”, ancorandola all’ uomo concreto che vive ” nell’ esigenza sempre più imperiosa di allargare i limiti della propria esperienza, tendendo all’ ideale di un’ esperienza totale “. Tale “soluzione dialettica” è resa trasparente nella vita assunta come arte , cioè assunta nelle dimensioni di immediatezza, tensione vissuta, creatività che si manifestano nel modo più evidente e intenso nell’ attività lato sensu estetica. ” Quell’ arte da cui abbiamo tratto i motivi per caratterizzare l’immediatezza spirituale di chi ricerca, se ha potuto veder slargati i propri limiti fino a coincidere con la vita, resta poi, nella sua specificità, a segnare i punti culminanti della vita stessa, in quanto protesa nello spazio per raggiungere l’universale ” (La vita come arte, I). La dimensione dell’arte viene poi allargata e integrata da Spirito con quella dell’ amore : dell’amore come fruizione appagante dell’immediato e come unità profonda con gli altri uomini “ricercanti”, che vanno riconosciuti nella loro costitutiva diversità e per ciò stesso “amati”. L’accentuazione del pluralismo dell’esperienza e della diversità negli esseri umani trova la propria definitiva formulazione teorica nella già ricordata concezione “onnicentristica”. Anch’essa, per Spirito, è essenzialmente un’ipotesi, che un giorno dovrà, come tute le altre, essere superata e accantonata. Tuttavia per ora interpreta efficacemente la condizione spirituale dell’uomo contemporaneo: la sua coscienza della precareità dell’esperienza e insieme il suo bisogno di assolutezza. Nella prospettiva dell’onnicentrismo la vita si fa “atto di radicale affermazione” in ogni sua forma: forma che è “sempre assoluta in quanto centro, relativa in quanto periferia”, e che viene così ad identificarsi col mondo, con la realtà assunta nella sua poliedricità e attualità, caratterizzata dalla pluralità dei suoi “centri”, sempre in movimento in se stessi e rispetto agli altri. L’onnicentrismo è anche in grado, per Spirito, di ispirare un nuovo umanesimo, che deve essere affermato sul terreno sia etico-sociale sia educativo. Si tratta di un umanesimo che riserva uno spazio privilegiato alla scienza, rivaluta più in generale tutte le attività dell’uomo (a cominciare dal lavoro) e accoglie in sè anche la dimensione della religiosità, interpretata come il senso dell’assoluto e dell’infinito. In tale contesto l’uomo “è riportato alla società” e “il suo conoscere e il suo agire diventano realtà collettiva”; la ” vera trasformazione è data dalla sostituzione del soggetto sociale a quello singolo, e la sostituzione non può non ingigantire le possibilità della conoscenza e dell’azione “.
RUDOLF STEINER

“Sbagliate a trattare il mondo della mente come se fosse soltanto una metafora. E’ un altro paese, e tutti abbiamo il passaporto per entrarci. ”
VITA E OPERE
Rudolf Josef Lorenz Steiner (1861-1925) nasce il 27 Febbraio 1861 a Kraljevec (allora Impero Austro-Ungarico oggi Croazia). All’età di circa sette anni al comune principio di realtà associa percezioni e visioni di realtà ultra mondane: ” distinguevo cioè esseri e cose ‘che si vedono’ ed esseri e cose ‘che non si vedono’ “. Tra il 1879-1883 frequenta il Politecnico di Vienna (Wiener-Technischen Hochschules). Studia matematica, fisica, botanica, zoologia, chimica oltre a letteratura, storia e filosofia. Segue i corsi di Brentano, assieme a Sigmund Freud e Edmund Husserl, e le lezioni sulla letteratura tedesca di Karl Julius Schrörer. Su indicazione di quest’ultimo, nel 1882, Steiner viene nominato editore degli scritti scientifici di Goethe per la “Deutsche National-Literatur” di Kürschner. Conosce Joseph Breuer. Intrattiene rapporti epistolari con il filosofo Eduard Von Hartmann. Nel 1886 appare la sua prima pubblicazione: “Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung” (“Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del mondo”). Nel 1888 è redattore presso il “Deutschen Wochenschrift” di Vienna. Tiene una conferenza al Goethe Verein (Società Goethiana) su “Goethe als Vater einer neuen Ästhetik” (“Goethe padre di una nuova estetica”). Collabora al “Goethe und Schiller Archiv” tra il 1890 e il 1897. Nel 1890 la Signora Föster Nietzsche propone a Steiner di curare il riordino dell’archivio e degli scritti inediti del fratello. Nel 1892 la sua tesi di Dottorato viene pubblicata con il titolo “Wahrheit und Wissenschaft” (“Verità e scienza”). Nel 1894 pubblica “Die Philosophie der Freiheit” (“La filosofia della libertà”). Nel 1895 pubblica presso l’editore Emil Felber lo scritto: “Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zein” (“Friedrich Nietzsche, un lottatore contro il suo tempo”). Per la “Cotta’sche Bibliothek der Weltliteratur” cura un’edizione in dodici volumi dell’ opera omnia di Schopenahauer e un’edizione in otto volumi delle opere di Jean Paul. Nel 1897 pubblica: “Goethes Weltanschauung” (“La concezione goethiana del mondo”), la summa dei suoi studi fino ad allora condotti su Goethe. A Berlino nel 1898 viene nominato editore e redattore del “Magazin für Literatur” e dei “Dramaturgische Blätter” . In un circolo berlinese conosce Franz Wedekind di cui mette in scena “L’intrusa”. Dibatte sul Magazin con il poeta Rainer Maria Rilke sulla “parola teatrale” (“Bemerkungen zu dem Aufsatz: Der Wert des Monologes”). Nel 1899 insegna storia alla Scuola di formazione dei Lavoratori fondata da Wilhelm Liebnecht. L’anno successivo viene invitato dal conte e della contessa Brockdorff (appartenenti alla cerchia teosofica di Berlino) a tenere una conferenza su Nietzsche e sulle favole di Goethe. In autunno inizia un ciclo di conferenze intitolato “Die Mystik”. Nel 1901 svolge un secondo ciclo di conferenze, presso la Biblioteca Teosofica, dal titolo “Das Christentum als mystiche tatsache” (“Il cristianesimo quale fatto mistico”). Incontra Anne Besant, segretaria generale dell’Associazione Teosofica, al Congresso teosofico di Londra. Viene eletto Segretario generale della Sezione tedesca dell’Associazione Teosofica. Inizia nello stesso anno a tenere conferenze pubbliche. Tra il 1901 e il 1918 tiene a Berlino cicli di conferenze presso la Freien Hochschule, fondata da Bruno Wille e Wilhelm Bölsche, e presso l’Archtektenhaus. Fonda il mensile Luzifer in seguito ribattezzato Luzifer Gnosis (1903). Con Marie von Sivers, sua stretta collaboratrice dal 1902 e futura moglie, fonda logge teosofiche in Germania e all’estero. Nel 1904 appare “Theosophie Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung” (“Teosofia introduzione alla conoscenza sovrasensibile all’autodeterminazione umana”). Il libro stimola W. Kandinsky (“Lo spirituale nell’arte”, 1912) e desta sospetto in P.Klee (“Diari”, 1916-1918). In occasione del congresso internazionale della Società Teosofica che si tiene a Monaco nel 1907 mette in scena il dramma di Eduard Schuré “Das heilige von Eleusi” (“Il mistero di Eleusi”). Kandinsky assiste alle conferenze di Steiner a Monaco e a Berlino (“Sonne Mond Und Sterne”, conferenza tenuta il 26.3.1908 presso l’Architektenhaus di Berlino). In seguito al ciclo di conferenze tenuto a Praga (“Fisiologia occulta”), il 28 Marzo 1911, Franz Kafka si presenta a Steiner nella sua stanza al Viktoria Hotel di Praga (Diari, 26 e 28 marzo 1911). Il 1913 è l’anno della separazione dalla Società Teosofica e della fondazione della Società Antroposofica. In quel periodo viene edificato a Dornach (Basilea, Svizzera) il Goetheanum, progettato da Steiner interamente in legno, a doppia cupola. Nella notte di San Silvestro del 1922 l’edificio viene distrutto da un incendio. Steiner realizza prontamente un secondo edificio interamente in cemento armato (edificato, dopo la sua morte, tra il ’25 e il ’28). Dal 1914 nascono altre costruzioni in cemento progettate da Steiner intorno all’area dell’edificio principale. Lavora alla scultura in legno: Il rappresentante dell’umanità fra Lucifero ed Arimane, pensata per essere collocata nell’area dell’abside della cupola minore del Goetheanum. Nel 1917 pubblica “Von Seelnrätseln” (“Enigmi dell’anima”), sul rapporto tra Antropologia e Antroposofia e sulla triplice conformazione dell’organismo umano. Tra il 1919 e il 1924 svolge un’intensa attività di conferenziere a Dornach e in tutta Europa. Steiner interviene su tutti i campi dello scibile: arte (storia dell’arte e corsi per pittori), educazione (fonda a Stoccarda la Freie Waldorfschule), vita sociale (elabora l’idea di uno stato tripartito in una libera vita spirituale, democratica ed economica), agricoltura (metodo di coltivazione biodinamica), medicina, fisica, arte drammatica (Sprachgestaltung, arte della parola) e teologia (fonda la “Chiristiangemenischaft”). Nel 1912 inaugura un nuovo stile di arte del movimento: l’Euritmia. Il 25 febbraio 1921 Piet Mondrian scrive a Steiner una lettera in cui, dopo aver riscontrato forti attinenze ideologiche tra il proprio pensiero e le teorie antroposofiche, lo invita ad esprimere un parere sul contenuto del suo scritto “Le Neo-Plasticisme” (1920). Dagli inizi del ‘900 fino al ’24 Steiner , senza avvalersi di manoscritti, tiene circa 6000 conferenze, poi stenografate e raccolte, assieme agli scritti, in 354 volumi che costituiscono l’opera omnia. Dal 1914 circa Steiner si avvale, durante le sue esposizioni, di un nuovo mezzo espressivo che si interpone all’atto linguistico: disegna con gessi colorati su una o più lavagne. Una sua allieva, Emma Stolle, decide di stendere sulla superficie delle lavagne del cartoncino nero. Dal 1919 al 28 settembre 1924 si sono così conservati 1100 disegni (Wandtafelzeichnungen). Nel 1958 Assja Turgenieff espone per la prima volta i disegni alla lavagna ad una mostra d’archivio a Dornach. Dal ’54 i WTZ compaiono in alcune pubblicazioni della GA di compendio al testo delle conferenze. Alcuni di questi volumi sono presenti nella biblioteca di Joseph Beuys, sul quale l’influsso di Steiner (databile sul piano teorico dal 1952, Cfr. La teoria Plastica di Beuys con la teoria steineriana delle api in “Über das Wesen der Bienen”) è ravvisabile sul piano formale-concettuale nella installazione dal titolo Richtkräfte (Nationalgalerie di Berlino 1976). Nel 1961 alcuni WTZ vengono esposti in una retrospettiva sul lavoro di Steiner presso il Museum Strauhof di Zurigo. Dal 1989 i WTZ vengono pubblicati in volumi a parte dalle conferenze ed inseriti nel quadro generale dell’opera omnia di Steiner. Dal 1992, grazie all’interessamento di due allievi di Beuys, Johannes Stüttgen e Walter Dahn, e al supporto tecnico e teorico del direttore dell’Archivio di Steiner a Dornach (Rudolf-Steiner Nachlaßverwaltung), Dr. Walter Kugler, i disegni vengono esposti in tutto il mondo (Germania, Giappone, Stati Uniti, Sud America, Svezia, Svizzera). Tra le opere ricordiamo: “Fondamenti di una gnoseologia goethiana” (1886), “Filosofia della libertà” (1894), “Il Cristianesimo come fatto mistico” (1902), “Teosofia” (1904), “L’iniziazione” (1904), “Dalla cronaca dell’akasha” (1904), “I gradi della conoscenza superiore2 (1905), “La saggezza dei Rosacroce” (1907), “La scienza occulta” (1910), “Il mondo dei sensi e il mondo dello spirito” (1911), “Vita da morte e nuova nascita” (1913), “La soglia del mondo spirituale” (1913), “Esigenze sociali dei tempi nuovi” (1918), “Arte dell’educazione” (1919), “La questione sociale” (1919), “L’uomo, sintesi armonica delle attività creatrici” (1923), “Antroposofia” (1924), “La mia vita” (1925).
IL PENSIERO
Nel 1913 si staccò dalla Società Teosofica per fondare la Società Antroposofica con sede a Dornach in Svizzera, nel “Goethenaum”, un tempio appositamente costruito. L’Antroposofia si distingue dalla Teosofia per il maggior rilievo conferito alla natura e al destino dell’uomo. Centro della dottrina antroposofica è la distinzione nell’uomo di sette principi: il corpo fisico, il corpo etereo, il corpo astrale, l’io, l’io spirituale, lo spirito vitale, l’uomo-spirito. Con la morte il corpo fisico si dissolve, mentre quelli etereo e astrale accompagnano l’io in un periodo di sonno profondo che precede una successiva incarnazione. Il ciclo delle rinascite, coinvolgendo l’intero cosmo attraverso millenni di evoluzione, è destinato a concludersi con “l’universale ritorno allo Spirito puro”. Steiner mutuò da Hudson la teoria delle due menti e dei due emisferi. Il cervello di destra – l'”altro tu” – ha a che fare con le intuizioni, i “significati globali”, le forme complessive; è la parte di noi che apprezza la musica e la poesia. Il cervello sinistro studia il mondo al microscopio; è ossessionato dal “qui e ora”. Ha a che fare col linguaggio, la logica e il calcolo. L’emisfero destro porta in sè lo “spazio dell’anima”, un mondo interiore che Steiner riteneva reale, parallelo e, in qualche modo, ispezionabile. “Per visitare i nostri mondi interiori – anche solo per essere completamente assorbiti da un libro o per ascoltare la musica – dobbiamo perdere l’abitudine di essere sempre all’erta. Dobbiamo acquisire l’abitudine al rilassamento, al mettere da parte le nostre ansie”. Steiner era convinto che coll’addestramento chiunque potesse sviluppare la facoltà di vedere questo altro regno dell’essere. Per accedere ad esso occorre sviluppare “la visione interiore”: una sorta di “percezione extrasensoriale” che non ha niente a che fare con la chiaroveggenza o lo spiritismo. Huxley sostiene che ci sono due modi per vivere quello strano continente: le droghe e l’ipnosi. Il metodo di Steiner ha a che fare piuttosto con quest’ultimo. Egli sosteneva di essere una di quelle persone che sono nate colla capacità di “rilassarsi dentro il cervello di destra”. Aveva esplorato quel mondo mentale che ciascuno porta dentro di sè: Sapeva che esisteva. E non cessava mai di ripetere ai suoi amici: ” sbagliate a trattare il mondo della mente come se fosse soltanto una metafora. E’ un’altro paese, e tutti abbiamo il passaporto per entrarci”. I suoi insegnamenti raggiunsero gli angoli più remoti del mondo (egli diede origine a vere e proprie scuole e “scienze applicate”: dalla pedagogia alla medicina, all’agricoltura all’economia, ecc.) . Scrisse una quantità straordinaria di libri dai titoli più strani e dai contenuti più stupefacenti epperò la valanga di idee proposte oscurano la chiarezza e la semplicità della sua visione di base che, a tratti e a lampi ci illumina sul suo segreto imperscrutabile. Ma al di là delle pretese della ragione, quello che ci attrae è di essere stati in contatto con una mente capace di questa straordinaria qualità di esperienza interiore. Il pensiero estetico-filosofico, che nel nostro discorso preannuncia l’operato di Rudolf Steiner in qualità di pensatore e artista, verte sull’unione del principio della metamorfosi goethiana con l’estetica di Schiller: dal Tutto dipendono le parti che aspirano a compiersi nel loro incessante divenire sempre le stesse, ma mai identiche. Solo all’arte è dato di sconfinare ciò che alla natura è interdetto. In questo gioco creativo è data all’uomo la libertà concreta, e non meramente idealistica o fantastica, del suo essere per il mondo. Rudolf Steiner indica il soggetto della nostra enunciazione, ma non la significa. Il soggetto del nostro discorso è costantemente eccentrico rispetto ai canali entro i quali ogni volta sembra attuarsi la sua visione del mondo. Niente è più nascosto di quanto ciò che nell’operato steineriano appare: il segno grafico, che si colloca nell’interdetto, fa parte di un processo di pensiero attuato nel discorso in atto di cui, al suo apparire sotto forma di segno grafico, il portatore si è già disfatto. I disegni alla lavagna tracciati da Steiner durante le conferenze, essendo gesti che nascono da-e-con-la parola e rifluiscono in essa, si sono rivelati come l’eventualità di un’opera d’arte. Il discorso in atto nelle conferenze appare anch’esso come l’eventualità di una filosofia pratica, di un idealismo concreto che, nel disfarsi di ciò che crea, per sempre ri-generare la libertà del creare, rende possibile l’esperienza di ciò che diviene. Attraverso il disparire del detto, nell’intervallo di senso, ci appare l’evento di un segno che, nell’intenzione originaria, non tenta la permanenza. La negazione della parola scritta, negata dall’attività di Steiner conferenziere, attesta la volontà di depensare l’opera. La parola si viene a posizionare nella stasi dell’azione discorsiva e nella scissura tra immagine e parola viene recuperata l’origine di un fenomeno primordiale. Fruire dopo sessant’anni di latenza storica di questi disegni attesta il ritorno ad un linguaggio fittizio che sta a fondamento di un soggetto che insiste a non divenire il vettore di significati permanenti. Steiner si è occupato del sovrasensibile attraverso l’arte per non sottrarre forza alla vita; si è rivolto al pensiero filosofico e scientifico per ribaltare le categorie estetiche del bello e dell’idea per “vedere la scienza con l’ottica dell’artista e l’arte con quella della vita” (Goethe) superando d’un solo colpo la dicotomia tra la scienza e ciò che pertiene all’operare artistico: l’arte come vettore di conoscenza e la scienza assunta come metodo conoscitivo. Per Steiner non esiste realtà che non sia visibile, attraverso l’arte l’invisibile si dischiude alla forma apparente. L’arte si assume il compito etico di pre disporre alla libertà senza scadere nell’illusione o nell’arbitrio soggettivo di chi crea. L’arte infine “non è un’idea in forma sensibile, ma è una realtà sensibile in forma di idea.” La domanda a cui abbiamo cercato di non rispondere è se le lavagne di Steiner siano o no delle opere d’arte. Attraverso la negazione di un assunto teoretico abbiamo cercato di slittare sui significanti avendo ben chiara l’apertura al possibile determinata dall’atto creativo; questa apertura è ciò che dal nostro punto di vista costituisce il senso di una vera critica, al di là delle categorie artistiche e dei termini storicizzati, di cui pure, dovendone tener conto in questa sede, affermiamo l’importanza negandone l’assolutezza. II fondatore Nella sua autobiografia “II cammino della mia vita”, Rudolf Steiner (1861-1925) parla di esperienze soprasensibili che incontrarono opposizione nel suo ambiente. Il materialismo imperante lo ripugnava. I suoi obiettivi erano in contrasto con la sua idea dei mondi superiori. Malgrado ciò, riprese alcune idee di gente come Ernst Haeckel e Friedrich Nietzsche, per trasporle in seguito sul “livello superiore” della sua neonata “Scienza dello spirito”. Rudolf Steiner formulò la dottrina antroposofica fra il 1902 e il 1909. Accanto alle fonti induiste e buddiste, egli si ispirò soprattutto alla concezione nietzschiana del “ritorno dell’identico” per sviluppare la sua dottrina del ripetersi della vita sulla terra, cioè della reincarnazione. In quanto editore degli scritti scientifici di Goethe e collaboratore dell’archivio goethiano di Weimar, Steiner studiò approfonditamente il pensiero scientifico e filosofico di questo autore classico. Goethe aveva sviluppato l’idea di una “pianta originaria” soprasensibile, che conteneva, in quanto concetto superiore, tutte le singole piante sensibili. Spirito e materia rappresentano un’unità in cui lo spirito è il principio formante. Steiner riprese quest’idea e suppose l’esistenza di un'”idea originaria” anche per gli uomini e tutto il cosmo, che verrebbe raggiunta nella sua completa purezza in seguito ad uno sviluppo evolutivo. L’uomo attuale, rilevabile attraverso i sensi, rappresenterebbe quindi, uno stadio transitorio verso l’uomo spirituale. Attorno al 1900 Steiner entrò a far parte della Società teosofica, fondata nel 1875 dal medium Helena Petrovna Blavatsky. I teosofi propagano un miscuglio di dottrine esoteriche e gnostiche, “rivelate”, come essi affermano, in modo soprasensibile. Steiner si distanziò inferiormente da molte di queste dottrine. I contrasti portarono infine all’allontanamento dai teosofi e alla fondazione della Società antroposofica nell’anno 1913. Percorrere la via della conoscenza antroposofica significa ottenere dei poteri occulti di veggenza. L’obiettivo finale è lo stesso di altri sistemi occulti, come la via dello yoga, la via gnostica o la meditazione dei rosacrociani: l’uomo deve creare in sé le prerogative perché il “mondo spirituale” soprasensibile, cioè il mondo degli spiriti, possa penetrare in lui. A questo scopo le percezioni esterne devono passare sempre più in secondo piano, il pensiero, la volontà e i sentimenti devono concentrarsi sulle realtà soprasensibili, l’intelletto deve essere eliminato. Steiner sviluppò quattro stadi:
1. Stadio della scienza dello spirito. Con esso si intende soprattutto la lettura degli scritti di Steiner con un atteggiamento di apertura e privo di pregiudizi. Con ciò si persegue un triplice obiettivo: (a) una scuola di pensiero – nel campo dell’antroposofia; (b) una trasformazione della persona attraverso una piena identificazione nei contenuti; (c) una scuola di estetica.
2. Immaginazione. Quando l’anima si dedica a immagini, parole, formule o sentimenti simbolici, essa si libera dal campo fisico. Questo processo coincide con la tecnica della meditazione e dei mantra induisti. La persona si dissolve “con piena coscienza in due IO”. Essa deve “cancellarsi”.
3. Ispirazione. Immagini e simboli esteriori non sono più necessari dopo il distacco dalla realtà fisica. Si ascende quindi alla lettura di uno “scritto misterioso” (Cronaca di Akasha) e al pensiero asensuale. Si ottiene un “udito inferiore”. L'”IO superiore” entra in contatto con gli spiriti che pensano in lui e formano il suo corpo astrale.
4. Intuizione. Mentre l’ispirazione significava entrare in contatto con un essere spirituale, l’intuizione significa “essere diventati completamente uno con esso, essersi uniti interiormente” e rappresenta quindi un ulteriore gradino sulla via della conoscenza soprasensibile.
Steiner però si oppose allo spiritismo terra-terra e alla comune chiaroveggenza. Ma la sua via è poi tanto diversa da quelle? Tutta la via della conoscenza serve alla dissoluzione della personalità e all’eliminazione del pensiero critico. Ciò risulta evidente per esempio nello sviluppo di “due IO”, nella “cancellazione” del Sé e nell’infiltrazione di “mondi superiori”. Gli psicologi definiscono ciò che accade in questo caso uno sdoppiamento della personalità con la perdita del senso della realtà. Dal punto di vista biblico, invece, si tratta di un’apertura all’azione demoniaca. Il sistema di Rudolf Steiner rappresenta un sistema religioso con carattere autoritario. Esso sussiste o crolla con la fede nel suo fondatore, nella sua via della conoscenza e nelle sue visioni. Se Steiner si è sbagliato, tutto il sistema antroposofico crolla come un castello di carte. Come molti chiaroveggenti, Steiner lesse anche la Cronaca di Akasha, una misteriosa cronaca eterea, che è situabile in qualche luogo indefinito fra la terra e il cielo e che conterrebbe la descrizione di tutti gli avvenimenti passati, presenti e futuri. Si tratta di una memoria universale che ha le sue origini nell’induismo, in cui colui che medita può penetrare tramite la fusione con il macrocosmo. Per scoprire qualcosa sul passato, tramite la Cronaca di Akasha, Steiner ritornò alle anime dei personaggi direttamente coinvolti. Per esempio rivisse le battaglie di Cesare nell’anima di Cesare. Ciò non è altro che il noto fenomeno occulto dell’interrogazione degli spiriti dei defunti, anche se su un livello più alto, mascherato di “scientificità”. Agli occhi di Dio, però, tali azioni sono “un abominio” (Deuteronomio 18:8 e seguenti). L’antroposofia rappresenta un culto dell’io. Passi biblici come Galati 2:19 e seguenti (“lo vivo; ma non più io, bensì Cristo vive in me”) vengono interpretati in modo da affermare che il mio “IO inferiore” è morto, mentre Cristo risorge quale mio “IO superiore”. Cristo non viene considerato un interlocutore reale e personale, ma in un certo senso una parte dell’uomo. In questo modo però, l’autodivinizzazione dell’uomo raggiunge il suo apice. In base alla testimonianza della Rivelazione biblica. Gesù Cristo è il figlio dell’Iddio vivente e personale. Egli è l’unica via che conduce al Padre, e ha compiuto tramite la sua morte espiatoria sulla croce la completa salvezza e la liberazione dai nostri peccati. Tramite la potenza della sua risurrezione egli offre ad ogni uomo, che crede in lui, la vita eterna. Steiner invece fa di Cristo un “principio”, un impulso cosmico, che continua a tenere in moto l’evoluzione. Secondo lui si tratterebbe dell’impulso all’autoredenzione, all’avanzamento del processo evolutivo attraverso le incarnazioni e la somma di buone opere. Si tratta di due concezioni completamente opposte. Nell’antroposofia, alla rivelazione biblica, si oppone una speculazione umana e occulta. In base alla dottrina antroposofica, il pensiero del karma è alla base di ogni buona azione, cioè il tentativo di autoredimersi attraverso una vita lodevole. Ciò però è in netto contrasto con il messaggio del vangelo della salvezza, secondo il quale l’uomo è incapace di salvarsi da solo e soltanto Dio ha compiuto la salvezza. Soltanto chi pone tutta la sua fiducia in Gesù Cristo e crede che egli è morto come vicario per i suoi peccati, può essere salvato. Senza dubbio le buone opere restano delle buone opere. Perlomeno agli occhi degli uomini. Ma ciò non implica necessariamente che esse siano apprezzate anche da Dio. Agli occhi di Dio è buono soltanto ciò che avviene concordemente alla sua volontà. Se qualcuno vuole guadagnarsi la salvezza con le sue opere, tali opere non possono più essere buone agli occhi di Dio. Come in ogni altro caso, però, anche qui vale il fatto che Dio – e Dio soltanto – conosce il cuore del singolo e a lui non sono occulti i suoi e i miei moventi. Possiamo condannare la dottrina antroposofica, ma non il singolo seguace di tale dottrina (Matteo 7:1). Senza radici non si hanno dei frutti. Ciò significa che la pedagogia, la medicina, l’agricoltura, l’arte e tutte le altre attività antroposofiche sono influenzate e permeate della concezione dell’universo di Steiner e del suo occultismo. Nella pedagogia la concezione dell’uomo steineriana determina cosa e quando qualcosa debba essere insegnato. L’insegnamento scolastico viene suddiviso, secondo la dottrina dei quattro corpi, in ritmi settennali. L’insegnante deve fornire al bambino degli “aiuti per la reincarnazione”. L’uomo viene giudicato in grado di raggiungere la perfezione in base alle ideologie dell’evoluzionismo e dell’umanesimo. Le storie bibliche vengono studiate accanto alle favole, alle leggende, ai miti, con un miscuglio di religioni. Termini, pratiche, contenuti didattici (p.e. l’euritmia) e lo stile architettonico antroposofico caratterizzano la giornata scolastica perlomeno in modo subliminale. Continuamente si diffondono inviti a manifestazioni della Società antroposofica e spesso anche alle cerimonie di consacrazione della “Comunità dei cristiani” proceduta dall’antroposofia. La vita in una scuola Waldorf non è quindi affatto ideologicamente neutrale. Anche nella medicina antroposofica la suddivisione dell’uomo in corpi visibili e sensibili e in corpi invisibili e soprasensibili determina la diagnosi e la scelta dei medicinali. Si afferma che “forze misteriose” e “spiriti gerarchici” parlino all’uomo tramite i prodotti alimentari e i medicinali. Le sostanze non sono morte, ma sono considerate animate da un “mondo spirituale soprasensibile” che agisce nel corpo, per esempio attraverso il potenziamento omeopatico. I prodotti Weleda e Wala rientrano in questo campo. Anche nell’agricoltura biologica-dinamica sviluppata da Steiner, la materia viene considerata animata, portatrice di poteri terreni e cosmici. Tenendo conto delle costellazioni astrologiche e di processi alchimici, i preparati vengono prodotti e “dinamizzati”. In altre parole, vi vengono racchiuse le energie cosmiche. Come esempio ecco due citazioni dal “Corso di agricoltura” di Steiner. Contro i topi di campagna egli consiglia la seguente “ricetta”: “Nel periodo in cui Venere si trova nel segno dello Scorpione, ci procuriamo la pelle di questo topo e la bruciamo, prendendo accuratamente ciò che si sviluppa tramite la combustione, cioè quello che rimane – (…) In ciò che è stato distrutto dal fuoco, resta soltanto la forza negativa nei confronti della forza riproduttiva del topo di campagna. Se quindi la sostanza ricavata in questo modo (…) viene sparsa sul campo, se è stato passato per il fuoco nel modo giusto al momento della massima congiunzione di Venere e dello Scorpione, si otterrà il mezzo che terrà lontani i topi da quel campo.” Steiner espone quanto segue a proposito del fertilizzante contenuto nel corno di mucca: “Sotterrando il corno di mucca con il suo contenuto di letame, conserviamo nel corno di mucca le forze che esso esplicava abitualmente nella mucca stessa, cioè riflettiamo ciò che è vivificante e astrale (…) Il contenuto di letame del corno verrà interiormente vivificato con queste forze (…) Tutta la vita viene conservata in questo letame…” Qui troviamo un’unione dell’astrologia e della magia. L’agricoltura biologica-dinamica con i suoi “prodotti Demetra” (Demetra era la dea della fertilità pagana dei greci) va nettamente distinta da altri metodi agricolturali – quello biologico-organico o quello integrato – in cui non si fa uso di questi metodi occulti. Nell’arte antroposofica (p.e. euritmia e architettura) si vuole esprimere la presenza di mondi soprasensibili tramite il linguaggio, il movimento e la forma. “Con una palpante atmosfera di attesa si ascolteranno i movimenti delle vocali, delle consonanti, dei pianeti e delle posizioni zodiacali in sé, per poter scoprire le forze e i movimenti spirituali che hanno formato la varietà di forme della nostra terra e dell’uomo… L’euritmia vorrebbe proseguire il lavoro che gli esseri superiori hanno compiuto nell’individualità prima della nascita e poi, durante la prima infanzia, nella formazione dell’organismo, nello sviluppo delle facoltà motorie, del linguaggio e del pensiero.” (da: E. Göbel, “Euritmia nella scuola materna”). Con l’euritmia e nelle rappresentazioni di misteri di Steiner, vengono praticate delle vere e proprie danze spiritiche. Vorrei mettere in guardia contro le istituzioni antroposofiche. Anche se trasmettono molte cose che apparentemente sembrano positive, giuste e affascinanti, attraverso la e fascino si affaccia il potere del male. Non per nulla la Bibbia ci avverte che Satana si traveste da “angelo di luce” (2 Corinzi 11:14). Chi pensa di poter raccogliere i frutti dell’antroposofia, senza rimanere avvelenato dalle sue radici, si illude. La Bibbia critica espressamente l’antroposofia. L’apostolo Paolo scrive infatti nella Prima Lettera ai Corinzi, al capitolo 2, versetti 1 a 5: “E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza; poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. lo sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore; la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di Spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana (greco sophia anthropo = antroposofia), ma sulla potenza di Dio.” Tutti i veri filosofi sono artisti dei concetti. Per loro le idee divennero materiale artistico, e il metodo scientifico tecnica artistica. Il pensare astratto acquista così vita concreta e individuale. Le idee diventano forze di vita. (Rudolf Steiner, 1894, GA 4: 199) L’analisi del pensiero di Rudolf Steiner affrontata in questo contesto storico-artistico predilige un punto di vista specifico all’interno del vasto orizzonte di senso offerto dall’ermeneutica steineriana. Un punto di vista dal quale emerge un caso critico del tutto particolare: il caso di un “filosofo-artista”. Per Friedrich Nietzsche, secondo Martin Heidegger, scegliere la prospettiva dell’arte per la pratica della conoscenza significa non intendere più: il concetto di filosofia secondo la figura del moralista, di colui che, contro questo mondo che non vale niente, pone un mondo superiore,… contro questo moralista nichilista,…deve essere posto l’anti-filosofo, il filosofo del contromovimento, il “filosofo-artista”. Questo filosofo è artista in quanto forma, operando sull’ente nel suo insieme, ossia anzitutto là dove l’ente nel suo insieme si manifesta, sull’uomo. (cors. nostro) Steiner cominciò a leggere Nietzsche dal 1889: “il primo libro che lessi fu Al di là del bene e del male…,amavo il suo stile, amavo il suo ardimento…, mi sentivo vicino a lui nelle lotte e sentivo anche di dover trovare un’espressione a questo senso di affinità.” Steiner, La mia vita -tit. or. Mein Lebensang (1923-1924), pubblicata sul settimanale “Das Goetheanum”, ora in GA 28: 141. Il legame che si instaurò tra il pensiero di Steiner e quello nietzschiano fu immediato : ” io sentii in Nietzsche quel libero librarsi delle sue idee, la loro lievità mi entusiasmavano perché quel suo libero volare aveva maturato in lui molti pensieri simili a quelli che, per vie del tutto diverse, s’erano formati in me…, la mia fiducia in lui fu immediata…, dirò che lo compresi come se avesse scritto per me.” Steiner, GA 28:193 L’opera di Steiner, lungo i percorsi speculativi che attraversano il pensiero estetico, si coniuga in più luoghi con la visione del mondo nietzschiana, di cui Steiner approfondisce la conoscenza durante il suo lavoro presso l’Archivio Nietzsche a Weimar nel 1894. ( cfr. Rudolf Steiner, Friedrich Nietzsche, Ein Kämpfer gegen seine Zeit, (1895), 3 ed. 1963 RSN, pp. 203, GA 5, tr.it. Friedrich Nietzsche, un lottatore contro il suo tempo, 1 ed. Lanciano, Carabba 1925, 2 ed. Roma, Tilopa 1991). L’anno seguente, sotto l’enunciato: Nietzsche un lottatore contro il suo tempo, Steiner pubblica una trattazione sulla dottrina nietzschiana in cui pone in luce le innovazioni e i limiti del pensiero del filosofo indicando i confini e le aspirazioni in cui egli vede incarnato il destino del XIX secolo. Steiner edifica il programma scientifico-spirituale della sua filosofia realizzando il suo progetto di mondo attraverso la messa in opera di ciò che egli chiama Antroposofia: la conoscenza dell’uomo. “Ogni cosa prodotta” da Steiner in nome della Antroposofia è all’insegna dell’arte e questo suo “saper produrre” è sotto il segno di un pensiero d’artista. Prima di procedere oltre è per noi di fondamentale importanza chiarire, attraverso l’interpretazione heideggeriana, il senso che Nietzsche attribuisce alle parole: arte e artista. Ciò è essenziale poiché tutte le volte che compariranno i termini arte e artista li impiegheremo unicamente nel significato elaborato dal pensiero nietzschiano: Arte non significa qui il ristretto concetto odierno nell’accezione di ‘belle arti’…, Nietzsche interpreta quel precedente uso del termine arte inteso in senso lato, nel quale le ‘belle arti’ sono soltanto una specie di arte fra le altre…, l’artista in senso stretto che produce opere di ‘belle arti’ è “solo uno stadio preliminare” (Martin Heidegger, Nietzsche, ) L’interpretazione di Heidegger circoscrive quindi il senso conferito alla parola arte identificandolo con il concetto: “ogni cosa prodotta” e il concetto relativo alla parola artista con “ogni saper produrre”. Il senso dei due concetti così determinato indica una direzione ermeneutica che consente di risalire all’assunto teorico che è alla base dello sviluppo del pensiero di Steiner e costituisce una sorta di manifesto sintetico-programmatico ante litteram di tutta la sua attività conoscitiva. Ed ecco in che senso Steiner incarna, dal nostro punto di vista, il filosofo-artista auspicato da Nietzsche: Il filosofo-artista. Superiore concetto dell’arte. Se l’uomo possa porsi tanto distante dagli altri uomini da plasmarli ? (Esercizi preliminari: 1- colui che plasma se stesso, il solitario; 2- l’artista quale è stato finora, cioè un piccolo perfezionatore, rispetto ad una materia). (F. Nietzsche) L’artista che secondo Nietzsche si è rivolto finora solo alla materia non può essere che un “piccolo perfezionatore”; il filosofo, colui che non può far altro che plasmare il suo pensiero, non è che un solitario. L’artista e il filosofo quindi sono solo ad uno “stadio preliminare” della vera conoscenza. Ma entrambi sono necessari per poter concepire il frutto della loro unione: “il filosofo-artista”, colui che sarà in grado di creare un “superiore concetto dell’arte”.
RICHARD RORTY
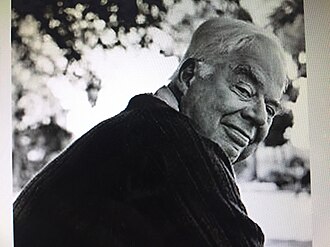
“La giustificazione, da parte del pragmatista, della tolleranza, della libera indagine, della ricerca di una comunicazione non distorta, può soltanto prendere la forma di un paragone tra società che esemplificano questi abiti e quelle che non li esemplificano, conducendolo al suggerimento che nessuno che le abbia sperimentate entrambe vorrebbe preferire le ultime. ” (Solidarity or Objectivity?)
VITA E OPERE
Fra i pensatori statunitensi più noti e discussi Richard Rorty rappresenta lo studioso che più di ogni altro ha spezzato i legami con la filosofia analitica e con la maniera tradizionale di fare filosofa. Rorty nasce a New York nel 1931. Dopo aver insegnato filosofia a Princeton, è passato al Dipartimento di discipline letterarie dell’Università della Virginia. La sua formazione è avvenuta a Chicago e a Yale, due “bastioni di resistenza”, come dirà il suo compagno di studi R. Bernstein, alla dilagante egemonia della filosofia analitica. Circostanza che però non esclude il peso di tale filosofia nella formazione di Rorty, ma che, fin dall’inizio, gli ha permesso di muoversi in orizzonti più vasti. Lui stesso dichiarerà in seguito di dovere molto ad alcuni fra i principali esponenti “eterodossi” della filosofia analitica: W. Sellars, Quine e, in misura minore, Goodman. Altri autori che hanno influito sul suo pensiero sono Kuhn e Davidson. Nel 1901 appare il suo primo articolo pubblicato, ” Pragmatism, Categories and Language “, in cui manifesta interesse per Pierce e introduce ” temi che avrebbero pervaso il suo lavoro: la tradizione pragmatistica americana e il potere terapeutico dell’ultimo Wittgenstein ” (R. Bernstein). Successivamente, partecipa alle discussioni sul rapporto mente-corpo, approdando ad una prospettiva antidualistica, basata sulla tesi, condivisa da Feyerabend, secondo cui ” non ci sono menti, ma soltanto cervelli “. Nel 1967 pubblica un’ampia raccolta di testi della tradizione analitica, nelle sue varie espressioni e correnti. Nell’introduzione, intitolata “Difficoltà metafilosofiche della filosofia linguistica”, Rorty inizia a prendere le distanze da tale tradizione, esaminando, al tempo stesso, una serie di possibili scenari alternativi per la “fine” della filosofia. Egli ritiene che il pensiero analitico, sia quello di matrice neopositivistica, sia quello del linguaggio ordinario, pur non avendo rispettato la promessa di fare, della filosofia, una scienza, abbia pur sempre avuto il merito di attirare l’attenzione sulle difficoltà epistemologiche della filosofia tradizionale: ” la cosa più importante che è accaduta nella filosofia degli ultimi trent’anni non è la svolta linguistica come tale, ma piuttosto l’inizio di un ripensamento a tutto campo di certe difficoltà epistemologiche che hanno tormentato i filosofi a partire da Platone e Aristotele ” (“La svolta linguistica”). Negli anni Settanta-Ottanta (a partire dal suo grande successo, “La filosofia e lo specchio della natura”, 1979), Rorty approda ad una prospettiva radicalmente post-analitica e post-filosofica, caratterizzata da un recupero della tradizione pragmatistica americana (Dewey, James) e da un confronto creativo con l’heideggerismo, l’hegelismo, il nietzscheanesimo, l’ermeneutica, il decostruzionismo, il postmoderno ecc. Nello stesso tempo, accentua i suoi interessi letterali, confrontandosi non solo con i filosofi, ma anche con gli scrittori (Proust, Nabokov, Orwell ecc). Tra i suoi scritti meritano di essere menzionati: “La svolta linguistica” (1967), “La filosofia e lo specchio della natura” (1979), “Conseguenze del pragmatismo” (1982), “Contingenza, ironia e solidarietà” (1989), “Oggettività, relativismo e verità” (1991), “Saggi su Heidegger e altri articoli filosofici” (1991), “Verità e progresso” (1998). Il lavoro del 1989 è stato tradotto in italiano con il titolo “La filosofia dopo la filosofia”. I lavori successivi sono stati raccolti sotto il titolo “Scritti filosofici”.
FILOSOFIA, MENTE, CONOSCENZA
L’impegno di Rorty non è quello di escogitare nuove concezioni circa i tradizionali oggetti della filosofia (Dio, l’essere, l’Uomo ecc.), ma quello di sbarazzarsi di un bimillenario modo di filosofare. Al centro della sua riflessione troviamo infatti una serrata polemica contro la Filosofia (la maiuscola designa la tradizione filosofica “ufficiale” a cui egli intende contrapporsi) e un atteggiamento “terapeutico”, come egli stesso lo definisce, contro la corrente dominante del pensiero occidentale: ” i pragmatisti ritengono che la più grande aspirazione della filosofia è quella di non praticare la Filosofia “. Questa impostazione risulta evidente soprattutto in “La filosofia e lo specchio della natura” : l’immagine canonica della filosofia, dice Rorty in questo scritto, che più di ogni altro ha contribuito alla sua fama di studioso, è quella di un ” sapere fondazionale ” che giudica la validità di tutte le altre aree della cultura (dalla scienza alla religione, dalla matematica alla poesia) assegnando, ad ognuna di esse, un posto specifico. Tale immagine trova in Kant, e nella sua concezione della filosofia come metacritica delle scienze speciali, il maggior teorico e interprete: ” dobbiamo al XVIII secolo, e in particolare a Kant, la nozione della filosofia come tribunale della ragione pura, che conferma o respinge le pretese della cultura restante ” (“La filosofia e lo specchio della natura”). In seguito, la ritroviamo nel neokantismo, nella fenomenologia, in Russell, nell’empirismo logico e nella stessa filosofia analitica, che in luogo della critica trascendentale pone l’analisi linguistica:
” Per come la vedo io, il genere di filosofia che discende da Russell e da Frege, proprio come la fenomenologia classica di Husserl, è semplicemente un ulteriore tentativo di mantenere la filosofia nella posizione in cui Kant desiderava porla: quella cioè di giudice delle altre aree della cultura. […] L’empirismo logico era una variante della canonica e accademica filosofia neokantiana incentrata sull’epistemologia. […] La filosofia “analitica” è una variante ulteriore della filosofia kantiana, una variante caratterizzata principalmente dal considerare la rappresentazione come linguistica piuttosto che mentale, e quindi la filosofia del linguaggio come la disciplina che esibisce i “fondamenti della conoscenza”, invece della “critica trascendentale” o della psicologia ” .
Il presupposto comune di queste dottrine è l’idea della Filosofia come disciplina che possiede una sua specifica e privilegiata via d’accesso ai fondamenti della conoscenza e ai meccanismi della mente: “ la filosofia può essere fondazionale nei confronti della cultura restante perché la cultura è la raccolta delle pretese di conoscenza, mentre la filosofia sottopone a giudizio tali pretese. Può fare questo perché comprende i fondamenti della conoscenza e trova questi fondamenti attraverso lo studio dell’uomo-come-soggetto-della-conoscenza, dei “processi mentali” o delle “attività della rappresentazione” che rendono possibile la conoscenza. Conoscere significa rappresentare accuratamente quel che si trova fuori della mente; in tal modo concepire la possibilità e la natura della conoscenza significa capire il modo in cui la mente riesce a costruire tali rappresentazioni. Il compito cardinale della filosofia è quello di costituire una teoria generale della rappresentazione, una teoria che sia in grado di dividere la cultura nelle aree che rappresentano bene la realtà, in quelle che la rappresentano meno bene, e in quelle che non la rappresentano affatto (malgrado la loro pretesa di riuscirci) ” . Filosofia, conoscenza e mente sono quindi idee interconnesse: ma di quale “mente” parla, polemicamente, Rorty? Della mente come “specchio”, ovvero come occhio immateriale che rappresenta, in modo adeguato o inadeguato, la realtà. Infatti, asserisce Rorty (secondo cui sono le immagini piuttosto che le proposizioni, le metafore piuttosto che le asserzioni a determinare il maggior numero delle nostre convinzioni fìlosofìche), esiste un’immagine che continua a tenere prigioniera la filosofia. È l’immagine della mente ” come un grande specchio, che contiene rappresentazioni diverse – alcune accurate, altre no – e può essere studiato attraverso metodi puri, non empirici ” (il pensiero corre immediatamente a Kant). Del resto, prosegue Rorty, senza la nozione della mente come specchio non ci sarebbe stata l’idea della conoscenza come rappresentazione accurata e quindi non avrebbero avuto senso gli sforzi di Cartesio e di Kant, volti ad ottenere ” rappresentazioni più accurate attraverso l’esame, la riparazione e la pulitura dello specchio “. Nemmeno avrebbero avuto senso, fuori di questa strategia, ” le recenti tesi secondo le quali la filosofia consisterebbe di “analisi concettuale”, o di “analisi fenomenologica”, o di “spiegazione dei significati”, o di esame della “logica del nostro linguaggio” oppure della “struttura dell’attività costitutiva della coscienza” “.
DALLA FILOSOFIA ALLA POST-FILOSOFIA
Questa teoria “speculare” o “spettatoriale” della conoscenza (che affonda le sue radici profonde in Platone e nel mondo greco, ovvero in una tradizione di pensiero che ha inteso la conoscenza in termini di metafore visive) oggi risulta in crisi. Infatti, la pretesa di uscire dalle nostre rappresentazioni, per afferrare un punto di vista esterno o neutrale, da cui potersi interrogare circa la legittimità delle rappresentazioni stesse, si è rivelata un semplice mito cartesiano-lockiano-kantiano, ovvero il frutto di una costruzione storica, da cui abbiamo preso irrimediabilmente le distanze. Tant’è che, se la Filosofia tradizionale aveva l’aspetto di un pensiero fondazionalista ed epistemologico (termini che in Rorty sono sinonimi), la post-Filosofia ha l’aspetto di un pensiero antifondazionalista e antiepistemologico (e quindi antikantiano e postkantiano). Del resto, le ambizioni epistemologiche della Filosofia sono state respinte da quelle stesse attività (la scienza, la politica ecc.) che la Filosofìa si proponeva di legittimare. E se Cartesio, Locke e Kant sono stati i fondatori della filosofia moderna, Wittgenstein, Heidegger e Dewey ne sono stati i distruttori. Infatti, dopo aver cercato, in un primo tempo, nuovi modelli di filosofia fondazionale, in un secondo tempo ciascuno di essi consumò il proprio tempo a metterci in guardia contro quelle tentazioni alle quali essi stessi avevano ceduto. Così la loro opera successiva è terapeutica piuttosto che costruttiva. Anche lo scopo di Rorty intende essere terapeutico, ossia volto a “guarire” le menti dalla filosofia e a promuovere la transizione dalla Filosofia alla post-Filosofia. Tuttavia, come risulta chiaro dalle ultime pagine del suo capolavoro, il discorso di Rorty è più articolato di quanto sembri a prima vista. Da un lato, l’autore dichiara la fine della Filosofia, assimilandola a una “malattia culturale” da cui occorre liberarsi, in vista di una nuova età postfilosofìca: ” può darsi che l’immagine del filosofo proposta da Kant stia per tramontare com’è tramontata l’immagine medievale del prete ” . Dall’altro, egli puntualizza che dopo la Filosofia ci sarà ancora la filosofia, in quanto ad essere finita non è la filosofia tout court , ma la filosofia protesa ad una fondazione sistematica dell’Essere e della Conoscenza: ” non c’è pericolo che la filosofia “si esaurisca”. La religione non è finita con l’Illuminismo, nè la pittura con l’impressionismo […] anche se la filosofia del XX secolo si avvia ad apparire come un confuso stadio di transizione […] ci sarà certamente qualcosa chiamato “filosofia” dopo la transizione ” . Convinzione ribadita in un intervento del 1990: “ sono spesso accusato di essere un pensatore della “fine della filosofìa”, e vorrei cogliere quest’occasione per sottolineare ancora una volta […] che, semplicemente, la filosofia non è un genere di cosa che possa avere una fine; è un termine troppo vago e amorfo per sopportare il peso di predicati come “inizio” o “fine” ” Per quanto concerne il presente, Rorty, dopo aver distinto tra filosofi “normali” e “rivoluzionari”, afferma che tra questi ultimi occorre distinguere due tipi: 1) quelli che ” fondano nuove scuole all’interno delle quali può essere praticata la filosofia normale e professionalizzata ” (ad esempio Cartesio e Kant, Husserl e Russell); 2) quelli che ” rifiutano l’idea che il loro vocabolario possa mai essere istituzionalizzato, o che i loro scritti possano essere considerati commensurabili con la tradizione ” (ad esempio Kierkegaard e Nietzsche, l’ultimo Wittgenstein e l’ultimo Heidegger). La simpatia di Rorty va esplicitamente a quest’ultima categoria di filosofi, che egli chiama edificanti per distinguerli da quelli sistematici: “ i grandi filosofi sistematici sono costruttivi e offrono argomentazioni. I grandi filosofi edificanti sono reattivi e offrono satire, parodie e aforismi […]! grandi filosofi sistematici, come i grandi scienziati, costruiscono per l’eternità. I grandi filosofi edificanti distruggono a beneficio della loro propria generazione ” (La filosofia e lo specchio della natura). Più in particolare, la filosofia edificante, che Rorty accosta all’ermeneutica (per la comune ispirazione storicistica e antiepistemologica), lascia cadere sia l’immagine della filosofia come sapere professionale di tipo specialistico, sia l’idea del filosofo come uno ” che conosce alcunché intorno al conoscere che nessun altro conosce altrettanto bene “, e si concretizza in una ricerca dedisciplinarizzata di nuovi dizionari e di nuove maniere di vivere e di pensare. Per queste sue caratteristiche di sapere narrativo, la filosofia re appare protesa a edificare, cioè a formare gli uomini, più che a “conoscere” oggettivate mente il mondo. In questa nuova veste, di tipo etico-formativo, la filosofia, semplice scrittura fra le scritture , non si pone più come espressione privilegiata del sapere, ma come una delle tante voci all’interno della “conversazione” complessiva dell’umanità: ” l’impegno morale dei filosofi dovrebbe essere quello di continuare la conversazione dell’Occidente ” (La filosofìa e lo specchio della natura). Conversazione che si nutre del dialogo, ossia di una “democrazia dialettica” che vive del confronto costante dei diversi punti di vista, senza pretese di sopraffazione reciproca.
CONTINGENZA, IRONIA E SOLIDARIETA’
Nello scritto “Contingenza ironia e solidarietà” (1989, tradotto in italiano con il titolo “La filosofia dopo la filosofia”) Rorty è andato sempre più accentuando la fisionomia storicistica e pragmatistica del suo pensiero. All’idea metafìsica di una descrizione privilegiata della realtà, capace di rispecchiare in modo sovratemporalmente valido l’essenza delle cose egli ha contrapposto l’idea “postmetafisica” di una pluralità mutevole di approcci al reale ossia il concetto della storicità dei vari modelli di comprensione dell’esistente (e quindi dei vari “paradigmi culturali” entro cui il mondo ci è dato) Non esiste, dice Rorty a più riprese, un mitico là fuori, che la nostra mente intesa come essenza rispecchiante, avrebbe il compito di riprodurre poiché la realtà esiste sempre all’interno di una serie di prospettive storicamente e socialmente condizionate che corrispondono a modi diversi di atteggiarsi di fronte al mondo. Alla concezione (metafisica) della verità come “scoperta”, Rorty, partendo dall’idea del mondo finalmente perduto, oppone la concezione (pragmatistica) della verità come costruzione umana, connessa a determinate pratiche sociali di giustificazione e di controllo e quindi a determinati valori. Non esiste una verità oggettiva di tipo platonico, cioè esistente al di sopra e indipendentemente dagli uomini. Vero è ciò che una determinata comunità, sulla base di determinate regole storielle di controllo e di verifica, crede, in maniera argomentata, che sia tale. Il punto decisivo dell’opera di Rorty, scrive Aldo G. Gargani, risiede ” proprio nel rovesciamento teorico che egli opera quando, in luogo di una legittimazione degli enunciati in rapporto diretto e estensivo ai loro referenti “là fuori”, indipendenti dai nostri sistemi simbolici, [ ] propone invece un nuovo modo di guardare ai nostri discorsi, che non devono essere legittimati rispetto ai princìpi o fondamenti già predisposti, ma in relazione a ciò che riteniamo migliore, più utile, più bello da fare e da pensare nell’ambito di una comunità [ ] di valori condivisi e partecipati “. Prospettiva che viene ribadita e radicalizzata nel terzo volume dei Philosophical Papers, in cui Rorty afferma che soltanto “sbarazzandosi” delle teorie tradizionali della verità la filosofia riesce ad assolvere meglio alla sua funzione culturale ed esistenziale. Questo atteggiamento neo-storicistico e neo-pragmatistico, che rifiuta ” la nevrotica ansia cartesiana di certezze “, si accompagna alla proclamata necessità di una cultura postmetafisica (osservando che ” cultura postmetafisica […] sembra non più impossibile di una cultura postreligiosa ed egualmente desiderabile “). Cultura che, per Rorty porta a termine il processo moderno di secolarizzazione e disincantamento del mondo: ” A cominciare dal XVII secolo cercammo di sostituire all’amore per Dio l’amore per la verità trattando il mondo descritto dalla scienza come una semidivinità. A partire dalla fine del XV secolo cercammo di sostituire all’amore per la verità scientifica l’amore per noi stessi, di venerare la nostra natura profonda, spirituale e poetica, trattandola come un’ulteriore semi-divinità. La prospettiva condivisa da Blumenberg, Nietzsche, Freud e Davidson ci chiede di provare a non venerare più nulla, a non considerare niente come una semidivinità a considerare tutte- linguaggio, coscienza, comunità – come un prodotto del tempo e del caso ” (La filosofia dopo la filosofìa). La nuova prospettiva di Rorty ruota intorno a tre parole-chiave: contingenza, ironia e solidarietà. Con il termine contingenza Rorty intende la tesi secondo cui non esistono essenze universali e sovratemporali, ma tutto è socializzazione e quindi circostanza storica . Con il termine ironia intende la posizione di chi riconosce il carattere storico, cioè fugace e contingente, delle proprie convinzioni. Per solidarietà intende l’atteggiamento di chi si batte per diminuire la sofferenza e l’umiliazione degli esseri umani.
DEMOCRAZIA E FILOSOFIA
I tre concetti appena spiegati caratterizzano la nuova figura dell’intellettuale postfilosofico, ossia di ciò che Rorty chiama ” l’ironico liberale “. Di fronte allo scontro fra gli studiosi in cui domina il bisogno di autocreazione e di autonomia individuale e gli studiosi in cui risulta preponderante il desiderio di una comunità giusta e solidale, l’ironico liberale invita a non scegliere tra essi ma a dar loro, invece, ugual peso, per usarli poi per scopi diversi: ” gli autori come Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger e Nabokov sono utili in quanto modelli, esempi di perfezioni individuali – di vita autonoma che si è creata da sé. Gli autori come Marx, Mill, Dewey, Habermas e Rawls sono, più che dei modelli, dei concittadini. Il loro impegno sociale, è il tentativo di rendere le nostre istituzioni e pratiche più giuste e meno crudeli ” (“La filosofia dopo la filosofia”). Di fronte alle pretese della Filosofia (metafisica) di parlare in nome dell’unica Verità e dell’unico Bene, tramite un platonico attingimento delle essenze universali delle cose (natura umana inclusa), l’ironico liberale afferma il “primato della democrazia sulla Filosofìa “, intendendo sostenere, con questa espressione, che le pretese assolutistiche della Filosofia (tradizionale) vanno ripudiate, in quanto risultano strutturalmente inconciliabili con gli assetti pluralistici e democratici delle società avanzate: ” quando entrano in conflitto, la democrazia ha la precedenza sulla filosofia “. Nelle democrazie nessuno può ergersi a custode dell’unico Vero e dell’unico Bene e nessuno può pretendere di imperli agli altri, alla maniera dei guardiani platonici. Contrariamente a quanto si afferma talora, il prospettivismo di Rorty non coincide affatto con una forma estrema di relativismo culturale. Infatti, di fronte all’anti-etnocentrismo di coloro che, partendo dal postulato antropologico dell’equivalenza di tutte le culture, rinunciano a difendere i valori della propria cultura, Rorty afferma un “etnocentrismo moderato ” che, pur essendo consapevole del carattere locale di determinati valori dell’Occidente (libertà, uguaglianza di diritti, pluralismo ecc.), ne afferma la validità transituazionale, cioè l’universalità di diritto: ” l’anti-antietnocentrismo sollecita […] ad accettare con assoluta serietà il fatto che gli ideali della giustizia procedurale e dell’eguaglianza umana sono sviluppi culturali provinciali, recenti ed eccentrici e a rendersi conto che non per questo vale meno la pena di battersi per essi; insiste sul fatto che gli ideali possono essere locali e legati a una cultura e ciò nondimeno costituire la più grande speranza della specie ” (“Scritti filosofici”).
EMMANUEL LEVINAS

A cura di Antonino Magnanimo
“ Il nostro rapporto col mondo, prima ancora di essere un rapporto con le cose, è un rapporto con l’Altro. E’ un rapporto prioritario che la tradizione metafisica occidentale ha occultato, cercando di assorbire e identificare l’altro a sé, spogliandolo della sua alterità. “
VITA E OPERE
Emmanuel Lévinas è nato a Kaunas (Lituania) nel 1905 da una famiglia ebrea e ha vissuto la rivoluzione russa in Ucraina. Nel 1923 si trasferisce in Francia a Strasburgo, dove inizia gli studi universitari, seguendo i corsi di Blondel e di Halbwachs. Nel 1928-1929 si reca a Friburgo, dove assiste alle ultime lezioni di Husserl e conosce Heidegger di cui rimase affascinato. L’ ” apprendistato della fenomenologia “, come egli lo ha definito, orienterà poi la sua ricerca personale. Dal 1930 fino alla guerra occupa diverse funzioni nella “École normale israélite di Auteuil”, che forma gli insegnanti dell’Alliance Israélite Universelle e stringe amicizia con Henri Nerson, cui dedicherà il suo primo libro di scritti giudaici ” Difficile Liberté “. Emmanuel Lévinas rievoca spesso gli anni dei suoi studi universitari a Friburgo, dove si recò prima che ” Hitler diventasse Hitler “. Fa poi ritorno in Francia prima che Hitler salisse al potere, nel 1932. E in seguito, per giustificare il fatto che Heidegger si era compromesso con il nazismo, il filosofo francese adduce la genialità del maestro tedesco. Prima della sua permanenza a Friburgo, in Francia, Lévinas aveva conosciuto Jean-Paul Sartre di cui apprezzava il ” pensiero audace e regolare “. La sua formazione filosofica inizia con Blondel che incarnava la ” luminosità dello spirito francese “, la “clarté”, l’ordine. Accanto all’incontro con Heidegger e Husserl, Lévinas ricorda l’altro grande evento della sua vita: il rapporto con Monsieur Chouchani, un genio talmudico, che aveva il Talmud dentro, incarnato, vivente. Questo sapiente ebreo gli trasmette ” il vigore intellettuale nella crudezza della potenza del Talmud ” (ebraico: disciplina), raccolta di norme religiose e legali, Mishna, e di sentenze rabbiniche, Gemara. Ve ne sono due redazioni: quella di Babilonia e quella di Gerusalemme, e molti commenti. Il Talmud contiene, tra l’altro, il credo ebraico, di 13 articoli) . La sua tradizione familiare ebraica viene alimentata, dopo questo incontro decisivo, da un giudaismo vivente. Husserl viene descritto come splendido genio che rappresenta il filosofo tedesco tradizionale, legato a doppio filo con la fenomenologia. Lévinas parla del suo incontro con Jacques Derridà, anche lui passato attraverso Heidegger e Husserl. Poi accenna alla sua lingua madre, il russo, che però non ha utilizzato per le sue opere filosofiche che ha scritto in francese o in tedesco, infarcendole di riferimenti in greco e latino. Mobilitato nel 1939, viene fatto prigioniero e sarà liberato solo nel 1945. Nell’ immediato dopoguerra riprende il suo posto all’ “École normale israélite”, questa volta come direttore, e partecipa alle riunioni settimanali di Gabriel Marcel e al “Collège philosophique” di Jean Wahl, sotto la cui direzione prepara la tesi di Stato, pubblicata nel 1961 sotto il titolo di ” Totalité et infini ” che gli apre le porte dell’insegnamento universitario. Nel 1957 inizia anche l’attività di lettura e commento del Talmud ai ” Colloques des Intellectuels Juifs de Langue Française “. Nel 1964 viene chiamato all’Università di Poitiers, nel 1967 passa a Paris-Nanterre e nel 1973 alla Sorbonne. Muore nel 1995. Le due opere fondamentali di Levinas sono ” Totalità ed infinito ” e ” Altrimenti che essere o al di là dell’essenza “. Da ricordare anche ” Nomi propri “.Il tema dell’ebraismo viene svolto nelle ” Quattro lettere talmudiche “. Un’utile lettura preliminare può essere ” Dall’esistenza all’esistente “, in cui viene posto il legame con il pensiero di Husserl e di Heidegger.
L’IMPIANTO FILOSOFICO
La filosofia di Lévinas è incentrata sul problema dell’ Etica della quale ha elaborato i princìpi primi per aprirla alla metafisica. L’etica equivale alla metafisica, perché l’unica filosofia possibile, l’unica possibile conoscenza, è quella dei princìpi primi dell’agire morale. La Bibbia e la filosofia sono in accordo, anche se la vera filosofia è quella che distrugge tutti i miti costruiti dall’uomo. Il compito della filosofia è pensare (secondo un’espressione desunta da Barth) al “Totalmente Altro” dall’Essere e dal Logos che sono le categorie di una comprensione riduttiva e fallace del reale. Lévinas ha una diversa prospettiva dell’alterità radicale. La sua filosofia nasce dallo ” stupore del silenzio di Dio ” verso le tragedie. Pensare è ascoltare la Parola dell’infinito che è udibile dal volto dell’altro nella cui nudità e povertà risplende la traccia di Dio. Ciò è possibile solo nel rispetto della sua alterità, della sua solitudine, del suo mistero e della sua persona: è questo il principio primo dell’etica che, in questo ambito, diventa metafisica: se non violo con le mie categorie onnicomprensive il mistero dell’altro, cioè se non lo riduco ad un’essenza pre-determinata e pre-giudicata, arrivo ad un tipo di conoscenza che è reale perché è traccia dell’infinito. L’alterità è totalmente estranea all’ego (frattura tra sé e l’altro) e, pertanto, la mia esperienza non sarà mai paragonabile a quella di un altro, io non posso vivere il dolore, la gioia e altre esperienze limite di un altro. Per il filosofo lituano l’etica costituisce la possibilità di uscita dalla conoscenza come comprensione dell’altro che viene generalmente assimilato a sé ed espropriato della sua alterità e diversità. L’altro, per essere tale, non può essere ricondotto né alla conoscenza che io ne ho (che è sempre un’interpretazione parziale), né all’amore che parte da me e intende abbracciarlo. Lévinas vede nell’ ” eros uno dei simboli massimi dell’alterità “, eros non è possesso, ma mistero che implica la presenza dell’infinito. Un’altra manifestazione dell’alterità è la filialità o la paternità perché la donna ha difficoltà nel distinguere il figlio da sé, mentre vero padre è colui che distingue il figlio da sé pur sentendolo da sé generato. Lévinas è contro l’amore romantico inteso come la fusione di due esseri. Il volto non può essere assorbito nella mia identità e rappresenta l’inizio della rottura con la totalità perché la vera unione è un faccia a faccia, alterità reciproche che non vengono assorbite o eliminate. La rottura della totalità è rappresentata dalla soggettività umana, ridefinita da Lévinas nel volto che esprime il mistero del soggetto. La società non sarà mai la somma di soggettività fuse nel tutto, ma sarà fondata su una relazione intersoggettiva che non abolisce l’altro, ma ne rispetta il mistero. L’altro è soggettività che trascende la totalità. L’etica di Lévinas è una forte provocazione per chi svilisce il messaggio evangelico dell’amore nell’estensione della propria soggettività. Il rapporto con l’altro non è immediato, ma è mediato dall’Infinito. Il culmine dell’identità è la distinzione, il culmine dell’amore è l’alterità personale pienamente realizzata nel rapporto, il culmine della giustizia è il faccia a faccia con l’altro, che è tutto ciò che impedisce di ridurre l’altro a me. Per questo Lévinas può affermare che il principio primo dell’etica è la separazione , ossia il muoversi verso l’altro sentito come altro da sé; occorre considerare sempre l’altro come un fine e mai come un mezzo. Se nel volto dell’altro risplende l’ “Eglità” come traccia dell’Infinito, tuttavia questa traccia non giunge mai a farsi realmente segno di Dio che rimane, perciò, assente perché la traccia sul volto dell’altro è cancellata come una traccia lasciata sulla sabbia che è traccia di un passato e di un’assenza. L’essenza viene vista come totalità che fa di tutte la cose degli oggetti per me, da me utilizzabili e, quindi, apre la prospettiva della violenza, mentre il volto altrui è il Totalmente Altro da me, è per sé e, dunque, non manipolabile da me, in quanto segno del Mistero.
L’ETICA DELLA DIFFERENZA
L’opera di Lévinas è assillata da ciò che non può essere detto. Una comunicazione con l’altro che lo lasci essere altro, senza ridurlo alla comune misura. Ultima grande architettura filosofica del Novecento, quella di Emmanuel Lévinas è un’opera compatta, che non consente estrapolazioni, poiché ogni singolo frammento rinvia al disegno d’insieme. E come se la scrittura sorvegliasse il suo lettore, lo obbligasse a cercare la chiave. Per usare un termine che Lévinas stesso ha indicato come cifra della propria ossessione, il lettore è ” ostaggio del testo ” su cui inavvertitamente si è chinato. Erede e interlocutore discreto del grande Novecento filosofico, ha nutrito la propria scrittura di scetticismo e gentilezza, l’unico modo di trattare e amare il cuore segreto dell’utopia senza cedere alle lusinghe della grandezza. Scrittura rigorosa, incatenata e paziente. Nessuna concessione agli estetismi tanto cari a buona parte degli epigoni della filosofia heideggeriana. Parole come esposizione, vulnerabilità, prossimità, sostituzione, ostaggio, sono altrettanti distillati di un rigore che non consente abusi, pena il tradimento dell’intenzione profonda che li unisce. Fanno esplodere il linguaggio filosofico dall’interno come gocce d’acqua che ritornano dalla loro congelazione. Conducono la filosofia al punto della sua fissione, costringendola a sé fino alla rottura, all’apertura, che non è rinuncia, ma rivelazione della pienezza stessa. L’etica della differenza, dell’alterità che sussiste fra me e il prossimo, è alla base del pensiero ermeneutico di Lèvinas. Il nostro rapporto col mondo, prima ancora di essere un rapporto con le cose, è un rapporto con l’Altro. E’ un rapporto prioritario, che, invece, la tradizione metafisica occidentale ha occultato, cercando di assorbire e identificare l’altro a sé, spogliandolo della sua alterità. Ciò è stato fatto privilegiando l’essere, cioè la realtà nel suo aspetto generalissimo, in cui vengono a smarrirsi le differenze, le individualità, che sono, invece, irriducibili le une alle altre. ” L’essere è il non senso: ha senso solo l’esistente, l’uomo “. E l’esistente acquista significato solo in relazione all’Altro, cioè attraverso una comunicazione interumana nella quale l’Altro non viene assimilato a me. Dell’Altro non ci si può appropriare in alcun modo, l’Altro irrimediabilmente mi sfugge perché non ha alcun comun denominatore con me. Il volto dell’Altro, degli Altri, è al di là dell’immagine che di loro mi faccio.
IL SENSO DELLA VITA
Lévinas cerca di accordare le tradizioni della Bibbia e della filosofia. Se esse non si sono conciliate è perché ogni pensiero filosofico si fonda su esperienze pre-filosofiche come, per lui, è stata la lettura della Bibbia, il cui miracolo è il confluire di letterature diverse verso uno stesso contenuto essenziale. Il polo di questa influenza è l’etica e, in questo modo, la verità etica è comune. La religione non è identica alla filosofia, la quale non necessariamente offre le consolazioni che può dare la religione. Il filosofo si deve porre accanto alle cose senza illusione, rispettando la loro oggettività (sono altro da me). Per chiarire dove nasce l’esistente, Lévinas analizza la nozione di “il ya” che è l’essere in generale. L’esistente esce dall’esistenza, il sensato prende vita spezzando la neutralità dell’essere. ” L’essere e la realtà sono puro non senso, chi ha senso e dà senso è l’esistente, l’uomo “; in quest’ottica si può scorgere sullo sfondo il pensiero di Heidegger che vedeva l’uomo come l’ente che si pone la domanda sul senso dell’essere. Una corretta impostazione di questo problema, richiede una esplicitazione preliminare di quell’ente che si pone la domanda sul senso dell’essere, e questo ente è da Heidegger indicato col termine di Esserci (Dasein). L’uomo, considerato nel suo modo di essere, è Da-Sein, esser-ci; e il “ci” (da) sta ad indicare il fatto che l’uomo è sempre in una situazione, gettato in essa, e in rapporto attivo nei suoi confronti. L’Esserci, cioè l’uomo, non è soltanto quell’ente che pone la domanda sul senso dell’essere, ma è anche quell’ente che non si lascia ridurre alla nozione di essere. Le cose sono diverse l’una dall’altra, ma tutti sono oggetti posti davanti a me: l’uomo non può ridursi ad un oggetto puro e semplice del mondo; l’Esserci non è mai una semplice presenza come le cose, giacché esso è proprio quell’ente per cui le cose sono presenti. Il modo di essere dell’Esserci è l’ esistenza , l’ “essenza” dell’Esserci consiste nella sua esistenza, e l’essenza dell’esistenza è data dalla possibilità da attuare e, di conseguenza, l’uomo può scegliersi perdendosi o conquistandosi. Ciò detto, l’uomo che si trova a dover decidere della propria vita, conosce la disperazione della solitudine o dell’isolamento nell’angoscia. Secondo Lévinas, il fatto di essere è quanto di più privato ci sia, l’esistenza è la sola cosa che non posso comunicare perché la posso raccontare, ma non condividere. La solitudine appare come lo stesso evento di essere:
” siamo circondati da esseri e da cose con i quali intratteniamo relazioni. Siamo con gli altri con la vista, con il tatto, con la simpatia, con il lavoro in comune. Io tocco un oggetto, vedo l’altro, ma non sono l’altro. Tra esseri ci si può scambiare tutto tranne l’esistere “.
DIFFERENZA DEI SESSI
Si affaccia nel pensiero di Levìnas anche la riflessione su quella alterità che è rappresentata dalla donna , talvolta in alcuni suoi tratti tradizionali, ma anche arrivando a rovesciare la valutazione delle tradizionali categorie di virilità e femminilità: la virilità è il simbolo del soggetto che non vuole farsi alterare dall’Altro, la femminilità è liberazione da questo senso di proprietà e di chiusura. Si delinea, così, quella riflessione sulla differenza dei sessi che è uno dei temi più recenti e complessi del pensiero. Gli “esseri” non si possono scambiare l’esistenza, ma entrano in rapporto tra loro in vario modo. La prima figura di relazione con gli altri, è l’ eros , nel quale si esalta un’alterità tra esseri che non si limita ad una semplice alterità erotica. Il femminile è l’origine del concetto stesso di alterità che non scompare nella relazione amorosa. ” La differenza di sesso non è la dualità di due termini complementari. Infatti, due termini complementari suppongono un tutto preesistente. Ora, dire che la dualità sessuale suppone un tutto, significa porre già prima l’amore come fusione e, dunque, come annullamento dell’ego. ” Al contrario, il patetico dell’amore consiste in una insormontabile dualità degli esseri, è una relazione con ciò che sempre si sottrae, un faccia a faccia, appunto, un aut-aut. La relazione non neutralizza l’individualità, ma la conserva. La seconda figura di relazione con gli altri, è quella della filialità. Quella biologica è solo il primo tipo, ma se ne può concepire uno come relazione tra esseri umani, senza legami di parentela. ” La paternità è una relazione con un estraneo che, pur essendo altri, è me, il figlio non è opera mia, egli non è neppure una mia proprietà. Io non ho mio figlio, io sono, in qualche modo, mio figlio. Egli è un io, è una persona “.
IL MULTICULTURALISMO
Il riconoscimento dell’Altro viene da Levìnas ricondotto alla fede , poiché l’Altro, con la sua irriducibilità e alterità, è la rivelazione dell’infinito, dell’infinita alterità, che pure è presente e ci ispira, anche se non si svela compiutamente a noi. Levìnas contrappone Rivelazione biblica a Ossessione dell’essere : è la prima a consentirci di riconoscere l’Altro come tale, con una sua totale autonomia, un suo compiuto orizzonte di senso. Essa ci impone di non ridurlo a noi stessi con un uso totalizzante delle nostre categorie interpretative. Ma la relazione all’Altro, oltre che fondata sulla fede, ha anche una connotazione etica: l’irriducibile alterità dell’Altro è quella, ad esempio, che ci impone di non uccidere o alimenta, quando lo facciamo, un perenne rimorso della coscienza. Ecco perché la relazione e la responsabilità che abbiamo nei confronti dell’Altro sono una dimensione costitutiva di noi stessi. Per diversi studiosi, la riflessione di Levìnas sull’Altro costituisce uno dei fondamenti teorici del multiculturalismo contemporaneo, suggerisce, cioè, una visione nuova e diversa dei rapporti fra gli individui e fra le culture: come rapporti fra diversi, che come tali vanno riconosciuti e valorizzati. Solo attraverso questo riconoscimento è possibile attivare una comunicazione autentica fra le culture, senza affermazioni egemoniche di una sull’altra. Questa è una prospettiva feconda, attraverso cui, ad esempio, è possibile guardare in modo nuovo ai problemi di rapporti fra le culture che vengono a determinarsi con i processi migratori in atto su scala planetaria. Il pensiero di Emmanuel Lévinas si è sviluppato, quindi, su due versanti privilegiati: l’ esercizio fenomenologico di cui è stato tra i primi rappresentanti in Francia e le letture talmudiche , ispirate a temi biblici ed ebraici. Partendo da Heidegger, Lévinas rimette in questione il primato del problema dell’essere, dominato dal principio di totalità, per cercare nell’appello dell’alterità il fondamento di una soggettività autentica. In questa preminenza dell’etica, nella parte più interna della quale si incontra il principio dostoevskiano della responsabilità universale, l’essere responsabili di tutto verso tutti, Lévinas ritrova il tema della Legge, centrale nel pensiero ebraico.
VOLTARE LE SPALLE A PARMENIDE
” II vero Desiderio è quello che il Desiderato non sazia ma rende più profondo. È bontà. Non si riferisce a una patria o a una pienezza perdute, non è la malattia del ritorno e neppure nostalgia. È la mancanza nell’essere che già è in modo compiuto e a cui non manca nulla ” (“La traccia dell’altro”). ” Si tratta di uscire dall’essere per una nuova via “, scrive Lévinas nel 1935 (“De l’evasion”). ” Voltare finalmente le spalle a Parmenide “. Come ha scritto Derrida, il pensiero di Lévinas ci invita ad abbandonare il luogo greco, e forse il luogo in generale, verso ciò che non è più nemmeno una sorgente o un luogo ma una “respirazione”, una parola profetica già effusa non solo a monte di Platone, non solo a monte dei presocratici, ma al di qua di ogni origine greca. Sullo sfondo di questo proposito, discreta ma decisiva, vi è l’ opzione tutta ebraica per il monoteismo . Levinas non accetta il panteismo cosmico che muove l’intera parabola del pensiero greco, nel quale il computo degli esseri torna uguale e perfetto, senza che nulla vada veramente perduto e senza che nulla di nuovo accada davvero. Si chiede se non vi sia proprio in questa positività priva di ferite un qualche male. L’angoscia di fronte all’essere, l’orrore dell’essere è forse tanto originaria quanto l’angoscia di fronte alla morte. L’essere in generale è la vera prigione; ad esso Lévinas dà il nome di “il ya”, il puro c’è, compatto e inestinguibile, che ritorna anche in seno alla propria negazione. Ciò che nel pensiero di Heidegger si definiva come l’abbraccio che raccoglie e dispone ogni cosa nella propria luce, rivela ora le fattezze soffocanti, spersonalizzanti e invasive della notte. Di fronte a quest’oscura invasione siamo esposti, non è più possibile raccogliersi in sé, rientrare nel proprio guscio. Siamo di fronte al c’è, al naufragio del tempo, all’ Universo che nessun volto illumina. Una delle caratteristiche del pensiero di Lévinas è la tendenza continua all’evasione dalla neutralità, dall’anonimato, da se stessi come “essere generale”. In questo modo egli reinterpreta l’immagine dell’ebreo errante come figura ontologica. Nell’ “uscir fuori di sé” l’uomo incontra l’Altro. Dalla inevitabilità dell’incontro con l’altro e dal superamento dell’estraneità deriva la centralità dell’etica. Lévinas osserva che il monoteismo segna un momento di rottura nella storia del sacro e che nei confronti del precedente politeismo esso è una forma di negazione ateistica. Il monoteismo è anche una manifestazione d’intelligenza che lo avvicina alla filosofia.
” Il monoteismo giudaico non esalta una potenza sacra, un numen che trionfi su altre potenze numinose, ma che partecipi ancora della loro vita clandestina e misteriosa. Il Dio dei giudei non è sopravvivenza degli dèi mitici. Secondo un apologo Abramo, il padre dei credenti, sarebbe stato figlio di un mercante d’idoli. Approfittando dell’assenza di Tereh, li avrebbe tutti spezzati, risparmiando il piú grande di essi per attribuirgli, agli occhi del padre, la responsabilità del massacro. Ma Teher al suo ritorno non può accettare questa versione fantastica: egli sa che nessun idolo al mondo potrebbe distruggere gli altri. Il monoteismo segna una rottura con una certa concezione del sacro; non unifica né gerarchizza gli dèi numinosi e numerosi; li nega. Rispetto al divino ch’essi incarnano, non è altro che ateismo. Su questo punto il giudaismo si sente estremamente vicino all’Occidente, voglio dire alla filosofia. Non è semplicemente un caso che la via verso la sintesi fra rivelazione giudaica e pensiero greco fosse magistralmente tracciata da Maimonide, cui si richiamano i filosofi giudei e musulmani; che un profondo rispetto per la sapienza greca riempisse già i sapienti del Talmud; che l’educazione per il giudeo si confonda con l’ispirazione e che l’ignorante non possa essere realmente religioso! E sono frequenti curiosi testi talmudici che cercano di presentare la natura della spiritualità d’Israele come costituita dalla sua eccellenza intellettuale: non certo per orgoglio luciferino della ragione, ma perché l’eccellenza intellettuale è interiore, e i “miracoli” ch’essa rende possibili non feriscono la dignità dell’essere responsabile, come invece fa la taumaturgia; ma soprattutto perché non deteriorano le condizioni dell’azione e dello sforzo. Da ciò deriva in tutta la vita religiosa giudaica l’importanza dell’esercizio dell’intelligenza, certo, applicata in primo luogo al contenuto della rivelazione, alla Torah. Ma la nozione di rivelazione è destinata ad ampliarsi rapidamente, sino a comprendere tutto il sapere essenziale. Un apologo rabbinico rappresenta Dio che insegna agli angeli e a Israele; in questa scuola divina gli angeli (intelletti senza debolezze ma senza malizia) domandano a Israele, posto in prima fila, il senso della parola divina. L’esistenza umana, malgrado l’inferiorità del suo rango ontologico, a causa di questa inferiorità, di ciò ch’essa implica di tormentato, di inquieto e di critico, è il vero luogo in cui la parola divina incontra l’intelletto e perde il resto delle sue virtú che si pretendono mistiche. Ma l’apologo intende anche insegnarci che la verità degli angeli non è di specie diversa dalla verità degli uomini, che gli uomini hanno accesso alla parola divina senza che l’estasi debba strapparli alla loro essenza, alla loro natura umana. ” (“Difficile libertà”)
CIO’ CHE NON PUO’ ESSERE DETTO
” Dall’esistenza all’esistente ” è stata scritta nel 1947. Di quest’opera non si comprenderà nulla se non la si illumina con il “sole nero” che ha coperto l’Europa tra il 39 e il 45, dove la semplice positività autoevidente dell’esistere è stata scossa per sempre, ha visto svanire il suo diritto. La notte di Lévinas è l’irrimediabile ripercussione filosofica “ dei cerchi concentrici di Notte e Nebbia ” (Neher) che ancora oggi soffocano la memoria dei sopravvissuti al paese delle ombre. Tutta l’opera di Lévinas è assillata da ciò che non può essere detto . E non per dirlo, finalmente, piegandolo alle condizioni del linguaggio, ma per ricomprendere l’intero compito del linguaggio e della parola a partire da ciò che inevitabilmente vi si sottrae. Una comunicazione con l’altro che lo lasci essere altro, senza ridurlo alla comune misura. Un cammino che, obbediente all’intenzione ebraica del “dabar”, che assieme significa “parola” ed “evento”, ci conduca verso una patria nella quale non siamo mai nati. Nessun ritorno all’origine, dunque, nessuna ricomposizione, ma esodo, partenza, destituzione della sovranità di un soggetto che conosce e dispone e che, nella sua originaria libertà, dice e pensa ogni cosa a partire da sé, come se avesse assistito alla creazione del mondo e alla propria stessa nascita. Generalmente si affronta il pensiero di un filosofo attraverso l’enucleazione dei suoi temi, ma è proprio questo che in Lévinas risulta impossibile. L’unico suo interesse è nella costruzione di un pensiero e di una scrittura che si lascino sollecitare da ciò che resiste alla coscienza e al suo movimento appropriante.
IL VOLTO E’ LA VERA FRATTURA
Prima di ogni avventura speculativa, è nell’incontro con l’altro che si fa strada l’idea dell’infinito. Evento a cui Lévinas dà il nome di visage, volto . Anche nella distanza invalicabile delle culture, l’altro è cercato nel suo volto e in questa prossimità la relazione si gioca. Il volto è la vera frattura nel territorio unificato e reso disponibile dalla conoscenza e dalle armi. Con esso avanza l’indisponibile per eccellenza. Lo sguardo è conoscenza e percezione. La relazione col volto può essere dominata dalla percezione, ma ciò che è specificatamente volto, è ciò che non vi si riduce. Anzitutto c’è la sua esposizione diretta, senza difesa nella quale appare la sua nudità dignitosa. E’ proprio il volto che inizia e rende possibile ogni discorso ed è il presupposto di tutte le relazioni umane. L’altro non è un dato che viene afferrato quasi mettessimo le mani su di lui. L’altro mi guarda e mi riguarda e si disfa dell’idea che di lui ho in mente. Scrive Lévinas in ” Totalità e Infinito “: “ Noi chiamiamo volto il modo in cui si presenta l’Altro. Questo modo non consiste nel mostrarsi come un insieme di qualità che formano un’immagine. Il volto d’Altri distrugge ad ogni istante e oltrepassa l’immagine plastica che mi lascia “. Il volto dell’Altro ha significato di per sé, si impone al di là del contesto fisico e sociale: il senso del volto non consiste nella relazione con qualcos’altro, esso è senso per sé. Si può dire che il volto non è visto. Esso è ciò che non può diventare un contenuto afferrabile dal pensiero; è l’incontenibile, ti conduce al di là. Il volto dell’Altro ti viene incontro e ti dice: “Tu non ucciderai”. Nonostante il divieto può esserci l’assassinio, ma la malignità del male riapparirà nei rimorsi della coscienza dell’assassino, nell’accesso al volto c’è anche un accesso all’idea di Dio. Il volto è responsabilità per Altri: il volto dell’Altro entra nel nostro mondo; esso è una visitazione; è responsabilità: esso mi guarda e mi riguarda. Il volto d’Altri mi impone un atteggiamento etico: ” è il povero per il quale io posso tutto e al quale devo tutto “. E’ così che il volto si sottrae al possesso; il volto dell’Altro, afferma Lévinas, ” mi parla e mi invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita “. Il volto dell’Altro, dunque, mi coinvolge, mi pone in questione, mi rende immediatamente responsabile. La responsabilità nei confronti dell’Altro viene a configurarsi, nel pensiero di Lévinas, come la struttura originaria del soggetto. Fin dall’inizio, ” l’estraneo che non ho né concepito, né partorito, l’ ho già in braccio “. La mia responsabilità nei confronti dell’altro arriva fino al punto che io mi debba sentire responsabile anche della responsabilità degli altri.
LO STATO E LA GIUSTIZIA
Questo comporta la costruzione delle istituzioni e anche dello Stato. Difatti, scrive Lévinas, ” l’Altro per il quale sono responsabile può essere il carnefice di un terzo che è anche il mio Altro ” . Di qui la necessità di una giustizia, e dunque delle istituzioni e dello Stato. Ha detto Lévinas in un’intervista: ” se noi fossimo stati in due, nella storia del mondo ci saremmo fermati all’idea di responsabilità, ma dal momento in cui ci si trova in tre, si pone il problema del rapporto tra il secondo ed il terzo. Alla carità iniziale si aggiunge una preoccupazione di giustizia e quindi l’esigenza dello Stato, della politica. La giustizia è una carità più completa .” Per Lévinas, quindi, la responsabilità è responsabilità per altri ed è alla base della soggettività per quel che non è fatto mio e che non mi riguarda. Il legame con altri si stringe solo con la responsabilità, sia che questa sia accettata o rifiutata perché io sono responsabile di altri senza aspettare il contrario, perché l’inverso riguarda loro. Siamo responsabili delle persecuzioni che subiamo perché sopportandole e combattendole, senza scappare da esse, ma rendendosene testimoni, reclamiamo giustizia per il “proprio popolo”. La giustizia ha senso soltanto se conserva lo spirito del disinteresse che anima l’idea della responsabilità per l’altro uomo. La responsabilità mi incombe e non la posso rifiutare, preme su di me attraverso lo sguardo altrui che non posso deificare come frammento della Totalità. ” Nessuno, in questo momento può dire: ho fatto tutto il mio dovere “. Questa affermazione è un’apertura all’infinito perché significa che siamo volti in costante tensione verso la realizzazione della nostra testimonianza di responsabilità per Altri. La testimonianza etica è una rivelazione che non è una conoscenza perché il testimone agisce per propria volontà e con l’affermazione “Eccomi!”, testimonia il suo aver risposto davanti agli altri e per gli altri. In ” Altrimenti che essere o al di là dell’essenza “, Lévinas giunge a vedere nella responsabilità per l’Altro ” un’assegnazione a rispondere dell’Altro, un’espiazione per l’Altro, una sostituzione dell’Altro “. A questo proposito, il Filosofo afferma: ” il soggetto è ostaggio “. ” Il termine io significa Eccomi, rispondendo di tutti e di tutto “. Ed è soltanto attraverso la condizione di ostaggio, scrive Lévinas, che nel mondo può esserci ” pietà, comprensione, perdono e prossimità “. Dietro a questa posizione etica c’è, ad avviso di Lévinas, Dio: c’è Dio come ispirazione, quantunque non come svelamento di se stesso, perché Dio o la sua parola, mi viene all’idea concretamente, davanti al volto dell’altro uomo in cui io leggo il comandamento “Tu non ucciderai”. Il divieto scritto sul volto non si può considerare una prova dell’esistenza di Dio, ma è la circostanza in cui la parola di Dio acquista senso. Ed ecco ancora Lévinas: ” io non vorrei definire nulla attraverso Dio, giacché io conosco l’umano. E’ Dio che posso definire attraverso le relazioni umane, non l’inverso. ” In Lévinas, l’etica si fa spia di un Dio presente e irraggiungibile, vicino e differente.
HILARY PUTNAM

Riteniamo che vi siano interpretazioni migliori e peggiori- altrimenti che senso avrebbe discutere?
VITA E OPERE
Hilary Putnam, uno dei più importanti filosofi statunitensi della generazione successiva a Quine, nasce a Chicago il 31 luglio 1926 da famiglia ebraica. La sua formazione filosofica si muove fra le correnti analitiche di derivazione neopositivistica (il filosofo può annoverare Reichenbach e Carnap fra i suoi insegnanti) e la tradizione pragmatistica americana (i cui nomi portanti sono Dewey, James, Peirce e quindi Quine, con cui Putnam si incontra poco dopo il ritorno dall’Europa di quest’ ultimo). Si diploma nel 1948 all’Università della Pennsylvania e consegue il dottorato a Los Angeles nel 1951. Inizia nel 1953 a Princeton la sua carriera accademica come assistente e nel I960 diventa associato di filosofia, dal 1961 al 1965 insegna al MIT (Massachusets Institute of Technology) e quindi si sposta all’Università di Harvard- nello stesso periodo si getta nell’impegno politico e aderisce a posizioni pacifìste e marxiste (sono gli anni della guerra in Vietnam), entrando a far parte prima del movimento Studentsfor a Democratic Society e poi di un gruppo maoista interno a quello stesso movimento, i Progressive Labor Party. Mette così a frutto le giovanili letture fìlosofiche di Kierkegaard, Marx, Freud e dei francofortesi, che lo convincono che la filosofia non è soltanto un impegno teorico o, peggio, accademico; in seguito tuttavia abbandona questo radicalismo politico. Inoltre, amplia progressivamente lo specchio dei suoi interessi e giunge a occuparsi anche di etica e di estetica, ambiti lontani dalla sua primitiva formazione neopositivistica, consapevole che i valori influenzano la scienza. Da1 1976 è Professor of Modern Mathematics and Mathematical Logic sempre all’Università di Harvard. Sposato due volte e appassionato di cucina, è membro corrispondente della British Academy e ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali fra cui due lauree ad honorem. Negli anni Cinquanta ha pubblicato una serie di articoli di filosofia del linguaggio e di logica; la maggior parte dei suoi articoli composti a cavallo fra gli anni Sessanta e Ottanta si trova ora raccolta nei tré volumi dei “Saggi filosofici”, intitolati rispettivamente “Matematica materia e metodo” (1975), “Mente, linguaggio e realtà” (1975) e “Realismo e ragione” (1985). Nel frattempo, però, anche le preoccupazioni etiche si fanno breccia cosicché Putnam da alle stampe nel 1978 “Verità e etica”, dove, tra l’altro, si annuncia la svolta nella sua concezione del realismo, e nel 1981 “Ragione, verità e storia”. Le indagini sul realismo divengono quindi il tema centrale della riflessione del filosofo che ad esso dedica i suoi più ampi sforzi, pubblicando nel 1987 “La sfida del realismo” (nato a partire dalle Paul Carus Lectures tenute a Washington nel 1985), nel 1988 “Rappresentazione e realtà” e nel 1990 l’ampio “Realismo dal volto umano”. Il recupero del pragmatismo è invece al centro del recente “Il pragmatismo: una questione aperta” (1992), che raccoglie una serie di conferenze tenute da Putnam a Roma. Il suo ultimo libro è “Rinnovare la filosofia”, del 1992, una serie di saggi che coprono un ampio spettro di tematiche, dal bilancio sul ruolo di filosofi ormai classici come Dewey o Wittgenstein alla filosofia della mente, dalla filosofìa del linguaggio allo spazio che devono avere anche all’interno della filosofia analitica le tematiche morali e religiose.
LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO E DELLA LOGICA
Putnam nega quinianamente l’esistenza di verità a priori : la stessa geometria euclidea è una teoria sullo spazio finito e dunque risulta empirica, ossia, in termini kantiani, sintetica. In “L’analitico e il sintetico” (1962) Putnam contesta tuttavia la reiezione quintana dell’analiticità, che a suo avviso invece si può e si deve in qualche modo continuare a sostenere: la critica di Quine ha avuto il merito di mostrare la connessione strettissima fra le nozioni di significato, di analiticità e di sinonimia, ma da ciò non discende che non sia opportuno mantenere quella distinzione; anzi, Quine sembra aver identificato erroneamente l’analiticità con l’a priori. A giudizio di Putnam non è possibile trovare un criterio adeguato e rigoroso per definire le nozioni analitiche, e allora egli fa ricorso a un criterio pragmatico per identificarle: esse sono tali perché le intendiamo senza poter dare ragione di questo loro carattere, anche se talvolta dobbiamo affidarci a degli “specialisti” per distinguerle da quelle che non lo sono e che pure sembrerebbero esserlo. Esse vengono fissate mediante una “convenzione implicita”, il che non esclude tuttavia la loro rivedibilità. Allo stesso modo, nei saggi “Sulla tesi che la matematica è riducibile alla logica” e “Che cosa è la verità matematica” il filosofo asserisce la correggibilità della conoscenza matematica, che dunque non è fondamentalmente diversa dalla conoscenza empirica. Infatti, il carattere a priori della verità matematica e logica è tale solo all’interno del nostro schema concettuale, e sembra allora potersi ravvisare in Putnam una forma di costruttivismo: non è necessario dover scegliere fra platonismo (che ritiene le entità matematiche esistenti al di fuori della nostra mente) e nominalismo (che le ritiene mere costruzioni mentali), perché la conoscenza delle entità matematiche non è indipendente dalle nostre esperienze e tale posizione viene definita “aristotelica” dal filosofo stesso. La matematica, a differenza di quanto ritengono i platonisti, non ha oggetti propri, semplicemente si occupa di oggetti non reali, ma astrattamente possibili. La conferma delle teorie matematiche non sarà tuttavia costituita da generalizzazioni induttive, ma da metodi che fanno parte della prova stessa, cioè che sono in certo modo a essa interni. Lo sfondo realistico è presente anche in “Filosofia della logica” (1972), che combatte il nominalismo affermando l’esigenza delle classi e la loro ineliminabilità.
REALISMO METAFISICO
Gli scritti degli anni Settanta sono condotti da una prospettiva che Putnam stesso chiama realismo metafìsico , la presupposizione, cioè, dell’indipendenza della realtà dalla mente umana, che può essere pertanto smentita dalla prima. Questa forma di realismo si accorda sia con il “realismo ingenuo” (quello tipico del senso comune), per il quale esistono gli oggetti della nostra esperienza ordinaria, come i tavoli, le sedie e i cubetti di ghiaccio, sia con il realismo forte degli scienziati, per i quali esistono le entità inosservabili a cui fa riferimento la scienza, come gli atomi, i quark ecc. In particolare, nel secondo volume dei “Saggi filosofici” Putnam difende il cosiddetto realismo empirico , fondato sull’inferenza alla miglior spiegazione: sia le esperienze quotidiane sia gli esperimenti di laboratorio confermano che la realtà esiste, che è indipendente da noi e che rende vere o false le nostre proposizioni. Questa teoria è certamente un’ipotesi empirica, cioè non può ottenere una fondazione apodittica e perciò definitiva, ma possiede una tradizione amplissima che va dall’antichità a Kant e che a tutt’oggi non è stata soppiantata da nessuna migliore ipotesi. Peraltro, il realismo metafisico si è storicamente attuato in una grande varietà di atteggiamenti, come il materialismo, l’idealismo, il soggettivismo, ma tutti accomunati dalla pretesa di individuare una stabile essenza “definitiva” della realtà. Per il realismo esterno, come la realtà è una sola, una totalità di oggetti interamente precostituita rispetto alla mente umana, così c’è una sola descrizione vera di com’è il mondo e la teoria della verità che ne consegue è corrispondentistica, nel senso che la nostra descrizione della realtà per essere vera deve ricalcarne esattamente la configurazione. Tale prospettiva è da Putnam definita “esternista”, perché considera la realtà non dal punto di vista dell’uomo, ma da un ipotetico punto di vista esterno e neutrale, come potrebbe essere l’occhio di Dio.
REALISMO INTERNO
In “Verità e etica” assistiamo a una fondamentale svolta di sapore trascendentale nella concezione di Putnam del realismo: se la rivoluzione copernicana di Kant aveva insegnato che la nostra apprensione della realtà non è indipendente dal nostro apparato categoriale, adesso Putnam sostiene che è certo possibile pensare con il vecchio realismo metafisico a un mondo indipendente dalla nostra mente, ma che tale convinzione si paga al caro prezzo della sua stessa conoscibilità. Per contro, il mondo esiste per noi, cioè è per noi conoscibile solo attraverso gli strumenti che adoperiamo per conoscerlo, e di conseguenza l’ontologia, cioè l’insieme degli oggetti mondani la cui esistenza noi siamo disposti a riconoscere, viene assunta all’interno di una teoria previamente assunta sulla costituzione del mondo. Ad esempio, se la nostra teoria ci consente di parlare dell’elettrone, vuol dire che noi ci muoviamo già all’interno di una teoria che ammette e riconosce gli elettroni. Il realismo metafisico non è inammissibile, ma diventa sterile perché ci costringe a rinunciare a qualsiasi tesi su com’è il mondo; di conseguenza, l’unico realismo plausibile da un punto di vista gnoseologico è quello interno, prospettiva introdotta da Kant, reperibile quindi in autori come Peirce, Wittgenstein e in tempi più recenti nel costruzionismo di Goodman e nell’antirealismo semantico di Dummett. L’ internismo che Putnam sostiene può ammettere (anche se non necessariamente) che esista più di una descrizione vera del mondo: in questo modo si effettua una combinazione di due differenti prospettive. Da un lato vengono riconosciuti elementi derivanti dal mondo esterno che sono in connessione dialettica con la teoria, la quale dunque non ha per unico contrassegno la coerenza interna ma deve continuare a rispondere all’esperienza; dall’altro lato si sostiene che questi elementi non sono neutrali, ma hanno la loro esistenza e traggono il loro rilievo solo perché assunti all’interno di una determinata prospettiva teorica. Di essi, dunque, non si da una sola descrizione vera, come se fossero indipendenti da qualsiasi scelta concettuale, come non sono neutre nemmeno le nostre sensazioni. Questo realismo, sebbene possieda indubitabili tratti kantiani, rigetta con decisione la “cosa in sé”. Il realismo interno è ben attento a non sfociare nel relativismo assoluto e tanto meno nello scetticismo, e pur non condividendo il realismo metafisico non contraddice quello del senso comune e della scienza: esso non ci porta a dubitare dell’esistenza della realtà esterna, anche se la sua immagine nella conoscenza è costituita dalla collaborazione fra gli enti e il mondo stesso. Resta infatti aperta la possibilità che descrizioni differenti della realtà siano compatibili: com’è possibile conferire forme diverse alla stessa materia e nessuno direbbe che si tratta di materie diverse, così si può descrivere la realtà come composta da tavoli, sedie e cubetti di ghiaccio oppure da atomi tenendo fermo che si tratta pur sempre delle stesse cose, anche se le due versioni del mondo, pur strettamente correlate, sono irriducibili l’una all’altra. È dunque possibile essere allo stesso tempo sia realisti sia relativisti concettuali. I concetti, il nostro apparato categoriale sono indubbiamente relativi alle diverse culture, ma non tutto è assolutamente relativo e incommensurabile nelle varie culture. E se da un lato non esiste un punto di vista assoluto da cui giudicare le questioni, e quelle ontologiche per cominciare, dall’altro non può essere neppure vero che tutto dipenda semplicemente dalla nostra cultura di appartenenza. Gli oggetti esterni permangono e noi abbiamo la possibilità di dire (secondo una o più descrizioni) come sono, anche se non possiamo dire come sono indipendentemente da ogni nostra scelta concettuale. In tal modo Putnam non ritiene con Goodman (e meno che mai con Rorty) che il mondo vada “perduto”, dal momento che versioni concettuali diverse per lui rimandano comunque all’unico mondo esistente. I fatti non vengono costituiti da noi, sono indipendenti e preesistenti, anche se possiamo parlarne solo dopo l’assunzione di un determinato linguaggio; e infatti è proprio il linguaggio, connotato da una natura intrinsecamente sociale e soggetto al mutare delle culture, lo strumento mediante il quale noi organizziamo l’esperienza.
TERRE, GEMELLI E GATTI-ROBOT
Trasversalmente al modificarsi delle posizioni sul realismo, Putnam sviluppa una teoria del riferimento che invece mantiene in gran parte immutata nel corso della sua riflessione e che si inserisce nell’ambito della cosiddetta teoria causale del riferimento . Sappiamo che la tradizionale teoria del riferimento di matrice freghiana sostiene come esso venga determinato mediante descrizioni, per cui conoscere il significato, significa possedere la conoscenza di alcuni tratti dell’oggetto indicato: il paradigma tradizionale si caratterizza così per essere eminentemente denotazionale e mentalistico. In netta contrapposizione a questa visione, nel celebre saggio “Il significato di ‘significato'” (1975) e in molti altri scritti successivi Putnam sostiene che l’elemento costante del significato, che si mantiene anche quando un determinato termine viene usato in due teorie diverse, è l’identità del riferimento. Ciò implica l’invarianza del significato dei termini osservativi anche nel mutare degli enunciati teorici e contrasta la tesi di Feyerabend del carattere pregno di teoria di tutti i termini. Putnam ipotizza il caso di una Terra Gemella in tutto uguale alla nostra tranne che nella composizione chimica dell’acqua: un astronauta che vedesse l’acqua della Terra Gemella la chiamerebbe tranquillamente così finché non l’avesse analizzata, scoprendo che la sua composizione non è H2O, bensì XYZ; a questo punto egli affermerebbe che nella Terra Gemella “acqua” non ha lo stesso significato che sulla nostra Terra, poiché lì significa (cioè si riferisce a) XYZ e qui, da noi, H2O. Se tuttavia non pensiamo all’astronauta ma a un ipotetico visitatore terrestre che fosse riuscito a recarsi nella Terra Gemella per esempio nel Settecento (o comunque anteriormente allo sviluppo della chimica moderna), allora il terrestre e l’abitante della Terra Gemella continuerebbero a usare lo stesso termine riferendosi (inconsapevolmente) a due sostanze diverse, ma – e questo è essenziale per Putnam – essendo in possesso delle stesse nozioni sull’acqua: che è incolore, inodore, insapore, che disseta ecc. Questo dimostra che non sono le conoscenze dei parlanti a determinare il riferimento, ossia che l’estensione del termine non è funzione esclusiva degli aspetti cognitivi o, in altre parole ancora, che i significati non sono nella testa . Infatti il terrestre e l’alieno della Terra Gemella indicano con il termine “acqua” due cose diverse pur trovandosi nella medesima condizione psicologica (cognitiva). Il significato si correla allora all’oggetto, nel nostro caso all’acqua, in virtù di un’operazione sociale, cioè di una relazione causale che sussiste fra i parlanti e il referente reale del termine. L’estensione è determinata dalla natura degli oggetti a cui il termine si riferisce, indipendentemente dalle conoscenze di cui sono in possesso i parlanti, cosicché sulla nostra Terra “acqua” si riferirà esattamente a H20 e sulla Terra Gemella a XYZ. A sua volta, il significato viene fissato dal riferimento e quindi trasmesso dalla competenza semantica dei parlanti. Il termine viene attribuito a un determinato oggetto in base a un battesimo iniziale , è indipendente dalle idee che se ne fanno i parlanti e si riferisce e continua a riferirsi al genere di cose a cui viene riferito all’inizio del tutto indipendentemente dalle proprietà delle cose stesse. Ma a chi spetta questo battesimo? Poiché la competenza semantica è complessa e socialmente stratificata e da pertanto origine a quella che Putnam chiama la divisione del lavoro linguistico , all’interno della comunità vi sono persone le cui conoscenze intorno a un determinato genere di cose sono maggiori di quelle in possesso di altre persone. È dunque molto più naturale che siano queste a fissare il riferimento dei termini, mentre gli altri parlanti erediteranno tale denominazione entrando in possesso del mero stereotipo, cioè una serie di caratteristiche tipiche e fondamentali (molto meno ricche e articolate della conoscenza che possiedono gli “esperti”) che tuttavia consentono comunque la corretta identificazione dell’oggetto e la trasmissione della competenza semantica. Ma il significato è indipendente dallo stereotipo : infatti esso viene fissato in relazione al genere naturale di cose in riferimento a cui è stato creato il termine e mantiene questo riferimento anche se ci si dovesse accorgere poi che lo stereotipo è una rappresentazione largamente inadeguata del genere che indica: ecco perché, dice Putnam, se noi scoprissimo che i gatti non sono in realtà che robot telecomandati dai marziani dovremmo continuare a chiamarli gatti. Ciò segnala una volta di più l’indipendenza del significato dalle credenze: l’unica condizione essenziale è che il riferimento venga mantenuto costante, cosa che ci permette di dire che le parole hanno in ogni caso lo stesso significato.
CERVELLI IN VASCA E SCETTICISMO
In “Ragione, verità e storia” Putnam rinforza la sua concezione realistica combattendo esplicitamente lo scetticismo . Nel celebre saggio “Cervelli in una vasca” egli immagina uno scienziato pazzo che estrae un cervello umano dal corpo, lo pone in una vasca piena di liquido nutriente e lo connette a un computer appositamente programmato per simulare la vita del corpo. Il cervello continua a vivere nell’illusione di avere un corpo, di compiere esperienze, mentre in realtà tutto questo non è che l’illusione dettata dal computer dello scienziato. Non si tratta in fondo che della rivisitazione contemporanea del genio ingannatore che campeggia nelle “Meditazioni metafisiche” di Cartesio (e che trova una brillante trasposizione cinematografica nel film “Matrix”, del 1999). Chi ci garantisce non solo l’esistenza della realtà esterna, ma della nostra stessa esistenza? Noi siamo ciò che crediamo di essere? Come possiamo essere certi di non essere cervelli in una vasca, manipolati da un qualche scienziato geniale e demente? La risposta di Putnam si fonda sulla teoria causale del riferimento e sul vecchio argomento che sosteneva il carattere autoconfutatorio dello scetticismo . Il punto di partenza di Putnam è sostenere che se fossimo cervelli in una vasca, pur conducendo una vita apparentemente “normale” e ritenendo di avere esperienze e sensazioni ordinane, non potremmo renderci conto di essere cervelli in una vasca, anzi, non saremmo nemmeno in grado di porci il problema. Se infatti non fossimo persone umane, ma per l’appunto cervelli in una vasca, avremmo dei significati diversi, cioè le nostre parole non avrebbero lo stesso riferimento. I termini “tavolo”, “sedia” e anche “cervelli” e “vasca” non sarebbero infatti determinati dai relativi oggetti mondani, cioè da tavoli, sedie ecc ma semplicemente dalle stimolazioni provenienti dal computer del gemo pazzo che ci comanda Se noi fossimo cervelli in una vasca e dicessimo di essere cervelli m una vasca muoveremmo da un’ipotesi strutturalmente diversa sulla conformazione del mondo, per cui il nostro enunciato non potrebbe riferirsi a reali cervelli e a reali vasche quali noi uomini li conosciamo nella nostra esperienza: le espressioni, nonostante la loro omofonia avrebbero differenti significati e di conseguenza, allorché il cervello nella vasca dicesse di essere in vasca, non potrebbe significare davvero, come noi m effetti e in realtà lo intendiamo, di essere un cervello in vasca. Lo scetticismo è dunque confutato e con esso anche ogni forma di realismo metafisico- lo scettico e il realista metafisico concordano almeno su questo punto: l’esistenza di un mondo interamente precostituito e da noi indipendente, sebbene il primo insista sulla sua inconoscibilità e il secondo aspiri invece a una teoria corrispondentistica della conoscenza. Al contrario, la teoria del riferimento a cui Putnam fa appello ci vieta di credere al fatto che determinate, rappresentazioni mentali si riferiscano in ogni caso a specifiche cose esterne la cui configurazione è del tutto indipendente dalla nostra mente.
TRA PLURALISMO E DEMOCRAZIA
Gli schemi concettuali non sono per Putnam a priori com’erano per Kant, sono invece assunti in base a una scelta che ha a fondamento determinati valori: ogni concezione della razionalità e della verità si basa comunque sull’ etica , perché senza valori non ci sarebbero neppure i fatti. In “Verità e etica” Putnam spiega che la scienza ha i suoi valori cognitivi come dimostra l’impossibilità di demarcare rigorosamente enunciati osservativi ed enunciati teorici. Quando parliamo di giustificazione, di conferma ecc. facciamo ricorso a dei criteri di accettabilità razionale che non sono pienamente oggettivi ma dipendono da un giudizio di valore sui canoni che deve possedere una teoria per essere scientifica. In secondo luogo, la tesi neopositivistica che contrapponeva nettamente fatti e valori e che insisteva sulla intrinseca non razionalità dei valori sembra controintuitiva, dal momento che tutti cerchiamo di produrre una qualche giustificazione del nostro modo di vivere: anche se ogni giustificazione razionale dovesse alla fine risultare incompleta e non decisiva, noi non ci sentiamo esonerati dal fornire argomenti per il nostro comportamento. Si affaccia una ripresa della tesi kantiana sul primato della ragion pratica su quella Teoretica (e d’altra parte Putnam si rivela influenzato da autori più o meno kantiani come Dworkin, Habermas, Apel, Hóffe). Tuttavia, i valori non sono perenni, statici, perché invece seguono la tendenza al miglioramento che il filosofo riscontra nella società- non è però l’uomo come singolo individuo che può darsi tali valori e aspirare al miglioramento, perché soltanto nel dialogo e nel confronto con altri uomini tale tendenza prende corpo. L’unica via al progresso, alla razionalità, sta allora nella democrazia e nel pluralismo. A ciò è connessa la visione parzialmente strumentalistica del ruolo della scienza che emerge in Putnam negli anni Ottanta e che è di chiara derivazione pragmatistica: la scienza è funzionale, più che alla conoscenza m se, al miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo, all’attuazione di una situazione ideale di eudemonia. Ma la razionalità non è riducibile a una concezione tutta strumentale (di tipo weberiano): prima della razionalità strumentale devono infatti sussistere dei criteri di rilevanza in base ai quali noi decidiamo quali tipi di problematiche, quali interessi e quali finalità siano propri delle nostre imprese, fra cui la scienza stessa. Nella terza parte di “La sfida del realismo” il kantismo viene integrato con una dottrina scettica che serve a mantenere aperta la prospettiva pluralistica: la conoscenza del bene oggettivo è inattingibile alla nostra intuizione morale (ciò è il corrispettivo etico del realismo interno perché depura la nostra conoscenza da pretese all’assolutezza), ma ciò è un fatto positivo in quanto mantiene libera la facoltà del giudizio e non introduce aspetti eteronomi nell’etica. Di conseguenza, non si può che adottare un atteggiamento pluralistico nei confronti delle posizioni etiche, filosofiche e anche religiose. In “Conversazioni americane” Putnam evidenzia come la religione non gli interessi nella dimensione fideistica, ma in quanto importante riflessione sul limite dell’umano; non a caso l’accentuazione progressiva dell’umanesimo, avviata da Feuerbach, è culminata nella deificazione dell’uomo che ha prodotto le società totalitarie dei fascismi e del socialismo reale. Come vengono assunti allora i valori? Per sfuggire all’alternativa stretta di assolutismo e totale relativismo come pure all’individualismo solipsistico (ovvero alla scelta individuale), essi sono giocati su di un equilibrio tra visione del mondo, che integra conoscenze e scienza ma anche assunzioni metafisiche e teologiche, e ideali che forniscono una collocazione globale dell’uomo, senza per questo rinunciare alle tecniche argomentative dell’analisi, cioè una mediazione continua e progrediente fra individuo e società. La morale sembra consistere esclusivamente nell’accordo fra la valutazione individuale e l’approvazione collettiva (esigenza meno forte di quella sviluppata da Rawls): in ogni caso la concezione più ragionevole della razionalità deve e può essere sviluppata solo all’interno dei vari sistemi culturali e non ha senso volerla giudicare situandosene fuori, in un illusorio punto archimedeo.
GABRIEL MARCEL

“Il primo dovere del filosofo consiste nel pronunciarsi chiaramente sui limiti delle proprie conoscenze e riconoscere che vi sono dei campi in cui la sua incompetenza è assoluta. ” (“Gli uomini contro l’umano”)
VITA E OPERE
A partire dagli anni Venti del Novecento, lo spiritualismo francese si carica di sfumature esistenzialistiche (pur mantenendo al centro della riflessione la centralità della coscienza come fonte primaria di ogni verità): appartiene a questi sviluppi il pensiero di Gabriel Marcel (1889-1973), autore di opere come “Essere e avere” (1935) e “Il mistero dell’essere”. Nato a Parigi il 7 dicembre 1889, Marcel studiò al Liceo Carnot ed alla Sorbona, dove risentì dell’influenza dell’idealismo critico di Léon Brunschvicg e dello spiritualismo di Henri Bergson. Laureatosi nel 1910 con una tesi su “L’influence de Schelling sur les idées métaphisiques de Coleridge”, svolge l’attività di professore di liceo fino al 1923, anno in cui entra come lettore presso le case Grasset e Plon. In questi anni si confronta con la riflessione filosofica di Heidegger e Jaspers, accogliendo alcune istanze della corrente esistenzialista, senza tuttavia riconoscersi del tutto in questo orientamento di pensiero. Nel 1927 pubblica a Parigi il “Giornale metafisico”, un diario filosofico in cui è documentata la riscoperta dell’esistenza. Di religione ebraica, nel 1929, si converte al cattolicesimo. Nel 1935 pubblica “Essere e Avere”, in cui approda al tema dell’esistenza in rapporto all’essere e alla distinzione tra problema e mistero. L’opera è, però, preparata dal saggio “Posizione e approcci concreti del mistero ontologico”. Tra le sue opere ricordiamo: “Il sacro nell’età della tecnica” (1964); “Manifesti metodologici di una filosofia concreta”; “Dal rifiuto all’invocazione, saggio di filosofia concreta”; “Homo viator”; “Il declino della saggezza”; “La dignità umana e le sue matrici esistenziali”; “Dialogo sulla speranza”; “Gli uomini contro l’umano”; “Schizzo di una fenomenologia dell’avere”; “Il mistero dell’essere” (1951).
PRESENTAZIONE DEL PENSIERO DI MARCEL
Nella sua prima opera importante, “Il Giornale metafisico”, apparsa nel 1927 (lo stesso anno in cui usciva “Essere e Tempo”, di Heidegger) Marcel prende in esame la dimensione dell’esistenza nella forma letteraria di un “diario dell’anima”: il costante interesse per il problema ontologico (come fondamento stesso della descrizione esistenziale) non consente, però, di accostare eccessivamente il pensiero dell’esistenzialismo (accostamento da Marcel stesso respinto) mentre alcune interpretazioni novecentesche hanno scorto in esso piuttosto l’espressione di una ramificazione francese e spiritualizzata della fenomenologia tedesca. In ogni caso, la riflessione di Marcel non può essere ricondotta a schemi di scuola e la sola denominazione possibile è quella di filosofia concreta che egli stesso impiegò per definirla. Il tema fondamentale della riflessione di Marcel è l’ essere : tuttavia, l’essere per lui non rappresenta tanto un problema, quanto un mistero: da qui il titolo della sua famosa opera “Il mistero dell’essere”. Il problema, infatti, è qualcosa di perfettamente oggettivabile, di cui si conoscono i dati che, appunto, devono essere composti per giungere alla soluzione. Il mistero , invece, è qualcosa ” in cui mi trovo coinvolto ” e che, pertanto, impedisce di mantenere una chiara distinzione (come avviene invece nel problema) tra il soggetto e l’oggetto. E’ questo il caso dell’essere, dove l’oggetto dell’indagine non è qualcosa di distinto dal soggetto che si pone la domanda: tale mistero non può dunque essere risolto negli stessi termini in cui si risolve un problema, ma deve essere colto soltanto con un’ apertura alla dimensione della trascendenza . Alla distinzione tra problema e mistero fa riscontro quella tra avere ed essere (trattata soprattutto in “Essere e avere”): l’ avere esprime una condizione di esteriorità e di oggettivazione, mentre l’essere rinvia all’esistenza così come essa viene concretamente vissuta dall’uomo. Ma essere e avere non sono disgiunti, ma, al contrario, connessi da un rapporto dialettico che trova la sua espressione nel corpo : nello stesso tempo, io ho il mio corpo come una realtà esterna e oggettivata e sono il mio corpo, giacché la mia esistenza concreta è inscindibile da esso. Ancora una volta, dunque, si deve superare la distinzione dualistica tra soggetto e oggetto o, meglio, la contrapposizione di remota ascendenza cartesiana tra un soggetto che ha esclusivamente una funzione conoscitiva e spirituale e un corpo oggettivo cui sono assegnate le funzioni biologiche. La sfida che l’uomo si trova a dover sostenere è, in tale prospettiva, quella consistente nell’impedire che l’avere abbia la meglio sull’essere, ossia che l’essere venga, in qualche modo, alienato nell’avere. Questo funesto pericolo può avverarsi quando noi consideriamo i contenuti della nostra esistenza concreta (le idee, i sentimenti, le abitudini) alla stregua di cose oggettive, senza vivificarle continuamente con la nostra creatività; oppure quando consideriamo il mondo oggettivo del possesso, della scienza e della tecnica come una realtà a sé stante che finisce con il condizionare le nostre scelte. Ma avviene anche allorchè cessiamo di considerare gli altri individui come persone che intrattengono con noi una relazione di “Io-Tu”, per degradarli al livello di “cose”, di un “esso” che ha con noi esclusivamente un rapporto impersonale. In tutti questi casi, l’essere può conservare i suoi diritti sull’avere solamente nella misura in cui rimane vivo il senso del mistero dell’essere stesso, cioè il senso di quella trascendenza che va al di là della nostra esistenza e nello stesso tempo ne esprime il fondamento.
ANALISI DEL PENSIERO DI MARCEL
Piú noto come filosofo, ma degno di attenzione anche come musicista, drammaturgo, conferenziere e saggista, Gabriel Marcel ha saputo offrire, soprattutto nel periodo compreso tra le due guerre, spunti interessanti alla riflessione novecentesca. La tragedia della grande guerra ha indubbiamente indotto Marcel ad interrogarsi sugli aspetti irrazionali della realtà, scoprendo, in polemica anti-idealistica e anti-positivistica , l’esistenza come incarnazione e affrontando, quindi, i temi della sensazione e della corporeità. Egli, infatti, si scaglia duramente contro la filosofia intellettualistica che pretende di ridurre tutta la realtà, e con essa l’uomo, ad un concetto astratto. Il pensatore francese attacca soprattutto l’idealismo hegeliano e lo scetticismo, rimproverando al primo di aver ridotto al minimo il ruolo dell’esistenza, privilegiando l’idea rispetto al concreto esistere, al secondo, invece, di aver messo in dubbio la stessa esistenza. Marcel rileva che entrambe le correnti di pensiero sono vittime della dicotomia cartesiana tra soggetto ed oggetto, che ha comportato una riduzione dell’oggetto a ciò che deve essere per il soggetto razionale e dell’esistenza a ciò che viene dopo il pensiero. Egli propone un’ontologia concreta che privilegia l’analisi dell’esistenza, convinto che ” il piano ontologico può essere riconosciuto soltanto con un atto personale, tramite la totalità di un essere impegnato in un dramma che è il suo […], un essere al quale è stata concessa la singolare qualità di affermarsi o di negarsi, sia che affermi l’Essere e si apra a Lui, sia che Lo neghi e quindi si chiuda ad Esso ” (Giornale metafisico) . Marcel è, perciò, fortemente critico nei confronti di tutto quanto risulti già definito e catalogato ma rifiuta, anche, ogni affermazione dogmatica, ogni sistemazione ed etichettatura del pensiero, incluso il proprio. Egli intende, infatti, proporci la sua riflessione come una via, un cammino che ciascuno può ripercorrere e rivivere in maniera originale. Egli ammette che la ricerca continua, libera da ogni intento utilitaristico, è sempre stata la sua vocazione, che egli è sempre andato alla scoperta della verità con quella avida apertura che è tipica del fanciullo non ancora scolarizzato. Ed è con questa curiosità impaziente ed universale e con la consapevolezza di non giungere mai a risoluzioni definitive che Marcel ci propone il suo percorso filosofico mettendoci sempre di fronte a situazioni reali che nessuno può eludere senza rifiutare le proprie responsabilità. Di qui il sottoporre alla nostra attenzione questioni ancora aperte e innumerevoli spunti di riflessione che ci inducono ad interrogarci sulle linee di sviluppo e sulle prospettive della civiltà odierna. Uno dei temi piú interessanti individuati nella lettura di alcune opere del pensatore francese è la riscoperta del compito storico del filosofo , questione che Marcel sentì particolarmente urgente nel contesto culturale in cui visse e che, ancora oggi, è al centro di un vivo dibattito. Egli osserva, in primo luogo, che l’identità del filosofo, dai tempi antichi ad oggi, ha subito una forte degradazione dovuta al fatto che la stessa nozione ha perso la sua dignità originaria. Pertanto, soprattutto a partire dal XIX secolo, il filosofo è diventato, nella maggior parte dei casi, il professore di filosofia che difficilmente è in grado di conservare capacità di meditazione, libertà di pensiero e verginità di spirito. Se riesce a farlo, finisce con il condurre inevitabilmente un’esistenza ascetica, ritirandosi dalla vita, confinandosi in una solitudine eremitica e diventando, cosí, prigioniero del proprio pensiero. Marcel, pur riconoscendo ad entrambi onestà, serietà e disinteresse, tuttavia afferma: ” come non spaventarsi del carattere angusto e astruso delle loro ricerche? ” (“Gli uomini contro l’umano “). Nella società odierna, quindi, Marcel ritiene che non si possa piú concepire il filosofo come un pensatore tutto orientato verso la piú profonda ed assoluta indagine speculativa, come cioè il teoreta puro che non irradia in alcun modo il proprio pensiero. Quello del filosofo deve essere un pensare “erga omnes”, che si realizza solo quando si riconosce la comune origine della condizione umana e la sua caratteristica piú universale: l’essere portatrice di una luce, che, se accolta, guida ogni essere umano nel travagliato percorso dell’esistenza. È da questa luce che anche il filosofo deve lasciarsi penetrare per rendere la sua testimonianza a favore degli uomini e per contribuire a migliorare la vita. Il filosofo, pertanto, senza mai perdere il contatto con la realtà concreta, deve sentire come compito imprescindibile, cui non può sottrarsi senza negare la sua stessa vocazione, quello di proporre, dinanzi all’angoscioso smarrimento ed al progressivo tramontare della sensibilità morale e religiosa, una riflessione sull’identità del soggetto responsabile. Al contempo non deve cercare a tutti i costi il consenso del vasto pubblico, servendosi dei mezzi di comunicazione e trasformandosi in un “oggetto” nelle mani della pubblicità e degli impresari; così facendo rinnegherebbe la propria condizione di autentico e libero pensatore. Quando, infatti, un’idea, magari per il gusto dello scandalo e della provocazione, viene consegnata ai giornalisti, alla pubblicità, ai mass-media che ne fanno quasi uno slogan, essa si degrada a tal punto da perdere ogni significato e da convertirsi addirittura nella piú risibile parodia di se stessa. Altre diffuse tentazioni da cui il filosofo deve tenersi lontano, aggiunge Marcel, sono il prendere posizione su questioni e problematiche di cui ha una modesta conoscenza, o che addirittura ignora, e il ricondurre ogni specifica e concreta situazione a dei principi illegittimamente assolutizzati. ” Il primo dovere del filosofo consiste nel pronunciarsi chiaramente sui limiti delle proprie conoscenze e riconoscere che vi sono dei campi in cui la sua incompetenza è assoluta ” (“Gli uomini contro l’umano”) . Certamente, riconosce Marcel, quella del filosofo è una posizione difficile, problematica dal momento che egli vive una condizione paradossale: ” è nel mondo ma non è di questo mondo “. È proprio l’intuizione di non appartenere definitivamente alla realtà terrestre che gli consente di impegnarsi per rendere piú umana la vita del nostro pianeta, per valutare criticamente la realtà in cui viviamo e per operare, poi, una efficace saldatura tra il mondo della tecnica e quello della pura spiritualità, evitando che il primo prenda il sopravvento sul secondo, fino ad annullarlo. Marcel, infatti, dedica molta attenzione al problema della tecnica , piú precisamente al rapporto concreto che tende a stabilirsi tra questa e l’essere umano. In primo luogo si preoccupa di sottolineare, nei suoi scritti, il valore positivo della tecnica che va al di là della semplice utilità. ” Ogni tecnica è in se stessa buona per il fatto che incarna una certa autentica potenza della ragione e, anche, per il fatto che introduce nel disordine apparente delle cose un principio di intelligibilità ” (Gli uomini contro l’umano”) . Inoltre, ogni tecnica assolve un compito formativo per la precisione che esige da colui che la esercita: il tecnico non può non praticare, secondo Marcel, la virtù dell’esattezza, dal momento che nel campo tecnico l’imprecisione è necessariamente punita. Il pensatore francese, poi, sottolinea la gioia sana che accompagna la ricerca del tecnico intento a perfezionare il suo modo di procedere. Egli, infatti, non si preoccupa di sé ma solo dell’opera da portare a termine; il pensiero dei vantaggi materiali che la sua invenzione potrà fruttargli è solo marginale, perciò in lui vanità ed ambizione non hanno motivo di esistere. Fatte queste considerazioni, Marcel si pone il problema di quali siano gli effetti della tecnica su colui che ne è solo beneficiario, in quanto colui che fabbrica uno strumento o contribuisce a perfezionarlo, è raro che ne diventi schiavo poiché ” vi è qualche grado di libertà dal momento in cui vi è creazione persino ai livelli piú modesti ” (“La dignità umana e le sue matrici esistenziali”). . Secondo Marcel, l’uomo moderno tende ad abusare del potere che gli viene dalla tecnica ed è per questo che è necessaria un’attività meta-tecnica di controllo, corrispondente ad un potere di secondo grado. Ma, egli afferma, in una civiltà di tipo tecnico e non sacrale, il potere di secondo grado, che altro non è se non la riflessione, tende inevitabilmente ad essere screditato, poiché ” un uomo divenuto maestro nell’esercizio di una o piú tecniche sarà, in generale, portato a guardare con diffidenza tutto ciò che è estraneo a queste tecniche ” (“Il declino della saggezza “). In questo contesto l’uomo, quindi, rischia di divenire, addirittura, prigioniero della tecnica se non è in grado di dominarla e di subordinarla alla propria natura umana. Marcel cita, a tal proposito, il filosofo tedesco Gunther Anders, il quale, nel suo libro “Der Antiquierte Mensch” sostiene che l’uomo tende sempre piú a pensare se stesso in funzione dei prodotti della sua stessa tecnica e, paradossalmente, finisce con il sentirsi inferiore ad apparecchi così precisi e sempre piú perfetti. Ciò, egli sottolinea, non può non avere delle conseguenze etiche di notevole portata, poiché questa svalutazione dell’essere umano conduce alla negazione radicale della trascendenza che la filosofia classica riconosceva allo spirito. Secondo Marcel siamo di fronte, perciò, ad un fenomeno di alienazione nel senso che ” nelle condizioni di un mondo in cui le tecniche affermano sempre piú la loro egemonia, l’essere subisce un’autentica enucleazione “. La vita, in questa prospettiva, perde il suo peso esistenziale e l’idea di uomo si decompone. L’individuo, infatti, non riesce che a dare un’immagine indecifrabile di sé poiché tende a rappresentare il mondo e quindi se stesso solo alla luce delle tecniche messe a punto. L’esplosione del mondo oggettivo comporta l’annullamento del gnwqi sauton (“conosci te stesso”) socratico, una incredibile polverizzazione del soggetto. Quest’ultimo non è piú riconosciuto come tale quando gli vengono applicate tecniche invalse nel dominio della natura. Basti pensare, dice Marcel, alle manipolazioni del cervello umano fra cui il ricorso al cosiddetto “siero della verità”, esempio inquietante della violazione della intimità, come se la verità, nel senso puro e nobile della parola, possa avere a che fare con i risultati di un’iniezione.
” Non è certo un caso che procedimenti del genere siano stati messi in opera, con una fretta e una perseveranza senza paragone, da regimi totalitari di cui non basta dire che non si preoccupano della verità, ma piuttosto che questa è per loro il nemico numero uno, perché alla sua luce le pretese inconfessabili che li muovono, si rivelano quelle che sono “.
Marcel parla anche di desacralizzazione della vita , intendendo dire che essa è stata spogliata di tutti quegli attributi sacri che le venivano conferiti da un pensiero teocentrico che, nell’età della tecnica, è stato sostituito da un antropocentrismo pratico. L’uomo, infatti, si sente sempre piú come il solo principe in grado di attribuire un senso al mondo che, altrimenti, ne sarebbe privo. La vita è ritenuta sempre meno un beneficio, un dono di cui essere riconoscenti per cui l’uomo si arroga il diritto di manipolarla. ” La vita è considerata sempre piú qualcosa che non presenta alcun valore intrinseco e che si può sopprimere pressappoco come si gira un interruttore ” 13, afferma Marcel in “Il sacro nell’età della tecnica” e intende sottolineare come, nell’età della tecnica, l’atto di uccidere sia stato privato di quel carattere di crimine che gli è proprio, per cui anche in quegli individui che non si sono mai macchiati di alcun delitto e che, quindi, rimangono legati ai canoni valutativi tradizionali, esso non suscita piú alcun allarme. Marcel riconosce, pertanto, che in un momento in cui il primato assoluto spetta alla tecnica, si determina inevitabilmente un processo di desacralizzazione che investe la vita e tutte le sue manifestazioni. Egli si chiede, quindi, come sia possibile lottare contro quella “legge di gravitazione” che trascina l’uomo dalle tecniche verso gli eccessi della tecnocrazia. Sostiene, in primo luogo, la necessità di reagire contro la dissociazione del vitale e dello spirituale operata da un esangue razionalismo ma ritiene fondamentale un riapprofondimento della nozione di vita alla luce del piú elevato ed autentico pensiero religioso ed una riscoperta del sacro, non considerato, però, come soluzione o rimedio facile agli effetti disumanizzanti del vivere odierno; in tal caso, infatti, si rischierebbe di sconfinare in una sorta di pragmatismo contrario ai propositi di Marcel. Egli si riferisce, invece, ad una conversione sincera e profonda alla grazia, con la quale tutto si spiega e si chiarisce, che non è, però, un far ritorno alla religione nelle sue forme confessionali e catalogate. Solo cosí l’uomo potrà cercare di arginare la disperazione che lo investe quando legge l’esistenza in termini quantitativi, efficientistici e tecnologici. Marcel chiarisce, quindi, il concetto di disperazione : essa si presenta come l’esito inesorabile di una vita che privilegia l’orizzonte dell’avere anziché dell’essere; ogni possesso è, infatti, caratterizzato da una profonda instabilità poiché oscilla continuamente tra la tensione dell’individuo verso l’appropriazione definitiva della cosa e la tendenza continua dell’oggetto a sfuggire al possesso. È proprio questa instabilità che determina sentimenti di paura, ansia e disperazione. A quest’ultima, che è la dimensione esistenziale del misconoscimento dell’essere, si oppone la speranza: ” solo esseri totalmente liberi dalle pastoie del possesso in tutte le sue forme sono in grado di conoscere la divina levità della vita nella speranza ” (“Homo viator”). Essa è considerata come apertura al mistero dell’essere, come volontà di affermare che c’è, al di là di tutto ciò che è dato, un principio misterioso che mi sorpassa, che mi invade e al quale aderisco. Il contatto con l’essere, aggiunge Marcel, non avviene attraverso una conoscenza puramente intellettuale poiché l’essere, in quanto mistero, non è suscettibile di ricerca condotta esclusivamente con gli strumenti dell’indagine scientifica. Il pensatore francese invita, pertanto, gli uomini a fare professione di umiltà, a riconoscere, cioè, che l’intelligenza umana non può chiarire ciò che le è superiore e non può ridurre alla sua dimensione ciò che la trascende. L’essere è una luce che si rivela all’uomo e questi può soltanto riconoscerla. Si viene, così, a stabilire un rapporto di presenza, di amore, tra l’essere e noi uomini; questa relazione, puntualizza Marcel, vive solo finché l’uomo le dà vita con la sua disponibilità nei confronti dell’essere. Se l’individuo, invece, si chiude ad esso, perché troppo occupato di sè, vive in una desolata solitudine che non può non sfociare nel suicidio: negando l’essere l’uomo nega se stesso. Grazie all’incontro con l’essere, invece, l’uomo si riscopre come unità, non come ” un puro e semplice vivente, una creatura abbandonata alla vita e senza prese su di essa ” (“Manifesti metodologici di una filosofia concreta”) . Riconoscere il mistero ontologico implica ” affermare che c’è nell’Essere, al di là di tutto ciò che è dato, al di là di tutto ciò che può fornire materiale per un inventario o servire di base ad una qualsiasi valutazione, un principio misterioso che è mio complice, il quale non può non volere anche lui ciò che io voglio, almeno fino al punto in cui ciò che voglio merita effettivamente di essere voluto ed è effettivamente voluto da tutto me stesso ” (“Manifesti metodologici di una filosofia concreta”). Questo significa sperare: in altri termini, mentre la disperazione consiste nel riconoscere la capacità delle tecniche presenti e future di risolvere i problemi, la speranza, pur riconoscendo l’efficacia delle tecniche si pone su un terreno che sfugge ad ogni tentativo di dominio. Marcel chiarisce, ulteriormente, nel corso di un dibattito radiofonico del 12 maggio 1967 con il filosofo tedesco Ernst Bloch, la natura della speranza , l’ambito della sua realizzazione e il nesso tra la speranza e la morte. ” La speranza è una proprietà universalmente umana, basata sulla piú universale proprietà umana, intendo dire il desiderio e, ad un livello superiore, la nostalgia ” afferma Bloch, chiarendo, poi, che essa consiste nel presentificare un futuro non ancora compiuto sia per il mondo esterno che per l’io nella sua vita interiore. Marcel, invece, ritiene che la speranza sia l’anelito di un’anima ad una forma di liberazione assoluta il cui compimento non si realizza pienamente nell’arco della vita. Bloch limita la sfera dello sperabile a ciò che può realizzarsi nella vita terrena, Marcel, invece, vede in questa limitazione una sorta di disperazione, un precludersi la possibilità di comprendere il nesso che intercorre tra speranza e morte. Per Marcel, infatti, l’unica speranza che interessa veramente l’uomo è quella di essere liberato dalla morte, cioè la speranza della resurrezione. Bloch, togliendo alla morte ogni drammatica gravità, la considera lucrezianamente, come la fine di un banchetto, dal quale i commensali si alzano sazi e soddisfatti. Marcel risponde che una tale argomentazione e una siffatta concezione “gastronomica” della vita risulta insignificante a chi, per esempio, ha perso un figlio o è affetto da malattia incurabile. Emerge, quindi, la profonda distanza tra due modi di intendere l’avventura umana: l’uno di tipo immanentistico, l’altro, invece, profondamente religioso e aperto alla trascendenza. È evidente, nella ricerca di Marcel, l’ispirazione cristiana nell’interpretazione dell’uomo; inoltre è possibile ravvisare come il pensatore francese sia capace di intuizioni in grado di rovesciare l’antropologia angusta di quanti tentano di rinserrare la trascendenza nell’orizzonte soffocante dell’esistenza. Ciò che, tuttavia, mi ha maggiormente colpito e che risulta particolarmente apprezzabile è la volontà di Marcel di reagire, di dare una risposta significativa alla crisi storico-sociale e filosofico-culturale che ha investito la società occidentale nel periodo tra le due guerre e nel secondo dopoguerra, ma che continua a caratterizzare il nostro tempo. Marcel ha cercato di restituire valore alla nozione di esistenza facendo appello alle innumerevoli risorse di cui l’individuo è depositario. È l’essere che fascia e avvolge l’esistenza, ma soprattutto che alimenta, secondo Marcel, lo spazio della risorsa e della novità cui bisogna attingere. Pertanto, la ricerca del pensatore francese risulta attraversata da un fondamentale ottimismo, perché caratterizzata da un’inesauribile fiducia nell’uomo. Ne risulta, quindi, sebbene il filosofo, per la scarsa preoccupazione di sistematicità, lasci talvolta indefinite talune allusioni peraltro molto stimolanti, una riflessione antropologica di straordinaria densità e profondità che può contribuire efficacemente a dare un indirizzo piú serio alla moderna concezione dell’uomo, dominato sempre piú da un inquietante disordine e da una sconcertante inconsapevolezza.
HERMANN COHEN

“ Ciò che davvero conta è il nome che si riesce a dare ai fatti, non i fatti in sé. “
Il kantismo a cui facevano riferimento i pensatori che propugnavano apertamente il “ritorno a Kant” era ancora troppo imbevuto di elementi tendenzialmente positivistici: è solamente con la figura di Hermann Cohen (1842-1918) che si può parlare di “neocriticismo” (o “neokantismo”) in senso pieno. Professore a Marburgo dal 1873 al 1912 e in seguito alla Scuola superiore ebraica di Berlino, egli espresse il suo pensiero soprattutto nell’opera “Sistemi di filosofia”, che si articola (è significativo) in tre parti: la “Logica della conoscenza pura” (1902), l’ “Etica del volere puro” (1904) e l’ “Estetica del sentimento puro”. Fin troppo evidente il riferimento a Kant e alle sue tre “Critiche”. Il “Sistema di filosofia” era stato preceduto, in realtà, da tre ampi studi su “La teoria kantiana dell’esperienza” (1871)- che segna l’atto di nascita del neocriticismo di Marburgo- , “La fondazione kantiana dell’etica” (1877) e “La fondazione kantiana dell’estetica” (1879). Soprattutto il primo di questi tre scritti merita di essere menzionato, giacché segna l’inizio epocale di una nuova interpretazione di Kant in chiave anti-idealistica e anti-psicologistica che influenzerà fortemente gli studi per diversi decenni. Nell’interpretare la “Critica della ragion pura” di Kant, di cui preferisce la seconda edizione, Cohen mantiene saldo l’assunto che essa debba essere intesa una ” teoria dell’esperienza “, e in particolare dell’esperienza scientifica fisico-matematica, della quale deve garantire l’universalità e la necessità – quindi la validità – dei princìpi sul piano trascendentale di una fondazione rigorosamente formale. In altre parole, la critica non ha nulla da dire sui contenuti del sapere, ma si presenta come riflessione critica sulla forma della conoscenza: in questo senso, la filosofia di Kant è ” la critica del sistema, dei metodi e dei princìpi di Newton “. E Cohen insiste sul carattere formale sfumando la distinzione kantiana tra sensibilità ed intelletto, presentando l’ Io penso in termini strettamente funzionali, eliminando di fatto il problema della cosa in sé , concepita come un puro concetto-limite. Così scrive Cohen nel I volume del “Sistema di filosofia”:
Nel collocarci nuovamente sul terreno storico della critica, noi rifiutiamo di far precedere la logica da una dottrina della sensibilità. Noi cominciamo col pensiero […]. Questo non può avere nessuna origine fuori di sé. Noi, qui, cerchiamo di costruire la logica come dottrina del pensiero, e questa logica è dottrina della conoscenza “
Tuttavia, quella di Kant è una teoria formale non solo dell’esperienza scientifica, ma anche dell’etica e dell’estetica, i cui diversi princìpi son pur sempre “forme”, condizioni di possibilità. E la stessa unità della ragione viene garantita in quanto unità metodologica. Le dottrine esposte nel “Sistema di filosofia” costituiscono per Cohen uno sviluppo e, per così dire, un aggiornamento del pensiero di Kant: in primis, Cohen chiarisce che la filosofia è una logica della scienza, cioè del sapere universalmente valido, e ha il compito di mostrare le condizioni che rendono possibile la scienza come tale. Egli fa riferimento al modo in cui la matematica costruisce i suoi oggetti producendoli; da ciò desume la convinzione che il principio unico e originario della conoscenza scientifica sia il pensiero puro . Esso è origine e produzione, ma non in senso idealistico, bensì nel senso in cui in matematica si parla di una “x” da determinare. Se la logica della conoscenza pura si riduce ai giudizi del pensiero puro, e questi costituiscono la forma della conoscenza degli oggetti, inevitabilmente Cohen deve concludere con l’identità di pensato ed essere. Ed è qui che il suo pensiero si discosta maggiormente da Kant, nello sforzo, da una parte, di sopprimere la posizione di qualsiasi dato che precede la conoscenza e, dall’altra, di ridurre il problema della logica alla giustificazione del sistema dei giudizi della scienza matematica della natura. L’influenza di Kant si combina qui con quella di Platone. Nelle opere sull’etica e sull’estetica, Cohen estende a queste discipline il problema di una fondazione trascendentale . A proposito dell’etica, egli sostiene che il ” volere puro ” porta al superamento della distinzione tra essere e dover essere, in modo che l’imperativo categorico, che comanda di trattare l’umanità sempre anche come un fine e mai soltanto come un semplice strumento, non rimanga una pura forma morale ma si concretizzi nella realtà. A questo proposito, si fa evidente la dimensione politica della socialdemocrazia tedesca, pur nel rifiuto del materialismo, peraltro testimoniato dal recupero del convincimento kantiano che il sistema etico dovesse culminare nell’idea di Dio:
Con l’ateismo il socialismo perde il suo vertice […] come nel materialismo perde […] il suo fondamento. Con l’ateismo esso diventa in effetti un’utopia […] non gli rimane altra via di scampo che la smania ostinata della distruzione o, nel migliore dei casi, la rassegnazione quietistica […]. Chi parte dalla verità dell’idea spera nella realtà della giustizia. Questa speranza è qualcosa di più che l’espressione emotiva di una convinzione etica: essa è la fede in Dio. “
Cohen, dunque, respinge il materialismo marxista e ad esso contrappone una sorta di “socialismo kantiano”, noto anche come “socialismo della cattedra”: Kant è, a suo avviso, ” il vero ed effettivo fondatore del socialismo tedesco “, giacché comanda di vedere negli altri sempre una finalità, un valore che non può essere calpestato.
PAUL NATORP

Paul Natorp (1854-1924) è, insieme a Cohen, il principale esponente della cosiddetta “scuola di Marburgo”, proponente un critico “ritorno a Kant”. Laureatosi insieme a Gadamer, Natorp fu professore a Marburgo a partire dal 1892 e autore de “La dottrina platonica delle idee” (1903) e dei “Fondamenti logici delle scienze esatte” (1910). Egli si mantiene fedele alla stragrande maggioranza dei capisaldi del pensiero di Cohen, estendendoli anche ai campi della pedagogia e della psicologia, naturalmente non a quella empirica, ma ad una psicologia concepita come vera e propria scienza filosofica, identificabile in fondo con la logica come conoscenza pura. Natorp fa particolarmente leva sull’aspetto logico-metodologico della filosofia, inteso come la trasformazione di ogni fatto – che diventa così un fieri – in problema; ciò implica il riferimento a premesse sempre più fondamentali, nel tentativo di una sempre più rigorosa – ma mai definitiva – legalizzazione dell’esperienza. In questa direzione, si muove anche la sua interpretazione della dottrina platonica delle idee, considerate come le norme della conoscenza vera, i princìpi della sua universalità e necessità. Natorp rimprovera al maestro Cohen di aver preteso di unificare le varie espressioni della cultura in un sistema filosofico dominato dal primato esclusivo della logica e della scienza matematica della natura. La moralità, la religione, l’arte sono forme della coscienza che, per essere diverse da quella scientifica, non sono però meno autentiche di questa e richiedono un’unità del sistema della cultura che la logica non è in grado di offrire. Ne deriva il recupero, avviato nell’ “Introduzione alla psicologia secondo il metodo critico” (1888), della psicologia, cui Natorp affida il compito di raccogliere nell’unità della coscienza le diverse oggettivazioni della cultura, riconducendole al corrispondente “vissuto soggettivo”. Ma non per questo Natorp si allontana dalle istanze neocriticistiche: tant’è che non parla di psicologia empirica, bensì di psicologia filosofica impegnata, per potersi costruire come scienza, a ricondurre il vivente mondo della coscienza all’oggettività di un sistema di leggi, ma insieme anche intesa a recuperare, in un movimento di approssimazione all’infinito, la soggettività pura nella sua originaria immediatezza. Questo aspetto del pensiero di Natorp eserciterà una significativa influenza sulla filosofia fenomenologica di Husserl. Un altro importante contributo al neocriticismo è rappresentato dal modo in cui Natorp mostra di intendere il fatto, ossia gli oggetti di cui si occupa la scienza. In sintonia con Cohen nel considerarli produzioni del pensiero, egli nega che siano qualcosa di fisso e di determinabile una volta per tutte. Viceversa, l’oggetto del sapere scientifico non si esaurisce mai del tutto nelle determinazioni, sempre provvisorie, attraverso le quali la scienza viene definendolo, bensì perché è in se stesso un indeterminato in via di determinazione mai destinata a concludersi. Insomma, l’oggetto non è un dato preesistente alla ricerca, bensì un “compito” che non si lascia mai esaurire. Scrive Natorp nei “Fondamenti logici delle scienze esatte”:
” Non si può dunque più parlare di un ‘fatto’ nel senso di un sapere conchiuso, ma ogni conoscenza che colma con una lacuna del sapere antecedente susciterà nuovi e maggiori problemi […] ‘comprendere’ non significherà giungere col pensiero a un punto fermo, ma al contrario, togliere nuovamente nel movimento quell’apparente punto fermo. ‘Mi si è fermato il cervello’, recita il linguaggio popolare per dire che non si capisce nulla; anch’esso ha dunque coscienza del fatto che l’intelletto è movimento, che l’immobilità equivale al non comprendere […] il ‘fatto’ della scienza deve essere inteso solo come ‘fieri’. Quel che importa è ciò che si va facendo, non ciò che si è fatto. Il ‘fieri’ solo è il fatto; tutto l’essere che la scienza cerca di ‘stabilire’ deve risolversi di nuovo nel flusso del divenire. E di questo divenire, ma soltanto di esso, si può dire che è ” .
Un importante completamento di questa concezione faustiana dell’essere lo troviamo nella lettura kantiana che Natorp propone di Platone, o, se si preferisce, nella lettura platonica che egli fa di Kant. In un famoso saggio del 1903, “La dottrina platonica delle idee. Un’iniziazione all’idealismo.”, egli legge la filosofia platonica alla luce della teoria kantiana delle “categorie”. Contro la tradizione risalente ad Aristotele, che aveva scorto nelle idee di Platone delle realtà “date”, delle “super-cose” esistenti in un mondo trascendente, Natorp le interpreta come la pensabilità delle cose: esse rappresentano le leggi del procedimento scientifico, le funzioni a priori della conoscenza, i princìpi regolativi che esprimono il termine, il punto posto all’infinito al quale sono rivolte le vie dell’esperienza. La lettura delle idee platoniche che dà Natorp è in aperto contrasto con quella che affiora nella “Dialettica” della “Critica della ragion pura”, dove Kant sosteneva che il platonismo sta nell’assimilare le idee di Platone non già alle categorie dell’intelletto, bensì alle noumeniche idee della ragione, veri e propri scavalcamenti dell’empiria. Non è però una dissonanza casuale: ciò che la Scuola di Marburgo respinge di Kant è, per l’appunto, la distinzione tra sensibilità, intelletto e ragione, che essa riconduceva invece ad un medesimo sattuto epistemologico. Una tale riduzione determina l’esaurirsi della ragione nell’immanenza della conoscenza scientifico-naturale e il venir meno di quella tensione verso la noumenicità, che aveva segnato, in senso realmente platonico, la ragione kantiana.
WILHELM WINDELBAND

Già nella seconda metà dell’Ottocento si andò sviluppando negli ambienti culturali tedeschi un ritorno a Kant in funzione antipositivistica. Alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento questo “ritorno” si configurò come un vero movimento filosofico, definito “neocriticismo” o “neokantismo”, che ebbe i suoi centri di elaborazione nella “Scuola di Marburgo” e nella “Scuola di Baden”. Alla prima appartennero Cohen, Natorp, e Cassirer, alla seconda Windelband e Rickert.I membri della “Scuola di Baden” si dedicarono soprattutto a delineare delle “filosofie dei valori”, partendo dalla contrapposizione kantiana tra “fatto” e “valore”. Wilhelm Windelband (Potsdam 1848-Heidelberg 1915), filosofo tedesco, professore nelle università di Zurigo, Strasburgo e Heidelberg, è uno dei più noti storici della filosofia, è considerato il maggior rappresentante della cosiddetta “filosofia dei valori”. E’ autore di Preludi (1884), La libertà del volere (1904), Manuale di storia della filosofia (1892) Principi di logica (1912), Introduzione alla filosofia (1914), Storia e scienza naturale (1894, vi critica le idee esposte in Introduzione alle scienze dello spirito da Dilthey). Storico della filosofia, studioso di Platone, Windelband contesta la concezione, propria dei positivisti classici – anch’essi ritenuti “metafisici” al pari degli idealisti o degli spiritualisti -, che la filosofia debba coordinare, rielaborare e condurre ad unità sistematica i risultati delle scienze. Non c’è dubbio che la filosofia deve collegarsi con i risultati scientifici, ma per individuare in essi la “struttura intima” del lavoro intellettuale e le sue “premesse obiettive”. Deve individuare cioè il loro “valore di verità”. Ogni concezione scientifica è una sistemazione delle esperienze, anzi delle rappresentazioni, secondo una “regola” di “ordine logico”. Ed è questa regola che costituisce il “valore di verità” di una teoria scientifica. Tale regola anzi è la norma a cui l’attività conoscitiva deve conformarsi nel suo procedere. Dunque la filosofia dev’essere in generale “scienza critica dei valori universali”, cioè scienza del vero, del bene e del bello. Essa deve indagare quando e a quali condizioni le attività teoretica pratica ed estetica sono contrassegnate dai loro valori e li attuano nei loro prodotti. In tal senso la filosofia non ha per oggetto il contenuto empirico del conoscere del volere e del sentire, ma le “norme” in virtù delle quali il conoscere il volere e il sentire raggiungono i loro valori. Essa pertanto non tratta “giudizi di fatto”, ma “giudizi di valore”. I primi sono propri della scienza; i secondi invece non possono esser determinati scientificamente, ma solo filosoficamente. Ma quali caratteri deve avere un autentico giudizio di valore? Esso – dice Windelband – dev’esser tale da aspirare ad avere una validità assoluta. Pertanto gli autentici giudizi di valore sono in sostanza “ideali” e “necessari”; anzi sono “idealmente necessari”; essi cioè possono anche non esser riconosciuti validi dalla singola coscienza giudicante, ma “devono” esser tali da poter essere riconosciuti validi universalmente. Sicché l’uomo, nel suo conoscere, agire e sentire, dev’esser sempre “idealmente giudicante”; deve esprimere le regole della sua “coscienza normativa”; cioè deve adeguare la sua “coscienza empirica” alla “coscienza normativa” ch’è il carattere universale e comune a tutti gli uomini. Ecco allora che Windelband contesta la concezione positivistica secondo cui alla filosofia spetterebbe di coordinare, rielaborare e ricondurre ad unità concettuale i risultati scientifici, anche se indubbiamente la filosofia deve correlarsi ai risultati della scienza, ma per trovare in essi la struttura nascosta del lavorio speculativo e le sue precondizioni oggettive di operatività, individuando così il loro valore veritativo. Ogni visione di tipo scientifico organizza esperienze e rappresentazioni secondo un sistema di elaborazione/strutturazione logicamente fondato, ed è questo sistema che determina il valore veritativo. Questo sistema è il principio a cui il conoscente deve adeguarsi nel suo processo di apprendimento.Per Windelband la filosofia si costituisce come “scienza critica dei valori universali”, che sono i classici valori scolastici del vero, del bene, del bello. La filosofia non ha come oggetto il contenuto empirico della conoscenza, della volontà e della percezione, ma le modalità mediante le quali queste pervengono ai loro valori. Il sapere filosofico dunque non applica giudizi di fatto, tipici della scienza, ma giudizi di valore, che non possono esser costituti in prospettiva scientifica, ma solo dal punto di vista speculativo. Per Windelband un autentico giudizio di valore dev’esser in grado di aspirare ad una validità di tipo assoluto, essendo sostanzialmente ideali e necessari, o, più esattamente, sono “idealmente necessari”. Per cui l’uomo come singolo e come collettività, mediante gli atti del conoscere, dell’agire e del sentire, deve sempre porsi in condizione di essere “idealmente giudicante”, di esprimere la propria “coscienza normativa” che si eventua nella creazione e conservazione delle regole, di conformare infine la sua “coscienza empirica” alla “coscienza normativa” che è la caratteristica universale tipica di ogni essere umano. La lezione di Windelband, se fa propria la tendenza kantiana alla schematizzazione ed all’astrattezza, è tuttavia importante per il ruolo che accorda alla scienza storica, ruolo che assumerà sempre più un carattere determinante in Dilthey e nell’altro esponente della Scuola del Baden, Rickert. Nel 1904, Windelband scrive La libertà del volere, in cui parte dai seguenti presupposti: la conoscenza non può mai essere assoluta, sicchè mai conosciamo la realtà quale essa è effettivamente; la nostra conoscenza, dunque, non attinge altro che fenomeni. Ma Windelband – dopo questo incipit kantiano – estende quello che era l’orizzonte di Kant: se per questi la conoscenza fenomenica è determinata da forme a priori (spazio e tempo nel sensibile; le 12 categorie per l’intelletto), per Windelband, invece, essa è determinata dall’applicazione di criteri diversi (“punti di vista“) in forza dei quali si legge la realtà, con l’inevitabile conseguenza che la connessione causale necessaria legante i fenomeni l’uno all’altro è solo un “punto di vista“, un modo di fenomenizzare (e di distorcere) che non può pretendere di conoscere la realtà nella sua noumenicità. Dunque, se per Kant c’è una sola forma di fenomenizzazione, per Windelband, viceversa, ne esistono una pluralità, tutto dipende dal punto di vista che si assume. Così, accanto alla causalità necessaria – usata nell’ambito delle scienze -, esistono anche altri modi di fenomenizzare il reale, ad esempio considerando gli oggetti in una sequenza non di cause ed effetti, ma di mezzi e fini in vista di valori: e il valore è, evidentemente, qualcosa di nettamente diverso da quella causalità necessaria in cui a contare è solamente la connessione necessaria, a prescindere dai valori; qui invece – cioè nell’ambito dei valori – vale l’esatto opposto, a contare sono i valori e, conseguentemente, la possibilità di creare gerarchie assiologiche, senza che la causalità necessaria perda il suo valore. Anzi, essa è affiancata dalla causalità libera, senza la quale non sarebbe in alcun modo possibile parlare di valori: ne segue che ci troviamo dinanzi non già a realtà diverse, bensì a diverse modalità di fenomenizzazione di una stessa realtà. In perfetta sintonia con Windelband, Cassirer – in Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna (1937) – sostiene che vi sono diversi modi di determinazione dell’oggetto, diversi perché obbedienti a diverse forme di conoscenza, che Casirer chiama forme “simboliche“, a sottolineare che non c’è oggettività, ma soggettività che costituisce l’oggetto nella sua simbolicità. Così la scienza determina l’oggetto in connessione causale, mentre la moralità lo determina coi valori. Per meglio chiarire questo punto tipicamente neokantiano, Windelband ricorre ad un esempio particolarmente chiarificante: immaginiamo di avere a portata di mano una statuetta antica; essa sarà considerabile sotto diversi punti di vista, ossia come oggetto di più modi di determinazione. Ad esempio, sul piano naturalistico del rapporto tra causa ed effetto, potrò considerarla come insieme di determinati elementi chimici interagenti fra loro; sul piano estetico, invece, introdurrò forme simboliche e potrò dire che la statuetta è bella; ancora, sul piano religioso la considererò sacra secondo modalità diverse da quelle per cui la concepivo come bella o come aggregato di elementi. Ciò significa, allora, che queste modalità di determinazione sono tra loro indipendenti, cosicchè potrò venerare la statuetta come sacra anche qualora non sia bella. Ne segue che, in realtà, di fronte a me non ho una statuetta in assoluto, ma, al contrario, una statuetta considerata ora dal punto di vista naturalistico, ora da quello estetico, ora da quello religioso: e i criteri con cui la considero in questi modi sono assolutamente slegati l’un dall’altro e non riconducibili fra loro (così, non posso valutare la bellezza della statua considerandone la composizione chimica). Ci troviamo qui di fronte ad un dualismo, o, meglio, ad un pluralismo che però non è più di tipo metafisico (quale invece era quello kantiano del noumeno e del fenomeno), ma è un pluralismo dei punti di vista e che, in forza di ciò, elimina il problema cartesiano – allontanato ma non debellato da Kant – dello “spettro nella macchina” (G. Ryle): questo problema, crassamente evidente in Cartesio e teoricamente allontanato (ma non del tutto) da Kant, è completamente sconfitto da Windelband e da Cassirer che, in questa maniera, salvano la libertà dell’uomo: sono libero perché il determinismo non è che un punto di vista, cosicchè, quando mi considero soggetto morale, non sono un corpo entrante nella serie causa/effetto e ciò non perché la realtà ha due diversi ordini (il fenomenico e il noumenico di cui parlava Kant); basta dire che non c’è oggettività assoluta e subito la causalità non è che un a priori della mente umana (e per ciò presente in tutti gli uomini) che fenomenizza in svariati modi, simbolizzando la realtà e riducendola (dunque ingabbiandola) a forme soggettive. Similmente, certo esistenzialismo novecentesco arriva a negare la realtà nella sua datità – quella presenzialità di cui parla Heidegger -, sostenendo che la realtà non è mai data nella sua oggettiva assolutezza, ma è necessariamente sempre ridotta a significati legati all’esistenza, in virtù del rapporto esistenziale determinato dal soggetto stesso (e non dalle forme a priori dei neokantiani); secondo gli esistenzialisti, sento nella mia esistenza un certo rapporto nel vivere le cose, un modo determinato da me stesso e dal mio modo di percepire la realtà.
HEINRICH RICKERT

Sostenitore di quel “ritorno a Kant” che grande successo ebbe negli ambienti culturali tedeschi a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, Heinrich Rickert (Danzica 1863-Heidelberg 1936), filosofo, professore nelle università di Friburgo e di Heidelberg, allievo di Wilhelm Windelband, fu, col maestro, promotore della “filosofia dei valori”, corrente di pensiero neokantiana che ebbe a Heidelberg e nella scuola di Baden il centro propulsore. Tra le sue opere meritano di essere menzionate: L’oggetto della conoscenza (1892), I limiti della formazione dei concetti scientifici (1896-1902), Scienza della natura e scienza della cultura (1899), Filosofia della storia (1905), Filosofia della vita (1920), Sistema di filosofia (1921), Kant come filosofo della cultura moderna (1924), Problemi fondamentali della filosofia (1934), Immediatezza e significato (1939, postumo). Rickert riprese e rielaborò i temi del discorso di Windelband. Egli pure sottolinea che un contenuto conoscitivo deve incarnare un valore riconosciuto e riconoscibile come tale in modo necessario e universalmente. Sbagliano Nietzsche, Bergson, James e Dilthey a ritenere che i valori siano mere espressioni del fluire incessante della vita e puri e semplici prodotti storici: al contrario, essi sono – asserisce Rickert – le eterne ed immutabili condizioni del processo storico; pur essendo trascendenti, sono essi a conferire un senso alla storia, un senso che essa, di per sé, non avrebbe. Analogamente anche sul piano etico ed estetico. Anzi egli specifica il numero e le caratteristiche dei “domini di valore”. Essi sono sei: logico, estetico, mistico, etico, erotico, filosofico-religioso. I loro rispettivi “valori” sono: verità, bellezza, santità impersonale, moralità, felicità, santità personale. In ognuno di questi domini l’uomo raggiunge un “bene”: scienza, arte, uno-tutto, comunità libera, comunità d’amore, mondo divino. Ognuno d’essi poi comporta una specifica “relazione”: giudizio, intuizione, adorazione, azione autonoma, unificazione, devozione. E infine ciascuno implica una particolare “intuizione del mondo”: intellettualismo, estetismo, misticismo, moralismo, eudemonismo, teismo o politeismo. Ma ciò ch’è piú valido nell’elaborazione di Rickert è invece lo sviluppo di un’idea già esposta da Windelband: quella della necessaria distinzione tra scienze della natura e scienze storiche. Windelband aveva caratterizzato le seconde come “idiografiche”, cioè descrittive della specificità del singolo fatto, in relazione alla particolarità e alla determinatezza della situazione storica in cui esso sussiste; le prime invece come “nomotetiche”, cioè tendenti a “porre leggi” dei fatti. Rickert, riprendendo il discorso elaborato dal maestro, ripropone la distinzione, e specifica che essa non dipende dall’oggetto ma dal metodo. La stessa realtà empirica può esser giudicata sia come natura sia come storia. Nel primo caso, essa viene valutata in relazione alla sua universalità, nel secondo in relazione alla sua particolarità. Nel primo caso la si tratta con il metodo delle scienze naturali, nel secondo con quello delle scienze storiche. È evidente, egli sottolinea, che l'”individuale” assunto ad oggetto delle scienze storiche dev’esser solo quello “significativo”. Pertanto, l’individuale da trattare è sempre “scelto” dallo studioso. Ma la scelta è effettuata in base al “valore” ch’esso esprime. Ciò non significa però che lo storico pronunci giudizi di valore sui valori che quel fatto esprime; lo storico si limita solo a “riconoscerli” là dove sussistono. I valori tuttavia non vengono “prodotti” né “si trasformano” nella e con la storia. Essi sussistono in sé, intangibili, e pertanto sono pre-posti agli eventi. Sono cioè “assoluti” e non “storicizzati”. Anzi, la storia stessa acquista senso nel suo farsi in quanto è guidata e orientata dai valori. Errano quindi quegli “storicisti” che ritengono che essi siano da considerarsi totalmente storicizzati; con tale convinzione essi rivelano solo una concezione relativistica e quindi riduttiva dei valori stessi; concezione peraltro che toglie validità alla conoscenza storica. Di fronte al tragico crollo di tutti i valori che stava percorrendo l’Europa di quegli anni e colto con estrema acutezza da Nietzsche, Rickert e Windelband si oppongono richiamandosi direttamente a quella tradizione metafisica che, da Platone in poi, si era appellato ai valori del bello, del buono, del giusto. Contro tutte le filosofie contemporanee, miranti ad azzerare i valori, Rickert si schiera a viso aperto nel suo scritto del 1920, La filosofia della vita.
ADRIANA CAVARERO

VITA E OPERE
Adriana Cavarero nasce a Bra (in provincia di Cuneo) nel 1947. Trascorre la sua adolescenza a Torino e, successivamente, a Verona. Si laurea in Filosofia e lavora all’Università di Padova, sino al 1984. Poi a Verona, dove fonda con altre la Comunità filosofica femminile “Diotima” – da cui si dimette nel 1990 – e insegna “Filosofia politica”. Negli anni Novanta intensifica i rapporti con il pensiero femminista internazionale, tenendo vari corsi universitari in Inghilterra e negli Stati Uniti. Fra le sue opere ricordiamo: Dialettica politica in Platone (1974); L’interpretazione hegeliana di Pamenide, Quaderni di Verifiche, (1984); Nonostante Platone (1990); Corpo in figure (1995); Tu che mi guardi, tu che mi racconti (1997). Fra i saggi ed articoli vanno invece menzionati: Per una teoria della differenza sessuale; Il pensiero della differenza sessuale (1987); La passione della differenza, in Storia delle Passioni (1995); Il bene nella filosofia politica di Platone e di Aristotele, in “Filosofia politica”, 2(1988); Il modello democratico nell’orizzonte della differenza sessuale in “Democrazia e diritto”, 2(1990); Hannah Arendt: la libertà come bene comune in “Democrazia e diritto” 5-6(1991); Birth, Love, Politics, in “Radical Philosophy” 86(1997).
IL PENSIERO
Il mondo non è abitato dall'”Uomo” – come invece sostiene la tradizione filosofica dai Greci fino al ‘900 -, ma da esseri umani, corporei e sessuati, unici e irripetibili. La domanda fondamentale della filosofia non deve più chiedere che cos’è l’Uomo o l’Essere, bensì chi sei tu. Da sempre la narrazione conosce l’importanza di questa domanda e risponde raccontando una storia. La filosofia può invece rispondere pensando l’identità, fragile ed esposta, di un sé che esiste in relazione con gli altri e la cui esistenza non può essere sostituita da nessun’altra. Il pensiero della differenza sessuale e quello di Hannah Arendt risultano decisivi per pensare questo carattere espositivo e relazionale dell’identità che lavora per una riedificazione radicale dell’etica e della politica. In un’intervista di fine anni ’90, così disse la Cavarero: “Ho molti interessi, ma il mio interesse filosofico fondamentale è quello di dare senso, di fare una filosofia, di praticare una filosofia sensata, ossia restituire a che cos’è, a ciò che è. E una delle caratteristiche di ciò che è, per quanto riguarda noi esseri umani è il fatto che ognuna e ognuno di noi è un essere unico, con una vita irripetibile. Questo mi sembra una realtà molto interessante e tuttavia tradizionalmente la filosofia non si interessa di questo. Lo ritiene un elemento secondario da indagare. Questo è esattamente l’aspetto della filosofia che a me piace di meno. Quindi cerco di praticare una filosofia che invece dia senso a questo nostro esistere, che è un esistere unico, incarnato, irripetibile, dove ne va di ognuno e di ognuna di noi“. Nel femminismo classico si cercava di costruire l’identità femminile partendo da un soggetto centrale, il maschio, ed elaborando differenze rispetto a questo: in tal modo, la donna manteneva connotati di marginalità e risultava essere un polo contrapposto e non paritetico rispetto alla dominanza del polo maschile, che così diveniva quasi un soggetto universale neutro.
Oggi, nell’epoca del post-moderno, lo sviluppo delle nuove tecnologie porta a riflessioni diverse. In Europa, e in genere nei paesi di lingua latina, prevalgono atteggiamenti quasi anti-tecnologici, che identificano nella Tekne ancora un simbolo del predominio maschile, portando in se’ il rischio di arrivare ideologicamente a posizioni metafisiche. Nei paesi anglosassoni, la tecnica viene invece assorbita fino ad arrivare, in particolar modo nella Bay Area di San Francisco, alla nascita del cyberfemminismo, presente soprattutto nell’opera di Donna Haraway (autrice di “Manifesto Cyborg”). La tecnologia non e’ più isolata e dicotomica di fronte all’umano, essere sessuato che nel processo si dissolve, incorpora e viene incorporato, fino ad arrivare ad un nuovo soggetto, fatto di uomo-animale-macchina, il CYBORG, ibrido di cibernetico e organismo. Il cyborg post-moderno accoglie il processo di autodissoluzione, senza preoccuparsi di mantenere un’identità sessuale, e si riconosce in tutti i frammenti che rimangono e che non possono più essere ricomposti in una qualsiasi totalità organica e narrazione. Per Donna Haraway, le identità di classificazione sono inutili e obsolete, costruite e determinate dall’ambiente, mentre l’identificazione in generi multipli diviene sovversiva nei confronti degli stereotipi dominanti. Adriana Cavarero ha un approccio critico rispetto a queste posizioni: affermando che si può fare a meno del concetto di appartenenza sessuale, si rischia di creare un immaginario non corrispondente al reale e non utilizzabile sul piano politico.
Nello Stato moderno si ha un dominio di tipo territoriale con un ambito spaziale ben definito (i confini), centralizzato, razionalizzato e legittimato dal comando dato a chi in esso ha la rappresentanza. Nel territorio si delegano a presenze centrali compiti non sostenibili dalle assenze periferiche, dislocando cosi’ le presenze con scansioni anche temporali e cerimoniali (elezioni). La rete, con la sua struttura a nodi inter-comunicanti, mette in crisi questo modello.
Nascono contatti multipli e incontrollabili tra molteplici presenze virtuali, saltano i ritmi temporali, si sfasa lo stesso ciclo giorno-notte, anche perché il tempo del soggetto e’ insufficiente rispetto ai tempi della rete. In un ambiente in cui saltano tempo e spazio, entrano anche in crisi i quadri di riferimento della politica fisica, e causa prima di questo e’ proprio la comunicazione inter-attiva. Il mondo fisico non riesce più a contenere il mondo virtuale, e questo comporta un ripensamento radicale del concetto di democrazia. La Cavarero critica inoltre l’approccio della Haraway paragonandolo alla nascita di un nuovo pensiero mitologico, in cui tutte le figure hanno polivalenza semantica in quanto ibridi, si veda la Sfinge. E osserva che tutte le mitologie sono allusive sul problema sessuale, che non e’ invece superfluo, ma viene sempre ribadito anche nello scambio dei ruoli, in cui mai si cancella la differenza. Pur sostenendo la validità del superamento delle dicotomie (es. uomo-donna come visto sopra), la relatrice vede un pericolo: un nuovo pensiero che non si dà però la possibilità di ri-pensare, e che, soprattutto nel concetto di genere, potrebbe portare ad una fuga dalla “datità” verso l’astrazione. Si rischia un nuovo processo di omologazione che, pur essendo fluido, diventa nuovamente uno stereotipo, in quanto tutto viene risucchiato dall’identità comune. In sostanza, all’antico sogno del primo femminismo, che voleva costruire una società più giusta, a cui la maggiore presenza femminile avrebbe dato contributi importanti per migliorare la vita umana, si contrappone il disorientamento del pensiero femminista contemporaneo, nel quale una critica corrosiva che raggiunge le origini del pensiero occidentale si unisce ad un senso di disgregazione culturale così totale da non dare spazio a nessun progetto di ricostruzione. Il saggio Le filosofie femministe presenta un saggio introduttivo di Restaino (dedicato alla ricostruzione storico-critica del pensiero femminista) e uno di Cavarero (di taglio teorico-interpretativo) e, infine, un’antologia di testi che chiude il volume. La lucida ricostruzione di Restaino – in cui si coglie il frutto di un’esercitata volontà di ascolto – offre una lettura storica degli sviluppi del pensiero delle donne, ripercorsi tramite un’esposizione dei singoli contributi teorici delle diverse autrici. L’autore (in ciò rimanendo fedele a un’interpretazione che fa dipendere gli inizi del femminismo dal processo storico delle rivoluzioni borghesi: una lettura – sia detto per inciso – certo non infondata, ma che focalizza piuttosto l’apparizione storica allo sguardo maschile di una soggettività femminile che le origini di un percorso che procede da prima e nonostante l’epoca apertasi nel 1789) ne individua gli albori negli scritti di Mary Wollstonecraft, che nel 1792 pubblicava a Londra la Rivendicazione dei diritti della donna. Da allora la riflessione femminista – con la “rivoluzione copernicana” del concetto di differenza sessuale – sarebbe proseguita senza soluzione di continuità, e Restaino ne segue il percorso in un itinerario per temi e aree culturali. Dalle inglesi Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor alle americane Kate Millett e Shulamith Firestone, passando per Virginia Woolf e Simone De Beauvoir, fino ad arrivare alle pensatrici del femminismo italiano contemporaneo, Carla Lonzi, Luisa Murano e la stessa Adriana Cavarero: le affinità e le divergenze tra le diverse filosofie femministe vengono ripercorse, mostrandone le vicende, senza trascurare i più fecondi contatti tra femminismo e una certa tradizione filosofica maschile. La critica femminile al pensiero filosofico occidentale, infatti, è condotta con una libertà che permette di sviluppare alcune delle intuizioni teoriche maschili (tra i nomi ricordati dall’autore quelli di Mill, Engels, Marx, Freud, Derrida, Lacan, Foucault) in un senso imprevisto e di ciò il saggio dà ben conto. Ciò che non poteva essere previsto era un pensiero che riuscisse a superare i limiti di un contesto definito da ciò che Cavarero, nel suo saggio, chiama l’economia binaria dell’ordine simbolico patriarcale (in parole povere, la gabbia è quella dell’incapacità maschile di pensare a sé senza decidere una rappresentazione del sesso femminile a questo sé funzionale. E’ così che il pensiero rimane impigliato nelle ben note dicotomie con poli positivo/negativo: cultura/natura, mente/corpo, pubblico/privato e, chiaramente, uomo/donna). Di costruire quell’ordine appunto si tratta e Adriana Cavarero mostra come su questo le interpretazioni e le strategie femminili si differenzino, anche notevolmente. Lo stesso scritto di Cavarero non vuole essere una neutra esposizione delle vicende filosofico-politiche del movimento femminista, ma si presenta esplicitamente come una presa di posizione all’interno di un panorama variegato, di cui si ricostruiscono rilievi e contorni, con un’attenzione tanto preziosa quanto insolita al radicamento della riflessione filosofica in luoghi precisi: l’autrice a questo riguardo parla di “configurazione geofilosofica”, perché nel recente dibattito femminista “non si tratta solo di varie correnti, e perciò di diversi stili di linguaggio e di pensiero che si incrociano. Si tratta anche di una diversa espansione e clonazione di tali incroci secondo aree geografiche, e perciò linguistiche, distinte”. Le diverse posizioni delle pensatrici su cui Adriana Cavarero si sofferma sono dunque analizzate in riferimento a precise aree geografico-culturali (dai confini mobili e discontinui), e soprattutto secondo l’interpretazione “di parte” che l’autrice chiarisce fin dall’inizio del saggio e che la avvicina, è Cavarero stessa a suggerire l’accostamento, a filosofe come l’inglese Christine Battersby, a dispetto della configurazione geofilosofica che dovrebbe collocarle.
DONALD DAVIDSON

A cura di Sergio Levi
Donald Davidson nasce a Springfield (Massachusetts) il 6 marzo 1917. Trascorre gli anni del liceo fra Staten Island e New York, ma compie gli studi universitari ad Harvard, dove segue i corsi di Whitehead. All’inizio la sua passione è per la letteratura, legge la Bibbia, Shakespeare, Omero e Goethe. Dopo la laurea va a Hollywood, dove si propone senza molto successo come autore radiofonico, finché durante l’estate lo chiamano da Harvard per offrirgli una borsa in letteratura e filosofia. Qui inizia a seguire un corso di logica e un seminario sul positivismo logico, tenuti entrambi da Quine. Questi nel 1933 era tornato dall’Europa dove aveva conosciuto Tarski e Carnap, di cui avrebbe diffuso e successivamente criticato le teorie. Nel 1947 riceve il primo incarico come insegnante al Queens College di New York, dove frequenta Carl Hempel, Sydney Morgenbesser e A.J. Ayer. Completa la tesi di dottorato sul Filebo di Platone. Alla fine del 1950 ha un contrasto con il nuovo presidente del Queens, e già nel gennaio del 1951 è in partenza per Stanford, dove è assunto come Assistant Professor. Qui rimarrà fino al 1970. Dal 1967 al 1968 insegna anche a Princeton, dove frequenta Gil Harman, Gregory Vlastos e Tom Nagel. Nel 1970 accetta un incarico alla Rockefeller University di New York, dove collabora con H.G. Frankfurt, Joel Feinberg e Saul Kripke. Nel 1975 lascia New York per andare a insegnare a Chicago. Nel 1981 entra all’Università della California a Berkeley, dove rimarrà fino alla fine. Nel 1991 la città di Stoccarda gli conferisce il Premio Hegel. Muore in California il 30 agosto 2003. L’influenza del pensiero davidsoniano sul dibattito contemporaneo abbraccia un’area che si estende dalla filosofia dell’azione (qual è la differenza fra un evento fisico e un’azione?) alla teoria della spiegazione razionale (che cosa rende un’azione o un pensiero razionale?), dalla questione del realismo intenzionale (esistono davvero gli stati mentali o sono meri concetti esplicativi?) al problema del significato (che cosa fa sì che le parole abbiano il significato che hanno?), dal problema del rapporto fra mente e corpo all’analisi dei comportamenti irrazionali (autoinganno e debolezza del volere). In filosofia della mente il nome di Davidson è legato alla dottrina del monismo anomalo, una concezione ontologica escogitata per far convivere tre principi comunemente accettati ma apparentemente incompatibili. (1) Principio dell’interazione causale fra mentale e fisico: eventi mentali come credenze e desideri causano le nostre azioni, che causano eventi fisici nel mondo esterno; questi ultimi causano in noi percezioni, credenze e altri stati mentali. (2) Principio nomologico della causalità: se fra due eventi si dà una relazione causale, allora esiste una legge rigorosa sotto la quale i due eventi possono essere sussunti. (3) Principio dell’anomalia del mentale: non esistono leggi psicofisiche rigorose. Proprio in virtù di tale principio, quegli eventi mentali che hanno relazioni causali con eventi fisici devono avere anche descrizioni fisiche, sotto le quali possano ricadere sotto leggi rigorose: dunque devono essere fisici. In altre parole, gli eventi mentali sono individualmente identici a eventi fisici (fisicalismo), ma non c’è modo di ridurre il vocabolario mentale a quello fisico (anti-riduzionismo). Una volta che separiamo il piano delle relazioni causali dal piano delle descrizioni sotto cui gli eventi possono esemplificare leggi rigorose, possiamo difendere l’irriducibilità del mentale senza ricorrere a barriere ontologiche o metodologiche fra scienze umane e scienze della natura. A impedire l’esistenza di leggi psicofisiche rigorose concorrono due ordini di fattori. Innanzitutto, (I) l’olismo del mentale, il fatto che gli stati intenzionali non possono esistere isolatamente. Un atteggiamento proposizionale (come, per esempio, la tua credenza che la terra non sia piatta) viene identificato dalla posizione che occupa all’interno di una rete di credenze, desideri, speranze e altri tuoi atteggiamenti. A ciò si deve aggiungere (II) l’imporsi di principi di carità che inducono un interprete a rendere i suoi informatori razionali e coerenti ogniqualvolta è possibile farlo. La carità, ha spiegato Davidson, “non è un’opzione”, ma la condizione per interpretare gli altri. Se non accordassimo alle parole altrui i nostri standard di razionalità, non potremmo nemmeno avvicinarci a ciò che il parlante intendeva dire. Ma, al di qua degli standard di razionalità imposti dall’interprete, che cos’è che determina il significato delle mie parole o (che è lo stesso) il contenuto dei miei pensieri? Per rispondere a tale domanda è necessario riandare alle situazioni in cui le parole furono acquisite. Ciò che un individuo intende con ciò che dice dipende, infatti, sia da queste situazioni di apprendimento (“veri battesimi di senso”) sia da come le altre persone parlano e si comprendono. È il tema wittgensteiniano della natura essenzialmente sociale del linguaggio e del pensiero, che Davidson riprende attraverso l’immagine del “triangolo di base” parlante-interprete-mondo, in cui ciascun individuo risponde contemporaneamente alle risposte di somiglianza dell’altro, e agli oggetti ed eventi del mondo a cui l’altro sta rispondendo. Il metodo dell’interpretazione radicale non fornisce una spiegazione del processo interpretativo, ma solleva una domanda sulle condizioni di possibilità del suo inizio. Lo scopo del filosofo, sembra dirci Davidson, non è più descrivere da un punto di vista scientifico le tappe che scandiscono la crescita del sapere, come voleva il naturalismo epistemologico di Quine. Tale ideale, essendosi rivelato incapace di porre un argine allo scetticismo, può passare in secondo piano, per fare spazio (sul terreno più generale della filosofia della mente) all’articolazione di un principio “esternalista” o anti-cartesiano, secondo cui i contenuti intenzionali non sono costitutivamente indipendenti dall’ambiente esterno alla mente.
JEAN PIAGET

A cura di Mario Trombino
“L’evoluzione interna dell’individuo fornisce soltanto un numero piú o meno grande, a seconda delle attitudini ai ciascuno, di abbozzi suscettibili di essere sviluppati, distrutti o lasciati ad uno stadio incompleto. Ma non sono che degli abbozzi, e soltanto le interazioni sociali e educative li trasformeranno in condotte efficaci oppure li distruggeranno per sempre. Il diritto all’educazione è dunque, né piú né meno, il diritto dell’individuo a svilupparsi normalmente, in funzione delle possibilità di cui dispone, e l’obbligo, per la società, di trasformare queste possibilità in realizzazioni effettive e utili”. (J. Piaget, Dove va l’educazione?)
VITA E OPERE
Jean Piaget nacque il 9 agosto 1896, a Neuchâtel, Svizzera. Suo padre, uno storico dedito alla letteratura medievale, è descritto da Piaget come “un uomo con una mente molto coscenziosa e critica, che disdegna fortemente le generalizzazioni improvvisate e che non teme di dare avvio a una battaglia quando scopre che una verità storica è rigirata per adattarsi a tradizioni rispettabili” [Piaget 1952, 237]. Piaget ricorda sua madre come una persona intelligente, energica e dolce, ma con un temperamento nevrotico che lo ha portato sia a imitare il padre, sia a rifugiarsi in quello che Piaget ha chiamato un “mondo privato e non fittizio”, un mondo di lavoro serio. Piaget riconosce che la situazione turbolenta della sua famiglia ha creato in lui l’interesse per la teoria psicoanalitica. Sarebbe più facile elencare ciò che non interessava Piaget da bambino piuttosto che ciò che lo interessava. Un campìone dei suoi interessi comprendeva la meccanica, le conchiglie di mare, gli uccelli e i fossili. Uno dei suoi primi scritti è stato un opuscolo (scritto in matita, perché non gli era ancora permesso di scrivere con l’inchiostro) in cui descriveva un “autovap”, un’interessante unione fra un carro e una locomotiva. La prima pubblicazione di Piaget fu un articolo di una pagina, su un passero albino che egli aveva osservato nel parco. Questo risultato fu raggiunto all’età di 10 anni, molto prima che venisse a conoscenza del detto “pubblica o muori! “. L’interesse di Piaget per le raccolte esibite al museo di storia naturale locale, gli valsero l’invito del direttore ad assisterlo nella sua collezione di molluschi di mare. Così Piaget entrò nel campo della malacologia, lo studio dei molluschi, che catturò la sua attenzione per anni. Le pubblicazioni di Piaget sui molluschi attrassero in qualche misura l’attenzione degli studiosi di storia naturale. Senza che fosse conosciuto di persona, gli fu offerta la cura della sezione mulluschi al museo di storia naturale di Ginevra. Egli dovette però declinare l’offerta in quanto non aveva ancora completato la scuola secondaria! Piaget non si sottrasse alle crisi sociali e filosofiche tipiche dell’adolescenza. I conflitti fra l’insegnamento religioso e quello scientifico lo stimolarono a leggere avidamente Bergson, Kant, Spencer, Comte, Durkheim e William James, fra gli altri. Questa inquietudine filosofica viene espressa in un romanzo filosofico, pubblicato nel 1917. Che questo romanzo non divenne un best-seller lo si può capire leggendo frasi come queste: “Ora non ci può essere consapevolezza alcuna di queste qualità, perciò queste qualità non possono esistere, se non c’è relazione fra di esse, se cioè non sono mescolate in una qualità globale che le contiene pur mantenendole distinte”, e “una teoria positiva della qualità che prenda in considerazione solo le relazioni di equilibrio e disequilibrio fra le nostre qualità” [Piaget 1952, 241]. Piaget osservò che “nessuno parlò di quello scrhto, ad eccezione di due filosofi indignati” [ibidem, 243]. Piaget continuò a scrivere intorno a una quantità di questioni .filosofiche. Egli annota: “Scrissi anche se lo facevo solo per me stesso, poiché non potevo pensare senza scrivere, ma doveva essere fatto in modo sistematico, come se si trattasse di un articolo da pubblicare” [ibidem, 241]. In questi scritti si possono ritrovare temi che sono fondamentali nei successivi scritti di Piaget, quali l’organizzazione logica delle azioni e la relazione fra le parti e il tutto. Piaget completò i suoi studi formali in scienze naturali e prese la laurea con una tesi sui molluschi all’Università di Neuchâtel, nel 1918 all’età di 21 anni. Nonostante fino a quel momento egli avesse già pubblicato più di venti lavori, egli non era per niente ansioso di dedicare la sua vita alla malacologia. Dopo aver visitato i laboratori di psicologia a Zurigo e aver brevemente esplorato la teoria psicoanalitica, Piaget passò due anni alla Sorbonne. Lì studiò psicologia e filosofia. Fortunatamente (per la psicologia dello sviluppo), Piaget incontrò Théodore Simon, un pioniere nello sviluppo dei test di intelligenza. Simon, che aveva a disposizione il laboratorio di Alfred Binet in una scuola di Parigi, suggerì a Piaget di standardizzare i test di ragionamento di Binet sui bambini di Parigi. Piaget cominciò il lavoro con scarso entusiasmo, ma il suo interesse aumentò quando comincio a chiedere ai bambini le giustificazioni alle risposte corrette e scorrette da loro date. Cominciò ad essere affascinato dai processi di pensiero che apparivano guidare le risposte. In queste “conversazioni” egli faceva uso di tecniche psichiatriche che aveva appreso quando intervistava malati mentali per il corso che seguiva alla Sorbonne. All’insaputa di Simon, Piaget continuò questo studio per due anni. La successiva pubblicazione di tre articoli basati sulla ricerca condotta nel laboratorio di Binet gli procurò nel 1921 l’offerta di diventare direttore degli studi all’Istituto J. J. Rousseau a Ginevra. Piaget progettava di passare solo cinque anni a studiare la psicologia del bambino (un piano che, fortunatamente, non riuscì). La libertà e le facilitazioni per la ricerca che Piaget ha avuto in questa posizione nutrirono le sue tendenze produttive e lo condussero a pubblicare cinque libri: Il linguaggio e il pensiero del fanciullo (1923), Giudizio e ragionamento nel bambino (1924), La rappresentazione del mondo nel fanciullo (1926), La causalità fisica nel bambino (1927), Il giudizio morale nel fanciullo (1932). Con sua grande sorpresa, i libri vennero letti e discussi diffusamente. Egli divenne noto come psicologo dello sviluppo, anche se non aveva la laurea in psicologia. Era molto richiesto per conferenze e in Europa la sua fama crebbe rapidamente. Questa attenzione del pubblico in qualche modo disturbava Piaget, anche perché pensava che le idee espresse nei suoi libri fossero preliminari e poco solide, piuttosto che affermazioni definitive come molta gente riteneva. Negli anni immediatamente seguenti, Piaget continuò le sue ricerche all’Istituto, insegnò filosofia all’Università di Neuchâtel, imparò la teoria della Gestalt, osservò i suoi figli e persino condusse qualche ricerca sui molluschi nel suo tempo libero! Dal 1929 al 1945, egli occupò diverse posizioni accademiche e amministrative all’Università di Ginevra, come pure posti internazionali, come la presidenza della commissione svizzera dell’Unesco. Intrattenne collaborazioni produttive con Mina Szeminska, Barbei Inhelder e Marcel Lambercier su temi come la manipolazione di oggetti, le nozioni di numero, di quantità fisica, di spazio e lo sviluppo della percezione. Venuto a conoscenza del lavoro di Piaget, Albert Einstein lo incoraggiò ad occuparsi dei concetti di tempo, velocità e movimento. In seguito a questo suggerimento, Piaget scrisse due libri stimolanti: Le développement de la notion du temps chez l’enfant (1946) e Les notions du mouvement et de la vitesse chez l’enfant (1946). Gli anni Quaranta e Cinquanta furono segnati da ricerche su una straordinaria varietà di temi: vari aspetti dello sviluppo mentale, filosofia della conoscenza (la sua vecchia passione), educazione, storia del pensiero e logica. Fra i suoi titoli c’era quello di Professore di Psicologia all’Università’ di Ginevra e della Sorbonne, Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Educazione e Direttore dell’Ufficio Internazionale dell’Educazione. Inoltre, fondò il Centro di Epistemologia Genetica, un punto d’incontro per filosofi e per psicologi. Nel 1969, la American Association assegnò a Piaget il Distinguished Scientific Contribution Award “per la sua prospettiva rivoluzionaria sulla natura della conoscenza dell’uomo e dell’intelligenza biologica” [Evans 1973, 143]. Fu il primo europeo a ricevere tale riconoscimento. Piaget continuò a studiare il pensiero del bambino fino alla sua morte che avvenne il 16 settembre 1980, all’età dì 84 anni. Anche durante i suoi ultimi anni, libri e articoli continuarono a uscire dalla sua casa, il Centro di Epistemologia Genetica. I suoi ondeggianti capelli bianchi, la pipa, il berretto e la bicicletta erano una vista familiare a Ginevra. Abbiamo la seguente descrizione di Piaget a 70 anni: “Si muove in modo deliberato, ma i suoi occhi azzurri brillano di giovinezza, buon umore ed entusiasmo. Era benevolo ma non così pesante da assomigliare a Babbo Natale; piuttosto, richiamava vagamente delle immagini di Franz Liszt che fossero scese fra di noi” [Tuddenham 1966, 208]. Non si può fare a meno di essere colpiti dalla straordinaria produttività di Piaget. Una stima conservativa dei suoi scritti parla di un numero di libri superiore a quaranta e più di 100 articoli solo di psicologia del bambino. Se si aggiungono le pubblicazioni di filosofia e di educazione, le cifre si gonfiano ancora di più.
IL PENSIERO
Lo studioso che ha maggiormente contribuito a modificare l’immagine del fanciullo e dell’educazione nel XX secolo è Jean Piaget, benché non sia un pedagogista, ma uno psicologo. Il suo apporto alla psicologia dell’età evolutiva consiste nell’aver dato una consistenza concreta e scientifica all’idea della pedagogia moderna (da Rousseau all’attivismo) circa la specificità della natura infantile che nei suoi modi di pensare, agire, amare, fare, parlare è profondamente diversa da quella dell’adulto. Per quanto attiene alla pedagogia, Piaget ha sempre sostenuto la necessità di un suo passaggio ad una fase scientifica con precisi punti di riferimento nella psicologia sperimentale, nella sociologia e nei raccordi interdisciplinari, anche se non la concepisce come una disciplina puramente applicativa. L’educatore, infatti, deve avere una preparazione psicologica e deve conoscere quanto gli viene offerto dalla psicologia, ma tocca poi a lui vedere come potrà utilizzare questo bagaglio conoscitivo ideando un insieme di tecniche da sperimentare e adattare personalmente. Certo Piaget ritiene che i tempi e la successione delle fasi di sviluppo psicologico siano immodificabili, togliendo in tal modo rilevanza ed efficacia all’intervento dell’adulto che non può né cambiare né accelerare questi aspetti. L’educazione dunque può solo preparare l’ambiente alla loro comparsa o al loro rinforzo. Poiché il motore dell’intelligenza è la sua azione, l’educatore deve predisporre le condizioni idonee all’esercizio di questo fare, adeguando le sue richieste al livello di sviluppo dell’allievo e costruendo situazioni perché questo adeguamento si produca. Questa centralità del fare (che si traduce in un “far fare”) costituisce il punto di vicinanza di Piaget con l’attivismo. Perciò lo scienziato svizzero, se ha sempre insistito sulla necessità di un adeguamento della scuola alle scoperte della psicologia, ha caldeggiato anche un nuovo profilo professionale degli insegnanti che conciliasse la padronanza dei contenuti disciplinari con una solida preparazione psicologica e un’adeguata capacità di gestione dei metodi e della scuola secondo valenze interdisciplinari. In questo senso la didattica deve essere psicologica e l’insegnante un ricercatore in grado di trovare le condizioni migliori per l’apprendimento e le sottostanti dinamiche psicologiche. Si spiega così anche lo sforzo di Piaget di indagare e chiarire le strutture logiche, linguistiche metodologiche delle discipline in quanto, insieme con la delineazione dei momenti di costruzione, formazione e mutamento delle strutture logiche, psicologiche, cognitive, linguistiche, etiche ecc. dovrebbe essere così possibile dare un’impostazione nuova e funzionale ai metodi, ai curricoli e alla programmazione scolastica. In un contesto storico contrassegnato da profondi cambiamenti sociali, economici e tecnologici, Piaget reca in tal modo il suo contributo ad un adeguamento della scuola e dell’educazione nel delicato momento del passaggio da una scuola d’élite a una scuola di massa e a una formazione permanente.
EUGEN FINK

Eugen Fink (1905-1975) fu allievo di Husserl e di Heidegger a Friburgo: di Husserl egli fu l’ultimo assistente e a lui il padre della fenomenologia guardava, negli ultimi anni, come all’unico dei suoi allievi che avrebbe potuto completarne l’opera interrotta. In realtà, se letto in trasparenza, l’itinerario di Fink parte sì da Husserl, ma poi, passando per Heidegger, giunge alla fondazione di un pensiero autonomo e di una posizione teoretica a sé stante. Fin dall’opera Riflessioni sulla protostoria ontologica di spazio-tempo-movimento (1957), egli va sostenendo l’inadeguatezza del metodo fenomenologico a chiarire i concetti cosmologici essenziali del tempo, dello spazio e del movimento. Questi non sono dei puri e semplici “fenomeni”, ma qualcosa di più fondamentale che ne è alla base e alla cui chiarificazione si richiede un diverso “metodo ontologico”. Nell’opera successiva, intitolata Essere, verità, mondo. Questioni preliminari al problema del concetto di fenomeno (1958), Fink mette alla berlina il concetto di fenomeno, imputandogli l’insufficiente definizione della differenza tra due modi di apparire: apparenza (Schein) e apparizione (Erscheinung). La metafisica tradizionale – rileva Fink – interpreta l’apparire come un qualcosa che accade tra due enti intramondani: la facoltà rappresentativa del soggetto e le cose. Occorre invece sforzarsi di concepirlo come un evento più originario della stessa apparizione dell’ente, cioè come il dispiegarsi reciproco di verità e mondo. Esso coincide con il processo dell’universale individuazione, mediante la quale le cose si profilano spazialmente e temporalmente entro la totalità onnicomprensiva del mondo. Quello che occorre è un nuovo pensiero dell’essere – e qui la consonanza con gli intenti generali di Heidegger è evidente -, che sappia dischiuderci il senso del mondo come “la regione di tutte le regioni”. La ricerca di Fink, in particolare nello scritto Tutto e nulla. Una via più lunga alla filosofia (1959), dedicata al concetto kantiana di mondo, assume la forma di una ricostruzione storica del concetto metafisica di mondo, ed è su questo terreno che si possono misurare le distanze rispetto a Heidegger. Fink concorda con lui nel considerare la storia della metafisica occidentale come quella dell’oblìo progressivo dei concetti autentici di essere e mondo. Ma, mentre Heidegger pone tendenzialmente l’inizio di questa caduta in Platone e in Aristotele, Fink scorge già una profonda frattura tra il “pensiero del mondo” degli Ionici e il “pensiero dell’essere” degli Eleati, tra Eraclito e Parmenide. Il primato dell’idea dell’essere nei confronti di quella del mondo rappresenta, agli occhi di Fink, quell’evento fatale che si caratterizza come oblìo del mondo. La nascita dell’ontologia corrisponde infatti all’esclusione del movimento dal regno dell’essere. Al contrario, non si può ricavare il senso originario del mondo senza la considerazione simultanea di spazio, tempo e movimento. È in Anassimandro che Fink avverte la presenza di un diverso pensiero che non coglie nell’eon (il non spaziale, il non temporale, il non mosso) la “misura assoluta” delle cose intramondane, ma cerca di afferrare l’essere dell’ente dall’orizzonte del mondo. Nell’idea anassimandrea di apeiron, la vera infinitezza del mondo, del cosmo, è assunta a principio da cui scaturiscono tutte le cose. Il “tutto del mondo” è come il grembo in cui tutte le cose sono avvolte e protette. I due movimenti opposti, dello scaturire delle cose dall’apeiron e del loro declinare in esso, sono intesi in una sorta di “gioco” cosmico, cui sono affidate le sorti sia dei piccoli uomini sia delle immani masse stellari. Il pensiero dell’infinito, del movimento originario e del gioco sono – secondo Fink – tre elementi che debbono essere recuperati in un rinnovato pensiero (non metafisico) del mondo. Anche nello scritto Il gioco come simbolo del mondo (1960) il punto di partenza è offerto da un’intuizione del pensiero greco precedente a Platone e ad Aristotele: l’immagine eraclitea di aion (il corso del mondo) come un bambino che gioca a dadi. La tesi di Fink è che il fenomeno umano del gioco acquista un significato universale, una “trasparenza cosmica”, e che sia il gioco sia il mondo si prestano a essere chiariti l’uno alla luce dell’altro. Vi è naturalmente una differenza cosmologica (Heidegger parlava di “differenza ontologica”) tra il gioco come fenomeno umano, che si svolge tra enti intramondani quali l’uomo e le cose, e il gioco del mondo. Tuttavia la peculiarità dell’essere-nel-mondo dell’uomo – come quell’ente che si rapporta estaticamente al mondo e lo penetra comprensivamente – fa sì che il gioco umano possa essere assunto a simbolo del gioco cosmico. Attraverso una critica della concezione metafisica del gioco, ossia da una lato della teorizzazione platonica che riduce il gioco a immagine apparente del mondo, e dall’altro di quella mitica, in cui il gioco viene sacralizzato e, con ciò, ricondotto a regole prefissate, di cui l’uomo non è l’autore, ma gli dei o i demoni, Fink perviene a stabilire le seguenti determinazioni del concetto filosofico di gioco. Nel gioco – come in altre condotte fondamentali, quali il lavoro, la lotta, l’amore, il culto dei morti – l’uomo realizza la sua fondamentale apertura al mondo. Esso è caratterizzato dalla totale gratuità, dall’irrealtà, da un senso di gioia pagana per il sensibile, in cui viene sperimentato il “piacere dell’apparenza”. Nel gioco, l’uomo sembra mimare la stessa onnipotenza del mondo. In queste sue peculiarità, il gioco è simbolo del mondo, del suo essere senza fondamento, scopo, senso, valore e progetto, ma insieme del suo tenere aperti gli spazi e i tempi per l’essere delle cose, il quale ha una ragione e un fine, è ricco di significato e di valore. A differenza del gioco umano, quello cosmico è un gioco “senza giocatore”, un governo cosmico delle cose che non può essere riferito a nessuna entità personale. In forza di ciò, il mondo, al di là di ogni illusione teologica, conserva per l’uomo tutto il suo enigma. Tra le opere di Fink meritano inoltre di essere menzionate Oasi della gioia (1957), La filosofia di Nietzsche (1960) e Sull’entusiasmo: al cuore di quest’ultima, si trova la tensione tra entusiasmo e ragione, che viene mantenuta in un fecondo equilibrio, inteso come l’unico presupposto per una creatività originale e per la libertà di pensiero. Preservare uno spazio positivo alla sfera dell’entusiasmo nel quadro della produzione filosofica significa, soprattutto se questa intenzione proviene da un filosofo appartenente alla scuola fenomenologica, mirare ad un’inclusione del campo delle emozioni all’interno del discorso filosofico e, in definitiva, ad un’estensione del concetto di razionalità. Il contributo di Fink a questo allargamento di orizzonte, che in altre opere egli ha esplicitato soffermandosi su fenomeni dell’esistenza come il gioco, il conflitto, il mito o la gioia, si inscrive nel più ampio quadro delle applicazioni del discorso fenomenologico e presenta come un punto di partenza per riflessioni che possono spaziare dalla filosofia alla poesia, dall’arte alla religione.
ALFRED JULIUS AYER

Alfred Julius Ayer (1910-1989) fu inizialmente il corifeo anglosassone del neopositivismo, che egli sintetizzò in maniera esemplare nel suo saggio Linguaggio, verità e logica (1936). Durante un soggiorno a Vienna nel 1932, egli entrò in contato con il neopositivismo del “Circolo di Vienna” e nel suo primo scritto Language, Truth and Logic (Linguaggio, verità e logica, 1936), sostiene i principali temi neopositivistici, anche se con grande attenzione alle questioni etiche e religiose. Successivamente affronta le questioni tipiche dell’empirismo inglese (i dati sensibili, la conoscenza del mondo esterno, ecc.) risentendo anche dell’influenza del secondo Wittgenstein. Professore di Logica dapprima a Londra e successivamente a Oxford, Ayer accentua nella sua opera la valenza logico/linguistica dell’analisi, a svantaggio delle indagini sul funzionamento effettivo del sapere scientifico. Questo aspetto non discende però da un’intenzionale adesione agli atteggiamenti cardinali della filosofia analitica – adesione che in Ayer avviene in seguito -, ma da un limite oggettivo nel suo modo di intendere la filosofia della scienza. Infatti, si cercherebbero senza successo, nel saggio Linguaggio, verità e logica, riferimenti concreti e precisi alla prassi delle scienze positive e alla fisica in primis, ridotte a un genere specifico di linguaggio e di logica del quale viene ignorata la connessione con l’esperienza e con la sperimentazione. Del resto, l’opera del ’36 non rivela alcun interesse per l’analisi del linguaggio ordinario. Ayer vi difese strenuamente una forma accentuata di verificazionismo e abbracciò un empirismo estremo che poi fu superato dagli stessi sviluppi interni del movimento neopositivistico. La versione ayeriana, assai ristretta e parziale, del principio di verificazione si proponeva di mettere al bando senza mezzi termini ogni forma di metafisica, i cui enunciati non erano a suo avviso né analitici (come invece erano quelli matematici) né sintetici (come invece erano quelli empirici) e, pertanto, privi di qualsiasi valore conoscitivo. Il rifiuto della metafisica poggia dunque sulla constatazione della sua infondatezza gnoseologica. Ne seguiva che la filosofia si dissolveva come disciplina autonoma ed era riassorbita nella riflessione metodologica interna ai vari settori della scienza. Un po’ diversa sarà la posizione sostenuta da Ayer verso la metafisica in un saggio del 1966, intitolato Metaphysics and Common Sense: anche qui egli vuol mantenere le distanze dalla metafisica, secondo la tradizione del neopositivismo, dell’empirismo e del primo Wittgenstein, ma prendere le distanze non significa più rifiuto totale e in blocco. Certamente la metafisica non svolge nessuna funzione conoscitiva e nemmeno è in grado di autogiustificare la propria esistenza (sulla scia di quanto Ayer sosteneva già nel ’36); ma può svolgere comunque una funzione positiva come correttivo di certe difese strenue del “linguaggio comune” (come il linguaggio comune è correttivo “ai voli più spericolati della metafisica”):
C’è un senso in cui essa può accrescere la nostra comprensione del mondo, aprendoci gli occhi sulle implicazioni teoriche dei modi in cui noi lo descriviamo. Io non ho alcuna ricetta sovrana per risolvere, o dissolvere, gli enigmi filosofici, ma in alcuni casi, almeno, penso che la soluzione può prendere la forma “metafisica” di mostrare che qualche classe di entità è eliminabile, o che il carttere di qualche concetto, o serie di concetti, è stato inteso erroneamente, o che qualche concetto potrebbe, con vantaggio, venire definito piú rigorosamente o modificato in qualche maniera.Il fatto che si possano sollevare problemi esterni ci induce anche a tollerare asserzioni metafisiche come quella che siamo noi a introdurre il tempo nel mondo. L’implicazione è che la realtà è condizionata dal nostro modo di descriverla e che sta a noi decidere quale metodo impiegare, cosicché in un certo senso noi non scopriamo propriamente, ma determiniamo come il mondo è. Anche qui, tuttavia, non dobbiamo parlare di metodi alternativi di descrizione, dobbiamo accertarci che esistano, ed è arduo vedere come ci potrebbe essere una descrizione intelligibile del mondo che non includesse la categoria di tempo. Non va inoltre dimenticato che quando parliamo di noi stessi come facenti questo o quello, stiamo già operando all’interno di un sistema concettuale. Poiché, che cosa siamo noi, se non corpi fisici che occupano una posizione nello spazio e nel tempo? Ma, fino a che stiamo operando entro un sistema concettuale, siamo legati ai suoi criteri di realtà; e allora dire che introduciamo il tempo nel mondo è dire che capitò niente prima della comparsa degli uomini sulla Terra, il che è completamente falso, proprio come è completamente falso, se uno sta operando entro un sistema che pone la condizione degli oggetti fisici, dire che questi non esistono quando non sono percepiti. Ciò che il metafisico gradirebbe fare è di assumere una posizione al di fuori di un sistema concettuale: ma ciò non è possibile. Il massimo che e gli può sperare di ottenere è qualche modificazione del prevalente orientamento generale; trovare un modo, per esempio, di eliminare i termini singolari o forse anche escogitare di rappresentare se stesso e le cose attorno a sé come costruzioni logiche a partire dalle loro apparenze. Ma se tale avventura deve essere comprensibile, e sia pur soltanto di interesse teorico, essa deve avere almeno una corrispondenza grossolana con il modo in cui esse sono ordinariamente concepite. Cosí se un filosofo vuol riuscire non soltanto a coinvolgerci in enigmi logici o semantici o epistemologici, ma nel cambiare o nell’affinare la nostra visione del mondo, egli non può lasciare dietro di sé il senso comune. Questo non significa tuttavia, che egli debba vincolarsi strettamente alle sue domande. L’insistenza sul fatto che il linguaggio ordinario è perfettamente a posto è stata un correttivo assai utile ai voli piú spericolati della speculazione metafisica, ma, se presa troppo letteralmente, può portare al nostro lasciare andare cose che potrebbero essere poste in questione e a mobilitarci in difesa di ciò che non bisognerebbe difendere. È certo meglio ordinare le pietre miliari lungo la strada principale dell’uso ordinario che parlare con grande entusiasmo della nullità o dell’essenza dell’uomo; ma sarebbe un errore concettuale rinunciare alle specie piú ricche di immaginazione dell’esplorazione concettuale, puramente a causa del maggior rischio di perdersi. In filosofia niente dovrebbe essere assolutamente sacrosanto: neppure il senso comune.
Sempre nel saggio del ’36, Ayer andava sostenendo una prospettiva emotivistica dell’etica, secondo la quale le asserzioni etiche sarebbero semplicemente espressioni del sentimento, prive di contenuto cognitivo e di valenza prescrittivi. Le valutazioni non aggiungono alcunché di fattuale alle proposizioni, cosicché asserire “hai fatto male a rubare!” equivale in tutto e per tutto ad asserire “hai rubato”, a parte l’aggiunta della personale disapprovazione di quell’azione.
“Vi sono, in primo luogo, proposizioni che esprimono definizioni di termini etici, ovvero giudizi intorno alla legittimità o possibilità di certe definizioni. In secondo luogo si danno proposizioni che descrivono i fenomeni dell’esperienza morale e le loro cause. In terzo luogo vi sono esortazioni alla virtù morale. E, da ultimo, si danno effettivi giudizi etici. Purtroppo si dà il caso che la distinzione, pur cosí lineare, di queste quattro classi sia comunemente ignorata dai filosofi; con il risultato che spesso dalle loro opere riesce molto difficile dire cosa vadano cercando di scoprire o dl provare. In realtà è facile vedere che soltanto la prima delle nostre quattro classi, e precisamente quella comprendente le proposizioni che si riferiscono alle definizioni di termini etici, si può dire costituisca la filosofia etica. Le proposizioni che descrivono i fenomeni dell’esperienza morale e le loro cause, vanno assegnate alla psicologia o alla sociologia. Le esortazioni alla virtù morale non sono affatto proposizioni, ma esclamazioni o comandi con la funzione di spingere il lettore verso azioni di un certo tipo. Perciò non appartengono a nessun ramo della filosofia o della scienza. Riguardo alle espressioni di giudizi etici, non abbiamo ancora stabilito come classificarle. Ma in quanto certamente non si tratta né di definizioni, né di commenti a definizioni, né di citazioni, possiamo decidere che non appartengono alla filosofia etica. Perciò un trattato rigorosamente filosofico intorno all’etica non dovrebbe presentare espressioni etiche” (Linguaggio, verità e logica).
A partire dagli anni Quaranta, anche successivamente a parecchie critiche che lo accusavano dell’insostenibilità del principio di verificazione da lui formulato, Ayer cambiò rotta, scostandosi dalle posizioni neopositivistiche fino ad allora sostenute e scrivendo testi come I fondamenti della conoscenza empirica (1940), Saggi filosofici (1959), Il problema della conoscenza (1956), Il concetto di persona e altri saggi (1963) e infine Bilancio filosofico (1973) e La filosofia del Novecento (1982). Il fondamento empirico delle concezioni di Ayer risulta dalla permanente esigenza di un verificazionismo che però adesso richiede soltanto l’astratta possibilità di effettuare la verifica empirica indiretta degli enunciati. Il fatto che nessun enunciato sia verificabile in maniera totale e definitiva non porta comunque allo scetticismo, giacché uno scetticismo radicale è improduttivo. Rilevante è piuttosto stabilire il diverso grado di affidabilità delle nostre affermazioni, il che tuttavia non ha portato Ayer ad affrontare (come invece fecero gli altri neopositivisti) la teoria della probabilità, della quale egli sostenne sempre un’interpretazione soggettivistica. Benché si affacciassero sempre nuove problematiche, Ayer non rinnegò mai le tesi sostenute ai tempi di Linguaggio, verità e logica e rimase sempre fedele al metodo dell’analisi linguistica in tutta la sua produzione: quest’ultima, al di là della maggiore o minore originalità delle soluzioni prospettate, continua ad avere fortissime connessioni con l’empirismo inglese di David Hume e di Bertrand Russell.
JEAN-LUC NANCY

Jean-Luc Nancy, nato nel 1940, è sicuramente una delle figure più interessanti sullo scenario filosofico immediatamente successivo a Lévinas, Foucault, Derrida e Deleuze. Per sottolineare l’importanza di questa “figura di classico vivente” (Marco Vozza), Derrida ha a lui dedicato un voluminoso libro (Le toucher. Jean-Luc Nancy, 2000) e, nel corso del 2002, il Collège International de Filosofie ha in suo onore organizzato un convegno intitolato Sens en tous sens (Il senso in tutti i sensi). Nancy è stato docente di filosofia presso le università di Strasburgo e di San Diego; dopo aver subito un trapianto cardiaco, egli ha continuato a vivere grazie al cuore di una giovane donna, ossia di quell’Intruso di cui egli parla in un omonimo saggio autobiografico del 2000. In esso, Nancy affronta senza timore l’esperienza della malattia, raccontando apertis verbis le sofferenze provocate dal trapianto e da un cancro di origine immunodepressiva. Nancy è autore di parecchie opere, molte delle quali tradotte in svariate lingue. Con Lacoue-Labarthe ha scritto L’absolu littéraire (1978), Il titolo della lettera. Una lettura di Lacan (1990) e Il mito nazi (1991): di fondamentale importanza sono i suoi scritti La comunità inoperosa (1986), L’esperienza della libertà (1988), Il corpo (1992) e Essere singolare plurale (1996). L’idea cardinale che sta al cuore della riflessione di Nancy – a partire dal suo pensiero circa la comunità, la libertà e il corpo – è la nozione dell’essere singolare plurale, nozione che – come abbiamo precedentemente visto – dà anche il titolo a una sua opera. Secondo Nancy, il quale non fa segreto dell’ambizione di rifondare interamente la “filosofia prima”, il singolare plurale forma la costituzione d’essenza dell’essere, il quale è, al contempo, singolarmente plurale e pluralmente singolare. Infatti, convinto che mai vi sia stato né che mai vi sarà un assoluto solipsismo filosofico (ossia una filosofia del soggetto concepita come “chiusura infinita in sé di un per-sé”), egli asserisce che tutto ciò che esiste, dal momento che esiste, “coesiste”:
“Essere singolare plurale significa: l’essenza dell’essere è, ed è soltanto, una co-essenza; ma co-essenza o l’essere-con-l’essere-in-tanti-con designa a sua volta l’essenza del co-, o ancora meglio il co- (il cum) stesso in posizione o in guisa di essenza”.
Non si tratta allora dell’essere prima facie, cui si aggiunge il “con”, ma del “con” al cuore dell’essere. Da ciò deriva la necessità di rovesciare l’ordine dell’esposizione filosofica tradizionale, per cui il “con” solitamente viene dopo. Tale ordine è stato conservato da Heidegger stesso, che introduce la cooriginarietà dell’essere-con (Mitsein) solo dopo aver fissato l’originarietà dell’esser-ci (Dasein):
“Dunque: non prima l’essere dell’essente e poi l’essere stesso come essente l’uno-con-l’altro, ma l’essente – ogni essente – determinato nel suo stesso essere come essente l’uno-con-l’altro. Singolare plurale: cosicché la singolarità di ciascuno è indissociabile dal suo essere-con-in-tanti”.
D’altra parte – rileva Nancy – singuli in latino si dice solo al plurale, giacché designa “l’uno” dell’“uno a uno” e quindi la finitudine originaria dell’esistenza e della struttura relazionale che la costituisce: “il singolare è fin da subito ‘ogni’ uno, e dunque anche ogni ‘con’ e’ tra’ tutti gli altri”. Intrecciando ontologia e politica, Nancy finisce per fare di questa concezione sociale dell’essere – nel cui ambito “la verità dell’‘ego sum’ è un ‘nos sumus’” e la comunità coincide con il modo di essere dell’esistenza stessa – la base di un essere-insieme autenticamente inteso. Infatti, anche senza pretendere di addentrarsi in dettagli tecnici e normativi, che non competono al pensiero “radicale” della filosofia, Nancy finisce per approdare a una sorta di prospettiva “impolitica” indirettamente protesa a “depoliticizzare la società, ma non nel senso in cui intendono questa operazione i liberali. Alla politica non va sostituita l’economia, come sta avvenendo in quest’epoca di globalizzazione, ma la Politica vera, quella degli antichi” (Roberto Esposito, Con Jean-Luc Nancy. Filosofia allo specchio per guardare la libertà). In quest’accezione – avverte Nancy – l’ontologia non occupa uno spazio arretrato, speculativo, ossia quello dei princìpi astratti:
“Il suo nome significa: pensiero dell’esistenza. E la sua situazione significa oggi: pensare l’esistenza all’altezza di quella sfida di pensiero che è la mondialità come tale (che la si definisca poi come ‘capitale’, ‘(dis)occidentalizzazione’, ‘tecnica’, ‘frattura della storia’, ecc.)”.
Un altro tema che sta particolarmente a cuore a Nancy, che su di esso si è a lungo affaticato, è quello dell’esperienza della libertà. Essere liberi vuol dire decidere di esistere, senza pretendere di ancorarsi a un’essenza o a un fondamento. Significa accettare le condizioni di un essere che si ritrae e abbandona l’esistente alle proprie possibilità:
“Se non pensiamo l’essere stesso, l’essere dell’esistenza abbandonata, o l’essere dell’essere-nel-mondo come ‘libertà’ (e forse come una libertà e una generosità più originaria di ogni libertà) siamo condannati a pensare la libertà come un’idea e come un ‘diritto’ puri, per concepire in compenso l’essere-nel-mondo come una necessità assolutamente cieca e ottusa” (L’esperienza della libertà).
Animale “non ancora definito”, come dice Nietzsche, l’uomo è libertà perché, non precondizionato da un’essenza esterna, si trova nell’anarchica ed entropica condizione di dover fuggire da essenza a se medesimo, senza che tutto ciò implichi una teoreticistica riduzione dell’essenziale all’esistenziale (o del trascendentale all’effettuale), giacché l’uomo si sente libero quando, nella sua singolarità, non si identifica con nulla, neppure con la propria singolarità. Più che un concetto, un valore o un diritto, la libertà è allora un’opzione o una forma di vita (in greco bioV) distinta dal semplice vivere (in greco zhn) e dunque un’esperienza a cui non il pensiero astratto, ma l’esistenza concreta dà forma e risalto. Un altro motivo portante nella riflessione di Nancy è quello del corpo: si tratta evidentemente di un motivo che si riconnette organicamente ai precedenti. Infatti, se la specificità dell’esistenza è il non avere un’essenza, il corpo è l’essere dell’esistenza e il luogo originario del suo accadere: la concretizzazione del suo senso. D’altra parte, il contatto e la relazione avvengono solamente attraverso i corpi: da ciò affiora l’importanza imprescindibilmente ontologica della sessualità (trattata nel saggio Il y a du rapport sexuell, 2001), per via del suo emblematico rimando alla pratica della condivisione e dell’essere-in-comune.
UMBERTO GALIMBERTI

A cura di Simone Tunesi
Nato a Monza nel 1942, Umberto Galimberti è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca’ Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia.
Nelle sue opere più importanti come Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente (1975), Psichiatria e Fenomenologia (1979), Il corpo (1983), La terra senza il male. Jung dall’inconscio al simbolo (1984), Gli equivoci dell’anima (1987) e Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica (1999), Galimberti indaga il rapporto che effettivamente sussiste tra l’uomo e la società della tecnica.
Memore della lezione di Emanuele Severino (di cui è stato allievo) e di Heidegger, Galimberti sostiene che nelle condizioni attuali l’uomo non è più al centro dell’universo come intendeva l’età umanistica: tutti i concetti chiave della filosofia (individuo, identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, natura, etica, politica, religione, storia) dovranno essere riconsiderati in funzione della società tecnologica attuale.
Al centro del discorso filosofico di Galimberti c’è la tecnica, che secondo il filosofo è il tratto comune e caratteristico dell’occidente. La tecnica è il luogo della razionalità assoluta, in cui non c’è spazio per le passioni o le pulsioni, è quindi il luogo specifico in cui la funzionalità e l’organizzazione guidano l’azione.
Noi continuiamo a pensare la tecnica come uno strumento a nostra disposizione, mentre la tecnica è diventata l’ambiente che ci circonda e ci costituisce secondo quelle regole di razionalità (burocrazia, efficienza, organizzazione) che non esitano a subordinare le esigenze proprie dell’uomo alle esigenze specifiche dell’apparato tecnico. Tuttavia ancora non ci rendiamo conto che il rapporto uomo-tecnica si sia capovolto, e per questo ci comportiamo ancora come l’uomo pre-tecnologico che agiva in vista di scopi iscritti in un orizzonte di senso, con un bagaglio di idee e un corredo di sentimenti in cui si riconosceva. Ma la tecnica non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela verità: la tecnica funziona e basta.
Il punto cruciale sta nel fatto che tutto ciò che finora ci ha guidato nella storia (sensazioni, percezioni, sentimenti) risulta inadeguato nel nuovo scenario. Come “analfabeti emotivi” assistiamo all’irrazionalità che scaturisce dalla perfetta razionalità dell’organizzazione tecnica, priva ormai di qualunque senso riconoscibile. Non abbiamo i mezzi intellettuali per comprendere la nostra posizione nel cosmo, per questo motivo ci adattiamo sempre di più all’apparato e ci adagiamo sulle comodità che la tecnica ci offre. Ciò di cui necessitiamo è un ampliamento psichico capace di compensare la nostra attuale inadeguatezza.
Inadeguato non è solo il nostro modo di pensare, inadeguata è anche l’etica tradizionale (cristiana e kantiana in particolare): le diverse etiche classiche, infatti, ponevano l’uomo al centro dell’azione, per cui Kant dice di non trattare l’uomo come mezzo ma sempre come fine. Ma oggi questo è smentito dai fatti dell’apparato, infatti l’uomo (per usare un’espressione di Heidegger) è la materia prima più importante, è ciò di cui la tecnica si serve per funzionare. La scienza , da quando è al servizio della tecnica e del suo procedere, non è più al servizio dell’uomo, piuttosto è l’uomo al servizio della tecno-scienza e non solo come funzionario dell’apparato tecnico come gli esponenti della Scola di Francoforte andavano segnalando sin dagli anni ’50, ma come materia prima. L’etica, di fronte alla tecnica, diventa pat-etica, perché come fa a impedire alla tecnica che può di non fare ciò che può? E l’etica, nell’età della tecnica, celebra tutta la sua impotenza. Infatti, finora abbiamo elaborato delle etiche in grado di regolare esclusivamente i rapporti tra gli uomini. Queste etiche, religiose o laiche che fossero, controllavano solo le intenzioni degli uomini, non gli effetti delle loro azioni, perché i limiti della tecnica a disposizione non lasciava intravedere effetti catastrofici. Anche l’etica della responsabilità che affiancò l’etica dell’intenzione (Kant) ha, oggi i suoi limiti. A formularla fu Max Weber (poi la riprese Jonas nel suo celebre teso Il principio di responsabilità) che però la limitò al controllo degli effetti “quando questi sono prevedibili”. Sennonché è proprio della scienza e della tecnica produrre effetti “imprevedibili”. E allora anche l’etica della responsabilità è costretta a gettare la spugna. Oggi siamo senza un’etica che sia efficace per controllare lo sviluppo della tecnica che, come è noto, non tende ad altro scopo che non sia il proprio potenziamento. La tecnica, infatti, non ha fini da realizzare, ma solo risultati su cui procedere, risultati che non nascono da scopi che ci si è prefissi, ma che scaturiscono dalle risultanze delle sue procedure.
Per Galimberti viviamo in una società al servizio dell’apparato tecnologico e non abbiamo i mezzi per contrastarlo, soprattutto perché abbiamo la stessa etica di cent’anni fa: cioè un’etica che regola il comportamento dell’uomo tra gli uomini. Tuttavia quello che oggi serve è una morale che tenga conto anche della natura, dell’aria, dell’acqua, degli animali e di tutto ciò che è natura.
Riprendendo importanti autori come Marx, Heidegger, Jaspers, Marcuse, Freud, Severino e Anders e coinvolgendo discipline quali l’antropologia filosofica e la psicologia , Galimberti sostiene che oggi l’uomo occidentale dipende completamente dall’apparato tecnico, è un uomo-protesi come sosteneva già Freud, e questa dipendenza non sembra potersi spezzare. Tutto rientra nel sistema tecnico, qualsiasi azione o gesto quotidiano l’uomo compie ha bisogno del sostegno di questo apparato. Ormai viviamo nel paradosso, infatti se l’uomo vuole salvare se steso e il pineta dalle conseguenze del predominio della tecnica (inquinamento, terrorismo, povertà, etc.) lo può fare solo con l’aiuto della tecnica: progettando depuratori per le fabbriche, cibi confezionati, grattacieli antiaerei e così via. Il circolo è vizioso e uscirne, se non impossibile, sembra improbabile, visto soprattutto la tendenza delle società occidentali. Una speranza sarebbe quella di riuscire a mantenere le differenze tra scienza e tecnica; se riusciamo a salvaguardare una differenza tra il pensare e il fare, l scienza potrebbe diventare l´etica della tecnica. La tecnica procede la sua corsa sulla base del “si fa tutto ciò che si può fare”. La scienza, che è il luogo pensante, potrebbe diventare, invece, il luogo etico della tecnica. In questo senso va recuperato il valore umanistico della scienza: la scienza al servizio dell’umanità e non al servizio della tecnica. La scienza potrebbe diventare il luogo eminente del pensiero che pone un limite. Perché la scienza ha un´attenzione umanistica. Promuove un agire in vista di scopi. Mentre la tecnica è un fare senza scopi, è solo un fare prodotti.
Il valore più profondo del pensiero di Galimberti consiste, appunto, nel tentativo di fondare una nuova filosofia dell’azione che ci consenta, se non di dominare la tecnica, almeno di evitare di essere da questa dominati.
GÜNTHER ANDERS

A cura di Simone Tunesi
Günther Anders nacque a Breslavia nel 1902. Laureato in filosofia nel 1923 sotto la guida di Husserl, nel 1933 dopo l’avvento al potere del nazismo (era ebreo) si trasferisce prima a Parigi e poi negli Stati Uniti (New York e Los Angeles) dove tra le altre cose fa anche l’operaio. Dopo essere stato il primo marito di Hannah Arendt, sposò nel 1945 la scrittrice Elisabeth Freundlich. Nel 1950 tornò in Europa, stabilendosi a Vienna dove morì nel 1992. È autore di un’opera ancora in parte inedita in cui l’interesse per la filosofia si alterna con quello per la letteratura e per l’arte. La sua opera più importante L’uomo è antiquanto si divide in due volumi: il primo del 1956 ha come sottotitolo Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, mentre il secondo; pubblicato nel 1980, Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale.
Sono famose, inoltre, le sue prese di posizione sulla bomba atomica (Essere o non essere e La coscienza al bando entrambi Einaudi, 1961 e 1962), sulla guerra del Vietnam (fece parte del tribunale Russell contro i crimini di guerra) e su Černobyl. Disponibili in traduzione italiana anche: Opinioni di un eretico (Teoria, 1991); Patologia della libertà (Palomar, 1994); Noi, figli di Eichmann (La Giuntina, 1995), Stato di necessità e legittima difesa (Cultura della pace, 1997), Saggi sull’esilio americano (Palomar, 2003) e Amare.Ieri. Annotazioni sulla storia della sensibilità (Bollati Boringhieri, 2004).
Un episodio piuttosto curioso riguarda il nome del filosofo. Infatti Gunther Anders non è altro che lo pseudonimo di Gunther Strern; il fatto risale alla giovinezza dell’autore, quando un editore gli disse di scegliersi un nome diverso per pubblicare i suoi lavori, giacché era un cognome tipicamente ebreo e oramai stavano sempre più affermandosi le idee naziste. Così il giovane Gunther scelse come cognome proprio “diverso” (in tedesco Anders significa appunto “diverso”). Norberto Bobbio nel presentare Essere o non essere: diario di Hiroshima e Nagasaki ha scritto:
“Lo scopo dell’autore è più quello di scuotere gli indifferenti, di incitare i dubbiosi, di rendere perpetuamente inquieti gli ottimisti di professione e vigilanti i già convinti, che non quello di suggerire soluzioni immediate e indiscutibili. Da una pagina autobiografica del libro si apprende che, quando l’autore ebbe acquistato coscienza che è in gioco, oggi, ‘la conservazione del tutto’, il suo pensiero dominante diventò quello di suscitare questa coscienza anche negli altri, a costo di apparire agli occhi di qualche vecchio amico un ‘fissato’. A chi gli rimprovera di aver abbandonato la versatilità di un tempo, di voler viaggiare ormai su di un binario unico, risponde: ‘Ma a che serve questa versatilità, quando siete tutti sul treno che corre difilato sul suo binario unico verso la catastrofe?’“
Il pensiero di Anders (inspiegabilmente poco conosciuto, non solo in Italia) si radica profondamente nella cultura nel ‘900, la sua filosofia è volta a stabilire le cause che hanno portato l’uomo a creare una società in cui l’unico protagonista è l’apparato tecnico.
Secondo Anders, infatti, oggi viviamo in un mondo in cui la macchina e gli oggetti prodotti in serie sono diventati i protagonisti della storia, il mondo è il luogo in cui ogni essere umano è ‘gettato’ e costretto a vivere in qualità di essere totalmente inadeguato ai nuovi tempi.
Figura paradigmatica di questa situazione è Prometeo. Infatti, ciò che caratterizza oggi, più che mai, l’uomo è la vergogna prometeica. L’uomo della civiltà tecnologica, come un novello Prometeo, è subalterno alle macchine da lui stesso create, e per queste prova soggezione e vergogna. Questa vergogna è anche legata a una sorta di dislivello tra l’uomo e i prodotti meccanici, che essendo sempre più efficienti e funzionali lo oltrepassano facendolo diventare antiquato. Le macchine sono perfette, funzionano e sono ripetibili in serie: questo concedo loro una sorta di eternità che all’uomo è negata. Di fronte alle macchine l’uomo perde la sua importanza all’interno del sistema sociale, egli diventa antiquato perché, appunto, ha bisogno di riposarsi, di mangiare, di divertirsi mentre le macchine funzionano “sempre” senza intervalli e distrazioni. Il parallelo uomo-macchina sembra, dunque, volgere tutto a favore di quest’ultima.
Se la prima rivoluzione industriale è consistita nell’introduzione del macchinismo, se la seconda si riferisce alla produzione dei bisogni, la terza rivoluzione industriale (quella che attualmente stiamo vivendo e che è nata nello scorso secolo) è per Anders quella che produce l’alterazione irreversibile dell’ambiente e compromette la sopravvivenza stessa dell’umanità.
Simbolo incontrastato e paradigma della nuova era (e della sua pseudo-cultura) è indiscutibilmente la televisione.
Secondo il filosofo tedesco lo sviluppo della radiotelevisione è la piena espressione della società tecnologica, dove i diversi “mezzi” acquistano in effetti la sovranità sulla vita, non solo lavorativa. Questo è il segnale di una nuova fase, più perfezionata, della cultura di massa. Prima, sostiene Anders, il pubblico di massa si trovava almeno unito dal fatto di assistere insieme a uno spettacolo (pensiamo al teatro o al cinema), di condividere le emozioni. Con la televisione questo non avviene più, in quanto si impone una forma di atomizzazione. Il carattere domestico del mezzo è per il filosofo il maggior responsabile dell’ appiattimento emozionale che caratterizza il nostro essere. Guardiamo tutti le stesse cose, compriamo tutti le stesse cose e di conseguenza parliamo delle stesse cose e pensiamo in blocco le stesse cose: non c’è più spazio per l’originalità, ma solamente per l’omologazione intellettuale. “Ogni consumatore è un lavoratore a domicilio non stipendiato che coopera alla produzione dell’uomo di massa”, e aggiunge. “Dato che il mondo ci è fornito in casa, non ne andiamo alla ricerca; rimaniamo privi di esperienza”. L’esperienza muta: ora la televisione occupa la maggior parte del nostro tempo libero e fare esperienza (interagire con gli altri, leggere, etc.) non sembra essere più necessario. Con la televisione cade, inoltre, ogni barriera tra realtà e fantasia. Infatti la televisione sembra sostituire anche i nostri sogni.
Molto interessante risulta essere anche il discorso (sempre legato alla tecnica) che Anders imposta sull’energia atomica, in particolare sull’episodio di Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale. A tale proposito il filosofo elabora delle tesi:
1) Il 6 agosto 1945, giorno in cui fu sganciata la prima bomba atomica su Hiroshima, è cominciata una nuova era: l’era in cui possiamo trasformare in qualunque momento la terra intera in un’altra Hiroshima. Da quel giorno siamo onnipotenti in modo negativo; ma potendo essere distrutti ad ogni momento, ciò significa anche che da quel giorno siamo totalmente impotenti. Quest’epoca è l’ultima: la possibilità dell’autodistruzione del genere umano, non può aver fine che con la sua stessa fine.
2) La tesi apparentemente plausibile che nell’attuale situazione politica ci sarebbero (fra l’altro) anche “armi atomiche”, è un inganno. Poiché la situazione attuale è determinata esclusivamente dall’esistenza di “armi atomiche”, è vero il contrario: che le cosiddette azioni politiche hanno luogo entro la situazione atomica.
3) Ciò contro cui lottiamo, non è questo o quell’avversario che potrebbe essere attaccato o liquidato con mezzi atomici, ma la situazione atomica in sé. Poiché questo nemico è nemico di tutti gli uomini, quelli che si sono considerati finora come nemici dovrebbero allearsi contro la minaccia comune. Organizzazioni e manifestazioni pacifiche da cui sono esclusi proprio quelli con cui si tratta di creare la pace, si risolvono in ipocrisia, presunzione compiaciuta e spreco di tempo.
4) Le nubi radioattive non badano alle pietre miliari, ai confini nazionali o alle “cortine”. Ognuno può colpire chiunque ed essere colpito da chiunque. Se non vogliamo restare moralmente indietro rispetto agli effetti dei nostri prodotti, dobbiamo fare in modo che l’orizzonte di ciò che ci riguarda, e cioè l’orizzonte della nostra responsabilità, coincida con l’orizzonte entro il quale possiamo colpire o essere colpiti; e cioè che diventi anch’esso globale. Non ci sono più che “vicini”.
5) Ciò che si tratta di ampliare, non è solo l’orizzonte spaziale della responsabilità per i nostri vicini, ma anche quello temporale. Poiché le nostre azioni odierne, per esempio le esplosioni sperimentali, toccano le generazioni venture, anch’esse rientrano nell’ambito del nostro presente. Tutto ciò che è “venturo” è già qui, presso di noi, poiché dipende da noi.
6) Ciò che conferisce il massimo di pericolosità al pericolo apocalittico in cui viviamo, è il fatto che non siamo attrezzati alla sua stregua, che siamo incapaci di rappresentarci la catastrofe. Raffigurarci il non-essere (la morte, ad esempio, di una persona cara) è già di per sé abbastanza difficile; ma è un gioco da bambini rispetto al compito che dobbiamo assolvere come apocalittici consapevoli. Poiché questo nostro compito non consiste solo nel rappresentarci l’inesistenza di qualcosa di particolare, ma nel supporre inesistente questo contesto, e cioè il mondo stesso. Questa “astrazione totale” trascende le forze della nostra immaginazione naturale.
7) Ma poiché, come homines fabri, siamo capaci di tanto (siamo in grado di produrre il nulla totale), la capacità limitata della nostra immaginazione (la nostra “ottusità”) non deve imbarazzarci. Dobbiamo (almeno) tentare di rappresentarci anche il nulla. Ecco quindi il dilemma fondamentale della nostra epoca: “Noi siamo inferiori a noi stessi”, siamo incapaci di farci un’immagine di ciò che noi stessi abbiamo fatto. In questo senso siamo “utopisti a rovescio”: mentre gli utopisti non sanno produrre ciò che concepiscono, noi non sappiamo immaginare ciò che abbiamo prodotto.
8) La frattura che divide l’umanità non passa, oggi, fra lo spirito e la carne, fra il dovere e l’inclinazione, ma fra la nostra capacità produttiva e la nostra capacità immaginativa. Questo “scarto” non divide solo immaginazione e produzione, ma anche sentimento e produzione, responsabilità e produzione. Si può forse immaginare, sentire, o ci si può assumere la responsabilità, dell’uccisione di una persona singola; ma non di quella di centomila. Quanto più grande è l’effetto possibile dell’agire, e tanto più è difficile concepirlo, sentirlo e poterne rispondere; quanto più grande lo “scarto”, tanto più debole il meccanismo inibitorio. Liquidare centomila persone premendo un tasto, è infinitamente più facile che ammazzare una sola persona. Al “subliminare”, noto dalla psicologia (lo stimolo troppo piccolo per provocare già una reazione), corrisponde il “sopraliminare”: ciò che è troppo grande per provocare ancora una reazione.
9) Nulla di più falso della frase cara alle persone di mezza cultura, per cui vivremmo già nell'”epoca dell’angoscia”. Questa tesi ci è inculcata dagli agenti ideologici di coloro che temono solo che noi si possa realizzare sul serio la vera paura, adeguata al pericolo. Noi viviamo piuttosto nell’epoca della minimizzazione e dell’inettitudine all’angoscia. L’imperativo di allargare la nostra immaginazione significa quindi in concreto che dobbiamo estendere e allargare la nostra paura. Va da sé che questa nostra angoscia deve essere di un tipo affatto speciale: 1) Un’angoscia senza timore, poiché esclude la paura di quelli che potrebbero schernirci come paurosi. 2) Un’angoscia vivificante, poiché invece di rinchiuderci nelle nostre stanze ci fa uscire sulle piazze. 3) Un’angoscia amante, che ha paura per il mondo, e non solo di ciò che potrebbe capitarci.
10) L’imperativo di allargare la portata della nostra immaginazione e della nostra angoscia finché corrispondano a quella di ciò che possiamo produrre e provocare, si rivelerà continuamente irrealizzabile. Non dobbiamo lasciarci spaventare; il fallimento ripetuto non depone contro la ripetizione del tentativo. Anzi, ogni nuovo insuccesso è salutare, poiché ci mette in guardia contro il pericolo di continuare a produrre ciò che non possiamo immaginare.
11) Sarebbe una leggerezza pensare che quelli che sono responsabili delle decisioni, grazie a posizioni di potere politico o militare comunque acquisite, sappiano immaginare l’inaudito meglio di noi. Assai più legittimo è il sospetto: che ne siano affatto inconsapevoli. Ed essi lo provano dicendo che noi siamo incompetenti nel “campo dei problemi atomici e del riarmo”, e invitandoci a non “immischiarci”. Molti di loro si appellano alla “competenza” solo per mascherare il carattere antidemocratico del loro monopolio. Se la parola “democrazia” ha un senso, è proprio quello che abbiamo il diritto e il dovere di partecipare alle decisioni che concernono la “res publica”, che vanno, cioè, al di là della nostra competenza professionale e non ci riguardano come professionisti, ma come cittadini o come uomini. E un problema più “pubblico” della decisione sulla nostra sopravvivenza non c’è mai stato e non ci sarà mai. Rinunciando a “immischiarci”, mancheremmo anche al nostro dovere democratico.
12) Oggi si può avviare una serie di azionamenti successivi schiacciando un solo bottone; compreso, quindi, il massacro di milioni. L’uomo che schiaccia il tasto non si accorge più nemmeno di fare qualcosa; e poiché il luogo dell’azione e quello che la subisce non coincidono più, poiché la causa e l’effetto sono dissociati, non può vedere che cosa fa. E’ chiaro che solo chi arriva a immaginare l’effetto ha la possibilità della verità; la percezione non serve a nulla. Questo genere di mimetizzamento è senza precedenti: mentre prima i mimetizzamenti miravano a impedire alla vittima designata dell’azione, e cioè al nemico, di scorgere il pericolo imminente, oggi il mimetizzamento mira solo a impedire all’autore di sapere quello che fa. In questo senso anche l’autore è una vittima.
13) Finché l’agire si traveste ancora da “lavorare”, è pur sempre l’uomo ad essere attivo; anche se non sa che cosa fa lavorando, e cioè che agisce. La menzogna celebra il suo trionfo solo quando liquida anche quest’ultimo residuo: il che è già accaduto. Poiché l’agire si è trasferito (naturalmente in seguito all’agire degli uomini) dalle mani dell’uomo in tutt’altra sfera: in quella dei prodotti. Essi sono, per così dire, “azioni incarnate”. La bomba atomica (per il semplice fatto di esistere) è un ricatto costante: e nessuno potrà negare che il ricatto è un’azione. Qui la menzogna ha trovato la sua forma più menzognera: non ne sappiamo nulla, abbiamo le mani pulite, non c’entriamo. Assurdità della situazione: nell’atto stesso in cui siamo capaci dell’azione più enorme – la distruzione del mondo – l'”agire”, in apparenza, è completamente scomparso. Poiché la semplice esistenza dei nostri prodotti è già un “agire”, la domanda consueta: che cosa dobbiamo “fare” dei nostri prodotti (se, ad esempio, dobbiamo usarli solo come “deterrenti”), è una questione secondaria, anzi fallace, in quanto omette che le cose, per il fatto stesso di esistere, hanno sempre agito.
14) La guerra atomica possibile sarà la più priva d’odio che si sia mai vista. Chi colpisce non odierà il nemico, poiché non potrà vederlo; e la vittima non odierà chi lo colpisce, poiché questi non sarà reperibile. Nulla di più macabro di questa mitezza (che non ha nulla a che fare con l’amore positivo). Certo l’odio sarà ritenuto indispensabile anche in questa guerra. Per alimentarlo, si indicheranno oggetti d’odio ben visibili e identificabili, “ebrei” di ogni tipo. Ma quest’odio non potrà entrare minimamente in rapporto con le azioni di guerra vere e proprie: e la schizofrenia della situazione si rivelerà anche in ciò, che odiare e colpire saranno rivolti a oggetti completamente diversi.
Concludiamo questa breve trattazione del pensiero andersiano con dei comandamenti che , secondo il filosofo, sembrano guidare l’uomo nell’epoca atomica e che, nella loro agghiacciante verità, risultano essere paradigmatici: Il tuo primo pensiero dopo il risveglio sia: “Atomo”. Poiché non devi cominciare un solo giorno nell’illusione che quello che ti circonda sia un mondo stabile. Quello che ti circonda è qualcosa che domani potrebbe essere già semplicemente “stato”; e noi, tu e io e tutti i nostri contemporanei, siamo più “caduchi” di tutti quelli che finora sono stati considerati tali. E questo sia il tuo secondo pensiero dopo il risveglio: “La possibilità dell’apocalisse è opera nostra. Ma noi non sappiamo quello che facciamo”.
Anders, per il suo modo estremamente critico di intendere le cose, può essere accostato a diversi filosofi come, ad esempio, Adorno, Marcuse, Bloch o Jonas. Tuttavia la sua filosofia si distingue (per le conclusioni a cui arriva) da altri autori; in particolare è piuttosto evidente la differenza che effettivamente esiste tra Jonas, Bloch e Anders. Analizzando il drammatico momento che coinvolge attualmente l’umanità e il pianeta, Jonas con il principio di responsabilità, e Bloch con il principio “speranza” ammettono più o meno esplicitamente che c’è ancora spazio per un’inversione di rotta. Anders, invece, teorizza il principio “disperazione” (cfr. Pier Paolo Portinaro, Il principio disperazione), secondo il quale, ormai, non è più lecito nemmeno sperare in quanto la condizione a cui l’uomo oggi è arrivato è sostanzialmente irrecuperabile. Se Heidegger diceva che ormai solo un Dio ci può salvare, Anders si spinge oltre e dice che, dopo la bomba atomica, la salvezza non sembra più una realtà possibile.
EDITH STEIN

VITA E OPERE
Edith Stein nacque a Breslavia (Wroclaw, allora in Germania, oggi in Polonia) il 12 ottobre 1891. Ultima di una famiglia numerosa, il padre morì poco dopo la sua nascita. La madre, donna di carattere forte e di grande fede — era ebrea osservante —, prese in mano l’azienda del marito e con grande sforzo personale riuscì a farla prosperare, potendo così mantenere i suoi figli. La figura materna sarà importante nella vita di Edith: l’esempio di austerità di vita e di una fede profondamente vissuta segneranno il suo carattere e saranno sempre per lei un importante punto di riferimento.
La bambina Edith si dimostrò presto dotata di un’intelligenza vivace, particolarmente attratta dalla letteratura, alla quale era stata iniziata dai fratelli maggiori. L’esempio di religiosità di sua madre rappresentava un’eccezione rispetto all’ambiente familiare in cui si muoveva e, come lei stessa racconta, per l’esempio di ateismo dei suoi parenti, molto presto smise consapevolmente e deliberatamente di pregare. Brillante negli studi secondari, iniziò l’università nella sua città natale, indirizzandosi verso la storia e la letteratura tedesca.
Negli anni universitari l’interesse per la letteratura si approfondì in interesse per l’uomo, ed Edith aggiunse alle lezioni di storia e letteratura anche la frequenza a corsi della nascente scienza psicologica. Fu nell’ambito di questi studi — in quel momento, a Breslavia, psicologia e filosofia erano viste quasi come un’unica scienza — che un giovane docente, Georg Moskiewicz, le passò il secondo volume delle “Ricerche logiche” (Logische Untersuchungen) di Edmund Husserl, professore di filosofia all’università di Gottinga (“Gli altri hanno preso tutto da qui”, le disse Moskiewicz). Affascinata da questa lettura, attratta dalle descrizioni che Moskiewicz le faceva dell’ambiente universitario di Gottinga e incoraggiata dall’invito di un suo cugino che insegnava in quella università, decise di andarvi a frequentare un semestre, il suo quinto. Prima di partire aveva concordato un tema di tesi di psicologia sperimentale con il professor Stern. Edith Stein arrivò a Gottinga nella primavera del 1913, e questa città divenne ben presto la sua patria intellettuale. La fenomenologia insegnata da Husserl era veramente un pensiero innovativo: la concezione della filosofia come scienza rigorosa contrastava con i riduttivismi scientifici — soprattutto di tendenza psicologista — allora in voga, mentre l’invito a riportare l’attenzione sulle cose sembrava rompere con i vari tipi di idealismo, ripristinando le condizioni per svolgere una filosofia realista. Fra i giovani fenomenologi si percepiva l’entusiasmo dei pionieri. La descrizione che le aveva fatto Moskiewicz corrispondeva alla realtà: a Gottinga si parlava veramente di filosofia “giorno e notte, a pranzo, per la strada, ovunque”.
Il suo inserimento nell’ambiente universitario avvenne senza difficoltà: Moskiewicz la presentò ad Adolf Reinach, giovane professore e collaboratore di Husserl, che di fatto si occupava di facilitare l’accesso degli studenti alla fenomenologia e al suo “maestro”; quest’ultimo essendo meno portato per le relazioni umane. La buona impressione che fece a Reinach, e soprattutto a Husserl, le aprì poi le porte della “Società Filosofica”, una sorta di seminario creato dagli stessi studenti, al quale erano ammessi solo i discepoli maggiormente iniziati alla fenomenologia. Dopo poche settimane si muoveva nell’ambiente fenomenologico di Gottinga come se avesse sempre vissuto lì.
Fra le persone con cui strinse amicizia in quel periodo possiamo menzionare Roman Ingarden, Hans Lipps, Fritz Kaufmann. Frequentò molto anche i coniugi Reinach, ma tardò un poco ad accorgersi della loro sincera amicizia, fatto comprensibile se si considera che Adolf Reinach, benché giovane, era suo professore e non un compagno di studi come gli altri. Edith attribuiva molta importanza a queste amicizie e fece tutto il possibile per conservarle per tutta la vita.
Un incontro importante per la maturazione intellettuale e spirituale della giovane filosofa fu quello con Max Scheler. Questi era stato diffidato dall’insegnamento nell’università di Gottinga, per lo scandalo causato dalla sua causa di divorzio, ma la Società Filosofica lo invitò a tenere in un caffè delle conferenze private. In questi incontri Edith Stein poté constatare le divergenze fra Husserl e Scheler:
“Scheler naturalmente era aspramente contrario alla svolta idealistica e si esprimeva quasi in tono di superiorità (…). I rapporti tra Husserl e Scheler non erano del tutto sereni. Scheler non perdeva occasione di ribadire che non era allievo di Husserl, ma aveva trovato personalmente il metodo fenomenologico. Per quanto egli non fosse stato suo allievo, Husserl era tuttavia convinto della sua dipendenza da lui. (…) [Scheler] accoglieva da altri delle idee che poi trovavano sviluppo dentro di lui, senza che lui stesso si accorgesse di essere stato influenzato. In tutta coscienza poteva affermare che era tutta farina del suo sacco”.
Dai ricordi della Stein emerge il ritratto di un filosofo affascinante. Ma di particolare interesse risulta l’impatto che ebbe sulla giovane filosofa la sua maniera di difendere la fede — si era convertito al cattolicesimo — che, sebbene non portò Edith Stein ad esaminare seriamente il tema, per lo meno le trasmise l’idea della dignità filosofica dell’argomento, cosa che veniva invece esclusa dal pur credente Husserl, per il quale la religione poteva essere solo oggetto di fede, non di speculazione filosofica. Si vedrà più avanti come questo porterà la Stein a concludere che la fenomenologia secondo la concezione di Husserl è incompatibile con la fede.
La nuova fenomenologa decise di rimanere a Gottinga per terminare lì gli studi universitari. Quasi subito aveva abbandonato l’idea della tesi con Stern, e chiese a Husserl di farle da relatore, per studiare il tema dell’empatia (Einfühlung). Così lei stessa spiega la sua tesi:
“Nel suo seminario sulla natura e lo spirito, Husserl aveva parlato del fatto che un mondo esterno oggettivo poteva essere conosciuto solo in modo intersoggettivo, cioè da una maggioranza di individui conoscenti che si trovino tra loro in uno scambio conoscitivo reciproco. Di conseguenza, è premessa una esperienza di altri individui. Collegandosi alle opere di Theodor Lipps, Husserl chiamava Einfühlung (intuizione [meglio “empatia”]) questa esperienza, ma non dichiarava in che cosa consistesse. C’era perciò una lacuna che andava colmata: io volevo ricercare che cosa fosse l’intuizione. Ciò non dispiacque al maestro”.
Si trattava di un argomento chiave per il metodo fenomenologico, ma non era stato ancora sviluppato, solo Scheler vi faceva riferimento, ma più per una comprensione intuitiva del problema che per averlo approfondito; Husserl lo esaminerà molti anni più tardi. Questo è indicativo della tendenza di Edith Stein ad andare a fondo nelle questioni e del suo costante interesse per gli aspetti umani dei problemi; allo stesso tempo è un primo indice di quel certo disordine di Husserl, che contribuì a rendere difficile la comprensione con i suoi discepoli, come vedremo più avanti.
Il relatore la orientò verso un’impostazione che aumentava di molto il lavoro necessario, costringendola a studiare la voluminosa produzione di Theodor Lipps, il quale aveva parlato di empatia, ma in un senso piuttosto diverso da come lo intendevano i fenomenologi. La mole di lavoro e lo scarso aiuto da parte di Husserl la stancarono fino quasi all’esaurimento. Quando però iniziava a disperare della possibilità di portare a termine l’opera, le venne in aiuto Adolf Reinach, che la incoraggiò, valorizzando il lavoro fin lì svolto, e le diede un consiglio prezioso: ormai aveva già studiato abbastanza il tema ed era arrivato il momento di chiudere i libri ed applicare il metodo fenomenologico per svolgere una riflessione personale.
Nel frattempo era iniziata la prima guerra mondiale e tutti i suoi amici si stavano sparpagliando sui vari fronti. Il suo spirito patriottico le faceva sembrare un tradimento l’occuparsi dei suoi problemi filosofici mentre la gente moriva per il suo paese, e decise così di presentarsi come infermiera volontaria nella Croce Rossa. Roman Ingarden, ricordando il grande patriottismo che animava la Stein, osservava: “Questo è importante per un motivo: accresce la tragedia di essere stata vittima di quello che accadde in seguito”. Come crocerossina fu assegnata ad un ospedale militare per malattie infettive, dove lavorò con tanto impegno che, dopo circa nove mesi, venne dimessa dal servizio per l’evidente stato di esaurimento in cui si trovava. Tornò così a lavorare alla tesi. Nel frattempo Husserl, che a Gottinga era professore straordinario, aveva ottenuto la cattedra di ordinario di filosofia all’università di Friburgo in Brisgovia (Freiburg im Breisgau) e si era trasferito in quella città.
Terminata la tesi Edith Stein dovette faticare non poco per riuscire a farla leggere al professore. In una lettera del 16/8/1916 allude spiritosamente a queste difficoltà:
“Quando andai a Friburgo per un paio di settimane, il maestro era ancora imbronciato per la mia crudeltà di costringerlo a leggere la mia tesi”,
ma più avanti aggiunge
“mi venne un colpo quando, il giorno seguente, mi confidò che era molto soddisfatto della mia tesi, e che, in effetti, un bel po’ di essa coincideva con parti essenziali della seconda parte delle Ideen”.
Finalmente poté discuterla il 3 agosto 1916, ottenendo il titolo di dottore in filosofia, con il massimo dei voti. Pubblicò la tesi quello stesso anno.
A Friburgo Husserl si trovava relativamente solo, sia per il cambio di città, sia per la guerra che tratteneva al fronte la maggior parte dei suoi discepoli. Intanto il nuovo incarico gli dava diritto ad avere un assistente, ed in realtà ne sentiva bisogno: la mole di appunti accumulati negli anni era diventata per lui ingovernabile, e in molti casi non più leggibile per le peggiorate condizioni della sua vista, e non riusciva ad estrarne del materiale adeguato per una pubblicazione.
Nell’agosto del 1916 Edith Stein, che già da tempo rifletteva sulle difficoltà del maestro, incoraggiata dal giudizio positivo sulla sua tesi, si propose per il posto. Husserl non solo accettò, ma
“la sua soddisfazione all’idea di avere finalmente una persona a sua completa disposizione era evidente — benché, ovviamente, non abbia ancora un’idea chiara di come dovremo lavorare insieme”.
Lo stipendio offerto era modesto, ma lei era in grado di mantenersi con l’aiuto della famiglia.
Si può seguire abbastanza da vicino la breve storia del lavoro di Edith Stein con Husserl grazie ad una quindicina di lettere conservate da Roman Ingarden e Fritz Kaufmann. Ne emergono i fatti di un rapporto difficile, caratterizzato da una grande venerazione per il professore contrastata dall’impossibilità quasi assoluta di stabilire con lui una vera relazione di collaborazione.
Il primo incarico sarà di lavorare al manoscritto delle Ideen, e condizione previa lo studio del metodo di stenografia che Husserl usava per scrivere i suoi appunti. Così spiega il suo lavoro a Roman Ingarden:
“Adesso sto cercando di mettere insieme, a partire dal materiale in mio possesso, una minuta unitaria dell’intero processo di pensiero (del quale ho un’idea abbastanza chiara, anche se niente è definitivo e nemmeno portato fino alle conclusioni). Questo dovrà diventare la base per l’opera del maestro, pertanto vorrei finirlo perché non penso che sarebbe capace di orientarsi fra tanto materiale e rimarrebbe sempre invischiato nei dettagli”.
A gennaio la giovane assistente ha già iniziato a prendere contatto con i problemi legati agli “umori improvvisi e variabili del caro maestro”, come quando era riuscita a convincerlo della necessità di “ripensare l’intera dottrina della costituzione e a quello scopo riprendere in mano la prima parte delle Ideen. Così si fece per due giorni, poi ritornò ad essere troppo noioso”. Nello stesso periodo scrive:
“La collaborazione con il caro maestro è una questione molto complicata; ho il timore che possa non arrivare mai ad essere una reale collaborazione. (…) Non si riesce a smuoverlo, nemmeno una volta, a dare un’occhiata alla minuta che sto ricavando per lui dai suoi vecchi appunti per permettergli di riprendere la visione d’insieme che ha perso. Finché non si otterrà questo è ovviamente impossibile pensare alla composizione di una minuta definitiva”.
Naturalmente è impensabile che Husserl riveda la tesi dottorale della sua allieva per la pubblicazione: arriverà alle stampe senza il suo intervento
Ma la Stein non si lascia scoraggiare: la muove la certezza di avere fra le mani del materiale di grande valore e la conseguente determinazione a fare tutto il possibile perché anche altri possano beneficiarne. Il suo obiettivo è pertanto quello di organizzare gli appunti secondo una struttura logica, evidenziando le lacune e le parti incomplete, per preparare così una trascrizione chiara da presentare a Husserl e sulla base di essa lavorare con lui per riempire le restanti lacune. Se le difficoltà di collaborazione fossero continuate, avrebbe lasciato il materiale pronto per la stampa così com’era, oppure cercando lei stessa di integrarlo, affidandosi alla sua buona conoscenza del pensiero del maestro. Già a fine mese, però, soffre per questo modo di procedere, senza quasi potergli rivolgere la parola, ma qualche rara chiacchierata le restituisce la speranza di non dover fare tutto da sola.
Intanto lo sforzo per penetrare nel pensiero di Husserl la porta a maturare alcune considerazioni personali in disaccordo con le idee di lui:
“Credo di sapere un po’ che cosa si intenda per costituzione, ma in contrasto con l’idealismo. (…) Non sono ancora riuscita a confessare le mie eresie al maestro…”.
La “confessione” arriva poco tempo dopo:
“Di recente ho sottoposto solennemente al maestro le mie preoccupazioni sull’idealismo. Non ne è risultata una situazione “imbarazzante” (come Lei temeva). Mi ha fatto accomodare in un angolo del vecchio, caro sofà e poi abbiamo discusso animatamente per due ore — senza che l’uno convincesse l’altro, è ovvio. Il maestro dice che non sarebbe contrario a cambiare punto di vista se gliene dimostrassi la necessità. Cosa che finora non sono riuscita a fare”.
A marzo si prende una vacanza, non senza che Husserl le affidi un altro manoscritto per riordinarlo, come contributo al suo svago. I fogli sono “in un tale disordine, da far pensare che il maestro un bel giorno si sia stancato e li abbia cacciati così com’erano in un cassetto”. Intanto riflette sulle difficoltà che l’attendono al suo ritorno (“Se solo ora fosse disponibile ad un po’ di collaborazione!”; “non ho nessuna voglia di continuare ad accatastare pacchi di carta che lui non guarda nemmeno”), mentre inizia a sentire il desiderio di dedicarsi anche ad un po’ di lavoro autonomo.
Al rientro la situazione non è cambiata: alcune parti delle Ideen sarebbero pronte per la pubblicazione, ma nemmeno con questa prospettiva si riesce a convincere il maestro ad esaminarle. Intanto lui ha divagato, producendo del nuovo materiale molto interessante, ma che richiederà l’aiuto dell’assistente perché si trasformi in qualcosa di utilizzabile, e anche il manoscritto esaminato durante le vacanze meriterebbe attenzione. Ancora una volta la filosofa tiene duro:
“Non riesco tuttavia a pensare di rinunciarvi in futuro. Sono infatti quasi certa che il maestro da solo non pubblicherebbe più niente, mentre lo ritengo importante, più di qualunque scritto che io potrei eventualmente produrre”.
Qualche mese dopo, il lavoro sulle Ideen era completo ed il tempo passava senza che Husserl si decidesse a leggerlo. Edith Stein stava già pensando di presentare le sue dimissioni per ottobre, quando trova altri appunti del maestro (sulla coscienza del tempo — Zeitbewusstsein) e torna a prevalere in lei l’idea della missione da compiere. In estate, per costringere il maestro a lavorare un po’ con lei, deve andarlo a trovare in villeggiatura, ottenendo così ben tre giorni della sua attenzione.
La crisi arriva a febbraio del 1918, in occasione di una comunicazione del maestro, con la quale ancora una volta le chiede un poco gratificante lavoro da segretaria. Scrive al maestro una lettera di contenuto equivalente ad una richiesta di dimissioni, che egli accetta senza drammatizzare, solo con un leggero tono di rimprovero. Così spiega la sua decisione a Fritz Kaufmann:
“Mettere in ordine manoscritti, che era l’unico mio lavoro da mesi, iniziava gradualmente a diventarmi insopportabile, e non mi sembra così necessario che, per fare questo, io debba rinunciare a qualsiasi attività per mio conto”.
Dopo meno di due anni di lavoro, Edith Stein lasciava due importanti opere praticamente pronte per la pubblicazione: la seconda parte delle Ideen e la “sesta ricerca”, oltre ad una grande quantità di appunti di Husserl rimessi in ordine, di cui beneficeranno gli assistenti e studiosi che le succederanno. Così riferisce Ludwig Landgrebe, che fu assistente di Husserl dal 1923:
“Edith Stein aveva il compito di mettere in ordine, di trascrivere i manoscritti stenografati di Husserl — abbozzi di libri e testi di lezioni — e di produrne un testo unitario che doveva servire a Husserl per la pubblicazione. Questo riguardava soprattutto tre grandi complessi: l’abbozzo del secondo volume delle “Idee per una fenomenologia pura”, il testo delle lezioni sulla “coscienza del tempo” e i vari fogli sparsi sulla “teoria del giudizio”. La trascrizione fu fatta a mano, nella sua scrittura chiara e ancora oggi leggibile nonostante la cattiva qualità della carta del periodo successivo alla guerra (…). Dei problemi che ci furono per Edith Stein in questa sua collaborazione con Husserl posso parlare per esperienza personale. Nel mentre cioè si conduceva a termine un tale compito di rielaborazione e si poteva presentarne il risultato a Husserl, egli aveva già rivolto la propria attenzione a tutt’altri pensieri, e ci voleva uno sforzo notevole per riconquistare il suo interesse a quello che si era fatto. Queste erano le delusioni dunque che si provavano, ma che venivano accettate volentieri, perché erano il prezzo che si doveva pagare per prendere parte al divenire vitale dei pensieri del grande maestro. (…) Così queste rielaborazioni rimasero ferme per altri cinque anni dopo la dipartita di Edith Stein da Friburgo, finché Husserl non le riprese in mano nel 1924 e diede a me l’incarico di collezionarle assieme agli originali, quelli che ancora c’erano, e di trascriverle a macchina. Ma ci vollero ancora degli anni prima che tutto ciò giungesse alla pubblicazione: le lezioni sulla coscienza del tempo nel 1929, pubblicate da Heidegger, i manoscritti sulla teoria del giudizio, pubblicati da me nel 1939 col titolo “Erfahrung und Urteil” e le “Ideen II”, pubblicate soltanto dal lascito di Husserl nel 1952″.
Anche in lei questa esperienza lasciava un segno profondo: aveva potuto lavorare su del materiale cui pochi altri avrebbero avuto accesso per molto tempo, e ne ottenne una comprensione del pensiero di Husserl che poche persone — forse nessuno in quel momento — potevano vantare.
I rapporti con Husserl rimasero buoni: l’anno seguente la Stein si impegnava a promuovere un numero speciale dello Jahrbuch per celebrare il sessantesimo compleanno del maestro e cercava un modo per avviare una qualche forma di collaborazione stabile con lui. In una lettera all’amico Kaufmann (tornato a Friburgo dopo la guerra) ricambia i saluti affettuosi del maestro e scherza scrivendo:
“Deve rimordergli molto la coscienza se ha chiesto tanto amorevolmente mie notizie”.
L’amicizia e venerazione per Husserl non le impedivano, però, di considerarne lucidamente i difetti. “Non avrei mai considerato gli errori di una persona come motivo per togliergli la mia amicizia”, scrisse di sé nella Storia di una famiglia ebrea, e giudicava le persone con tanta più esigenza quanto più le erano care. Così si esprime senza reticenze riguardo alle difficoltà che tutti incontravano nei rapporti con Husserl, scrivendo che a casa Husserl ci si scontra con l’ingiustizia ad ogni passo, ma bisogna ricordarsi che “lui [Husserl] è quello che soffre di più, perché ha sacrificato la sua umanità per la sua scienza”. E in una lettera successiva:
“Non smetterò mai (…) di avere un’illimitata venerazione per il filosofo Husserl, e gli concederò sempre qualsiasi debolezza umana come cosa inevitabile. E mi sentirei ridicola se considerassi come un mio merito il fatto di essere un po’ più vicina di lui alla vita”.
Continuerà a mantenere buoni rapporti anche dopo la conversione. Quando, nel 1931, sembrano aprirsi per lei buone prospettive per l’insegnamento universitario, la famiglia Husserl vuole festeggiare con lei l’evento, e negli ultimi anni parteciperà vivamente alla preoccupazione per la salute del maestro, chiedendo e diffondendo frequenti notizie. L’occhio critico, però, rimane sempre presente, ora aperto alla prospettiva della grazia, e la Stein si preoccupa per la fede del maestro. In una conversazione con lui sui novissimi, constata la profondità con cui comprende queste cose, e se ne preoccupa, perché ciò accresce la sua responsabilità. Più tardi però si dichiara fiduciosa, perché “Dio è la verità. Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no”. A Friburgo Edith Stein ebbe anche occasione di conoscere Martin Heidegger. Così ricorda il loro primo incontro, nell’estate del 1916, in casa di Husserl:
“Quella sera Heidegger mi piacque molto. Era silenzioso e chiuso in se stesso per tutto il tempo in cui non si parlava di filosofia. Ma appena emergeva un argomento filosofico, si mostrava pieno di vita”.
Ma questa prima impressione positiva venne presto affiancata da vari motivi di perplessità, quando non di aperto disaccordo.
Appena persa la sua collaboratrice, Husserl si rivolse a Heidegger perché ne prendesse il posto. Questa volta, però, con un vero stipendio pagato dall’università, più consistente di quanto riceveva Edith Stein. Ma ciò che faceva indignare la fenomenologa era la maggiore fiducia che Husserl accordava al suo nuovo assistente, e la poca lealtà intellettuale dimostrata da quest’ultimo in contraccambio. Infatti Heidegger manteneva un atteggiamento distaccato nei confronti della fenomenologia husserliana, della quale si serviva a modo suo, e non senza criticarla. Così, mentre insegnava in qualità di assistente di Husserl, in realtà stava presentando il suo pensiero molto più di quello del “maestro”.
La fedele discepola registra:
“Heidegger gode della fiducia assoluta di Husserl e la usa per indirizzare la studentesca, sulla quale ha più influenza di Husserl stesso, in una direzione abbastanza lontana da lui. Tranne il buon maestro, lo sanno tutti”.
Intanto fra i “vecchi” fenomenologi ci si interroga sulla opportunità di organizzare delle conferenze per chiarire il vero contenuto della fenomenologia contro le deformazioni heideggeriane.
Edith Stein ammirerà sempre la genialità di Heidegger, ma criticandone le idee. Quando, nel 1931, cercava appoggi per l’abilitazione universitaria, escluse a priori l’ipotesi di lavorare per lui, perché in tal caso si sarebbe sentita in dovere di assecondare la sua linea di pensiero, cosa che non era in grado di fare. Anche la sua opera principale, Essere finito e Essere eterno, mostra già nella scelta del titolo la sua posizione polemica rispetto ad Essere e tempo di Heidegger, oltre a presentare in appendice una dettagliata analisi del pensiero di questo autore. Terminata la collaborazione con Husserl, il primo impegno di Edith Stein fu di tornare a Gottinga, presso la moglie di Adolf Reinach, essendo questi da poco deceduto in guerra. I suoi amici e discepoli volevano fare qualcosa per commemorarne la scomparsa ed erano indecisi fra varie alternative; la vedova propendeva per una pubblicazione dei suoi scritti inediti e per questo motivo chiedeva all’amica Edith di curare la preparazione del materiale. Questo impegno rappresentò un’esperienza importante per la conversione della nostra filosofa. I coniugi Reinach, infatti, si erano da poco convertiti al cristianesimo, e durante questo suo soggiorno nella loro casa, Edith Stein poté fare l’esperienza viva del modo cristiano di vivere il dolore. Ne restò profondamente impressionata ed iniziò ad interessarsi di più al problema della fede: negli anni seguenti leggerà il Nuovo Testamento e vari autori cristiani, in particolare Kierkegaard e santa Teresa di Gesù. Ricorderà sempre che il suo primo incontro con la fede fu un incontro con la Croce, e per questo volle includerla nel suo nome religioso quando entrò nel carmelo.
Finalmente poteva dedicarsi ad un lavoro autonomo: per qualche tempo rimase a Friburgo, collaborando con i fenomenologi, soprattutto coordinando il lavoro per la preparazione di un nuovo Jahrbuch. Da segnalare che fu probabilmente questa attività a farle iniziare un rapporto epistolare con Hedwig Conrad-Martius che si trasformò in una duratura amicizia. Ben presto però vide che ciò che stava facendo non richiedeva la sua presenza a Friburgo e decise quindi di tornare a Breslavia da sua madre. Qui iniziò ad insegnare in un liceo femminile ed istituì un corso privato sulla fenomenologia al quale partecipavano una cinquantina di persone. Intanto si dedicava a quelle riflessioni personali per le quali non aveva mai trovato il tempo negli anni precedenti e che porteranno alle pubblicazioni sullo Jahrbuch degli anni successivi. I coniugi Conrad vivevano ritirati nella loro casa di campagna, presso Bergzabern, dividendo i loro interessi fra filosofia e lavori agricoli. Per i loro amici avevano istituito quello che oggi chiameremmo un servizio di agriturismo: tutti sapevano di poter trascorrere da loro un periodo di tempo, ripagando l’ospitalità con l’aiuto nei lavori stagionali. Era una possibilità di cui si avvalevano in molti, dato che era un ottimo modo per riposare dal lavoro intellettuale ed anche una buona occasione per mantenere i contatti con i vari amici che di volta in volta si trovavano a trascorrere lì qualche giorno.
Rimasta sola, una sera, in casa Conrad, Edith Stein cercò nella biblioteca dell’amica qualcosa da leggere e scelse la Vita di santa Teresa di Gesù. Quella notte lesse il libro tutto d’un fiato, e alla fine della lettura, emozionata, diceva a se stessa “Questa è la verità!”. Il giorno dopo comprò un messale e un Catechismo romano, e dopo averli studiati si recò alla locale parrocchia cattolica dove chiese di essere battezzata. Venne accolta nella Chiesa il 1 gennaio 1922; l’amica Hedwig, benché protestante, ottenne il permesso per farle da madrina.
Il suo principale desiderio era quello di entrare immediatamente in convento, seguendo l’insegnamento di santa Teresa, ma le venne sconsigliato in considerazione della grande influenza che avrebbe potuto esercitare dalla sua posizione di filosofa già conosciuta. Nel 1923 accettò pertanto di insegnare lingua e letteratura tedesca all’istituto magistrale S. Maria Maddalena di Spira, tenuto dalle suore domenicane, presso le quali andò ad abitare, dedicandosi al lavoro, allo studio e alla preghiera.
Oltre a continuare ad occuparsi dei precedenti interessi filosofici, le esigenze del nuovo lavoro la portarono ad affrontare anche questioni di pedagogia, con particolare attenzione ai temi relativi all’educazione della donna. Entrò in contatto con vari intellettuali cattolici, e in particolare con il circolo animato da Dietrich von Hildebrand. Iniziò anche a ricevere gli inviti di varie associazioni cattoliche femminili a tenere conferenze in cui contribuiva alle discussioni, allora particolarmente vive, sulla condizione della donna e la sua emancipazione.
La svolta nella sua attività intellettuale si produsse però in seguito al suo incontro con il padre Erich Przywara. Questi era in cerca della persona giusta per tradurre in tedesco alcune opere del cardinale Newman, e Dietrich von Hildebrand gli consigliò di parlarne ad Edith Stein, che accettò l’incarico. Con l’occasione di questo lavoro ebbero modo di conoscersi meglio, e quando Przywara si rese conto della statura intellettuale della Stein, la incoraggiò a continuare lo studio di san Tommaso, iniziato già poco dopo la conversione, su consiglio di Günther Schulemann, vicario del Duomo di Breslavia, suggerendole in particolare di tradurre le Quæstiones disputatæ de veritate. Edith Stein accolse prontamente il consiglio, poiché comprendeva l’importanza di impossessarsi delle radici filosofiche della sua nuova fede.
Fin dall’inizio di questo nuovo studio sentì il bisogno di confrontare la dottrina del Dottore Angelico con la fenomenologia. La sua conversione, infatti, non comportò un rifiuto della filosofia precedentemente appresa, anzi, ella pensò sempre di poter trovare una conciliazione fra fenomenologia e tomismo. La prima espressione di questo confronto apparve nel numero speciale dello Jahrbuch per il settantesimo compleanno di Husserl
, mentre si può dire che Essere finito ed essere eterno ne fu l’ultima, dato che fin dalle prime pagine si presenta come un tentativo di realizzare una sintesi tra san Tommaso e la fenomenologia.
Durante gli anni di Spira tentò anche l’abilitazione all’insegnamento universitario, ma si scontrò con una mentalità che ancora non concedeva spazio alle donne per certe professioni. L’unico risultato del suo primo tentativo fu che a Gottinga l’insegnamento universitario per le donne smise di essere legalmente impossibile, rimanendo impossibile soltanto di fatto. Intanto la pressione delle sue varie attività cresceva: conferenze sempre più frequenti, il De veritate che non finiva mai, impegni sempre più coinvolgenti all’interno dell’istituto. Nel 1931 decise di lasciare l’insegnamento e di tornare a Breslavia, per dedicarsi interamente a terminare la traduzione del De veritate e poi decidere cosa fare per il futuro.
Nel 1932 venne invitata alla prima giornata di studi della “Société Thomiste” a Juvisy, vicino Parigi, e ne approfittò per fare visita all’amico Alexander Koyré, che insegnava a Parigi. Dell’intervento alla giornata di studi, dedicata a “Fenomenologia e tomismo”, di cui abbiamo gli atti, uno dei partecipanti fa questa ricostruzione:
“Si voleva scambiare le proprie idee sulla fenomenologia, sull’indirizzo filosofico che partiva da Husserl, prima a Göttingen, poi a Friburgo i. Br. Il congresso era presieduto da Noël di Lovanio. Erano presenti i primi filosofi cattolici francesi e belgi, fra gli altri Maritain e Berdjaev. Dalla Germania c’erano padre Mager OSB, Daniel Feuling OSB, von Rintelen, di Monaco, il prof. Sölingen di Bonn (poi Braunsberg, ora di nuovo Bonn), Edith Stein e io. Padre Feuling tenne la sua conferenza. La discussione fu dominata del tutto da Edith Stein. Certamente lei conosceva meglio di tutti la concezione di Husserl, perché era stata per anni sua assistente a Friburgo i.Br., ma ella sviluppò i propri pensieri in modo così chiaro, se necessario anche in francese, che l’impressione generale fu straordinariamente forte in questa società di dotti”.
Fra gli stimoli intellettuali che Edith Stein si aspettava dalla sua visita in Francia, ebbe sicuramente un peso importante l’incontro con Jacques Maritain e sua moglie, con i quali rimase in contatto epistolare negli anni successivi. Intorno al 1931-32 le si presentarono due nuove possibilità di tentare la strada dell’insegnamento universitario: a Friburgo, dove vari professori le avevano promesso il loro appoggio, e nella stessa Breslavia, dove le si offriva di tenere un corso di introduzione alla filosofia fenomenologica. Anche queste due opportunità sfumarono, ma di questo nuovo tentativo ci restano i lavori preparati per l’occasione: Potenz und Akt, e Introduzione alla filosofia. Si concretò invece un’offerta di lavoro dell’ “Istituto tedesco di pedagogia scientifica” di Münster, dove insegnò nell’anno accademico 1932/33.
L’inizio del successivo anno accademico fu preceduto da una nuova legge del Reich, che impediva l’accesso all’insegnamento alle persone di origine ebrea. Edith Stein si licenziò dall’Istituto. Trovandosi di nuovo a dover decidere del suo futuro, aveva davanti a sé due principali alternative: un’offerta di lavoro dall’America Latina o la possibilità di ritentare la strada del convento, che le era stata negata dieci anni prima. Dopo aver chiesto luci al Signore, e comprendendo abbastanza bene i rischi che correva rimanendo in Germania, chiese di essere ammessa nel carmelo di Colonia, dove prese il nome di Teresa Benedetta della Croce.
Entrò al carmelo disposta ad abbandonare del tutto la sua attività filosofica, ma ben presto i suoi superiori iniziarono ad affidarle incarichi intellettuali: opuscoli commemorativi di vari santi, studi sulla spiritualità carmelitana, uno studio su Dionigi l’Areopagita. Con l’intento di fare un’apologia degli ebrei tedeschi, già prima di entrare al carmelo aveva iniziato a scrivere la storia della sua famiglia, ed a più riprese la continuò anche nel carmelo. Infine venne incoraggiata, forse anche per distrarla dal crescente clima di persecuzione che si stava producendo in Germania, a riprendere e completare il lavoro iniziato con Potenz und Akt. Esaminando i suoi appunti decise di riscriverlo daccapo, e verso il 1936 era pronta per le stampe la sua più importante opera filosofica: Essere finito e Essere eterno. Non riuscì però a pubblicarla, perché anche le case editrici più coraggiose non osavano ospitare l’opera di un’ebrea, e pubblicare sotto falso nome un’opera così personale le parve una soluzione inaccettabile.
Nel 1938 la situazione in Germania era deteriorata tanto che il carmelo non offriva più alcuna garanzia di sicurezza. Venne pertanto deciso di trasferire Edith Stein in Olanda, nel vicino e affiliato carmelo di Echt, dove la raggiunse anche la sorella Rosa, convertitasi al cattolicesimo dopo la morte della madre. Qui Edith si mise a studiare la spiritualità di san Giovanni della Croce ed iniziò a scrivere il saggio Scientia Crucis. Con l’invasione tedesca del 1940, anche l’Olanda smise di rappresentare un rifugio sicuro per le due sorelle, sebbene le autorità tedesche avessero assicurato che non avrebbero incluso nella persecuzione gli ebrei cristiani, purché convertiti prima dell’invasione. Per questo si iniziarono le pratiche per tentare un trasferimento in Svizzera.
Nel frattempo (26/7/1942) i vescovi olandesi pubblicarono un documento di condanna della persecuzione antisemita. La risposta tedesca fu immediata: la domenica seguente (2/8/1942) vennero deportati i cattolici olandesi di origine ebrea, comprese le due sorelle Stein, ed uccisi ad Auschwitz il 9 agosto 1942. Fu un atto compiuto con l’evidente intenzione di offendere la Chiesa Cattolica, per questo l’11 ottobre 1998 Edith Stein è stata canonizzata come martire della fede, e viene venerata con il nome carmelitano di santa Teresa Benedetta della Croce.
Il 1 ottobre 1999 Giovanni Paolo II l’ha nominata co-patrona d’Europa, insieme con santa Caterina da Siena e santa Brigida di Svezia.
IL PENSIERO
“Ebrea, filosofa, carmelitana, martire, Edith Stein (1891-1942), ‘che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo’ (Giovanni Paolo II, 1 maggio 1985), e che la Chiesa annovera fra i suoi santi (dall’11 ottobre 1998) apre cammini di rapporto e di comunione in ambiti e a livelli diversi, ma in punti nodali dell’esperienza umana, cristiana, ecclesiale, interreligiosa”.
Di questa figura femminile così ricca e poliedrica altri esperti hanno scritto e scriveranno per lumeggiare il contributo di pensiero e di azione nei diversi ambiti. Per esempio, nell’ambito culturale sociale: Edith si adoperò, con scritti, lezioni e conferenze, a promuovere il ruolo della donna nella società e nella Chiesa. Con ricerche sulla nozione dello Stato ne chiarì il rapporto con la nazione, con il popolo e la società, e anche il suo precario equilibrio con la sfera religiosa. Lei che all’inizio era fortemente nazionalista e “prussiana”, dopo la grande guerra parteggiò per la repubblica di Weimar, e s’impegnò fortemente a contrastare i primi successi del partito nazionalsocialista.
Soprattutto nell’ambito filosofico, Edith ha lasciato segni incancellabili di originalità: lei che era l’allieva e assistente prediletta di Husserl, a Friburgo, e avrebbe meritato di succedergli nella cattedra, (la prese invece Heidegger, che si mostrò acquiescente col nazismo!) superando il maestro, tentò di gettare un ponte tra la filosofia contemporanea, sintetizzata nella fenomenologia husserliana e la tradizione medievale, espressa dalla filosofia di S.Tommaso, scavalcando la neo-scolastica.
Il suo capolavoro resta Essere finito ed Essere eterno, quasi una nuova ontologia, sintesi di filosofia e mistica. Se avesse potuto continuare le sue ricerche e creare un movimento di pensiero, com’era nella sua indole, forse l’avremmo salutata come la più grande filosofa dei secolo!
Infine, nell’ambito religioso mistico, attraversando la spiritualità domenicana, benedettina e approdando alla mistica di S.Teresa d’Avila e di S.Giovanni della Croce, portò a compimento il suo progetto di vita: pensiero ed esperienza della Croce con Cristo crocifisso, come sacrificio-donazione per la salvezza del suo popolo.
Il suo ultimo scritto, “La scienza della croce” (Scientia Crucis), rimase incompiuto, proprio perché lo avrebbe concluso in una camera a gas nel campo di Auschwitz!.
In tutti questi ambiti, sia col pensiero sia con l’azione, il filo rosso della continuità è stato la “intersoggettività”, (einfulung, “empatia”, intuizione empatica), la “comunione”. Quel che ora mi propongo è di mostrare il cammino di rapporto e di comunione che si è realizzato, nella vita di Edith, tra l’essere ebrea e l’essere santa-martire cattolica. Edith nasce a Breslavia (ora territorio polacco) il 12 ottobre 1891, in una famiglia ebrea molto praticante. Nasce, ultima di sette figli, proprio in una festa religiosa ebraica, nel giorno del Kippur, cioè dell’Espiazione. Per la madre, Augusta, questo era il presagio di un particolare destino della figlia.
Ecco come ricorda la tradizione religiosa nella famiglia materna: “I ragazzi studiarono religione sotto la guida di un professore ebreo; impararono anche un po’ di ebraico… Appresero i comandamenti, lessero brani tratti dalle scritture e impararono a memoria alcuni salmi (in tedesco). Fu sempre insegnato loro il rispetto nei confronti di qualsiasi religione, e di non parlarne mai male. Il nonno insegnò ai suoi figli le preghiere prescritte. Il sabato pomeriggio entrambi i genitori chiamavano a raccolta i figli che erano in casa, per pregare insieme con loro le preghiere vespertine e serali e spiegarle. Lo studio giornaliero delle Scritture e del Talmud – considerato un obbligo dell’uomo ebreo nei secoli precedenti e tuttora in uso presso gli ebrei orientali – non veniva più praticato a casa dei miei nonni; ciò nonostante tutti i precetti della Legge venivano osservati col massimo rigore”.
In seguito Edith racconta la pratica religiosa vissuta nella famiglia in occasione delle feste principali. Ma qualche annotazione ci apre alla comprensione del tipo di educazione assimilata. Per esempio, in occasione della liturgia del Seder (la Pasqua), annota: “la solennità della festa soffriva del fatto che soltanto mia madre e i bambini più piccoli vi partecipavano con devozione. I fratelli che dovevano dire le preghiere al posto di nostro padre, che era morto, lo facevano in modo poco dignitoso. Quando il maggiore mancava e il minore assumeva le funzioni di padrone di casa, faceva chiaramente notare quanto si prendesse intimamente gioco di tutto questo”.
E in occasione della festa dell’Espiazione (Kippur): “Quella sera non solo mia madre andava al tempio, ma era accompagnata dalle sorelle più grandi, e anche i fratelli consideravano un loro dovere morale il non mancare… Nessuno di noi si dispensava dal digiuno, anche quando non condividevamo più la fede di mia madre e non ci attenevamo più alle prescrizioni rituali al di fuori di casa nostra”.
Quello dunque che di questo ambiente ha messo forti radici in Edith non è la fede nel Dio d’Israele, ma un forte rigore morale, derivante dalla Legge. “La mamma ci insegnava l’orrore del male. Quando diceva: “è peccato”, quel termine esprimeva il colmo della bruttezza e della cattiveria, e ci lasciava sconvolti”.
Cosi altrove Edith ricorda gli anni dell’infanzia. Lei stessa, ormai sul punto di trasferirsi da Breslavia all’Università di Gottinga (1911), si confessa “non credente, dotata di forte idealismo etico”. Conserverà grande stima e ammirazione per la pietà religiosa della madre, e la accompagnerà sempre, quando è in famiglia, alla funzione della sinagoga, anche dopo il battesimo, anche alla vigilia dell’ingresso nel Carmelo.
Qualche tratto della sua limpidezza morale: quando attraverso la lettura di un testo romanzato le si rappresentò la vita studentesca con tratti ripugnanti, dissolutezza, alcolismo, ecc., ne rimase nauseata a tal punto che non poté, per settimane intere, ristabilirsi nella propria allegria. Eppure Edith, sebbene esteriormente riservata e dedita con abnegazione al lavoro, portava nel cuore “la speranza di un grande amore e di un matrimonio felice”, e annota: “Senza avere alcuna conoscenza della dogmatica e della morale cattolica, ero tuttavia impregnata dell’ideale matrimoniale cattolico”. Al rigore morale in Edith corrisponde, nella sua vivace e profonda intelligenza, la ricerca e la sete della verità. Non poteva sentirsi soddisfatta della corrente psicologista di tipo positivistico, prevalente nell’Università di Breslavia, e perciò si orientò, appena ne venne a conoscenza, verso la “Fenomenologia” di Edmund Husserl, cattedratico a Gottinga.
Ecco come, dopo anni di esperienza, descrive il metodo di Husserl: “Il suo modo di guidare lo sguardo sulle cose stesse e di educare a coglierle intellettualmente con assoluto rigore, a descriverle in maniera sobria, fedele e coscienziosa, ha liberato i suoi allievi da ogni arbitrio e da ogni fatuità nella conoscenza, portandoli a un atteggiamento cognitivo semplice, sottomesso all’oggetto e perciò umile. Nello stesso tempo ha insegnato a liberarsi dai pregiudizi e a togliere tutti gli ostacoli che potrebbero distruggere la sensibilità verso intuizioni nuove. Questo atteggiamento, a cui ci ha responsabilmente educati, ha liberato molti di noi, rendendoci disponibili nei confronti della verità cattolica”.
Ma già a partire dai primi anni di Gottinga (1911-1914) annota: “Avevo un profondo rispetto per le questioni di fede e avevo conosciuto persone credenti; a volte andavo addirittura in una chiesa – protestante – con le mie amiche… ma non avevo ancora ritrovato la via verso Dio” . E’ un fatto storico notevole: nel gruppo di allievi e collaboratori di Husserl ci sono state parecchie conversioni religiose. Lo stesso Husseri e la moglie erano passati dal giudaismo al protestantesimo, alla Chiesa Riformata luterana di Vienna, dove ricevettero il battesimo (Husserl aveva 27 anni). I figli erano stati istruiti nella religione protestante.
Sebbene nel suo lavoro filosofico non si ponga esplicitamente il problema religioso e affermi di non essere un filosofo cristiano, pure, in una conversazione privata con l’allieva e amica di Edith, Aldegonda, esclama: “Ve l’ho detto tante volte: la mia filosofia, la fenomenologia, non vuole essere altro che una via, un metodo che permetta a coloro che si sono allontanati dal cristianesimo e dalla Chiesa di ritornare verso Dio”. Nel gruppo husserliano spicca il prof.Adolf Reinach che, insieme alla moglie Anna si converte dal giudaismo alla fede evangelica. E questa, dopo la morte in guerra dei marito, passa alla Chiesa cattolica. Lo stesso avverrà della moglie del prof.Husserl e del prof. Alessandro Koyré, anche lui convertito.
La prof.ssa Hedwig Conrad-Martius, convertitasi alla fede evangelica con il marito, saranno grandi amici di Edith, ed è nella loro casa che Edith avrà la grande folgorazione, dopo la lettura – tutta d’un fiato – dell’Autobiografia di S.Teresa d’Avila: “Questa è la verità!” E sarà l’amica Hedwig, protestante, a fare da madrina al battesimo cattolico di Edith.
Ma fu sotrattutto Max Scheler, aggiuntosi più tardi al gruppo e spesso in polemica con Husseri, a esercitare influenza su Edith: “la maniera che aveva… di diffondere sollecitazioni geniali, senza approfondirle sistematicamente, aveva qualcosa di brillante e seducente” . I suoi scritti riguardanti i valori e l’empatia avevano per Edith un’importanza particolare. Proprio allora cominciò ad occuparsi dei problema della Einfulung (empatia, intuizione empatica) che fu l’argomento della sua tesi di laurea.
Ma l’influenza di Scheler acquistò importanza anche al di là dell’ambito filosofico. Egli infatti era passato dal giudaismo alla Chiesa cattolica, ma poi, per motivi di vita privata, se n’era allontanato e infine vi era rientrato. Scheler “aveva molte idee cattoliche e sapeva divulgarle facendo uso della sua brillante intelligenza e abilità linguistica. Fu cosi che venni per la prima volta in contatto con un mondo che fino ad allora mi era stato completamente sconosciuto. Ciò non mi condusse ancora alla fede, tuttavia mi dischiuse un campo di “fenomeni” dinanzi ai quali non potevo più essere cieca… I limiti dei pregiudizi razionalistici nei quali ero cresciuta senza saperlo, caddero, e il mondo della fede comparve improvvisamente dinanzi a me. Persone con le quali avevo rapporti quotidiani e alle quali guardavo con ammirazione, vivevano in quel mondo. Doveva perciò valere la pena almeno di riflettervi seriamente. Per il moniento non mi occupai metodicamente di questioni religiose; ero troppo occupata in molte altre cose. Mi accontentai di accogliere in me, senza opporre resistenza, gli stimoli che mi venivano dall’ambiente che frequentavo, e quasi senza accorgermene ne fui pian piano trasformata”.
In realtà in questi anni di Gottinga la “sete della verità” che Edith diceva essere la sua unica preghiera, inconsciamente si trasformava in “sete di Dio”. Quando, per esempio nel 1916, alla vigilia della discussione della tesi, a Friburgo, ha una lunga conversazione con Hans Lipps, uno dei gruppo che ironizza sul fervore di due amici, Dietrich von Hildebrand e Siegfried Hamburger, convertiti al cattolicesimo, Edith annota: “No, io non ero tra quelli. Avrei quasi detto: “Purtroppo no””. L’amico afferma di non capirci niente, e lei: “Io capivo un poco. Ma non potevo dire molto in proposito”.
Nel 1915 scoppia la Prima Guerra mondiale. Edith, appena superato l’esame di Stato in Filosofia, fece domanda alla Croce Rossa per entrare nel servizio sanitario. E così si trovò a prestare servizio come “ausiliaria”, per vari mesi, presso un grande ospedale militare per malattie infettive a Weisskirchen, in territorio austriaco. Alle rimostranze della madre per tale decisione oppone: “Se la gente era costretta a soffrire giù nelle trincee, perché io dovevo stare meglio di loro?”. Per parte sua, vorrebbe ancora continuare questo servizio, pensando a tanti suoi colleghi che stanno al fronte (e qualcuno non ne ritornerà vivo). Ma non ottiene il rinnovo. Certamente questa esperienza è stata per Edith occasione di crescita spirituale, come distacco da sé e dai propri progetti scientifici, maggiore apertura agli altri e incontro reale con la sofferenza e la morte. Per la serietà e la dedizione al lavoro infermieristio, alla fine della guerra le viene assegnata la “medaglia del coraggio” della Croce Rossa.
Nella vita della giovane Edith in questi anni (1915-1919, non mancano prove, come delusioni affettive, problemi familiari, crisi intellettuali, alle prese con gli sviluppi dei cammino “fenomenologico” del maestro Husserl, di cui è diventata assistente. Edith non condivide questi sviluppi, e sente il peso troppo forte di questa collaborazione. Lei che ha tanto desiderato un posto d’insegnamento all’Università – e lo stesso Husserl appoggia la sua domanda – vede fallire ogni tentativo in proposito (ottobre 1919).
Ma nel novembre 1917 riceve la notizia della morte di Adolf Reinach, ucciso sul fronte delle Ardenne. Per Edith è un trauma, perché, oltre che maestro, Adolf Reinach è per lei amico e confidente. Ora, stando accanto alla vedova Anna Reinach, e collaborando con lei per classificare le carte dei marito in vista della pubblicazione, fa un’esperienza di vita in chiave di fede, tutta positiva.
I coniugi Reinach si erano appena da un anno convertiti al protestantesimo. Ma già il marito si sentiva vicino al cattolicesimo, come appariva dai suoi Appunti su una fìlosofia della religione. Era stata la moglie a voler presto il battesimo: “non pregiudichiamo il futuro; quando saremo in comunione con Cristo, ci porterà dove vorrà. Entriamo nella sua Chiesa, non posso aspettare di più!”.
E proprio in questa prova suprema, la morte dei marito, Anna attinge nella “comunione con Cristo” tanta forza e tanta pace che è lei non a ricevere da altri, ma a dispensare consolazione a quelli che la circondano. Per Edith è un’esperienza della Croce di Cristo, determinante, come in seguito confiderà al P.Hirschmann, gesuita. Edith arriva al battesimo il I° gennaio 1922. Aveva lasciato il suo lavoro di assistente di Husserl (1919) e si era ritirata a Breslavia, concentrandosi nella ricerca personale filosofica e religiosa, e anche elaborando nuove forme di insegnamento. Passa lunghi periodi ospite degli amici Conrad-Martius, a Bergzabem nel Palatinato, anche lavorando duramente nei campi, con dedizione inesauribile… molto silenziosa e segreta… sembrava sempre concentrata, come assorbita in una meditazione ininterrotta…
La domenica accompagnava Hedwig alla chiesa protestante, per la funzione. Un giorno osservò: “Per i protestanti il cielo è chiuso, per i cattolici invece è aperto”. Anche prima della conversione, Edith aveva profondo rispetto per l’Eucaristia, presagendovi un mistero ineffabile. Uno squarcio autobiografico sul dramma interiore che sta vivendo lo possiamo leggere in un testo scritto da Edith sulla “Causalità psichica”, pubblicato proprio nel 1922 negli Annali di Husserl: “Faccio progetti per l’avvenire e organizzo di conseguenza la mia vita presente. Ma nel profondo sono convinta che si produrrà un qualche avvenimento che butterà a mare tutti i miei progetti. E’ la fede viva, la fede autentica alla quale ancora rifiuto di consentire, è a questa fede che io impedisco di divenire attiva dentro di me”.
Il testo, molto bello, continua descrivendo la trasformazione che avviene in questo stato di “riposo in Dio”, a partire dal silenzio della morte e sfociante in un afflusso di vita nuova, per la presenza di una “Forza che non è mia e che senza fare violenza alcuna alla mia attività, diventa attiva in me”.
Possiamo allora cogliere il senso del grido: “Questa è la verità!”, che Edith sente risuonare nel suo spirito, al termine della lettura dell’Autobiografia di S.Teresa d’Avila, con queste parole: “Realizzo pienamente la verità nel donarmi, nell’abbandonarmi totalmente all’Amore” (cf. Giov. 3,21; Ef 4,15). La “fede” in Cristo non era solo la conclusione della sua lunga ricerca intellettuale, ma la sintesi di una “nuova vita” operata dalla grazia.
La conversione è un punto molto importante per capire quanto sia “profetica” la vicenda di Edith. Si pensi a quel che avviene, più o meno negli stessi anni, in un altro gruppo di amici ebrei passati al cristianesimo evangelico: Eugen Rosenstock, Hans e Viktor Eherenberg, gravitanti intorno all’università di Lipsia.
Uno di loro, Franz Rosenzweig (1886-1929), in un primo momento stava per decidersi per il battesimo, ma poi ha un sussulto di orgoglio della propria radice ebraica, e polemicamente, in un confronto durato a lungo con l’amico Rosenstock, nega che possa esserci una base comune tra l’ebreo come tale e il cristiano di ascendenza ebraica. “Non c’è più alcun substrato ebraico vivo entro al cristiano militante e tanto meno, a parere di Rosenzweig, vi è liceità alcuna per l’ibrido giudeo-cristiano. Divenendo cristiani non si è più ebrei, si è cessato competamente di esserio. Anzi… in verità non lo si è mai stati, altrimenti la viva appartenenza alla comunità sinagogale non avrebbe reso possibile il passaggio al cristianesimo”.
Questa era la mentalità dominante. La madre di Edith, per esempio, non poté mai capire e accettare che la figlia, che pur continuava a frequentare con lei la sinagoga, si fosse rivolta a Cristo: era un tradimento, una separazione radicale dai beni più cari: il proprio popolo, la propria religione! Lo stesso grande filosofo ebreo Henry Bergson, che era approdato, nel suo lungo percorso, al Cristo dei vangeli, negli ultimi anni di vita (1859-1941) esitava a farsi battezzare nella Chiesa cattolica, per timore che il gesto fosse interpretato come un distacco dal suo popolo proprio nel momento più duro della persecuzione nazista.
Ora è indubitabile che la conversione a Cristo di Edith – avvenuta col battesimo del I° gennaio 1922 – non solo non segnò il distacco e tanto meno il tradimento del suo essere Ebrea, ma, paradossalmente, segnò una nuova riscoperta della propria ebraicità.
Disse un giorno Husserl, parlando della conversione di Edith Stein: “In lei tutto è autentico… Ma, in fin dei conti, c’è, in fondo a ogni ebreo, un assolutismo e un amore del martirio”.
Proprio cosi, da “vera ebrea” attirata da Dio, Edith vive solo per lui, con lo sguardo fisso sul suo Signore crocifisso, Gesù nazareno, Re dei giudei, e il desiderio di immolarsi per Cristo è tuttuno col desiderio di immolarsi per il suo popolo.
Su questo argomento, oltre alle fonti citate, ho trovato in Internet un ottimo studio del P.Jean Sleiman, Definitore Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, letto nel Simposio Internazionale su Edith Stein, tenutosi al Teresianum di Roma nell’ottobre 1998, in occasione della canonizzazione.
La mentalità dominante nell’ambiente familiare viene espressa – a distanza di tempo – da una nipote di Edith, Susanne Batzdorff-Biberstein: “Diventando cattolica nostra zia aveva abbandonato il suo popolo; il suo ingresso in convento manifestava di fronte al mondo esterno una volontà di separarsi dal popolo ebreo”.
Al contrario, nell’omelia per la beatificazione (1987), Giovanni Paolo II, con cognizione di causa, affermava: “Ricevere il battesimo non significò in alcun modo per Edith Stein rompere con il mondo ebraico. Al contrario ella afferma: “Quando ero ragazza di quattordici anni smisi di praticare la religione ebraica e per prima cosa, dopo il mio ritorno a Dio, mi sono sentita ebrea”.
Edith si considera “figlia di Israele” e ne rimarrà fiera tutta la vita, perché sente che è il popolo di Cristo stesso: “Non si può neanche immaginare quanto sia importante per me, ogni mattina quando mi reco in cappella, ripetermi, alzando lo sguardo al Crocifisso e all’effigie della Madonna: erano del mio stesso sangue!” .
Al padre gesuita Hirschmann scrisse: “Non può immaginare che cosa significhi per me essere figlia del popolo eletto, significa appartenere a Cristo non solo con lo spirito, ma con il sangue”. Come “ebrea”, Edith non fa questione di “razza”. Immersa nel mistero d’Israele, contempla nel Cristo Crocifisso, “re dei giudei” la piena realizzazione delle promesse, delle attese dell’alleanza divina col suo popolo. Perciò tutti gli ebrei sono di Cristo!
Ricordiamoci la data di nascita di Edith: 12 ottobre 1891, in cui ricorreva la festa ebraica del Kippur, giorno del perdono e della riconciliazione. Ora Edith, divenuta cattolica e prossima ad entrare nel Carmelo, contempla il legame profetico tra il giorno dei Kippur e il giorno del Venerdì Santo: “Il giorno della Riconciliazione dell’Antico Testamento è la figura del Venerdì Santo: l’agnello immolato per i peccati del mondo rappresenta l’Agnello immacolato”. Il Cristo, “accettando di morire vittima, è l’eterno Sacerdote”.
Cristo, dunque, appartiene al popolo ebreo, ma anche la Chiesa – dice esultando Edith nel “Dialogo notturno”: “La Chiesa vidi nascere dal seno del mio popolo. Dal suo Cuore spuntare vidi poi, come tenero tralcio allor fiorito, l’Immacolata, la tutta Pura, di David discendente”. E “nel cuore della Vergine”, figlia d’Israele, “dal Cuore di Gesù vidi fluire la pienezza di grazia”. Il rapporto stretto con la madre Augusta, fedele osservante della fede ebraica, ci aiuta ancora a comprendere la convinzione di Edith circa la non incompatibilità tra le due fedi, ebraica e cristiana. E’ l’ultima volta che Edith accompagna la madre alla sinagoga, per la festa dei Tabernacoli (sta per entrare nel Carmelo), e nel ritornare a casa la mamma le chiede: “Non era bella la predica?” – “Sì”. “Anche nella fede ebraica si può essere religiosi, non ti pare?” – “Certamente, quando non si è conosciuto altro”. Allora la madre replica, desolata: “E tu, perché l’hai conosciuto? Non voglio dir niente contro di lui, sarà stato certamente un uomo molto buono, ma perché si è fatto Dio?”. Madre e figlia soffrono terribilmente, al punto che Edith scrive: “Ho dovuto compiere il passo da sola e totalmente immersa nella notte della fede. Spesso, nel corso di quelle settimane così dure, mi sono chiesta quale di noi due, mamma o io, ci avrebbe rimesso la salute. Ma siamo rimaste ferme sulle nostre posizioni fino all’ultimo giorno”. Eppure Edith conserva ammirazione per la fede della mamma, non per puro istinto di affetto filiale, ma per la radicata convinzione che Dio opera anche oltre i confini della Chiesa, opera anche nelle altre religioni.
Alcune lettere scritte nel 1936, nel 1938 e nel 1939, ricordano la morte della mamma: “Dio l’ha presa con lui rapidamente”; “Oggi [la mamma] celebra il suo 87° anniversario con la cara nostra Santa Teresa”. Teresa di Lisieux: era infatti il 3 ottobre 1936, giorno – a quel tempo – della sua festa. Come si vede, pone sua madre in cielo in compagnia di una santa canonizzata, nessuna reticenza circa il destino dei suoi parenti giudei!
Questo suo sentire va insieme alla chiara affermazione: “Mia madre è rimasta fino all’ultimo fedele alla sua fede. Ma dato che questa sua fede e il completo abbandono nel suo Dio l’hanno accompagnata dall’infanzia fino all’87° anno di età, e sono rimasti accesi in lei fino all’ultimo, anche mentre lottava con la morte, sono convinta che abbia trovato un giudice molto generoso ed ora aiuterà anche me ad arrivare alla meta”. Edith arriva ad attribuire dei poteri di intercessione alla madre: commentando la visita fattale dal fratello in partenza per l’America, scrive all’amica Hedwig Dulberg: “Il giorno dei morti ricorderemo entrambe le nostre mamme. Questo pensiero mi è di grande consolazione. Credo fermamente che mia madre abbia il potere di aiutare i suoi figli in pericolo” (4 ottobre 1938).
Anche per il suo “caro Maestro”, il Prof.Edmund Husserl, che era in fin di vita (1938), Edith si esprime con grande apertura di spirito: “Non sono affatto preoccupata per il mio caro Maestro. E’ stato sempre lontano da me il pensare che la misericordia di Dio si permetta di essere circoscritta ai limiti visibili della Chiesa. Dio è la verità. Chi cerca la verità, cerca Dio, che ne sia cosciente o no”. Come non ammirare queste anticipazioni profetiche delle posizioni prese dalla Chiesa, dal Concilio Vaticano II in poi, circa i rapporti ecumenici, e particolarmente con gli ebrei?
Agli inizi degli anni ’30 la Germania versava in piena crisi economica e grave instabilità politica, mentre lentamente ma inesorabilmente saliva il partito nazionalsocialista di Hitler. Edith in quegli anni si trovava come insegnante presso le Domenicane di Spira (1922-1931), e in seguito presso l’Istituto di Pedagogia scientifica di Munster (1932-1933). Contemporaneamente, però, era impegnata in conferenze pubbliche molto richieste e apprezzate su problemi dell’educazione e del ruolo della donna.
Attenta da sempre alla storia del mondo, e come cristiana educata a interpretare gli eventi alla luce del vangelo, intuì presto il carattere totalitario e anticristiano del movimento nazista: “Oggi non c’è nulla che ci manchi così tanto come il battesimo nello spirito e nel fuoco… Nella grande battaglia che, più che mai, è in corso tra Cristo e Lucifero, vi sono quelle che sono chiamate per vocazione a formare gli uomini che devono andare al fronte. Armarci per la lotta e rimanere armate in permanenza: questo è il nostro dovere più pressante”. Così Edith si rivolgeva alle sue ascoltatrici. Intanto rifletteva quale fosse il suo posto al fronte.
Edith non stenta a capire subito il futuro: il nazismo, incarnazione del Maligno, nemico della Croce, combatte Dio stesso e il suo piano salvifico, perciò non può non cominciare dal voler distruggere il giudaismo, come fondamento della stessa religione cristiana, eliminare la “peste giudeo-cristìana” per instaurare il regno della razza ariana.
Nel 1931, al momento di accomiatarsi dalle allieve di Spira, una le dice: “Ma signorina, lei è sconvolta!”. “Non posso fare a meno di essere triste e di agitarmi, quando so che Hitler arresterà molto presto i miei parenti e anche me. Cosa fare?”.
Siamo al primo venerdì d’aprile 1933: Edith, non ancora carmelitana, proprio nella cappella del Carmelo di Colonia ha una profonda esperienza spirituale: “Mi rivolgevo interiormente al Signore, dicendogli che sapevo che era proprio la sua Croce che veniva imposta al nostro popolo. La maggior parte degli ebrei non riconosceva il Signore, ma quelli che capivano non avrebbero potuto fare a meno di portare la Croce. E’ ciò che desideravo fare. Gli chiesi soltanto di mostrarmi come”.
Sentendosi seriamente coinvolta nella sorte del suo popolo, continua a interrogarsi se potesse fare qualcosa per il problema degli ebrei. “Infine avevo deciso di recarmi a Roma e di chiedere al Santo Padre [Pio XI] una Enciclica, in una udienza privata”. Risultato impraticabile questo progetto (a giudizio del suo direttore spirituale, l’Abate di Beuron, Don Walzer), Edith ripiega a scrivere una lettera al Santo Padre, nella quale non si limitava a parlare degli ebrei, ma anche del futuro della Chiesa in Germania. “So che la mia lettera gli è stata consegnata direttamente e ancora chiusa… mi sono spesso domandata se il tenore del mio messaggio abbia in qualche modo destato l’attenzione del Sommo Pontefice. Le previsioni che vi facevo, riguardanti il destino dei cattolici in Germania, si sono puntualmente realizzate” . A giudizio del P.Jan H. Nota, gesuita olandese, che fu amico di Edith e ha poi approfondito il suo pensiero, questo passo compiuto da Edith potrebbe aver influito sulle posizioni assunte da Pio XI contro il razzismo e l’antisemitismo. Sul piano dell’azione a favore del suo popolo Edith ha fatto quanto le era unianamente possibile. Ma il Signore le apre nuove vie di amore eroico per i fratelli ebrei.
Nella stessa quaresima del 1933, ospite casuale di un collega dell’Istituto di Munster, Edith, che non era conosciuta da questi come ebrea, riceve molte informazioni dai giornali americani sulle atrocità commesse contro gli ebrei tedeschi. “Avevo già saputo delle persecuzioni… ma in quel momento… vidi con chiarezza… che il destino di quel popolo diveniva tutt’uno col mio”.
Se Edith deve partecipare al destino del suo popolo, e se questo destino è portare la Croce di Cristo che gli viene imposta… si comprende come queste esperienze spirituali la preparino al passo definitivo. Cosi si esprimeva poco dopo: “Non è l’attività umana che ci può salvare, ma soltanto la passione di Cristo. Esserne partecipe, questa è la mia aspirazione”.
Tenendo presente che una caratteristica della personalità di Edith è la piena integrazione tra il pensiero e il vissuto, tra le analisi, le elaborazioni filosofico-teologiche e l’esperienza mistica, comprendiamo come la vita di carmelitana rappresenti, per lei, la piena realizzazione della sua vocazione come donna: “L’unione nuziale dell’anima con Dio è lo scopo per il quale è stata creata: redenta dalla Croce e trovando il suo compimento nella Croce, l’anima è segnata per l’eternità dal sigillo della Croce”.
Nel suo scritto di anni prima (1931) sulla “Vocazione della donna”, Edith aveva esposto il modo d’intendere la “sposa del Cristo”: “Ella sta in piedi al suo fianco, come la Chiesa e come la Madre di Dio… Là ella sta, per aiutare l’opera della redenzione. Il dono totale del suo essere e della sua vita la fa entrare nella vita e nelle fatiche di Cristo, permettendole di compatire e di morire con lui, di quella terribile morte che fu per l’umanità la sorgente della vita. La sposa di Dio conosce così una maternità soprannaturale che abbraccia l’umanità intera, sia che prenda parte attiva alla conversione delle anime sia che ottenga con la sua immolazione i frutti della grazia per coloro che non incontrerà mai sul piano umano”.
Questo è stato il progetto divino pienamente realizzatosi nella vita di Edith: il 14 ottobre 1933 entra nel Carmelo di Colonia: il 15 aprile 1934 prende l’abito del Carmelo e il nome di Teresa Benedetta della Croce, come Lei aveva chiesto; domenica di Pasqua 1935 è chiamata alla professione semplice; il 10 maggio 1938 emette la professione solenne che la unisce definitivamente a Cristo.
Con l’esperienza della Croce era cominciato il cammino della conversione. Nel giorno dei battesimo si era fortemente sentita attratta verso la vita carmelitana, il cui tratto fondamentale – come lei stessa descrive – “consiste nel soffrire con Cristo… unite al Signore… Cristo continua a soffrire in loro… a intercedere per i peccatori attraverso una sofferenza liberamente accettata e gioiosa, partecipando così alla redenzione dell’umanità”. Nel Carmelo, vivendo intensamente questa vocazione, potrà dire: “Ora so molto di più che cosa significa essere la sposa del Signore sotto il segno della Croce. E’ chiaro che non si può facilmente capire perché è un mistero… E’ ai piedi della Croce che ho capito il destino del Popolo di Dio che già si stava delineando. Ho pensato che chi lo comprende deve prendere su di sé la Croce di Cristo per tutti”.
Quando nella famosa Notte dei cristalli (8-9 novembre 1938) si scatenò il fanatismo nazista contro negozi, case, e contro le stesse persone ebree, le suore rimangono esterrefatte, e Suor Benedetta (Edith) esclama: “E’ l’ombra della Croce che si abbatte sul mio Popolo! Oh, se adesso potesse capire!”.
“E’ qui il fondamento della teologia steiniana del giudaismo… Edith Stein ama sempre il suo Popolo, ma lo percepisce con gli occhi e il cuore di Cristo. Si rivolge a Lui e vede che la sua propria Croce è stata messa sulle spalle dei Popolo giudeo. In altri termini… la sorte di Cristo con il nazionalsocialismo è pure quella degli ebrei. La missione di ambedue è identica”.
Edith non separa mai il Messia dal suo Popolo messianico… L’Anticristo (il nazismo) odia in questo Popolo la sua messianità, e quindi il legame profondo, vitale, connaturale con Cristo… E’ alla luce dell’approfondimento del mistero di Israele sotto la Croce, al di là del contesto storico, che bisogna capire il suo amore, la sua compassione e anche le sue critiche: “Il grande peccato degli Ebrei, per Edith, se si deve parlare di peccato, è di trascurare la loro missione e quindi di tradire la propria identità: popolo messianico, popolo del Messia, ma anche Popolo Messia”.
Il 30 gennaio 1939 Hitler decreta e annuncia l’annientamento della “razza ebraica”. I segni dell’imminenza del conflitto sono evidenti. Il 31 dicembre Edith si rifugia nel Carmelo di Echt in Olanda, dove nell’agosto del ’40 la raggiungerà la sorella Rosa. In questa situazione drammatica Suor Benedetta si stringe sempre più al Cuore di Gesù “per diventare la tua vera sposa. Ti prometto solennemente: ogni volta che dovrò fare una scelta prenderò ciò che ti rallegrerà di più”. Fa, cioè, il voto dei “più perfetto”.
E qualche settimana dopo, chiede alla priora di Colonia (che è rimasta la sua superiora) l’autorizzazione a “offrirmi al Cuore di Gesù come vittima espiatoria per la vera pace, augurandomi che il regno dell’Anticristo crolli, se è possibile, senza una nuova guerra mondiale, e che venga rinnovato l’ordine dei mondo”.
Infine scrive un Testamento spirituale: “Fin da adesso accetto la morte che Dio mi ha destinato e con una totale sottomissione alla sua santissima volontà. Prego il Signore di voler accettare la mia vita e la mia morte per la sua gloria, per le intenzioni dei SS.Cuori di Gesù e di Maria, per quelle della Chiesa. In particolare… in espiazione per il rifiuto della fede da parte del popolo ebreo, affinché il Signore sia accolto dai suoi e venga il suo regno nella gloria; per la salvezza della Germania e, per la pace nel mondo”. Suor Benedetta non affronta temerariamente il martirio. Memore delle parole di Gesù (Mt 10, 23): “Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un’altra”, in accordo e per suggerimento degli stessi superiori, aveva cercato di farsi accogliere in un Carmelo della Svizzera, e le pratiche erano a buon punto. Ma in seguito alla convocazione ad Amsterdam da parte della Gestapo, si rende conto che non avrebbero avuto esito positivo. Si rivolge anche alla Spagna.
Intanto Suor Benedetta è tutta immersa nello studio e nella contemplazione degli scritti di S.Giovanni della Croce (per incarico della superiora, in vista di una pubblicazione per il 4° Centenario della nascita dei Santo, 1942). “Nella conclusione della sua analisi del Cantico spirituale... si può leggere tutto il suo destino, discernere la luce della Croce dalla quale sarà illuminata la notte misteriosa della sua fine: … “Il matrimonio spirituale dell’anima con Dìo, scopo per il quale l’anima è stata creata, viene comprato dalla Croce, consumato sulla Croce e per tutta l’eternìtà suggellato con il sigillo della Croce””. Ecco, in sintesi, la parte finale dei dramma: l’anno 1942 segna l’inizio delle deportazioni in massa degli ebrei verso l’Est: campi di lavoro, miniere di sale, camere a gas. Di fronte a questi eventi di incredibile ferocia, i Vescovi della Chiesa di Olanda, in accordo con la Chiesa Riformata, inviano al Commissario del Reich un lungo telegramma di protesta (11 luglio 1942).
In seguito a questo passo, il Capo nazista si dice disposto a non toccare quei cristiani di origine ebraica che possono dimostrare la loro appartenenza a una comunità cristiana prima del. gennaio 1941. I Vescovi ritengono del tutto insufficiente questa risposta, perché non tocca la questione di fondo, le deportazioni in massa, e – d’accordo con la maggioranza dei ministri protestanti – fanno leggere in tutte le chiese del paese (domenica 26 luglio) una lettera pastorale, nella quale veniva riportata la protesta e il pressante appello del telegramma. Inoltre si faceva menzione dello scambio di idee intercorso con il Commissario del Reich, e si concludeva con un ardente Appello alla preghiera per la giusta pace e per il popolo ebreo tanto duramente provato.
Conclusione? La mattina del 2 agosto, il commissario del Reich ordina che tutti i religiosi e le religiose non ariani presenti nei conventi olandesi vengano portati via. E nel pomeriggio dello stesso 2 agosto 1942, la Gestapo viene ad arrestare le sorelle Stein. In pochi minuti le due sorelle devono lasciare il convento. Inutile ogni protesta della superiora.
L’ultima parola di Suor Benedetta nel lasciare il Carmelo è indirizzata alla sorella: “Vieni, – le dice prendendola per mano – andiamo per il nostro popolo”.
La sera stessa, il Commissario aggiunto Schmidt rilascia una dichiarazione ufficiale secondo la quale, avendo l’episcopato cattolico rifiutato di rispettare il segreto dei negoziati, le autorità tedesche si vedono costrette a “perseguire i cattolici ebrei, come i loro peggiori nemici, assicurandone il più presto possibile la deportazione verso l’Est”.
Edith fu condotta per alcuni giorni nel campo olandese di Westerbork, e poi, il 7 agosto, fu avviata con gli altri ebrei, su un treno piombato, ad Auschwitz. Questi elementi ci danno la certezza che Edith Stein è stata arrestata e deportata perché cattolica ebrea, e non semplicemente come ebrea, per rappresaglia contro la Chiesa cattolica d’Olanda.
Per gli ebrei cattolici deportati ci fu un trattamento – se possibile – ancora più duro che per gli altri. Ad Auschwitz-Birkenau, all’arrivo dei convoglio, il 9 agosto 1942, le sorelle Stein vengono fatte entrare – con le altre deportate – nella camera a gas.
Nell’ultima lettera che, da deportata, era riuscita a far pervenire al Carmelo di Echt, aveva scritto: “Si può acquistare una “Scienza della Croce” [era il titolo dell’ultimo suo libro, rimasto incompiuto], solo se si comincia a soffrire veramente del peso della Croce. Ne ho avuto l’intima convinzione fin dal primo istante, e dal profondo del cuore ho detto: “Salve, o Croce, unica speranza””.
Nel tunnel della morte, il cuore di Edith palpita: “La Croce è tutta luce: il legno della Croce è divenuto luce del Cristo”.
GIORGIO AGAMBEN

A cura di Simone Tunesi
Giorgio Agamben (1942) si laurea nel 1965 presso l’Università di Roma con una tesi sul pensiero politico di Simone Weil. Negli anni sessanta, a Roma frequenta intensamente Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini (fa la parte di Filippo ne Il Vangelo secondo Matteo), Ingeborg Bachmann. Nel 1966 e nel 1968, partecipa ai seminari di Martin Heidegger a Le Thor (su Eraclito e Hegel). Nel 1974 risiede a Parigi, insegnando come lettore di Italiano presso l’Università di Haute-Bretagne. Studia linguistica e di cultura medievale. Frequenta tra gli altri Pierre Klossowski e Italo Calvino.
Nel 1974-75, grazie a di Frances Yates, inizia un lavoro di ricerca presso la biblioteca del Wartburg Institute a Londra. Prepara il libro Stanze, La parola e il fantasma nella cultura occidentale (Einaudi 1977).
Tornato in Italia, dal 1978 dirige per Einaudi l’edizione italiana delle Opere complete di Walter Benjamin, di cui ritrova importanti manoscritti.
Dal 1986 al 1993, è Directeur de programme presso il Collège International de Philosophie (Parigi).
Dal 1988 al 1992, professore associato di Estetica presso l’Università di Macerata.
Dal 1993 al 2003, professore associato di Estetica presso l’Università di Verona.
A partire dagli anni novanta, i suoi interessi si sono rivolti alla filosofia politica e al concetto di biopolitica. Attraverso una rilettura della Politica aristotelica e del pensiero di Michel Foucault, di Hannah Arendt e di Carl Schmitt, elabora una teoria del rapporto fra diritto e vita e una critica del concetto di sovranità (Homo sacer, Einaudi 1995).
Dal 1994, è regolarmente visiting Professor nelle università americane.
Nominato, nel 2003, Distinguished professor presso la New York University, abbandona l’incarico per protesta contro la politica del governo statunitense.
Dal novembre 2003, professore di estetica presso la Facoltà di Design e Arti della IUAV.
Tra i suoi lavori ricordiamo, “Il linguaggio e la morte” (Einaudi 1982) “Bartleby, la formula della creazione” (Quodlibet, 1993), scritto con Gilles Deleuze, e “Homo sacer” (Einaudi, 1995). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato “Mezzi senza fine. Note sulla politica” (1996); “Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone” (1998); “Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai Romani»” (2000); la nuova edizione di “La comunità che viene (2001, già Einaudi, 1990), “L’aperto. L’uomo e l’animale” (2002) e Stato di eccezione (2003).
Lo scritto più importante e significativo di Agamben è Homo Sacer (in realtà Homo Sacer è una trilogia formata da Homo Sacer (I), appunto, Stato di eccezione (II) e Quel che resta di Auschwitz (III). I tre libri sono dunque fortemente legati fra loro, anche se il contributo filosofico più importante è dato dal primo volume). Questo testo parte da un presupposto fondamentale: oggi la politica è diventata biopolitica.
Il discorso di Agamben prende le mosse analizzando la figura dell’ “Homo sacer” (Uomo Sacro: a questo proposito ricoro che l’aggettivo Sacro deriva da una parola indoeuropea che significa “separato”) che viene definito nel II secolo dopo Cristo dal grammatico latino Festo “colui che il popolo ha giudicato per un delitto; e non è lecito sacrificarlo, ma chi lo uccide, non sarà condannato per omicidio”. Si tratta, quindi, di una vita umana che si può uccidere ma che non è sacrificabile, che trascende tanto l’ordinamento del diritto umano quanto le norme del diritto divino. Se qui sacro è il vivente giudicato come assassino, allora nel momento in cui la vita viene dichiarata sacra in sé, ciò equivale a dichiararla colpevole. Da ciò si evince la violenza connaturata del diritto: la nuda vita è portatrice del bando sovrano, ovvero del nesso tra violenza e diritto perché è in quanto tale colpevole. Si tratta della “nuda vita”, secondo l’enigmatica espressione adottata da Walter Benjamin in Per la critica della violenza.
Un esempio è dato dagli ebrei nella Germania nazista (tema, questo, che il filosofo riprende in molti dei suoi scritti): gli ebrei erano colpevoli perché erano ebrei, in questo senso diventavano anche sacri e di conseguenza uccidibili. La nuda vita in quanto sacra viene deportata nel campo (di sterminio): il campo così inteso (come paradigma biopolitico del moderno) è lo spazio in cui si manifesta appieno la sacertà della vita.
L’homo sacer è la figura originaria della vita presa nel bando sovrano. Il potere sovrano in quanto produzione di un corpo biopolitico è produzione di homines sacri, consacrazione del vivente, è quel processo che rende la vita propriamente sacra, cioè uccidibile e non sacrificabile. Questo discorso è ripreso da Agamben anche nel suo lavoro più recente: Stato di eccezione. La vita, infatti diviene sacra solamente nell’eccezionalità propria del diritto. Ma, come è ben verificabile oggi (basti pensare alla politica degli Stati Uniti), l’eccezione tende ad estendersi nel tempo fino a diventare la regola; quello che dovrebbe essere uno stato d’emergenza (e quindi di eccezione) temporaneo, diventa lo stato normale delle cose.
Agamben segnala anche il particolare rapporto che effettivamente sussiste tra homo sacer e sovrano: “sovrano è colui rispetto al quale tutti gli uomini sono potenzialmente homines sacri e homo sacer è colui rispetto al quale tutti gli uomini agiscono come sovrani”.
Il discorso svolto da Agamben in Homo sacer si sviluppa dunque a partire da una domanda implicita che potremmo formulare in questo modo: è possibile interpretare la politica in base alla stessa “struttura originaria” della metafisica già analizzata e finemente decostruita in ricerche precedenti? Troviamo gli elementi per una risposta proprio nelle pagine che concludono Homo sacer: “L’isolamento della sfera dell’essere puro, che costituisce la prestazione fondamentale della metafisica dell’occidente, non è senza analogie con l’isolamento della nuda vita nell’ambito della sua politica”.
Ritorna qui il tema dell’eccezionalità. Come funziona la figura logica dell’eccezione? Si tratta di una paradossale “esclusione inclusiva”, come quella implicita nel potere di proclamare lo stato di eccezione. Secondo Carl Schmitt il potere sovrano è “monopolio della decisione ultima”, ossia della decisione intorno alla sospensione dell’ordinamento giuridico normale attraverso la proclamazione dello stato di eccezione. L’articolo 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar assegnava al presidente questo potere, di cui il regime totalitario di Hitler fece uso ininterrottamente a partire dal 28 febbraio 1933, instaurando una sorta di “stato di eccezione permanente”. A questo punto sorge un’altra questione: dove si colloca il sovrano rispetto alla legge, posto che ha il diritto di sospendere il diritto?
Il sovrano, che segna il limite dell’ordinamento giuridico, è, contemporaneamente, fuori e dentro l’ordinamento giuridico (in altre parole, la legge è fuori di se stessa, in quanto l’ordinamento giuridico riconosce al sovrano il potere di sospendere l’ordinamento giuridico stesso). In questo senso l’eccezione è la forma originaria del diritto, il presupposto delle coordinate giuridiche fondamentali: ordinamento e localizzazione.
La sovranità costituisce una soglia indecidibile tra diritto e violenza, come aveva intuito Pindaro nel celebre frammento 169 (Nómos, re di tutte le cose, conduce con mano più forte giustificando il più violento). La legge giustifica il più violento; il diritto quindi ha a che fare con la violenza fin dalla sua origine. È alla possibilità di spezzare questo nesso, o meglio di recidere questo nodo che alludono le riflessioni del giovane Benjamin Per la critica della violenza.
La comprensione della logica della sovranità esige un ripensamento dei concetti metafisici di potenza e atto. Il bando sovrano è infatti potenza di affermare la legge solo in quanto è in pari tempo potenza di non affermarla, o meglio di sospenderla, di non passare all’atto. In altre parole: nello stato di eccezione si manifesta l’impotenza del potere sovrano. Agamben, riprendendo l’idea benjaminiana di una radicalizzazione dello stato di eccezione, allude qui ad una prospettiva ulteriore,[1] [6] in cui si manifesta appieno l’implicazione reciproca tra ontologia e politica: “pensare l’esistenza della potenza senz’alcuna relazione con l’essere in atto – nemmeno nella forma estrema del bando e della potenza di non essere, e l’atto non più come compimento e manifestazione della potenza – nemmeno nella forma del dono di sé e del lasciar essere” .
Nella parabola di Kafka intitolata Davanti alla legge troviamo una perfetta rappresentazione della struttura del bando sovrano: il contadino viene interpretato da Agamben come la nuda vita abbandonata dalla Legge, che non esige nulla da lui.
A questo punto risulta chiaro come ogni tentativo di ripensare le nostre categorie politiche deve muovere dalla consapevolezza che della distinzione classica tra zoé e bios, tra vita naturale ed esistenza politica (o tra l’uomo come semplice vivente e l’uomo come soggetto politico), non ne sappiamo più nulla.
L’eclissi della politica è cominciata da quando essa ha omesso di confrontarsi con le trasformazioni che ne hanno svuotato categorie e concetti. Accade così che paradigmi genuinamente politici vadano ora cercati in esperienze e fenomeni che di solito non sono considerati politici: la vita naturale degli uomini, restituita, secondo la diagnosi foucaultiana, al centro della “polis”; il campo di concentramento, dove quanto si ha di più privato, il sangue, diviene criterio politico decisivo, delimitando uno spazio di indistinguibilità tra vita biologica e sfera politica; il rifugiato, che, spezzando il nesso fra uomo e cittadino, passa da figura marginale a fattore decisivo della crisi dello Stato-nazione; il linguaggio come luogo politico per eccellenza, oggetto di una contesa e di una manipolazione senza precedenti; la sfera dei mezzi puri o dei gesti, ossia dei mezzi che, pur restando tali, si emancipano dalla loro relazione a un fine.
Lo stato di eccezione, ossia quella sospensione dell’ordine giuridico che siamo abituati a considerare una misura provvisoria e straordinaria, sta oggi diventando sotto i nostri occhi un paradigma normale di governo, che determina in misura crescente la politica sia estera sia interna degli stati. Quando lo stato di eccezione tende a confondersi con la regola, le istituzioni e gli equilibri delle costituzioni democratiche non possono più funzionare e lo stesso confine fra democrazia e assolutismo sembra cancellarsi.
Le riflessioni filosofico-politiche di Agamben prendono spunto soprattutto dalla dimensione politica del campo di concentramento di cui Auschwitz è il paradigma.
Se il problema delle circostanze storiche (materiali, tecniche, burocratiche, giuridiche) in cui è avvenuto lo sterminio degli ebrei può considerarsi oggi sufficientemente chiarito (grazie soprattutto al lavoro monumentale di Raul Hilberg), ben diversa è la situazione per quanto concerne il significato etico e politico dello sterminio o anche soltanto la comprensione umana di ciò che è avvenuto – cioè, in ultima analisi, la sua attualità. Alla luce di quanto detto finora è abbastanza evidente che non soltanto manca uno strumento intellettuale che ci permetta di comprendere a fondo la Shoà, ma anche il senso e le ragioni del comportamento dei carnefici e delle vittime e, molto spesso, le loro stesse parole continuano ad apparirci come un enigma. Agamben analizzando lo sterminio avvenuto durante la seconda guerra mondiale, prova ad ascoltare non tanto la voce dei testimoni, quanto la voce intestimoniabile, la “presenza senza volto” che ogni testimonianza necessariamente contiene (cioè, nelle parole di Primo Levi, coloro che hanno “toccato il fondo” – i “musulmani”). In questa prospettiva, Auschwitz non si presenta più soltanto come il campo della morte, ma come il luogo simbolo di un esperimento ancora impensato, in cui i confini fra l’umano e l’inumano si cancellano; e, messa alla prova di Auschwitz (Adorno diceva che dopo Auschwitz è impensabile scrivere una poesia), l’intera riflessione etica del nostro tempo mostra la sua inattualità per lasciar apparire fra le sue rovine il profilo incerto di una nuova terra etica: quella della testimonianza.
AMARTYA SEN

Amartya Sen nacque nel 1933 a Santiniketan (in Bengala): divenne docente presso l’università di Calcutta, presso il Trinity College di Cambridge, poi a Nuova Deli, alla London School of Economics, a Oxford e, successivamente, all’università di Harvard. Nel 1998, pur mantenendo la sua carica di docente ad Harvard, ha fatto ritorno come rettore al Trinity College. Presidente della Economic Society, della International Economic Association, della Indian Economic Association, a Sen è stato conferito il Premio Nobel per l’economia nel 1998. Egli è autore di numerosissime opere, delle quali meritano sicuramente di essere ricordate Collective Choice and Social Welfare (1971), On Economic Inequality (1973), Commodities and Capabilities (1985), Etica ed Economia (1987), Inequality Reexamined (1992), Lo sviluppo è libertà (1999), Globalizzazione e libertà (2002).
Ciò che Amartya Sen si propone di porre al centro della propria riflessione è la discussione sulla disuguaglianza, letta però in una “nuova direzione” che si contrapponga a quelle tradizionali e prevalenti. L’idea di disuguaglianza (inequality) deve secondo Sen confrontarsi con due diversi ostacoli: a) la sostanziale eterogeneità degli esseri umani; b) la molteplicità dei punti focali a cui la disuguaglianza può essere oggetto di valutazione. Al di là della “potente retorica dell’uguaglianza”, che trova il suo apice nella nota asserzione per cui “tutti gli uomini nascono uguali”, Sen è convinto che gli individui siano del tutto diversi gli uni dagli altri e che dunque il pur ambizioso progetto egualitario debba muoversi “in presenza di una robusta dose di preesistente disuguaglianza da contrastare”. Sen è d’altro canto convinto che la misurazione della disuguaglianza dipenda dalla variabile focale (felicità, reddito, ricchezza, ecc) attraverso cui si fanno i confronti: la misurazione della disuguaglianza dipende cioè dai parametri assunti per definirla. La prima conseguenza di ciò sta nel fatto che, se tutte le persone fossero identiche, l’eguaglianza in una sfera (ad esempio nelle opportunità o nel reddito) tenderebbe ad essere coerente con eguaglianze di altre sfere (ad esempio, l’abilità di funzionare). Ma poiché le persone non sono affatto identiche, ma anzi vige un’assoluta “diversità umana”, ne segue che l’eguaglianza in una sfera tende a coesistere con disuguaglianze in altre sfere: così, ad esempio, redditi uguali possono coesistere con una forte disuguaglianza nell’abilità di fare ciò che si ritiene importante (un sano e un malato, pur avendo lo stesso reddito, non possono fare le stesse cose), ecc. La seconda conseguenza fondamentale scaturente dal fatto che la misurazione della disuguaglianza dipende cioè dai parametri assunti per definirla sta nel fatto che la disputa non si innesta tanto fra egualitari e anti-egualitari, giacché tutte le più importanti teorie etiche degli assetti sociali sono comunque favorevoli alla “eguaglianza di qualche cosa” (e infatti nelle loro scelte politiche tendenzialmente egualizzano una qualche dimensione della vita umana). Una prova di ciò sta nel fatto che anche le teorie considerate tradizionalmente come “anti-egualitarie” finiscono poi per essere egualitarie nei termini di qualche altro “punto focale”. Così l’iper-liberale Nozick rigetta tout court l’eguaglianza di reddito e di benessere, ma di fatto difende strenuamente l’eguaglianza di libertà (tutti gli individui sono parimenti liberi). Ciò vuol dire – rileva Sen – che per poter parlare di eguaglianza occorre preventivamente porsi il duplice quesito: a) why equality? (“perché eguaglianza?”); b) equality of what? (“eguaglianza di che cosa?”). Non si può infatti pretendere di difendere l’eguaglianza (o di criticarla) senza sapere quale sia il suo oggetto, ossia quali siano le caratteristiche da rendere uguali (redditi, ricchezze, opportunità, libertà, diritti, ecc). Interrogarsi sull’uguaglianza significa dunque innanzitutto interrogarsi su quali siano gli aspetti della vita umana che debbono essere resi eguali. La storia della filosofia ci offre una molteplicità di esempi diversi di soluzioni: Rawls descrive l’eguaglianza come un paniere di beni primari di cui tutti gli individui dovrebbero disporre; Dworkin come eguaglianza di risorse; gli utilitaristi come eguale considerazione delle preferenze o delle utilità di tutti gli individui. Quale, tra queste, è la soluzione migliore? Sen collega il valore eguaglianza al valore libertà: quest’ultima è da lui connessa ai concetti di “funzionamenti” e “capacità”. Non è un caso che, in origine, Sen voleva che l’opera La diseguaglianza fosse intitolata Eguaglianza e libertà. Con l’espressione funzionamenti (functioning) Sen intende “stati di essere e di fare” dotati di buone ragioni per essere scelti e tali da qualificare lo star bene. Esempi di funzionamenti sono ad esempio l’essere adeguatamente nutriti, l’essere in buona salute, lo sfuggire alla morte prematura, l’essere felici, l’avere rispetto di sé, ecc. Con l’espressione capacità (capabilities) Sen intende invece la possibilità di acquisire funzionamenti di rilievo, ossia la libertà di scegliere fra una serie di vite possibili: “nella misura in cui i funzionamenti costituiscono lo star bene, le capacità rappresentano la libertà individuale di acquisire lo star bene”. Per questa ragione, Sen sottopone a critica tutte quelle teorie che fanno della libertà un qualcosa di meramente strumentale, privo di valore intrinseco: gli stessi Dworkin e Rawls hanno soffermato la loro attenzione più sui mezzi e le risorse che portano alla libertà che non sull’estensione della libertà in se stessa. I “beni primari” di cui dice Rawls e le “risorse” di cui scrive Dworkin sono agli occhi di Sen degli indicatori assai imprecisi e vaghi di ciò che si è realmente liberi di fare e di essere. Ancora più vago e impreciso è il “reddito”, poiché una persona malata e bisognosa di cure è sicuramente in una condizione peggiore di una persona sana avente il suo stesso reddito. La conclusione a cui Sen perviene passando dalla critica delle altrui posizioni è che il grado di eguaglianza di una determinata società storica dipende dal suo grado di idoneità a garantire a tutte le persone una serie di capabilities di acquisire fondamentali funzionamenti, ossia un’adeguata qualità della vita o well-being generale (cioè non ristretto entri parametri strumentali o economici). Fedele a questa impostazione, Sen è giunto, nei suoi scritti successivi, a tratteggiare una teoria dello sviluppo umano in termini di libertà (development as freedom). E, nel fare ciò, si è direttamente riallacciato alla tradizione greca, inaugurata da Aristotele, dell’eudaimonìa: l’espressione greca eudaimonìa non corrisponde affatto alla sua usuale traduzione inglese in happiness (felicità), ma ha piuttosto a che vedere col termine fulfillment, che vuol dire realizzazione completa di sè e che può essere resa con la bella immagine di una “vita fiorente” (flourishing life), ossia di una vita che fiorisce in tutte le sue potenzialità. L’eudaimonìa quale la intende Sen si contrappone direttamente al vecchio ideale della Welfare economics, che bada soltanto al benessere materiale: ma si oppone anche alla formulazione monistica che dell’eudaimonìa ha dato lo stesso Aristotele. Secondo Sen, infatti, l’eudaimonìa deve portare ad uno sviluppo pluralistico, per cui “esiste una pluralità di fini e di obiettivi che gli uomini possono perseguire”. L’errore commesso da Aristotele sta nell’aver individuato una “lista” di funzionamenti universalmente valida, trascurando di fatto l’individuo. Secondo Sen, invece, essendo tanti i fini e gli obiettivi che ciascun individuo può legittimamente perseguire, anche le capabilities sono una pluralità.
DWORKIN

“Il liberalismo deve avere fondazioni etiche“.
VITA E PENSIERO
Ronald Myles Dworkin nacque a Worcester (nel Massachussets) nel 1931. Dopo aver condotto ad Harvard i suoi studi, ha insegnato a Yale. Divenuto docente di diritto a Oxford, ha anche insegnato alla Law School della New York State University ed è stato visiting professor presso numerose università degli USA. Tra le sue tante opere, meritano di essere ricordate: Taking Rights Seriously (1977), Questioni di principio (1985), L’impero del diritto (1986), Il dominio della vita (1994), I fondamenti del liberalismo (scritto con Sebastiano Maffettone, 1996), Virtù sovrana (2000). Nei suoi scritti, Dworkin è andato elaborando una forma etica del liberalismo, derivante valori e diritti da una nozione di libertà strettamente imparentata con quella di eguaglianza. In Taking Rights Seriously, Dworkin mette in luce come l’istituzione di diritti nei confronti dello Stato non sia né un dono divino, né un’antica consuetudine, né uno “sport nazionale”, ma piuttosto una pratica complessa che rende l’opera dello Stato più difficile e dispendiosa, al fine di garantire un beneficio comune. Si tratterebbe sicuramente di una pratica inutile e frivole se poggiasse su una base non solida e se non servisse a un ben preciso scopo. Le due idee imprescindibili a cui fare riferimento sono la “vaga ma potente” idea della dignità umana (già scoperta da Kant) e la “più familiare” idea di uguaglianza politica. Ne segue che il liberalismo, per Dworkin, dev’essere imperniato in una considerazione degli individui “come uguali” (as equals) e in una teoria delle istituzioni giuridiche e politiche come organi finalizzati a garantire il diritto di ciascuno all’equal concern and respect. Sicché il liberalismo dev’essere una teoria dei diritti “presi sul serio”, come recita il titolo dell’opera Taking Rights Seriously: una teoria che dunque ne rappresenti il fondamento intrinseco (constitutive morality) e l’assetto normativo. Nel delineare questa forma di liberalismo, Dworkin intende opporsi ai modelli del positivismo giuridico alla Kelsen e dell’utilitarismo tradizionale, tutti e due nemici alla “antica idea dei diritti umani individuali”. Al cuore delle successive opere di Dworkin (sempre più attente al tema dell’eguaglianza) sta la teoria per cui gli individui sono titolari di diritti connessi a princìpi eticamente fondati (in primis la “uguale considerazione e rispetto”) e pertanto preesistenti alla loro codificazione positiva e alle scelte politiche e giuridiche concrete. Nello scritto Virtù sovrana (una raccolta di saggi degli anni Ottanta e Novanta, significativamente sottotitolato Teoria dell’eguaglianza) Dworkin osserva, in bilico tra ironia e preoccupazione, come, nel regno degli ideali politici, oggi la specie in pericolo d’estinzione sia l’eguaglianza. Perfino i politici più spostati a Sinistra tendono oggi a rifiutarla: ciò significa che essa debba essere rigettata? Secondo Dworkin, un governo può dirsi legittimo nella misura in cui dimostra uguale considerazione per la sorte di quei cittadini sui quali pretende di esercitare la sovranità. Se viene a mancare questo presupposto, “il governo è soltanto tirannia”. La “nuova Sinistra” non rifiuta “l’eguale considerazione”, ma una specifica concezione di quel che l’eguale considerazione richiede. Sicuramente assicurare l’eguaglianza non significa assicurare a tutti la stessa ricchezza, sennò ne scaturirebbe un mondo in cui “le persone che scelgono di non lavorare, essendo in condizione di farlo, sono premiate col frutto del lavoro svolto dalle persone operose”. Che cosa vuol dire allora che il governo deve trattare tutti con equal concern and respect? Non si può rispondere a questa domanda in maniera chiara e inequivocabile, nota Dworkin: infatti, l’idea di eguaglianza è controversa e gli studiosi ne hanno dato definizioni diverse. Se ne deve allora trarre la conclusione che è meglio rinunciare a tale ideale problematico, seguendo la nuova moda? Dworkin replica che, se l’eguale considerazione è un requisito imprescindibile della legittimità politica, sarebbe poco saggio rinunciare a decidere se l’eguaglianza, e non semplicemente una diminuzione della disuguaglianza, debba essere un obiettivo legittimo per una comunità. Proprio per questa ragione, il filosofo americano ha continuato ininterrottamente a porsi il problema dell’eguaglianza: e l’ha intesa in termini di risorse e di opportunità più che di generico benessere. In opposizione ad ogni modello di Welfare State, egli nota come il liberalismo non possa andare tanto in là fino a decretare un modello di benessere uguale per tutti gli uomini, ma debba piuttosto limitarsi a garantire porzioni uguali di risorse e di opportunità. Ma del resto la libertà non è mai libertà di fare qualunque cosa ci passi per la testa, ma è piuttosto libertà di fare qualunque cosa si desideri e che rispetti i diritti legittimi degli altri individui. Per questo motivo, una coerente teoria liberale (e non liberista) non deve mai perdere di vista la doppia stella polare del principio di pari importanza (ciascuno dev’essere messo in condizione di poter attuare appieno le proprie aspirazioni) e del principio di responsabilità particolare (ciascuno è responsabile delle scelte che compie quando tenta di attuare le proprie aspirazioni). Il primo principio richiede che il governo adotti leggi e politiche in grado di assicurare che la sorte dei cittadini non dipenda dalle loro condizioni economiche, di sesso, di razza, ecc. Il secondo principio richiede che il governo agisca per far dipendere la sorte dei cittadini dalle scelte che essi hanno compiuto. Si viene in questo modo a delineare un nuovo liberalismo, costituente una terza via rispetto alle due antiche della Destra e della Sinistra. I vecchi egualitari ignoravano le responsabilità individuali; queste erano riconosciute dai conservatori, che però ignoravano la responsabilità collettiva. La scelta tra queste due vie è inutile e pericolosa: si tratta piuttosto di percorrere la nuova via del modello liberale avanzato da Dworkin, che identifica eguaglianza e responsabilità rispettandole tutt’e due. Sicché, se in origine Dworkin aveva riconosciuto il cuore del liberalismo nella neutralità tra le teorie del bene, in seguito egli ha scorto l’essenza del liberalismo nella cosiddetta teoria dell’eguaglianza liberale, per cui libertà, uguaglianza e comunità, lungi dall’essere tre virtù in perenne conflitto tra loro, sono “aspetti complementari di un’unica visione politica” (I fondamenti del liberalismo). Forte di questa nuova lettura del liberalismo, Dworkin passa in rassegna una nutrita serie di posizioni di filosofia politica, distruggendole una dopo l’altra: sbaglia Berlin a intendere la libertà e l’eguaglianza come valori politici in competizione; sbaglia Nozick a riconoscere lo Stato giusto nello Stato “poliziotto”, che assiste all’indisturbato svolgersi delle azioni di mercato; lungi dall’essere semplicemente un poliziotto che controlla che non ci siano disturbi sul mercato, lo Stato, secondo Dworkin, non può restare indifferente alle disuguaglianze di risorse e di opportunità. Sbagliano anche i comunitaristi radicali, che nell’esaltare la comunità si scordano le libertà e le responsabilità dell’individuo. Ma più di tutti sbaglia Rawls, accusato di essere “discontinuo” nella misura in cui separa la politica dall’etica: in opposizione, Dworkin propone una visione “continuista”, incentrata sul nesso morale-politica e sul rapporto tra il liberalismo e le concezioni filosofiche più appropriate sulla vita buona. Dworkin è infatti convinto che “il liberalismo deve avere fondazioni etiche” (Virtù sovrana) e che esso deve far sua non un’etica dell’impatto, bensì un’etica della sfida. Per l’etica dell’impatto, il valore di una vita buona consiste in ciò che essa produce, ossia nelle sue conseguenze per il resto del mondo (così ammiriamo Mozart per le Nozze di Figaro, Fleming per la scoperta della penicillina, ecc); per l’etica della sfida, una vita buona dal suo valore intrinseco, a tal punto che gli eventi, le realizzazioni e le esperienze possono avere un valore etico anche quando non producono alcun impatto al di fuori della vita in cui hanno luogo. Tentando di salvaguardare libertà, eguaglianza e comunità, Dworkin ha sostenuto il primato etico della comunità sulla vita individuale, adombrando la necessità di armonizzare due ideali etici che, in apparenza, fanno a pugni: l’ideale dei progetti e delle appartenenze personali, il quale domina la nostra vita privata e riguarda la responsabilità che crediamo di avere per le persone che, in qualche modo, ci sono vicine; e l’ideale dell’eguale considerazione politica dell’altro, che domina la nostra vita politica e che ha a che fare con un’eguale considerazione per tutti gli uomini. Nelle società in cui l’ingiustizia è sostanziale, secondo Dworkin gli individui che sono attratti da entrambi gli ideali si trovano in un lacerante stato di dilemma etico che li porta necessariamente a sacrificare, con le loro scelte, uno dei due ideali a favore dell’altro: in tal modo, quale che sia la scelta effettuata, è indelebilmente pregiudicato il successo della loro vita. Al contrario, nelle società giuste, ossia in quelle società caratterizzate da un’equa distribuzione delle risorse, è possibile conciliare entrambi gli ideali, cosicché diventa possibile per gli individui aver successo nella vita.
BRANI ANTOLOGICI
Il diritto di morire
Se sia nel migliore interesse di ciascuno che la vita si concluda in un modo anziché in un altro dipende in modo così stretto da quant’altro di speciale c’è in lui (dallo stile e dal carattere della vita, dal suo senso dell’integrità e dagli interessi critici) che nessuna decisione collettiva uniforme potrà mai sperare di promuovere così adeguatamente gli interessi di una persona. Abbiamo così anche una ragione fondata sulla beneficenza, oltre alla ragione fondata sull’autonomia, perché lo Stato non imponga alcuna uniforme concezione generale attraverso la sovranità della legge, ma piuttosto incoraggi le persone a dare esse stesse disposizioni meglio che possono per la loro assistenza futura, e perché in assenza di queste disposizioni, la legge, nei limiti del possibile, lasci la decisione nelle mani dei loro familiari o di altre persone intime, il cui senso del loro migliore interesse è probabilmente molto più corretto di un giudizio teorico e astratto concepito nelle stanze segrete, tra manovre di interesse e transazioni politiche.
(Ronald Dworkin, ll dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, trad. it. di C. Bagnoli, Edizioni di Comunità, Milano, 1994, pp.294-295)
Limitazioni leggittime e illeggittime della libertà
La maggior parte delle leggi che diminuiscono la mia libertà, vengono giustificate per motivi utilitaristi, per essere state emanate in funzione dell’interesse generale o per il benessere generale; se, come Bentham suppone, ciascuna di queste leggi diminuisce la mia libertà, nondimeno non sottraggono nulla di quanto io ho diritto ad avere. Ciò non vuol dire, nel caso della strada a senso unico, che, nonostante io abbia il diritto di guidare nel senso opposto in Lexington Avenue, nondimeno lo stato, per speciali ragioni, è giustificato se mi toglie quel diritto. Questo mi sembra sciocco, perché lo stato non ha bisogno di speciali giustificazioni, ma solo di una giustificazione, per questo tipo di leggi. Così si può avere un diritto politico di libertà, ma tale che ogni limitazione diminuisce o infrange quel diritto, ma solo in un significato talmente debole, che il diritto di libertà non è affatto in concorrenza con diritti forti come il diritto all’uguaglianza. Se invece pensiamo ad un significato forte di diritto, in conflitto con il diritto all’uguaglianza, allora non esiste affatto un generale diritto di libertà.
(Ronald Dworkin, I diritti presi sul serio, trad. it. di F. Oriana, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 319-322)
SCHILLEBEECKX

Nato nel 1914, il teologo olandese Edward Schillebeeckx studia a Lovanio, a Le Saulchoir e alla Sorbona: dapprima diviene docente nello Studentato teologico di Lovanio, poi alla facoltà teologica dell’Università cattolica di Nimega. All’interno della sua riflessione filosofica, si possono ravvisare due periodi ben distinti: nel primo periodo (1946-1967) Schillebeeckx fa proprio una sorta di “tomismo aperto”, caratterizzato dall’assunzione di un metodo storico in grado di ricostruire l’evoluzione storica delle affermazioni dogmatiche. Rientrano in questo primo periodo interessanti studi di teologia sacramentarla, come l’importante opera Cristo, sacramento dell’incontro dell’uomo con Dio (1958). Il secondo periodo (legato al post-Concilio) si apre con una ricca raccolta di conferenze pubblicata nel 1968 e intitolata Dio, il futuro dell’uomo: quest’opera segna una vera e propria svolta giacché Schillebeeckx, desiderando instaurare un dialogo coi pensatori contemporanei, si confronta con le tesi dell’ermeneutica e le utilizza egli stesso. Schillebeeckx si muove infatti nella convinzione che nella teologia cattolica sia assente una chiara dottrina ermeneutica che consenta di superare definitivamente le diverse posizioni inerenti all’evoluzione del dogma cristiano. La domanda su come si debba interpretare e attualizzare il messaggio cristiano, essendo la precomprensione moderna assai differente da quella dei tempi in cui il testo biblico venne composto, deve essere seguita da interrogativi ancora più profondi, che sorgono dalla consapevolezza che tutta la Bibbia è il prodotto di un processo ermeneutico. Pertanto i testi rimandano a una duplice sfera di esperienza: da una parte, a una storia vissuta, interpretata e fissata letterariamente; dall’altra parte, rimandano all’esperienza di chi legge e interpreta alla comunità di appartenenza. In questa prospettiva, si pone il problema della secolarizzazione, che crea dilemmi di intelligibilità dei testi biblici composti in realtà culturali assai differenti fra loro. Schillebeeckx è convinto che anche nell’era della secolarizzazione affiori la radicale problematicità dell’esistere e la domanda sul senso ultimo della realtà e della vita. Le diverse antropologie sono in ogni caso impegnate nella difesa dell’essere umano minacciato sotto vari aspetti: in esse è possibile scorgere una precomprensione universale che induce il credente a non identificare il suo messaggio con una particolare visione del mondo, ma a offrire una risposta di tipo indiretto (nell’ambito della prassi) alle domande capitali circa il vivere. A motivo della loro fede, i cristiani sono chiamati a impegnarsi contro la disumanizzazione e l’alienazione con un atteggiamento di solidarietà basato sulla promessa di Dio di una liberazione definitiva e finale dalla morte, consapevoli del fatto che il futuro escatologico ha comunque il carattere della gratuità e del dono divino. Quest’ultimo aspetto mette in luce come ogni realizzazione e ogni conquista cozzino contro un limite. Schillebeeckx ha inoltre composto una ricca serie di scritti nei quali affronta il tema cristologico cercando di risalire dai testi alle esperienze che li hanno originati, e in particolare alla comprensione di Gesù dei primi cristiani e al nucleo più originario della fede. Tra queste importanti opere, meritano di essere menzionate Gesù, la storia di un vivente (1974), Cristo, la storia di una nuova prassi (1977), La questione cristologica. Un bilancio (1978). Tratto comune di questi scritti è l’esposizione di una cristologia di tipo narrativo in cui si delineano due diversi livelli interpretativi: il primo è contrassegnato dall’attribuzione di titoli funzionali (ad esempio “Cristo-Messia”) ed esprime una teo-logìa di Gesù che può essere sintetizzata nell’idea che in Lui sia donata la salvezza piena da parte di Dio. Nel secondo livello interpretativo, viene tematizzata la personalità stessa di Gesù, interrogandosi sulla Sua realtà ontologica e avviando in tal maniera la storia dei dogmi. Quest’ultima è inevitabilmente connessa ad un orizzonte di comprensione storicamente condizionato: perciò, essa deve essere aperta a nuove espressioni e a nuove sintesi, in relazione alle diverse epoche e ai problemi che le contraddistinguono. A caratterizzare la produzione di Schillebeeckx è una prospettiva ecumenica, con la quale egli sottolinea come Dio agisca in tutta la storia e in tutta l’umanità e non soltanto nelle tradizioni bibliche (ebraica e cristiana). Le religioni e le Chiese debbono allora essere comprese nell’ordine dei segni, coma sacramenti di salvezza. In questa cornice così vasta, si colloca la storia di Gesù come espressione della divina volontà salvifica universale. La prassi credente nella storia anticipa la realtà finale di pienezza di vita che è biblicamente sintetizzata nella categoria del Regno. Per Schillebeeckx, non si può concepire, in questa prospettiva, una situazione eterna di infelicità o di dannazione, giacché il compimento escatologico è il definitivo trionfo del Bene sul Male.
HELMUTH PLESSNER

INTRODUZIONE
Helmuth Plessner (Wiesbaden 4/9/1892 – Gottinga 12/6/1985) è, con Scheler e con Gehlen, uno dei fondatori dell’antropologia filosofica contemporanea. Tra le sue opere più importanti, meritano di essere ricordate I gradi dell’organico e l’uomo (1928), Potere e natura umana (1931), La nazione in ritardo (1935), La questione della condizione umana (1961). Secondo Plessner, se si vuole comprendere l’uomo (ed è questo l’obiettivo dell’antropologia filosofica), non si devono più porre come criteri né l’antitesi tra filosofia e vita né tanto meno quella tra anima e corpo (tematizzata nel modo più chiaro da Cartesio). Proprio per questo motivo, l’antropologia di Plessner non si interessa di sostanze o di princìpi dal valore assoluto; essa si occupa piuttosto di strutture, con la conseguenza che l’animale, l’albero e l’uomo sono studiati non più come essenze, ma in relazione con l’ambiente circostante. E il rapporto tra l’organismo e l’ambiente è, per l’appunto, ciò su cui si fonda l’antropologia di Plessner. Sicché l’uomo, lungi dall’essere una realtà distaccata dalla natura e dai vari gradi dell’organico che lo precedono nella scala evolutiva e lungi dall’esprimere un’opposizione tra spirito e vita (come credeva Max Scheler), è costituito sia dal fisico sia dallo spirituale. Con l’uomo, la sfera della vita ha compiuto una vera e propria svolta radicale, raggiungendo il più alto livello di consapevolezza possibile. L’identità umana è particolarmente complessa e si riconosce sia nel suo essere-corpo sia nel suo essere-nel-corpo: ciò significa che l’io si riconosce appieno sia nella sua sfera fisica sia in quella psichica. In forza della sua “posizionalità eccentrica”, l’uomo può rapportarsi tanto alla dimensione corporea quanto a quella spirituale, tanto al mondo esterno quanto a quello interno. In altri termini, l’uomo ha se stesso ed è se stesso: può intendere il suo corpo (Körper) come un qualsivoglia altro oggetto e analizzarne in tal modo l’estensione e il peso; oppure può identificarsi col suo corpo (Leib), concepito come il cuore delle proprie sensazioni, azioni, emozioni. È un corpo vivente che ha un corpo inanimato: a differenza dell’animale, che è un corpo di cui diventa consapevole a seconda delle situazioni che di volta in volta vive, l’uomo non è solo un corpo, ma ha anche un corpo. Per l’uomo, trovarsi in una posizione eccentrica significa decentrarsi, smarrire la propria centralità rispetto alle cose e alle persone circostanti, fino a divenire anch’esso cosa tra le cose del mondo. È soltanto distanziandosi da sé (“ponendosi alle proprie spalle”, dice Plessner) che l’uomo può vedere se stesso e la propria situazione nel cosmo, quel centro provvisorio che occupa e da cui poi si decentra. A questa distanza da sé, a questo non coincidere mai con se stessi, la tradizione ha dato il nome di “coscienza”, la quale è dunque sinonimo di lacerazione. L’eccentricità ha originato un’insanabile frattura, la quale resta anche dopo che sia stata compiuta l’autoriflessione e che si sia raggiunta la coscienza. La necessità di essere un corpo in senso somato-psichico e, insieme, la necessità di avere un corpo in senso materiale portano infatti ad una frattura all’interno della vita umana: l’uomo è per l’appunto tale frattura, il centro dell’ininterrotta mediazione tra l’esterno e l’interno. Proprio in questa instabile posizione, egli deve condurre la propria esistenza, cercando una pur paradossale unità. Dalla riflessione di Plessner affiora dunque un’immagine dell’uomo assai particolare, caratterizzata da una naturale disposizione dell’io a non opporsi alla sua condizione antropologica fondamentale, che lo qualifica come incessante processualità. È da qui che affiora la condizione umana di perenne inquietudine, di incertezza e di insicurezza, una condizione che caratterizza soprattutto l’uomo del XX secolo.
I GRADI DELL’ORGANICO E L’UOMO
Plessner intende sviluppare una fenomenologia del vivente che, avvalendosi di un unico principio, possa render conto della specificità che caratterizza i diversi gradi della vita nel mondo organico e, soprattutto, la tipicità della natura umana. Nel 1928, l’anno in cui vede la luce La posizione dell’uomo nel cosmo di Max Scheler, esce anche I gradi dell’organico e l’uomo (Die Stufen des Organischen und der Mensch) di Plessner: in quest’opera, egli propone la teoria dei modali organici, detta anche “teoria aprioristica dei caratteri organici essenziali”; con tale teoria, egli opera una deduzione (in senso kantiano) delle categorie e dei princìpi a priori dai quali dipendono le caratteristiche della vita in generale e di quella dell’uomo in particolare. Al cuore di questa teoria è il principio della posizionalità, da cui si deduce la differenziazione (a livello sia ontologico sia conoscitivo) da un lato tra realtà organica e inorganica, e dall’altro tra mondo animale e mondo umano. Plessner può così stabilire una differenziazione “posizionale” tra i tre diversi regni della natura (vegetale, animale, umano), attribuendo a tale differenziazione non solo un valore di classificazione, bensì intendendola come un vero e proprio principio costitutivo della natura stessa, dalla quale traggono origine i diversi livelli organici. La gradualità con cui questi livelli si succedono si basa sulla coesione interna del vivente, sulla capacità di rapportarsi col mondo esterno e sull’autonomia interiore del proprio io. Per questa via, si istituisce un’autentica scala posizionale, caratterizzata da una gerarchia sistematica per cui al vertice sta l’uomo. Il primo livello di questa scala del livello organico è dato dal vegetale, contrassegnato da una forma aperta in cui l’albero si trova ad essere immediatamente inserito. Sicché l’organismo vegetale si trova inglobato nell’area di cui fa parte senza potersene distinguere, ma restando necessariamente legato al ciclo vitale cui appartiene. Si ha dunque, in tal caso, un rapporto soltanto assimilatorio con l’ambiente favorevole allo sviluppo, senza alcuna possibilità di distaccarsene per far affiorare la sua individualità. Nel mondo vegetale manca dunque la capacità di distinguere tra mondo esterno e mondo interno, che risultano unificati nell’esigenza di sopravvivenza, proprio in forza del fatto che manca un organo centrale, un sé che conferisca consapevolezza al soggetto. Mancando di un organo centrale, l’albero è non già un individuum, bensì un dividuum: è inoltre incapace di muoversi in senso proprio; tutt’al più può compiere movimenti impercettibili e involontari (tende verso la luce, verso l’acqua, ecc). Infine la forma aperta dell’albero non perviene mai al proprio completamento, ma si trova in un mutamento incessante: dalla nascita alla morte, continua a crescere, ad allungarsi, giacché la sua caratteristica è un’intrinseca incompiutezza. Nel regno animale la forma aperta si tramuta in forma chiusa. Ci troviamo dinanzi ad un nuovo livello vitale in cui l’interazione è mediata da una struttura centrale determinante l’attiva immissione dell’animale nel suo habitat; viene meno quella circolarità indisturbata che caratterizzava il ciclo biologico delle piante. L’animale è un organismo autonomo che reagisce all’ambiente secondo i propri impulsi, istinti, sensazioni: esso dunque agisce direttamente sull’ambiente. L’animale è pertanto un vivente equipaggiato di coscienza, poiché è capace di distinguersi dall’ambiente e di opporsi ad esso. Ma la sua è una coscienza limitata, perché non è consapevole di quel che fa: l’animale ha un suo corpo, ha un ambiente che conosce e su cui agisce, ma non sa di averli. Proprio in ciò risiede l’insuperabile limite dell’animale. Plessner tratteggia il livello animale ricorrendo alla metafora della “centricità”: l’animale occupa una posizione nello spazio che altro non è se non il suo centro. In tale centro, l’animale avverte gli stimoli che provengono dall’esterno e da questo centro mette in moto le sue risposte. Plessner sostiene che “l’animale vive a muovere dal centro e a ritornare nel suo centro […], ma non vive come centro”, non ha riflessività, è posto nel suo corpo vivente e si muove a partir dal centro dato da questo corpo, ma senza avere coscienza di ciò che fa. L’organismo centrale dell’animale non è ancora un io: pur sapendo conoscere e agire, l’animale non ne ha coscienza. Al livello più alto della scala sta l’umano, che costituisce il più compiuto grado della legge posizionale: al pari dell’animale, anche l’umano rientra nella forma chiusa; ma a differenza dell’animale “si pone alle proprie spalle”, riuscendo cioè a distanziarsi da sé e a raggiungere l’autocoscienza, che è il più alto punto di riflessività di tutto il sistema vivente. Solo nell’umano è raggiunta la riflessività totale: l’uomo, prendendo le distanze da sé, riesce a porre fine al dominio incontrastato della centralità. In virtù di ciò, l’uomo supera la necessità biologica a cui restava ancorato l’animale (il quale vive al centro del proprio ambiente naturale e non può mai uscirne perché non ha coscienza). Grazie all’autoriflessione, all’uomo è dato trascendere il centro biologico della propria vita, conquistando una posizione eccentrica. Caratteristico dell’uomo è poi il presentarsi in una pluralità di forme, per cui “è corpo, nel corpo (come vita interiore o psichica) e fuori dal corpo, come punto di vista dal quale esso è entrambi. Un individuo che ha questa triplice caratteristica posizionale si chiama ‘persona’”. Se con l’animale si passa dal dividuum (tipico del vegetale) all’individuum (che è la singolarità garantita dal centro), con l’uomo e con la sua eccentricità si passa dall’individuo alla persona. Quest’ultima è la perfetta realizzazione dell’eccentricità, il più perfetto modo dell’uomo di essere se stesso e di riflettere su di sé, raggiungendo l’autocoscienza.
LE TRE LEGGI ANTROPOLOGICHE
Come può l’uomo assumere un’adeguata posizione all’interno della sua vita? Su quali basi deve fondare il proprio agire? A costituire un ostacolo al modo di vivere umano è l’opposizione conflittuale tra eccentricità e vitalità. Esponendo le tre leggi antropologiche fondamentali, Plessner intende mettere in luce come l’uomo costruisca la sua vita nel distacco originario dall’immediatezza mediata. La prima è la legge dell’artificialità naturale, per cui l’uomo non vive in contatto immediato con l’ambiente, ma ha bisogno di ricorrere a cose artificiali. Se l’animale esiste semplicemente senza conoscersi e senza riflettere sull’ambiente di cui è parte, l’uomo ha smarrito la naturalezza e deve tramutare il mondo naturale in mondo artificiale, trovandosi in una situazione di disagio e di instabilità costante. Si vede costretto a produrre strumenti (utensili, abitazioni, vestiti) per vivere nella natura. L’uomo trova nell’artificialità del mondo della cultura la sua seconda terra di nascita e può in tal maniera infrangere tutti i limiti che lo vincolano ad un’esistenza soltanto naturale: se vuole sopravvivere, deve agire e deve farlo in modo intelligente, superando le carenze che la natura gli ha imposto (“l’uomo è un animale carente”). Proprio perché sa far ricorso a mezzi naturali (e con essi raggiunge un equilibrio che la sola natura mai gli avrebbe concesso), l’uomo è il più alto livello del processo vitale. La seconda è la legge dell’immediatezza mediata, per cui l’uomo vive al contempo come organismo animale nell’immediatezza della natura e come essere eccentrico nella mediazione culturale. Nel comportamento umano sussiste una costante correlazione tra gli aspetti a priori e quelli a posteriori: la produttività umana e la capacità di dar vita a ciò che prima era inesistente richiedono sempre una trasformazione del naturale. Si parte dalla natura immediata e la si tramuta in una creazione artificiale. Dall’immediatezza dell’esigenza di potenziare la forza umana si è passati all’artificiosa mediazione del martello, inventato appunto per potenziare la forza della mano. La terza è la legge del luogo utopico, per cui l’uomo, in quanto essere eccentrico, si trova sempre proiettato al di là di tutto ciò che gli si presenta dinanzi: rinunciando ad ogni stabilità, egli non ha patria, non può contare su una propria casa nel mondo. È da ricercarsi qui la scaturigine dell’insicurezza umana e dell’inquietudine: allontanandosi dall’immediatezza del puro dato, l’uomo sperimenta se stesso e il mondo come nullità; proprio per ciò avverte l’esigenza di ricercare un fondamento assoluto. E poiché all’eccentricità non corrisponde alcuna precisa posizione, l’uomo non può mai sapere in quale luogo stia la verità. Sicché la nozione di essere e di nulla, la causa dell’esistenza individuale e del mondo, mutano senza sosta nel corso della storia a seconda delle diverse culture e religioni che si succedono. L’uomo è diviso tra un mondo interno e uno esterno: egli si trova dietro e sopra la sua vita e sperimenta il suo essere e quello del mondo come elementi contingenti e del tutto deboli. L’eccentricità della sua forma di vita, il suo non esser mai da nessuna parte (il luogo utopico per l’appunto), dischiudono all’uomo le più svariate possibilità, che spaziano da un pessimismo nichilistico a un’apertura verso Dio.
IL COMPORTAMENTO DELL’UOMO
Essere nel mondo significa per l’uomo dirigere la propria vita: egli è esposto agli stimoli dell’ambiente esterno e, di fronte ad essi, deve selezionare le risposte comportamentali adeguate. Perché ciò possa accadere, l’uomo deve architettarsi un ambiente artificiale, un cosmo culturale equipaggiato di complessi strumenti con cui esprimersi e relazionarsi agli altri. Ciò non di meno, l’uomo mantiene sempre uno stretto rapporto con l’organicità naturale, alla quale resta ancorato. In questo senso, l’espressione, che pure dimostra un forte rapporto corporeo, mette in luce la presenza di un qualcosa che non è di per sé corporeo, ma che piuttosto sembra appartenere a un grado di interiorità psichica e mentale. Le sue estrinsecazioni appaiono non soltanto in forza della mediazione corporale: esprimono anche una componente concettuale. Il punto di partenza per Plessner ora non è più la differenza tra l’umano e il resto del vivente: è piuttosto il mondo dei comportamenti. Il nuovo percorso della riflessione plessneriana procederà dunque dalla sfera delle espressioni corporee fino alla più alta sfera dell’interiorità. Ed è quel che egli fa nello scritto Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano. In questa indagine, Plessner si trova ad approfondire comportamenti espressivi umani come il linguaggio, il gesto, il pianto e il riso, senza più curarsi degli elementi a priori su cui si fonda il carattere eccentrico dell’uomo. La corporeità e le sue attestazioni sono un’inesauribile fonte di conoscenza dell’uomo: non si può infatti separare la persona dal suo corpo, proprio perché essa è un’inscindibile unità psico-fisica. Comportamenti come l’espressione, la gestualità, il linguaggio, il riso e il pianto sono altrettanti prodotti derivanti dall’interazione fra l’uomo e l’ambiente, cosicché la loro unica spiegazione è di tipo meccanicistico. Plessner rigetta la soluzione darwiniana per cui ogni atto espressivo deriverebbe da un’eccitazione nel sistema nervoso e sarebbe riconducibile ad una ripetizione di comportamenti diventati abituali poiché selezionati come utili alla sopravvivenza della specie. Nella manifestazione mimica dell’ira, ad esempio, si mostra un’espressione della bocca che mette in evidenza i denti canini: questa smorfia è per Darwin ormai inutile in termini filogenetici, ma serviva (come difesa o come mezzo di minaccia) alle scimmie antropoidi (da cui deriva l’uomo). Una siffatta spiegazione è, agli occhi di Plessner, semplicistica e riduttiva, poiché egli si propone di interpretare il comportamento umano come uno specchio dell’essenza dell’uomo, alla luce del fatto che “il comportamento è la dimensione in cui l’uomo esprime se stesso e dalla quale è lecito partire per comprenderlo adeguatamente […] è la tipica manifestazione di un essere che è per natura in rapporto col mondo”. La capacità espressiva umana si manifesta particolarmente in due ambiti: il linguaggio e la gestualità. Il primo costituisce il simbolo dell’essenza umana che realizza per suo tramite la possibilità di tratteggiare ciò che al momento non è presente e di riattualizzarlo grazie al ragionamento. Più di ogni altra forma espressiva, il linguaggio definisce la specificità dell’uomo, consistente nella sua capacità di operare astrazioni concettuali e di comunicare in maniera articolata. A differenza dell’uomo, l’animale non ha il linguaggio giacché non è interessato alle informazioni che vanno al di là dell’immediata necessità. Permettendo la creazione di un mondo di concetti (grazie ai quali diventa possibile non smarrirsi in quel babelico eccesso di stimoli inviati senza sosta dal mondo circostante), il linguaggio aiuta l’uomo ad orientarsi e, insieme, a distaccarsi dal mondo, rendendo possibile l’acquisizione dell’umana posizione eccentrica. L’espressione mimica rappresenta, insieme al linguaggio, uno dei mezzi di cui l’uomo si serve per trasmettere ad altri i suoi stati d’animo: in essa il contenuto psichico e la forma fisica si comportano come i due poli di un unico insieme, che non può essere diviso senza demolire la sua vitalità naturale. L’aspetto del volto è un’immagine avente una trasparenza spirituale e un’adamantina capacità simbolica: e, per quanto sia possibile ingannare gli altri controllando la propria espressione mimica e la propria gestualità per mascherare il nostro aspetto interiore, sussiste comunque una specifica modalità dell’espressione corporea che non si può sostituire in alcun caso.
IL PIANTO E IL RISO
Secondo Plessner, l’uomo si caratterizza non solo per la sua capacità di esprimersi col linguaggio, di compiere procedimenti astrattivi e razionalizzanti, ma anche per la sua capacità di piangere (Weinen) e di ridere (Lachen). Sono espressioni emotive tipiche soltanto dell’essere umano: ma se fossero solo manifestazioni affettive, moti espressivi emozionali, allora dovrebbero essere presenti allo stesso modo negli animali. Ne segue che il pianto e il riso non sono soltanto forme emotive: per coglierne la natura, occorre indagare sul rapporto che l’uomo ha con se stesso e, soprattutto, col suo corpo. Quando si scoppia a piangere o a ridere, avviene una vera e propria frattura nell’equilibrio psico-fisico dell’uomo: questi perde il controllo di sé e non riesce più ad esprimersi come fa abitualmente, ad affrontare di petto l’ondata emotiva che lo travolge. Entra in questo modo in crisi l’unità della persona ed emerge un comportamento disgregato e di rottura: in esso, i processi corporei si emancipano e l’individuo perde il controllo sull’aspetto fisico del suo esistere. L’esistere gli sfugge di mano e lo obbliga a reazioni insospettate. Nello scoppio del riso e del pianto, l’uomo si sente improvvisamente spossessato: è come se smarrisse il rapporto con la dimensione fisica dell’esistenza, la quale sfugge al suo comando e scivola in una reazione incontrollabile. Sicché le condizioni essenziali del riso e del pianto sono la reazione “repentina” ed “eruttiva” verso un evento minaccioso a cui non si può rispondere. Tanto nel pianto quanto nel riso, si infrange l’equilibrio tra fisico e psichico, tra corpo e mente, con un’improvvisa perdita di autodominio; ma nell’esplosione fulminea del riso si interrompe il rapporto tra l’io e il suo corpo, lasciando a quest’ultimo la completa libertà di replicare. Invece, nel graduale abbandono al pianto, è l’uomo stesso a rinunciare a tale rapporto, lasciandosi trascinare dall’emotività. Sia nel riso sia nel pianto, è messa in luce la natura composita dell’uomo, il quale si presenta nella dialettica duplicità dell’essere un corpo e dell’avere un corpo. In questa duplicità, che richiede un’ininterrotta mediazione, consiste il rischio e, insieme, l’unicità dell’umana esistenza.
ROSA LUXEMBURG

A cura di Simona Verchiani e di Diego Fusaro
“La dialettica storica si compiace per l’appunto di contraddizioni e pone nel mondo per ogni necessità anche il suo contrario. Il dominio di classe borghese è indubbiamente una necessità storica, ma pure la sollevazione della classe lavoratrice contro di esso; il capitale è una necessità storica, ma anche il suo becchino, il proletariato socialista; il dominio mondiale dell’imperialismo è una necessità storica, ma anche la sua caduta per opera dell’internazionale proletaria” (La crisi della Socialdemocrazia).
All’interno della Socialdemocrazia tedesca, si vennero a formare diversi schieramenti che si proponevano obiettivi differenti e, non di rado, contrastanti: la polacca Rosa Luxemburg (1870-1919) si collocò sulla linea estremista e rivoluzionaria, rivelandosi ostile sia al revisionismo di Bernstein sia all’ortodossia di Kautsky. Rosa Luxemburg nacque in Polonia nel 1871, anno della Comune di Parigi. Nel corso della sua breve vita, conobbe tre grandi rivoluzioni e prese parte ai più importanti dibattiti tra i socialisti internazionali. Questi non avevano un modello di rivoluzione socialista di successo ma erano alle prese con il problema dei lavoratori e del come essi avrebbero dovuto lottare e prendere coscienza del bisogno di cambiamento della società. Rosa fu marxista, creativa e ragionevole, pronta a difendere le idee di Marx ed Engels ma predisposta a svilupparle, se necessario. Fu coinvolta in politiche rivoluzionarie quando frequentava ancora la scuola in Polonia. All’età di 18 anni, una repressione di Stato la forzò all’esilio presso Zurigo. Quando si trasferì in Germania, nel 1898, si era già affermata tra i socialisti internazionali come pensatrice marxista. Si attivò all’interno del partito socialdemocratico tedesco, il più grande partito a favore della classe operaia del mondo. Schieratasi fermamente nel 1914 contro l’adesione della Socialdemocrazia alla guerra, abbandonò il partito, giudicandolo ormai un “cadavere maleodorante”; e nel 1915 fondò insieme a Karl Liebknecht la Lega di Spartaco, un movimento collocato sull’estrema Sinistra e che prendeva il nome da quello Spartaco che aveva condotto la rivolta degli schiavi a Roma e che tanto caro era a Marx stesso. Proprio la Lega di Spartaco, dopo il conflitto, promuoverà la fondazione del Partito comunista tedesco. Quando nel 1919 partecipò all’insurrezione operaia, la Luxemburg fu brutalmente massacrata dai soldati inviati dal governo socialdemocratico a soffocare tale insurrezione. Mentre veniva condotta in carcere, il suo cranio fu sfondato a colpi di calcio di fucile e il suo corpo fu gettato in un fiume, per poi ricomparire parecchio tempo dopo. Al cuore della riflessione della Luxemburg sta il problema di come stia evolvendo il capitalismo nella cornice della nuova epoca, caratterizzata dall’imperialismo più sfrenato, dalla politica coloniale condotta ferocemente dalle potenze europee, dalla sempre più forte tendenza alla formazione di monopoli. Questi tratti peculiari del capitalismo novecentesco, già colti da Rudolf Hilferding in Il capitale finanziario (1910), portano la Luxemburg a trarre le seguenti conclusioni, nell’opera L’accumulazione del capitale (1913): la crisi definitiva del capitalismo, che lo porterà inevitabilmente al crollo, è da lei ravvisata nella formazione del monopolio nella fase più matura del capitalismo. Tale fase è rappresentata dall’imperialismo, che s’impadronisce gradatamente di sempre nuove aree di mercato nei paesi che ancora non conoscono lo sviluppo capitalistico. Questa dinamica, però, determina al tempo stesso il limite di sviluppo del capitalismo, che a un certo punto si trova privo di possibilità di espansione del mercato: in questa situazione diventa non possibile, ma necessario il crollo del capitalismo di fronte alla rivoluzione proletaria. La transizione dal regime capitalistico al socialismo non può secondo la Luxemburg avvenire mediante il dibattito parlamentare (come invece credeva Bernstein), ma soltanto per via rivoluzionaria, mediante la sollevazione spontanea delle masse e non attraverso la guida dall’alto di un partito. Proprio per questa ragione, nel 1917, la Luxemburg saluterà dapprima con grande entusiasmo la Rivoluzione Russa per la sua spontaneità, ma ben presto ne condannerà gli sviluppi dittatoriali, già embrionalmente presenti nel fatto che essa era stata guidata dall’alto da un partito e non dal basse delle masse spontaneamente organizzate. Nell’attenta analisi della Luxemburg, viene dato molto peso al militarismo: esso ha svolto, da sempre, un ruolo decisivo nello sviluppo del capitalismo, rendendo possibile la conquista manu militari di interi continenti e la proletarizzazione degli indigeni; il militarismo ha poi giocato un ruolo decisivo come arma della lotta di concorrenza fra paesi capitalistici per il controllo di aree non ancora capitalisticizzate. Il militarismo è dunque il più fruttuoso alleato del capitalismo. Sicché, secondo la Luxemburg, è la guerra (come esito necessario del capitalismo), ancor più delle crisi economiche, a rendere necessaria la rivoluzione. Il marxismo della Luxemburg si pone in netta rottura tanto con quello di Kautsky quanto con quello di Bernstein: contro Kautsky, ella rifiuta l’idea dell’inevitabilità del socialismo, il quale è a suo avviso una possibilità all’interno della storia; e però accetta l’idea dell’inevitabilità del crollo del capitalismo, crollo determinato dalle motivazioni poc’anzi esaminate: quando il capitalismo sarà (e lo sarà necessariamente) crollato, si potrà scegliere tra l’alternativa del socialismo o quella dell’anarchia, intesa negativamente come degenerazione. L’alternativa si configura allora come “socialismo o barbarie”, secondo un’espressione cara alla Luxemburg. Ella è altrettanto risoluta nel rigettare le tesi di Bernstein: il socialismo, lungi dall’essere una possibilità soggettiva o un’idea in senso kantiano, è una necessità storica anche se non “destinale”. Ciò significa che nella storia non c’è nulla di fatale, ma neanche nulla di arbitrario. Proprio per questo motivo, è necessaria una lotta quotidiana del proletariato per favorire il crollo del sistema capitalistico. In una ricca serie di articoli raccolta sotto il titolo Riforma sociale o rivoluzione? (1989) ella si propone di distruggere le teorie di Bernstein: l’errore commesso dal padre del revisionismo sta nell’aver rifiutato la dialettica come base del marxismo, precludendosi la possibilità di comprendere la totalità del processo storico e le contraddizioni che in esso si annidano. Vittima della stessa analisi atomistica della società compiuta dai borghesi, Bernstein non ha saputo vedere come, al di là delle congiunturali e non decisive contraddizioni che lo caratterizzano, il capitalismo rechi entro di sé l’insanabile contraddizione tra una sempre maggiore produttività e una sempre minore capacità di smerciare i prodotti. Riforma sociale o rivoluzione?, se letto in trasparenza, costituisce anche un’agguerrita polemica contro la posizione ortodossa di Kautsky: questi è accusato di considerare il rapporto tra le riforme e la rivoluzione in maniera estrinseca e meccanica, con la conseguenza inaccettabile che la mèta finale del socialismo resta slegata dall’operare quotidiano della classe operaia. Nel determinismo kautskyano, il vero obiettivo del socialismo resta indeterminato e proiettato in un futuro troppo lontano: la conclusione di ciò è che gli operai non agiranno per far cadere il capitalismo. Sicché, paradossalmente, per Kautsky non meno che per Bernstein vale il motto “lo scopo finale è nulla, il movimento è tutto”. La Luxemburg si trova (seppur solo provvisoriamente) d’accordo con Lenin nel propugnare la versione rivoluzionaria e dialettica del marxismo: come abbiamo detto, quando la Rivoluzione Russa si capovolgerà in dittatura sul proletariato, ella dissentirà dal rivoluzionario russo. Ma ella si era già schierata apertamente contro Lenin allorché ne aveva aspramente criticato l’opera Che fare?. Contro le tesi di Lenin, ella aveva sostenuto che nessun comitato centrale del partito è in grado di supplire all’assenza o all’immaturità di un movimento operaio sviluppato. Perché ci possa essere una rivoluzione, ci vuole un movimento operaio ben organizzato: non basta (come s’illudeva Lenin) un ben organizzato partito fatto di pochi intellettuali. La Luxemburg fa sempre e di nuovo leva sulla spontaneità del movimento operaio, dalla cui iniziativa dipende la rivoluzione. Dopo lo scoppio della rivoluzione del 1905 in Russia, ella sostenne a più riprese che si trattava di far sviluppare il più possibile i soviet, da lei intesi come espressioni di una più alta forma di democrazia rispetto a quella borghese. Nello scritto La rivoluzione russa (1918), composto in carcere, la Luxemburg conduce una sferzante requisitoria contro il leninismo, accusandolo di essersi presto capovolto in una dittatura e di aver erroneamente inteso come reciprocamente elidentisi democrazia e dittatura: si tratta invece di coniugare queste due componenti, dando vita ad una dittatura di classe caratterizzata dalla massima partecipazione delle masse popolari in una “democrazia senza limiti”.
KARL KORSCH

“Qual è il rapporto che intercorre tra il marxismo e la filosofia fintantoché questo complesso processo storico non ha ancora raggiunto il suo obiettivo finale, la soppressione della filosofia?” (Marxismo e filosofia)
VITA E OPERE
Nato da genitori borghesi nelle vicinanze di Lüneburg nel 1886, Karl Korsch si iscrive all’università e intraprende gli studi di giurisprudenza, di economia, di sociologia e di filosofia: tra il 1912 e il 1914, va in Inghilterra e là stringe rapporti con la Fabian Society. Finita la Prima Guerra Mondiale, Korsch milita nel Partito Socialdemocratico tedesco indipendente: ma ben presto se ne allontana per aderire, nel 1920, al Partito Comunista Tedesco. Tra il 1924 e il 1928, Korsch è deputato del Reichstag e assume un atteggiamento altamente critico nei confronti tanto del Partito Comunista Tedesco quanto del Comintern: di conseguenza è espulso dal Partito nel 1926 e “scomunicato” dall’Internazionale Comunista, che accusa di “revisionismo idealistico” la sua celebre opera Marxismo e filosofia. Emarginato dall’azione politica e impossibilitato a praticare un’opposizione al movimento comunista ufficiale, Korsch si ritaglia un piccolo spazio nel quale intrattiene rapporti con piccoli gruppi operai ultraradicali e con intellettuali marxisti (tra cui Bertolt Brecht). Abbandonata la Germania quando in questa si affermò il Nazismo, Korsch si trasferisce dapprima in Inghilterra e in Danimarca, successivamente negli USA, dove resta fino alla morte, avvenuta nel 1961. Tra gli scritti principali di Korsch, ricordiamo Marxismo e filosofia (1923), Il materialismo storico antiKautsky (1929), la riedizione di Marxismo e filosofia (1930), cui fa seguito una serratissima critica del leninismo; va poi ricordato Karl Marx (1938), uno dei tanti saggi che costellano la sua produzione tra il 1931 e il 1939, caratterizzata dall’audace tentativo di sottoporre il marxismo ad una revisione teorica tale da portarlo all’altezza del nuovo tempo, in cui proliferano incontrastati i totalitarismi, risorge il capitalismo, pare tramontata la possibilità di una rivoluzione operaia. Tra questi scritti, ricordiamo Crisi del marxismo (1931).
IL PENSIERO
Al cuore di Marxismo e filosofia sta il recupero del pensiero di Hegel in una prospettiva strettamente marxiana e la ripresa del concetto di totalità. Tanto Hegel quanto Marx hanno voluto costruire (il primo nell’età della borghesia rivoluzionaria, il secondo ai tempi della borghesia conservatrice) una teoria della società borghese incentrata sul nesso dialettico di pensiero e realtà, di teoria e prassi sociale. Sia la teoria sia il suo oggetto (la società borghese) sono pertanto concepiti come concreta totalità dialettica, che non accetta di essere disarticolata nelle sue singole parti: e queste parti sono la prassi sociale (“l’aspro regno delle lotte reali”) e la sovrastruttura ideologica data soprattutto dalla filosofia. Così sia Hegel sia Marx (o, meglio, il marxismo, che è espressione teorica del movimento operaio) considerano la “rivoluzione nella forma del pensiero” come una componente reale dell’effettivo processo sociale rivoluzionario. E in termini hegeliano-marxisti il sorgere della teoria marxista è solo l’altra faccia del sorgere del reale movimento operaio, cosicché, solo se presi insieme, essi formano la totalità concreta del processo storico. Nasce di qui la grande e ineludibile problematica che dà il titolo all’opera di Korsch: qual è il rapporto tra marxismo e filosofia? Marx ed Engels, con la loro formulazione del materialismo storico, avevano sostenuto che, con la rivoluzione, la filosofia sarebbe scomparsa insieme a tutte le altre espressioni della società borghese (compreso lo Stato). Ma se si tiene presente che il processo storico rivoluzionario, dopo i clamorosi fallimenti del 1848, è apparso non imminente, ma anzi destinato a dover attendere ancora per molto tempo, allora non ci si può sottrarre alla domanda circa il rapporto tra marxismo e filosofia fintanto che il processo storico rivoluzionario non ha ancora spazzato via la filosofia. Finché la filosofia resta in piedi, quale deve essere il suo rapporto col marxismo? Questo problema capitale è stato ignorato dal marxismo “volgare” della seconda metà dell’Ottocento, che ha commesso il grande errore di pensare che tali questioni teoriche fossero irrilevanti per la prassi. Questa deleteria separazione tra prassi e teoria, tipica del marxismo ottocentesco, è sempre e di nuovo criticata da Korsch, il quale giunge a ridicolizzare i marxisti dell’Ottocento asserendo che essi, rivoluzionari nella prassi, potevano tranquillamente essere seguaci della teoria di Schopenhauer. E quando i marxisti dell’età della Seconda Internazionale si sono spinti nelle regioni della filosofia, l’hanno fatto in maniera altrettanto volgare, scegliendo come ancella del marxismo le filosofie borghesi di Kant o di Mach, riconfermando l’assurda tesi per cui il marxismo sarebbe privo di contenuto filosofico. Questa gravissima perdita del nesso prassi-teoria, realtà-coscienza, è avvenuto per una pletora di motivi: innanzitutto perché, dopo i disastri del 1848, erano crollate le prospettive rivoluzionarie; ma anche (e soprattutto) perché si era perso di vista il nucleo dialettico, di marca hegeliana, del materialismo storico elaborato da Marx. E, perso di vista tale nucleo, si era di conseguenza perso di vista anche il concetto di totalità, indebitamente sostituito dal prevalere delle interpretazioni economicistiche che hanno surrettiziamente ridotto l’azione della classe a mera trasformazione di strutture economiche. La conseguenza da ciò scaturita era la separazione di teoria e prassi, separazione giunta al culmine con la riflessione di Rudolf Hilferding nel Capitale finanziario secondo cui non si potrebbero identificare marxismo e socialismo perché si sarebbe potuto utilizzare il primo contro il secondo. Le stesse posizioni riformistiche, opponendosi al rapporto rivoluzionario tra Stato e marxismo delineato da Marx, erano scaturite tutte in forza di questa indebita separazione di teoria e prassi. A partire dal XX secolo tuttavia, in virtù del mutato contesto storico e dell’affermarsi di un movimento rivoluzionario destinato a trionfare in Russia, il problema del rapporto tra marxismo e filosofia esce dall’oblio e torna all’ordine del giorno, come è attestato dai dibattiti rivoluzionari di Lenin o della Luxemburg. Torna cioè ad affacciarsi l’istanza originaria fatta valere da Marx e da Engels secondo la quale la lotta alla società borghese necessita del momento della critica teorica in vista della soppressione anche delle manifestazioni ideologiche della società. Korsch, profondamente convinto della necessità di una storicizzazione del marxismo, si sofferma sull’analisi dei momenti in cui si è sviluppato l’atteggiamento di Marx e di Engels nei confronti del rapporto tra realtà sociale e forme di coscienza (o ideologie), a cominciare proprio dalla filosofia. La prima forma in cui si è sviluppato il marxismo è, secondo la puntuale analisi di Korsch, quella degli anni precedenti il ’48: di questa forma, il Manifesto del partito comunista è l’espressione migliore. Essa è caratterizzata dal rigetto della filosofia borghese e della filosofia in quanto tale, come recita l’undicesima delle Tesi su Feuerbach. Ma, nonostante il dichiarato rifiuto della filosofia, questa prima forma del marxismo è fortemente filosofica, e si pone come teoria dello sviluppo sociale visto come totalità vivente, o, più precisamente, della rivoluzione sociale intesa e applicata come totalità vivente. Dopo il 1848, si assiste ad una seconda forma del marxismo: dopo tale data, infatti, la teoria marxista ha necessariamente dovuto modificare la sua forma, anche in forza del periodo storico non rivoluzionario in cui si è trovata ad esistere: l’espressione più tipica di questa seconda fase è il Capitale, opera in cui il marxismo trapassa in socialismo scientifico, con l’importante conseguenza che i singoli elementi (economia, politica, ideologia, prassi sociale, ecc), da congiunti che erano, si sono disgiunti e autonomizzati gli uni rispetto agli altri. Insistendo nel differenziare gli elementi costitutivi della totalità, questa seconda forma del marxismo ha forse contribuito – nota Korsch – all’indebita operazione compiuta dai successivi marxisti dell’Ottocento, i quali hanno frantumato in disjecta membra la teoria unitaria della rivoluzione sociale. Ed è a questo punto che si sviluppa la risposta korschiana alla questione del rapporto tra marxismo e filosofia. Sopprimere la filosofia non significa certo, per Marx ed Engels, metterla da parte: infatti, come i due non si stancarono mai di ripetere, non si può sopprimere la filosofia senza realizzarla. Sicché anche per il Marx maturo, teorico del socialismo scientifico, resta vero che di quella totalità che è la società borghese fanno parte anche le ideologie più alte, quali l’arte, la religione e la filosofia: la conseguenza è che il processo rivoluzionario non potrà mai spazzarle via. Il saggio sul Il materialismo storico antiKautsky, si configura come una sferzante requisitoria (peraltro già sullo sfondo di Marxismo e filosofia) condotta contro il marxismo di Kautsky: a lui Korsch muove l’accusa di aver ridotto il marxismo a mera dottrina scientifica, sciolta dalla dialettica hegeliana e da ogni nesso immediato con la prassi sociale del proletariato. È sì vero che Marx ed Engels ravvisano nella storia della natura il necessario presupposto su cui poggia lo sviluppo della struttura economica della società: ma essi escludono tassativamente che tale sviluppo sia interpretabile secondo il modello dei processi naturali. L’altra accusa che Korsch muove a Kautsky è di aver fornito un’interpretazione idealistica dello Stato, intendendolo come la più alta realizzazione della storia. In ciò, Kautsky è rimasto prigioniero di una visione borghese e idealistica dello sviluppo storico, tale per cui l’apparizione dello Stato moderno segnerebbe il punto d’approdo della Modernità. Assunto nella sua attuale forma democratico-borghese come sub specie aeternitatis, lo Stato è da Kautsky inteso come l’autentica realizzazione del processo storico. L’intento di Korsch era quello di colpire con la sua critica anche il marxismo trionfante della Terza Internazionale e il pensiero di Lenin, di cui scorgeva la diretta prosecuzione nel Diamat e nell’incipiente fenomeno dello stalinismo. Non a caso, appena a un anno dalla pubblicazione del Il materialismo storico antiKautsky, Korsch fece uscire la riedizione di Marxismo e filosofia con l’aggiunta di un saggio significativamente intitolato Lo stato attuale del problema ‘marxismo e filosofia’ (Anticritica). In questo saggio, egli individua una totale convergenza tra le critiche mosse al suo libro tanto dalla Socialdemocrazia quanto dal marxismo-leninismo. Ma la Socialdemocrazia e il marxismo-leninismo non sono che metamorfosi del marxismo in vuota ideologia, giacché avanzano l’assurda pretesa di inserirsi dall’esterno nel movimento operaio, di pilotarne dall’alto la prassi: la Socialdemocrazia esaurisce la dimensione politica nella cornice dello Stato borghese, e il marxismo-leninismo instaura la dittatura del partito sulla classe, mettendo in luce una spiccata tendenza giacobina e autoritaria. È questa la premessa teorica che per Korsch ha permesso al leninismo e allo stalinismo di nascondere, dietro la vernice ideologica del socialismo, la realtà di un capitalismo di Stato oppressivo e iperburocratico. In particolare, Korsch sottopone a dura critica i principali nodi teorici della teoria di Lenin, accusata di non essere adeguata all’attuale fase di sviluppo: la teoria leniniana della conoscenza intesa come mero rispecchiamento e riproduzione passiva non è che una banale riproposizione di un realismo meccanicistico ed ingenuo prekantiano, che ignora la relazione dialettica tra essere e coscienza. Tale teoria del rispecchiamento è peraltro consona al giacobinismo politico di Lenin, giacché include il riconoscimento dell’assoluta oggettività e necessità delle leggi che presiedono allo sviluppo sociale e che, sfuggendo alla coscienza immediata dei proletari, sono colte solo dal partito. Dal 1931 inizia un periodo particolarmente travagliato per la filosofia di Korsch, che prende le mosse dal riconoscimento della crisi che caratterizza il marxismo e dalla speranza di un recupero del movimento rivoluzionario. Nella monografia del 1938 su Karl Marx, Korsch apporta novità decisive al suo modo d’intendere sia il rapporto Hegel-Marx sia la teoria marxiana nel suo insieme. In quell’opera, Korsch rileva che l’eredità di Hegel in Marx va soprattutto ricercata nel contenuto delle analisi dedicate alla società civile, le cui contraddizioni erano state colte da Hegel. Marx si sarebbe però distaccato dal suo maestro ideale rifiutando la prospettiva di conciliazione fatta valere dall’Aufhebung hegeliano. Proprio grazie a tale rottura con l’hegelismo, Marx avrebbe potuto congedarsi dalla filosofia per approdare alla scienza e al socialismo scientifico. Diversamente da quel che aveva fatto in Marxismo e filosofia, in Karl Marx Korsch non distingue più tra il Marx “rivoluzionario” del Manifesto e il Marx “scienziato” del Capitale: tende invece a scorgere una continuità nell’operato del filosofo di Treviri. Prova ne è il fatto che quella che negli scritti filosofici era stata denominata (con un’espressione mutuata da Feuerbach) “autoestraniazione” dell’uomo, nel Capitale è chiamata “feticismo delle merci”, senza però che vari la sostanza. La vera novità introdotta dal Capitale sta piuttosto nell’aver adottato un metodo critico intorno al modo di produzione del capitalismo moderno: un metodo che, col suo rigore scientifico, intende rispettare la specificità delle forme proprie della società borghese. Connesso a questo principio di “specificazione” è il principio di “mutamento”, per cui la società borghese è concepita come una fase di passaggio verso qualcosa di più alto, e non come se le sue leggi fossero naturali e inviolabili. Sicché tale teoria della società capitalistica è necessariamente una teoria della rivoluzione proletaria. Questo è il vero cuore del marxismo, da distinguere dalle degenerazioni successive che – a partire da Engels stesso – hanno voluto fare del marxismo una teoria generale di ogni società o, peggio ancora, una filosofia totalizzante e onnicomprensiva. Sicché, come Korsch rileva anche in Crisi del marxismo, è possibile individuare una vera e propria frattura all’interno del marxismo: dapprima esso è nato come fenomeno storico dalla lotta rivoluzionaria della prima metà del XIX secolo, e poi (dalla seconda metà del XIX secolo) si è tragicamente capovolto in ideologia rivoluzionaria al servizio di un movimento operaio che non era più rivoluzionario. Ma Korsch, fatta questa diagnosi poco lusinghiera, apre spiragli di speranza verso il futuro, sostenendo che la teoria della rivoluzione proletaria del futuro sarà una prosecuzione storica del marxismo e che si porrà come un recupero, nei limiti del possibile, dell’originaria teoria rivoluzionaria formulata da Marx ed Engels nella prima metà del XIX secolo. Ma in questo modo Korsch si trova dinanzi ad un’aporia difficilmente risolvibile: come può il marxismo rispecchiare concettualmente una rivoluzione che non è ancora avvenuta? Non si deve forse riconoscere che il marxismo potrà esistere nella sua forma compiuta soltanto quando la rivoluzione proletaria sarà stata ultimata? E che pertanto il marxismo di Marx è insospettatamente rispecchiamento della rivoluzione capitalistica e borghese? O, meglio, della rivoluzione proletaria quale emersa dalla rivoluzione borghese? Korsch è pienamente consapevole di questa aporia, e a tal proposito parla, nel saggio su Hegel e la rivoluzione (raccolto in Dialettica e scienza nel marxismo), di “trasferimento”, con l’idea che quella creata da Marx sia una “teoria della rivoluzione proletaria non come si è sviluppata sui suoi propri fondamenti, bensì come è emersa dalla rivoluzione borghese”. La conseguenza di tale “trasferimento” è che la teoria marxiana porta con sé i segni del giacobinismo originario della rivoluzione borghese: sicché il giacobinismo non è un carattere specifico del leninismo (come Korsch aveva sostenuto in precedenza), ma è un tratto peculiare della teoria marxiana dalla seconda metà del XIX secolo in avanti. Pur avendo riconosciuto la grave crisi in cui versa il marxismo, Korsch non se ne allontana mai: tutt’al più, ne è allontanato ad opera dei vari partiti che non accettano nuove forme di marxismo eterodosso. E negli scritti degli anni ’30 e ’40, ormai emarginato, Korsch continua a farsi depositario del marxismo come movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, restituendo ad esso il suo statuto scientifico, antidogmatico e improntato alla prassi rivoluzionaria.
JÜRGEN MOLTMANN

“L’escatologia è la dottrina della speranza cristiana, che abbraccia tanto la cosa sperata quanto l’atto dello sperare. Il cristianesimo è escatologia dal principio alla fine, e non soltanto in appendice: è speranza, è orientamento e movimento in avanti e perciò è anche rivoluzionamento e trasformazione del presente. L’elemento escatologico non è una delle componenti del cristianesimo, ma è in senso assoluto il tramite della fede cristiana, è la nota su cui si accorda tutto il resto, è l’aurora dell’atteso nuovo giorno che colora ogni cosa con la sua luce” (Teologia della speranza).
Jürgen Moltmann nasce nel 1926 ad Amburgo: prigioniero di guerra in Gran Bretagna, inizia là i suoi studi di teologia, che terminerà a Gottinga nel 1956 con una tesi sulla teologia degli ugonotti. Divenuto libero docente nel 1957 con un lavoro sul calvinismo, Moltmann tiene lezione in parecchie università, tra le quali quella di Bonn e di Tubinga. Ad affascinarlo e ad avviarlo alla riflessione filosofica è soprattutto la lettura de Il principio speranza di Ernst Bloch: l’opera blochiana lo induce a domandarsi con insistenza perché alla fede cristiana sia sfuggito il tema della speranza, che è in realtà il suo tema principale. Riflettendo su questi argomenti, Moltmann compone nel 1963 un saggio su Il principio speranza e la fiducia cristiana: in questo scritto, esaminando le tesi di Bloch, egli mette in luce come l’intero impianto della filosofia blochiana tenda al futuro e, in forza di ciò, si proponga di recuperare gli elementi di speranza racchiusi nel passato. Il marxismo, nell’ottica blochiana, non è altro che la docta spes che recupera e rende superiori (conferendo ad esse la veste scientifica del materialismo storico) le speranze del passato, dalla preistoria ad oggi. Ma la pur pregevolissima filosofia di Bloch fa naufragio di fronte ad alcuni aspetti del cristianesimo, carichi di speranza, ma di una speranza ultramondana che non può in alcun caso essere ricondotta all’ipermondana riconquista dell’armonia dell’uomo vagheggiata da Bloch. Questi fondava la speranza su basi oggettive, mostrando come la realtà stessa, nelle sue strutture profonde di possibilità (strutture colte da Avicenna più che da ogni altro filosofo), è speranza: in ciò si risolve la blochiana ontologia del non-ancora-divenuto. L’uomo, in quanto non ancora compiuto, vive affacciato sul futuro: la sua piena realizzazione ancora non c’è stata, sicché per ora l’uomo è un homo absconditus, la cui vera realtà ha ancora da emergere. Ma questa speranza tutta intramondana, secondo Moltmann, non è assolutamente in grado di fronteggiare la morte: di fronte ad essa, la speranza va in frantumi. Solo la speranza cristiana, ponendo l’accento su una realtà ultramondana e trascendente, può vincere la morte: sicché non il marxismo (come credeva Bloch), bensì il cristianesimo, con la sua speranza in Dio, dev’essere considerato come la “dotta speranza” che eredita quelle del passato e che tiene viva, fra gli oppressi, la prospettiva di un futuro di giustizia. Il frutto di queste riflessioni su Bloch è la Teologia della speranza, del 1964: quest’opera segna una vera e propria svolta nel panorama teologico di quegli anni, ponendosi come alternativa alle posizioni di Barth e di Bultmann. In Teologia della speranza, Moltmann interpreta l’intera rivelazione cristiana alla luce del “principio speranza”, muovendo dalla constatazione che l’essenza del cristianesimo sia la sua escatologia, la quale dev’essere dunque intesa come il cuore del Nuovo Testamento. A questo proposito, Moltmann analizza una dopo l’altra le grandi interpretazioni dell’escatologia prospettate da teologi e filosofi: in particolare, egli rigetta la tesi kantiana per cui la dimensione escatologica altro non sarebbe se non la condizione di possibilità dell’esistenza etica. Da rifiutare è anche la lettura data da Karl Barth e incentrata sulla nozione greca di epifania (che, facendo della rivelazione una manifestazione dell’eterno nel tempo, nega la speranza in un futuro che deve ancora giungere). Lo stesso Bultmann sbaglia a far leva esclusivamente sulle speranze del singolo. In opposizione a queste interpretazioni, Moltmann mette in luce come l’Antico Testamento tratteggi la religiosità di Israele come rivolta al futuro e costellata da una serie di promesse divine sviluppate su di una terra che – ottenuta, perduta, riconquistata – è la base su cui poggiano attese più grandi, quali l’instaurarsi della pace e della giustizia. La stessa predicazione profetica e la letteratura apocalittica non fanno altro che radicalizzare e universalizzare le promesse, prospettando un futuro che riguarda non solo Israele, ma l’intera umanità. Il Nuovo Testamento deve essere letto in continuità con l’Antico Testamento, come un ampliarsi su scala universale e storica di tutte le promesse e le speranze: la stessa resurrezione di Gesù è l’evento che avvalora le speranze antiche e che ne fa nascere di nuove; è un evento storico non perché descrivibile con le categorie della scienza storica, ma piuttosto perché reale possibilità di eventi futuri. Moltmann nota come l’annuncio della resurrezione di Cristo abbia senso soltanto se incastonato nell’orizzonte biblico delle promesse e in quello moderno dell’utopia. La riflessione teologica deve dunque essere sviluppata nell’ottica della speranza messianica e della resurrezione, senza nulla concedere alla “teologia naturale” o alle prove razionalistiche dell’esistenza di Dio. Il cristianesimo deve poi rivolgersi non solo all’interiorità del singolo, ma alla storia tutta. In questa prospettiva di speranza, Moltmann analizza il gioco (nell’opera Sul gioco): se nella società moderna esso si inquadra nell’attività produttiva (condividendone il carattere alienante) e riveste una funzione distensiva, nella sua reale essenza, che dev’essere recuperata, il gioco ha potenzialità liberatrici e sovversive, tutte tese verso il futuro. Lo stesso cristianesimo, secondo Moltmann, deve porsi come il gioco, in maniera altamente estetica e liberatrice, foriera di gioia e di gaudio. Ciò non toglie, però, che l’evento cardinale del cristianesimo, la croce di Cristo, non sia sottoponibile, nella sua assoluta specificità, alle categorie estetiche del gioco. Nel saggio Uomo, Moltmann fa un’accurata indagine sulle diverse antropologie, a partire da quelle biologiche che leggono l’uomo a partire dalla sua “animalità”, per poi passare a quelle culturali e religiose, che leggono l’uomo in chiave religiosa e spirituale. Solo l’antropologia cristiana si confronta direttamente col dolore, negando tutte le pretese umane di autodivinizzazione. In un mondo dilacerato da accadimenti tragici come Auschwitz o Hiroshima, la coscienza utopica può resistere solo poggiando sulla vicenda cristica: è solo seguendo il percorso di Cristo, scegliendo l’amore anziché la violenza, credendo in una futura vittoria sulla morte, che si può evitare di precipitare nella disperazione o nell’inerzia. Elaborando la sua “teologia della croce” come teoria critico/liberatrice, Moltmann ha degli interlocutori privilegiati, dalla Scuola di Francoforte e Benjamin alla psicanalisi, fino alla teologia di Metz. Nel 1972 appare Dio crocifisso, un’opera che segna una svolta nel pensiero moltmanniano: nella prima parte dello scritto, egli critica tutte le forme alienanti di culto della croce, quali ad esempio gli atteggiamenti “doloristici”, quelli esaltanti il sacrificio e quelli mistici. Se considerata in maniera storica e precisa, la croce è, di per sé, irreligiosa, poiché appare come uno strumento di tortura e di oppressione, come il trionfo del non-Dio e della non-giustizia. Essa acquista senso solo se letta in senso escatologico e, insieme, storico. Bisogna interrogarsi sulle causae crucis, giacché da esse affiora un duplice conflitto teologico e politico. Cristo è condannato come ribelle e riottoso sovversivo e, insieme, come bestemmiatore per la sua opposizione all’interpretazione dominante della legge ebraica. In Cristo risorto è racchiuso e anticipato il futuro dell’umanità: e Cristo non è altro che un oppresso, un essere ingiustamente condannato dagli uomini e salvato da Dio. La vicenda cristica è l’emblema di questa teologia della speranza per cui, guardando alle vicende di Cristo, tutti quanti possiamo sperare in una salvezza futura e attuantesi non in questo mondo, bensì nell’alto dei Cieli. Opponendosi alle teologie apatiche, per cui Dio è unità inscindibilmente perfetta e non soggetta a patimenti, Moltmann elabora una teologia altamente patetica, per cui ampio spazio è concesso al soffrire di Dio per l’umanità. In questa prospettiva, Moltmann interpreta anche la risposta dell’uomo che, guardando al soffrire divino, si sforza di vivere nella fede e nella speranza, combattendo contro le diverse forme di alienazione e oppressione (autoritarismo, violazione dei diritti, distruzione dell’ambiente naturale). L’impegno per la pace e l’attenzione ai temi dell’ecologia caratterizzano la riflessione successiva di Moltmann, che nei saggi La giustizia crea il futuro (1989) e Lo Spirito della vita (1991) mette in evidenza i fondamenti della missione di riconciliazione dei credenti. La Chiesa nasce dall’agire giustificante e pacificatore di Dio, per mezzo di Cristo, nei confronti di uomini che erano privi di giustizia e di pace. Se Dio non ci fosse, ci si potrebbe accontentare dello status quo, dell’ingiustizia e della violenza; ma poiché Dio esiste ed è giusto, non ci si può accontentare, ma si deve vivere nella speranza. Moltmann individua tre diversi ambiti in cui adoperarsi per costruire una giustizia che fondi la pace: il primo ambito ha a che fare con le persone e con le loro relazioni; si tratta, dice Moltmann, di ridefinire il lavoro, ripartire equamente le possibilità lavorative ed economiche. Il secondo ambito riguarda invece i rapporti tra le diverse generazioni, e il terzo i rapporti tra l’umanità e l’ambiente. In altri termini, è necessario superare l’egoismo della presente generazione che sta sperperando senza criterio le risorse disponibili e generando un inquinamento insostenibile per la natura.
GEORGES DUBY

Georges Duby (1919-1996) è stato uno dei più grandi storici del Medioevo. Ha insegnato per oltre vent’anni Storia delle società medievali al Collège de France.
Con Michelle Perrot, è autore di Immagini delle donne e ha diretto i cinque volumi della Storia delle donne in Occidente. Con Philippe Ariès ha curato i volumi della Vita privata. E’ stato uno dei principali promotori del rinnovamento metodologico della disciplina storica che faceva capo all’Ecole des Annales, concentrandosi in particolare sulla dimensione antropologica della ricerca storica. Fondamentali sono i suoi studi sulla mentalità e sulla vita quotidiana del Medioevo, tra i quali Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti, guerrieri e lavoratori (1978) e Storia della vita privata (1985-1987).
METODOLOGIA DELLA STORIA
Il sogno romantico di una restituzione integrale del passato e il senso della storia
Per Duby il sogno di una ricostruzione integrale del passato è del tutto superato e questa idea si sarebbe rivelata assolutamente impossibile. Da almeno quarant’anni gli storici, i filosofi che riflettono sulla storia hanno stabilito con assoluta certezza che essa non era altro che un’illusione romantica. Infatti Duby ritiene che si possa scorgere soltanto una piccola parte del passato ed è forse illusorio anche credere di poter pervenire alla verità, di poter cogliere i genuini atteggiamenti degli uomini di altri tempi. D’accordo con Fernand Braudel sostiene che lo storico sia il contrario del futurologo: guarda verso il passato, tenta di comprendere il passato, e ci riesce appena. Per esperienza si rende conto che tutte le previsioni che si possono fare in base ai dati storici, risultano false, tutte le curve di estrapolazione che si possono tracciare per prevedere il futuro entrano in contraddizione con ciò che succede veramente. Lo storico non è un indovino, non ha lezioni da dare, non può aiutare la gente a prevedere il futuro. Appartenendo alla generazione che ha vissuto il crollo delle utopie rifiuta l’idea di un senso della storia poiché si tratta di un movimento che gli uomini non possono dominare perfettamente, che li trascina e di cui sono anche un po’ vittime. Gli storici non hanno più, come i loro predecessori del XIX e dell’inizio del XX secolo, lezioni da dare, non hanno, in quanto storici, delle consegne di azione politica da proporre alla luce del passato. Tuttavia la storia, rimane una disciplina di primaria importanza, perché è una scuola di lucidità. La critica storica libera la testimonianza da tutto ciò che la deforma e la ingombra e permette di avere gli occhi aperti sulla realtà: la realtà sociale, la realtà politica, la realtà intellettuale. La storia in particolare spesso permette di riprendere coraggio e fiducia di fronte agli eventi, perché insegna che anche le crisi più gravi possono essere superate.
Gli storici, cosiddetti realisti
La storia è tra le scienze umane quella che ha costruito l’armatura del suo metodo prima delle altre, nel secolo XVII, quando ci si è accorti che bisognava trattare in un certo modo le fonti documentarie, cioè raccogliere tutte quelle disponibili, non modificare le loro rispettive posizioni, criticarle una per una e sottoporle a verifica per tentare di liberare l’indizio, la testimonianza da tutte le scorie che la ricoprono e la mascherano. C’è un metodo di analisi della veracità del segno che è estremamente importante e che ci impegna a impiegare tutti i procedimenti tecnici elaborati recentemente sia per leggere il manoscritto, sia per stabilire la data di un reperto archeologico. Una volta fatta questa critica bisogna usare le testimonianze allo scopo di ricostituire un racconto. A questo proposito i filosofi, e in particolare il grande filosofo francese Paul Ricoeur, hanno stabilito che ogni discorso storico è fondato su una struttura narrativa, su un racconto, su un intreccio, e che anche quando si tratta di descrivere l’evoluzione dei prezzi durante il XIX secolo, o la natura delle pratiche religiose a un certo momento della storia, i prezzi o la devozione agiscono come personaggi in un racconto romanzesco. Bisogna dunque ricostruirlo con grande discrezione.
Lo storico è necessariamente obbligato a fare appello alla propria immaginazione, perché le testimonianze di cui dispone sono discontinue, intervallate da vaste lacune, da vuoti, e questi vuoti bisogna colmarli e non si possono colmare che mediante l’immaginazione. Ma l’immaginazione deve essere strettamente controllata dalla ragione e da una critica e da un’autocritica che lo storico deve continuamente esercitare su se stesso per difendersi dalle divagazioni nelle quali la sua immaginazione, se non fosse vincolata, lo trascinerebbe.
Il ruolo delle scienze umane, in particolare la sociologia, l’antropologia e la psicoanalisi nel metodo storico
Una delle lezioni più importanti della Scuola storica francese, le Annales, è che gli specialisti in scienze umane dovrebbero lavorare tutti in comune, dovrebbero formare una comunità di ricerca e prestarsi vicendevole aiuto. Lo storico per fare il suo lavoro è obbligato evidentemente a tener conto di tutte le innovazioni che vengono dal campo delle scienze umane e ormai anche dalle scienze naturali. Ma la cosa più importante per lo storico non è, a mio avviso, la psicologia né la psicoanalisi. È molto difficile ricostruire quello che gli uomini del passato avevano in mente. E, del resto, ogni psicoanalisi è una analisi individuale: non c’è un inconscio collettivo, e, di conseguenza, l’inconscio individuale degli uomini del passato è praticamente inaccessibile. E allora, quali sono le scienze ausiliarie più utili alla storia? Innanzi tutto l’economia, evidentemente, poiché, alla base dell’evoluzione delle società umane, c’è una trasformazione delle condizioni materiali di vita, cioè delle condizioni di produzione e di distribuzione della ricchezza. L’economia, dunque, propone delle riflessioni; ma, nella pratica, bisogna sapersi guardare da ciò che c’è di troppo teorico nelle proposizioni degli economisti. Lo storico deve portare avanti il suo lavoro in modo pragmatico e non legarsi a modelli precostituiti. I modelli li costruirà dopo, ma nella sua ricerca procede affrontando direttamente i documenti. Certo,l’economia ha avuto certo una parte importante, soprattutto negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta del XX secolo. Oggi, il suo ruolo non è più tanto importante, se non in alcuni settori storiografici di limitato interesse. Al contrario, la geografia e l’antropologia sono per Duby le due scienze umane fondamentali. La geografia, perché evidentemente l’uomo è inseparabile dal suo ambiente e bisogna ricollocarlo continuamente, non solo nel suo tempo, ma nello spazio che occupava. Quello spazio deve essere analizzato con cura. Anche l’antropologia ha un ruolo importante poiché comprende tutto quello che i ricercatori mettono in evidenza in società lontane da noi o in ciò che resta in Occidente della società tradizionale, a proposito del ruolo che hanno le strutture di parentela, la famiglia, le ideologie nei comportamenti umani. Sono tutte cose che hanno una importanza fondamentale. Duby ha spesso dichiarato il debito che ha contratto, in primo luogo, verso i geografi – ha cominciato con gli studi di geografia ed è arrivato alla storia attraverso la geografia; e, in secondo luogo, verso gli antropologi: Lévi-Strauss e tutti i suoi discepoli, che hanno lavorato sulle società africane o sulle società dell’Oceano Pacifico. Le loro ricerche sono state utili per la funzione della moneta nella società del Medioevo o i rapporti che intercorrevano tra gli uomini e le donne nella stessa epoca.
Il ruolo per la moderna storiografia del marxismo e della scuola marxista nelle moderna storiografia
Duby è largamente debitore verso il pensiero di Marx per la riflessione. I lavori di Marx meritano attenzione, in special modo per i periodi che Marx conosceva meglio, che aveva approfondito, come il XVIII e il XIX secolo. È evidente che, per i periodi più antichi, né Marx né Engels erano in grado di riflettere in modo utile, fecondo, perché i dati forniti dagli storici erano insufficienti per impostare correttamente i problemi. Ma per il XVIII e il XIX secolo è evidente che il pensiero marxista è stato un fermento di vitalità molto importante della ricerca storica. Il marxismo, come ausilio nel porre domande autentiche intorno al passato, non è morto, come si dice. È possibile che sarà ancora per molto un punto di riferimento utile nella problematica storica, per costruire la nostra problematica.
Il metodo storico può salvare dal rischio della manipolazione della memoria, e dunque del passato
La storia è sempre stata uno strumento politico. Sempre, in tutti i tempi, gli storici, certi storici almeno, sono stati al servizio del potere. Con la nascita delle grandi potenze la storia, a poco a poco, è arrivata a costituirsi come genere letterario. E gli uomini, che detenevano il potere, hanno sempre cercato nella storia delle giustificazioni e il mezzo per trascinare il popolo con l’esempio del passato e con il miraggio di utopie le cui radici affondavano nel passato. Questa situazione non è cambiata: c’è sempre una manipolazione del ricordo, della memoria storica, con la conseguenza di arrivare a dei controsensi, rispetto a ciò che insegnano le fonti.
Il nazionalismo, questo veleno che infettava l’Europa di Duby, e non solo l’Europa ma l’intero pianeta, poggia essenzialmente su una memoria manipolata. Perciò l’insegnamento della storia ha un ruolo molto importante nell’evoluzione dei metodi didattici. Per esempio, nella Terza Repubblica alla fine del XIX secolo, in Francia, l’insegnamento della storia è stato lo strumento fondamentale per introdurre nelle menti dei giovani, fin dalla scuola elementare, il sentimento nazionale: l’idea di appartenenza ad una comunità e dei doveri di fronte ad essa, e in particolare il dovere di partire, seguendo i loro fratelli maggiori, alla conquista dell’Alsazia e della Lorena. O, al contrario, per restare all’esempio della Francia, la storia è sembrata a volte sovversiva e così il regime totalitario francese, il regime di Vichy del maresciallo Pétain, ha fatto di tutto per ridurre l’insegnamento della storia o comunque non si insegnava più la storia del passato più recente. Ci si fermava prima e si autorizzava lo sguardo sul passato solo per i periodi più antichi, perché non si potessero acquisire elementi di riflessione sull’attuale abiezione del potere.
Dunque la storia è sempre stata manipolata. Il dovere degli storici è rettificare quelle manipolazioni. Se la storiografia ha un ruolo nella difesa della pace e della democrazia, deve puntare il dito sulle deformazioni, deve dire che le cose non stanno in un certo modo, deve controllare che i manuali scolastici siano veramente in accordo con la realtà.
STORIA SOCIALE E IDEOLOGIA DELLE SOCIETA’
Per comprendere l’organizzazione delle società umane e per riconoscere le forze che le fanno evolvere occorre prestare ugualmente attenzione ai fenomeni mentali,il cui intervento indiscutibilmente non è meno determinante di quello dei fenomeni economici e demografici. Gli uomini infatti regolano il loro comportamento in funzione non della loro reale condizione ma dell’immagine che se ne fanno e che non è mai il rispecchiamento fedele. Si sforzano di conformarla a modelli di comportamento che sono il prodotto di una cultura e che nel corso della storia si adattano alle diverse realtà materiali. Uno dei compiti principali delle scienze dell’uomo è quindi quello di misurare, in conseguenza di una totalità indissolubile di azioni reciproche, la rispettiva pressione delle condizioni economiche, e di in insieme di convenzioni e di precetti morali, dei divieti che essi pongono e degli ideali che propongono. Il contributo degli storici è decisivo; infatti i sistemi di valori che i procedimenti educativi trasmettono apparentemente senza cambiamento hanno un loro andamento e la loro storia. In questo campo si inserisce necessariamente lo studio delle ideologie; si intende per ideologia un sistema di rappresentazioni (immagini, miti,idee o concetti a seconda dei casi) dotato di un’ esistenza e di un ruolo storico in seno a una data società. Le modalità d’essere delle ideologie Globalizzanti: le ideologie appaiono come sistemi completi e globalizzanti dal momento in cui pretendono di dare una visione d’insieme della società, di dare una risposta a tutte le domande. In questo senso l’ideologia si ricollega a vasti sistemi di credenze (le cosmologie,le teologie..). basti pensare al sostrato ideologico cristiano dell’Europa medievale.
Rassicuranti e deformanti: per poter rassicurare l’ideologia deve sorvolare su alcune cose, deve far emergere certi aspetti della vita far tecere cio che mette in discussione l’ideologia stessa e la sua funzione rassicurante. Molteplici e concorrenti: E’ una conseguenza dell’ideologia globalizzante; le ideologie sono concorrenti perchè fra ideologie globalizzanti non ci può essere interscambio: l’ideologia cristiana non pùò essere in rapporto di interscambio con un’altra ideologia religiosa, fra etnie separate possono esserci gravi antagonismi.
4.Stabilizzatrici: le ideologie stabilizzano e integrano una società. Anche se un’ideologia può sembrare rivoluzionaria e utopica, coloro che la sostengono ritengono che l’ordine che essa possa stabilire sia definitivo. Rientrano in questa casistica anche i sistemi di rappresentazioni che mirano a conservare i privilegi acquisiti dai ceti dominanti. Non è detto che ci sia una condizione storica (nll’ideologia cristiana Dio è senza tempo). La paura del nuovo che rischia di far rompere gli equilibri raggiunti fa si che alcune società si rinchiudano in un “guscio di costumi” :il conservatorismo è appoggiato dai ceti dominanti che si mostrano ben disposti solo verso cambiamenti superficiali (l’estetica, la moda..) Un ceto dominante produce un certo tipo di cultura che non gli è controproducente; persino la cultura popolare è prodotta e diffusa da chi ha il potere, non è plausibile una cultura nata da chi non ha il potere. I modelli culturali prodotti dai ceti potenti si stabiliscono e si spostano progressivamente verso ceti più estesi e più umili, da essi affascinati e iniziano ad assimilarli. La cultura prodotta al vertice della gerarchia sociale si stabilisce.
Vista cosi, la storia delle ideologie è difficile da ricostruire, in quanto ai margini della società ci sono tutti quelli che non fanno parte del sistema produttivo e della produzione culturale. Inoltre le ideologie possono anche trasformarsi: ciò accade quando penetrano culture straniere ma anche quando devono necessariamente adattarsi alle situazioni storiche per essere più funzionali e per sopravvivere. A volte le ideologie cambiano perché la vita vissuta ha una certa forza; questa porta a far cambiare l’ideologia. Di alcuni sistemi ideologici addirittura non restano che poche tracce, fugaci e alterate. E’il caso delle ideologie popolari e di quelle sovversive e contestatrici: sono state perseguitate e represse e hanno lasciato vaghe tracce nella memoria, senza potersi esporre o espandersi. Ma persino l’ideologia dominante è di difficile accesso perché non ha testimonianze sicure, imparziali e complete. Lo storico delle ideologie deve analizzare ogni documento e ogni tipo di testimonianza e deve fare moltissima attenzione a cio’ che è stato taciuto. I silenzi della storia non significano assenza ma omissione, ma anche il significato delle omissioni deve essere messo in luce.
CHARLES LESLIE STEVENSON

Charles Leslie Stevenson (1908-1979), statunitense, occupa un posto particolare all’interno della “filosofia del linguaggio”: autore di uno scritto intitolato Etica e linguaggio (1944), per molti aspetti vicino alla corrente pragmatista e alla semiotica di Charles Morris, Stevenson intende gli enunciati etici (ossia quelli in cui si dice che qualcosa è buono o cattivo) come espressioni di approvazione o di disapprovazione verso qualcosa o verso qualcuno; e, nella misura in cui l’approvazione e la disapprovazione sono atteggiamenti emotivi, la teoria di Stevenson è stata battezzata emotivismo etico.
Del resto, la tradizione neopositivistica precedente alla Seconda Guerra mondiale aveva liquidato le proposizioni etiche come prive di significato, in quanto non riconducibili né a tautologie né a enunciati empirici: l’emblema di questa condanna è lo scritto Linguaggio, verità e logica di Ayer; e la conseguenza di tale condanna è che le proposizioni etiche non sono altro che espressioni di sentimenti o emozioni. Ed è da questi presupposti che prende le mosse l’emotivismo etico di Stevenson: egli in prima battuta distingue tra proposizioni empiriche e tautologie, da una parte, e proposizioni etiche, dall’altro; mentre le prime hanno un senso compiuto e hanno un significato descrittivo, che suscita atti cognitivi in chi le ascolta, le seconde (quelle etiche) hanno anch’esse un significato, e più precisamente un significato emotivo: esse cioè suscitano emozioni e sentimenti in chi le ascolta. Sicché le proposizioni etiche, pur mancando di descrittività, hanno, nella loro prescrittività, un ben preciso significato, che è un significato emotivo. Per chiarire questa distinzione, Stevenson ricorre ad un esempio piuttosto efficace: se dico “quest’uomo è un nero”, formulo una proposizione avente valore descrittivo e, di conseguenza, cognitivo (infatti tale proposizione mi dà informazioni sulla realtà che ho di fronte). Se invece dico “questo è un negro”, formulo una proposizione emotiva che, più che descrivere la realtà, suscita un sentimento negativo nell’ascoltatore. Quando poi formulo una proposizione del tipo “fai così, perché è un’azione buona”, sto in qualche modo fornendo elementi descrittivi, che però finiscono per essere riassorbiti nell’emotività: infatti, quando dico “fai così, perché è un’azione buona”, più che descriverti la realtà, voglio persuaderti ad agire in un modo che reputo positivo. Stevenson insiste molto sull’impossibilità di cogenza descrittiva degli asserti morali: rispetto ad Ayer, egli accentua il soggettivismo di tali asserti, aprendo le porte ad una possibile deriva relativistica (derivante dalla mancanza di un’oggettività degli asserti morali che mi permetta di definire universalmente che cosa è bene).
Connettendo tra loro etica ed emozioni, si ha poi l’impressione che Stevenson neghi qualsiasi componente razionale all’agire dell’uomo. Il fatto che egli riconosca un senso alle proposizioni etiche segna già un indubitabile distacco rispetto ad Ayer che, come s’è detto, nega ogni senso agli asserti morali per via della loro mancanza di descrittività.
ADOLF REINACH

Adolf Reinach (1883-1917) studiò presso l’Ostergymnasium di Magonza (dove sviluppò uno spiccato interesse per Platone) e, in seguito, entrò all’università di Monaco di Baviera nel 1901, dove studiò principalmente psicologia e filosofia con Theodor Lipps. Nel cerchio degli allievi di Lipps ebbe contatti con Moritz Geiger, Otto Selz, Aloys Fischer e soprattutto Johannes Daubert. Dal 1903-4 in poi fu sempre più coinvolto con le opere di Edmund Husserl, particolarmente le Ricerche Logiche. Nel 1904, Reinach ottenne il dottorato in filosofia sotto Lipps con il suo lavoro Über den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht (Sul concetto di causalità nella legge penale). Attorno al 1905, intendeva ancora proseguire gli studi a Monaco (dove nel frattempo aveva conosciuto Alexander Pfänder), per ottenere un diploma in legge, ma poi decise di andare a studiare con Husserl a Gottinga. In quel periodo anche altri allievi di Lipps (capitanati da Daubert) avevano deciso di abbandonare Monaco per Gottinga, ispirati dalle opere di Husserl. Successivamente, nel 1905, Reinach tornò a Monaco di Baviera per completare i suoi studi in legge e, nel 1906–1907, proseguì a Tubinga. Seguì parecchie lezioni e seminari su legge penale del teorico legale Ernst Beling, da cui fu molto impressionato e a cui deve moltissima ispirazione per le sue opere successive. Nell’estate del 1907 diede il Primo Esame di Stato in legge, ma poi andò a Gottinga per assistere alle discussioni nel circolo di Husserl. Con il sostegno di Husserl, Reinach fu in grado di ottenere l’abilitazione all’insegnamento a Gottinga nel 1909. Dalle sue lezioni e ricerche possiamo vedere che al tempo era influenzato anche da Anton Marty e Johannes Daubert, oltre che, ovviamente, da Husserl. A sua volta Reinach sembra aver ispirato parecchi altri giovani fenomenologi (come Wilhelm Schapp, Dietrich von Hildebrand, Alexandre Koyré e particolarmente Edith Stein) con le sue lezioni. Tra l’altro, teneva anche lezioni su Platone e Kant. In questo periodo Husserl iniziò una revisione completa della sua opera principale, le Ricerche Logiche, e richiese l’assistenza di Reinach in questa impresa. Inoltre, nel 1912 Reinach, assieme a Moritz Geiger e Alexander Pfänder, fondò il famoso Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung (Annuario per la filosofia e ricerche fenomenologiche), con Husserl come redattore principale. Oltre al suo lavoro nel campo della fenomenologia e filosofia in generale, Reinach è famoso soprattutto per lo sviluppo di una teoria degli “atti linguistici”. Il lavoro di Reinach si basò principalmente sulle analisi del significato fatte da Husserl nelle Ricerche Logiche, ma anche sulle critiche di Daubert su esse. Inoltre Pfänder allo stesso tempo stava facendo ricerche su ordini, promesse e simili. Tuttavia, l’opera di Reinach Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (I fondamenti a priori del diritto civile) fu la prima a dare un trattamento sistematico degli atti sociali e degli atti linguistici: in quest’opera fondamentale, scritta quando aveva appena trent’anni, Reinach ci offre una lucida anticipazione di un lavoro filosofico nuovo; un’ontologia che studia l’essere di entità e relazioni solide “come alberi e case” e, ciò non di meno, invisibili e immateriali. Queste entità sono i diritti, le pretese, gli obblighi, gli status, le promesse, e così via; sono cioè oggetti sociali, dei quali l’ essenza e l’esistenza sembrano fatalmente coincidere. Nel suo nucleo, la teoria di Reinach è piuttosto semplice e facilmente compendiabile: noi percepiamo oggetti, relazioni e atti giuridici ancora prima (e senza bisogno) che il legislatore a queste cose abbia dato un nome e una forma. E la sostanza di queste “cose” limita e indirizza l’attività legislativa. Dopo la pubblicazione delle Idee di Husserl nel 1913, molti fenomenologi presero una posizione critica verso le sue nuove teorie e nacque di fatto la corrente della fenomenologia di Monaco, in quanto Reinach, Daubert ed altri scelsero di rimanere più vicini al lavoro precedente di Husserl, la prima edizione delle Ricerche Logiche. Anziché seguire Husserl nella fenomenologia transcendentale, il gruppo di Monaco rimase una corrente realista. Allo scoppio della prima guerra mondiale Reinach divenne volontario nell’esercito sul fronte orientale. Dopo molte battaglie e avendo ricevuto la croce di ferro, Reinach cadde a Diksmuide nelle Fiandre, il 16 novembre 1917. Di lui rimangono saggi teoretici (sulla teoria dei giudizi sintetici a priori e sul giudizio negativo) e storiografici (su Hume, Kant e James).
HERMANN KEYSERLING

A cura di Marco Minniti
“Perchè mai tutti i pregi dovrebbero risiedere in un solo popolo? L’umanità è un’orchesrta polifonica, il filosofo ne ascolta l’accordo d’insieme“.
La vocazione metafisica
In un sintetico scorcio autobiografico redatto pochi anni dopo la pubblicazione del suo Diario di viaggio, Hermann Keyserling si identifica pienamente nel tipo dell’ “uomo demonico” illustrato da Jaspers nella Psicologia delle visioni del mondo, che, nel suo caso, si incarna in una personalità caratterizzata dalla tensione polare fra una componente femminile-recettiva, contemplativa, animica, e una componente virile-affermativa, creativa, spirituale. La polarità dinamica fra Seele e Geist, anima e spirito, o, se si vuole, fra Oriente e Occidente, contrassegna l’intero percorso vitale di Keyserling, che lo conduce alla fine a quel luogo, la scuola della saggezza, da lui fondata a Darmstadt nel 1920, in cui la conciliazione, nell’ideale della saggezza, fra anima e spirito, vita e conoscenza, diviene – per lo meno nelle intenzioni – il punto di partenza per un radicale rinnovamento dell’umanità occidentale.
Ma se è al tipo umano del saggio, del metafisico e del filosofo (profondamente antiaccademico) che, dopo la Prima guerra mondiale, spetta il compito di sanare l’umanità occidentale dalla sua crisi culturale, è anche vero che tale tipo rappresenta in Keyserling soltanto il punto di approdo di una complessa serie di metamorfosi interiori di cui il Diario di viaggio costituisce lo snodo cruciale. Nato a K ‘o’nn (Livonia) il 20 luglio 1880 da un’antica famiglia aristocratica di ceppo tedesco e di grandi tradizioni intellettuali, il giovane Keyserling, sulle orme del nonno Alexander, si dedica anzitutto alle scienze naturali (geologia, zoologia e chimica), disinteressandosi completamente delle discipline filosofiche. Ma gli aridi studi scientifici, condotti peraltro con impegno caparbio, non riescono a sopprimere la “natura d’artista”, il lato “tenero-femminile” del giovane studioso, che, stimolato dalla intensa frequentazione nei primi anni del secolo a Vienna, di Houston Stewart
Chamberlain e di Rudolf Kassner, si apre infine alla filosofia kantiana e al criticismo. Dopo essersi laureato a Vienna nel 1920 con una tesi in geologia, Keyserling, trasferitosi a Parigi, inizia la sua vita di filosofo e libero scrittore. La filosofia quindi fa la sua prima comparsa nell’orozzonte di conoscenza, da cui la metafisica rimane nettamente distinta. Appartengono a questa prima fase del suo pensiero tre opere di impianto criticista (sia pure – come spiega l’autore – composte musicalmente, come opere d’arte, senza particolari pretese sistematiche): La struttura del mondo (1906), Immortalità (1907) e Prolegomeni alla filosofia della natura (1910), il cui senso complessivo può essere identificato con il programma di sviluppare la strumentazione critica di impianto kantiano fino al limite estrmo oltre il quale si rende intrinsecamente necessario il passaggio all’esperienza metafisica, che avviene appunto nel Diario. Ma già nel quinto capitolo dei Prolegomeni, intitolato emblematicamente Vita, Keysreling prende congedo dalla ragione scientifica e dalla sua critica: “ciò che sta al di là dei fatti empirici si sottrae alla concettualità scientifica, ed è per questo che la scienza critica, e con essa ogni spiegazione idealistica del mondo, fallisce nell’attimo stesso in cui si tratta di comprendere la vita nel suo complesso”. Il termine “vita”, la cui centarlità filosofica Keyserling condivide con altri esponenti della Lebensphilosophie, come Simmel e Bergson (coi quali fu per anni in rapporti di sincera amicizia), identifica qui quell’elemento reale-trascendentale, creativo, sovraindividuale e sovraempirico che mette in scacco sia la scienza sia l’idealismo filosofico, e il cui senso può essere compreso solo mediante una pratica di interiorizzazione da parte del soggetto conoscente. Il sapere metafisico, che non riguarda i fatti, le apparenze, o le loro leggi, ma il senso trascendente che in essi si esprime, è “espressione vitale immediata e incomunicabile”, e scaturisce quindi dall’approfondimento del mondo interiore, dell’anima, dello spirito, dell’essenza, della persona: è anzitutto il microcosmo non concettualizzabile del nostro concreto “io” vivente e vissuto a rappresentare per Keyserling l’accesso diretto al macrocosmo del mondo, cioè al suo principio creativo, che agisce per così dire dal suo interno.
Come il “Keyserling scienziato” è spinto dal suo demone a cercare la via della filosofia oltre il naturalismo, così il “Keyserling kantiano” ne è spinto a cercare la via della metafisica oltre il criticismo, una via verso il senso del mondo che passa per l’interiorizzazione, lo sprofondamento nell’essenza personale, nel “sé”. È questa la base della futura Sinnphilosophie. Il compito che Keyserling assegna alle sue opere critiche è dunque soprattutto quello di sgombrare la strada alla sua vocazione metafisica, una volta contestato che “lo spirito è qualcosa di più essenziale della ragione kantiana”. Eppure il bisogno metafisico di riprendere contatto con il proprio “sé” non lo conduce nella cella di un monastero, o nell’isolamento di un eremitaggio meditativo, ma, paradossalmente, nella vastità del mondo, nella pratica del vagabondare e del viaggiare, nei cui confronti egli dimostra fin da giovanissimo una spiccata attitudine. Il diario di viaggio è la testimonianza romanzesca di questa errante metamorfosi interiore, rispetto alla quale le tappe del viaggio sono in un certo senso casuali, poichè si tratta appunto di tappe spirituali:
“L’unica cosa che m’importava era sperimentare e poi mostrae come uno spirito radicato in modo sufficientemente profondo nel proprio sè, nel fare il giro del globo ruoti di fatto solo attorno al proprio asse…Quest’opera non rappresenta insomma nient’altro che l’illustrazione artistica del processo della mia nascita personale”.
Quando nell’ottobre 1911, egli si imbarca a Genova alla volta dell’Oriente (il viaggio durerà circa un anno) non lo fa nè per spirito d’avventura nè per fascinazione esotica, ma nemmeno per uno specifico interesse di ricerca, bensì nel senso di un rigoroso esercizio spirituale: il suo errare nel mondo è il metodo, la via, la pratica per incontrare, approfondire, dominare il suo “sé” metafisico, e, di conseguenza, il senso del mondo. L’Oriente di Keyserling è anzitutto soltanto una tappa interiore della metamorfosi che porta all’autorealizzazione, cioè alla saggezza.
Il viaggio di Proteo
Il Tao-te-king rivela quanto poco orientale sia l’atteggiamento di Keyserling al momento di intraprendere il suo viaggio:”senza uscire di casa – scrive Lao-tse – si conosce il mondo/senza affacciarsi alla finestra / si conosce il Tao / tanto piu’ lontano si va / meno si conosce / perciò il saggio / conosce e non viaggia”.Viceversa, egli non può nemmeno venire annoverato fra coloro che considerarono l’India e la cultura orientale come oggetto di studio scientifico, filologico e filosofico, o come meta di conquiste, avventura, spedizioni ed esplorazioni, o infine come mera alternativa alla civiltà occidentale. Keyserling è troppo spirituale per accettare tout court la passività del saggio orientale, ma è nel contempo troppo animico per condividere l’attivismo dell’esploratore occidentale: teme la “cristallizzazione”, ma non mira ad alcuna alienazione o annessione culturale.
Una prima composizione fra Seele e Geist, staticità e dinamismo, egli la trova nel proteismo – è Proteo il vero protagonista del Diario – vale a dire in quell’atteggiamento di totale apertura mimetica, empatica nei confronti della forme estranee, che tuttavia è solo il mezzo, il metodo, la via, per il coglimento di quell’unico senso che, pur sussistendo al di là di esse, in esse si esprime: la metamorfosi di Proteo è incessante (Keyserling si sente di volta in volta idolatra, politeista e monoteista, buddista, indù e maomettano, monaco, mistico, teosofo, guerriero, anacoreta ecc), ma il dinamico susseguirsi delle sue incarnazioni non fa che avvicinarlo, con moto rotatorio, alla sublime qiete del suo sè più profondo, laddove il senso del mondo gli si rivela in modo automatico.Come nel caso del Viaggio in Italia di Goethe o del Diario di viaggio di Herder, in gioco, qui, non è la conoscenza dei fatti, ma il raggiungimento di un diverso e superiore stato di coscienza.
Ma nel Proteo del Diario si rispecchia anche il centro della Weltanschauung di Keyserling, cioè l’idea – che con Kassner potermmo definire “fisognomica” – che il senso, la verità, il carattere del mondo sia un alcunchè di dinamico, di puramente intensivo, che si esprime metaforicamente in forme (in volti) sempre diverse e che richiede, per essere compreso, un atteggiamento soggettivo a sua volta dinamico, aperto, interpretativo, in cui l’interprete, immedesimandosi nell’espressione, mette in gioco la sua stessa vitalità creativa. Alla dinamica della verità deve corrispondere la plasticità comprendente (proteiforme) dell’anima. Il nucleo gnoseologico di fondo del Diario – che affonda le radici del pensiero di Keyserling – risiede nell’unità dinamica fra senso, espressione e interpretazione, sicchè il viaggio intorno al mondo non è che un immane processo interpretativo vissuto e finalizzato alla pratica della verità in un diverso e più alto stato di coscienza. Il proteismo è un ideale squisitamente ermeneutico, ed è questa, appunto, la sua saggezza. E d’altronde, che cosa più della pratica interpretativa riesce a comporre paradossalmente, nella dimensione del vissuto, atteggiamento animico-ricettivo e atteggiamento spirituale-creativo, passività e attività, Seele e Geist, Oriente e occidente? Ma la necessità di una composizione dinamica (nel senso del simbolo taoista) della polarità anima-spirito assume nel Diario anche un carattere più sostanziale. Dal punto di vista socioculturale, Keyserling critica l’unilateralità dell’elemento animico, statico, passivo, femminile dell’orientale, che, proprio per mancanza di virilità e di creatività, cioè di spiritualità, impedisce di fatto, nella prassi, la dynamis culturale, il rinnovamento storico, la rinascita, la realizzazione. Il carattere tipicamente “vegetale” dell’orientale, derivante dall’ipostatizzazione dello psichico, va senz’altro superato. Ma dall’altro lato, come dimostra la tappa americana del viaggio, se non viene controbilanciata da valori animici la tensione, razionale al mutamento, al progresso, all’attività, al fare rispetto all’essere, porta a una ipostatizzazione dell’intelletto che genera una barbarie “senz’anima, senza interessi spirituali, senza cultura del sentimento”, dominata dal principio di prestazione e dalla reificazione. Ovvero: il moderno utilitarista occidentale schiavo della ratio funzionale è l’esatto opposto-speculare del saggio anacoreta orientale sporofondato nella psiche, e questa unilateralità va sbloccata in entrambi i sensi, se si vuole creare l’uomo nuovo, che deve saper coniugare produttivamente Sinnerfassung e Sinnverwirklichung, comprensione e realizzazione del senso. Ma il fascino della vegetalità, della vita contemplativa e dell’isolamento dal mondo va superato anche dal punto di vista personale. In più occasioni, durante la permanenza in Oriente, il viaggiatore sembra cedere alla tentazione di arrestare il suo vagabondaggio nel non-fare, nella vita monastica e nell’ascesi: “oggi – scrive per esempio in Himalaya – ho l’impressione che la mia meta si trovi nel mahatmismo, e mi sento maturo per uscire dall’umanità… Se incontrassi un maestro che mi dicesse ‘vieni!’ lo seguirei ciecamente”. Di fatto, nel 1914, ultimata la stesura del Diario, Keyserling medita di stabilirsi in un monastero in Corea per concludervi la propria vita in solitario eremitaggio. Ma, appunto, egli è troppo occidentale, troppo spirituale, per cristallizzarsi nel perfetto détachement. La sua saggezza non è quella femminea dell’anacoreta, ma quella virile del condottiero, di colui che, oltre il profeta Nietzsche, vuole essere non il messaggero, ma il realizzatore di una nuova umanità.
La via di Keyserling lo ha condotto dalla scienza alla critica della conoscenza, da questa alla metafisica, e dalla metafisica, appunto, alla saggezza. Si tratta ora di realizzare nel mondo questa saggezza: la parola deve farsi carne. È cosi che – anche al seguito degli incalzanti avvenimenti del 1918 – Proteo deve compiere la sua estrema metamorfosi, e negare se stesso, superando l’estetismo del diario: la sua libertà sta ora non nell’assoluta trasformabilità, ma proprio in quella forma che gli è assegnata dal destino: “se il mio compito è quello di perfezionare me stesso – si legge in chiusura del Diario – esso implica anche il compito ulteriore di contribuire al perfezionamento del mondo”. È questo senso tutto occidentale di attiva responsabilità nei confronti del mondo – assente nel saggio orientale – che spinge Keyserling nell’engagement intellettuale nella Germania weimeriana, e ciò nel segno della “fecondazione reciproca fra Oriente e Occidente”, come suona il titolo di uno dei suoi primi scritti dopo il ritorno in patria.
La scuola della saggezza
Il dopoguerra si apre per Keyserling nel segno di due eventi contrastanti: da un lato, la pubblicazione, nel dicembre 1918, del Diario, che diviene subito un bestseller, gli procura un successo e una notorietà paragonabili -con una paradossalità che è l’emblema dei tempi – a quelli ottenuti da un’opera coetanea di segno affatto opposto alla sua, il Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler. Dall’altro lato, gli sviluppi della Rivoluzione russa in patria lo privano dei suoi possedimenti, dunque della possibilità materiale di mettere in pratica i suoi propositi riformatori su larga scala. Esule in Germania, il “filosofo errante” acquista ora i tratti drammatici del “senzapatria”. Giunge quindi opportuna la proposta dell’editore Otto Reichl di fondare a Darmstadt, sotto il patrocinio del granduca Ernst Ludwing von Hessen, una “colonia filosofica”, guidata appunto da Keyserling. Dopo le trattative del caso, la Scuola della saggezza – che a dire dello stesso Keyserling incarna “la migliore possibiltà in assoluto di rendersi efficace del suo demone” – viene inaugurata il 23 novembre 1920 assieme al suo organo di gestione, la Società per la libera filosofia. I fondamenti teorici e programmatici della Scuola della saggezza sono esposti in Conoscenza creativa, l’opera che va considerata al tempo steso il compimento e il superamento del Diario. In una civiltà occidentale in cui il grande progresso intellettuale è avvenuto ovunque a spese della vita spirituale, appare decisivo per Keyserling sviluppare quel “tipo di formazione” dell’uomo che sia realmente in grado di sconfiggere la funesta ipertrofia dell’intelletto, e ciò può avvenire solo nel senso di una “nuova sintesi fra spirito e anima”, maschile e femminile, Occidente e Oriente. Stimolare, educare, addestrare, promuovere e sviluppare a ogni livello, sia individuale sia collettivo, questa sintesi è il compito del saggio occidentale. La conoscenza deve ritrovare il suo rapporto con la vita, ma ciò presuppone il raggiungimento di un diverso e più alto stato di coscienza in cui teoria e prassi, conoscere ed essere stabiliscono un’entità efficace e creativa.La consapevolezza orientale che è “il senso a creare il dato di fatto, e non viceversa” deve preludere quindi non già a un passivo acquietamento nello psichico, ma a una pratica attiva-vitale-creativa, spirituale, della conoscenza, che solo in questo senso dinamico diviene redenzione. Coerentemente con la dottrina, già accennata nel Diario, del rapporto dinamico fra senso, espressione e interpretazione, il compito del saggio resta dunque per Keyserling quello tutto occidentale di determinare “un’accellerazione della vita complessiva”, cioè di rianimarla sempre di nuovo a partire da una profonda cognizione del senso. Viceversa, laddove si tratta in praxi della formazione psicofisica del tipo umano in grado di realizzare il mutamento (sia esso imprenditore, commerciante, finanziere, generale, economista, amministratore, intellettuale, politico, scienziato ecc., insomma il componente di una sorta di nuova aristocrazia dello spirito dirigente), è da millenni la cultura orientale a possedee le chiavi del giusto metodo pedagogico.Già nel suo diario Keyserling si sofferma ripetutamente sull’efficacia dell’addestramento e dell’esempio, ma anche soprattutto della cultura della concentrazione e della meditazione (culminante nella pratica yoga): “noi occidentali siamo assai più vitali degli indù e disponiamo di un capitale psichico assai più sostanzioso: chissà dove potremo mai giungere se ci formeremo a sufficienza!”.
L Scuola della saggezza, il cui periodo di massimo fulgore va dal 1920 al 1930, è dunque anzitutto una poderosa macchina di formazione, una “scuola della coscienza”, che intende trasmettere un “essere” anziché un “potere”, cioè anzitutto e in primo luogo il giusto atteggiamento, al giusto livello, nei confronti del mondo. In tal senso, il “come” precede sempre il “che cosa”, sicchè è comunque non sui contenuti, ma sull’influsso personale, sull’esempio, sul vissuto che cade l’accento: “la Scuola della saggezza non vuole né può trasmettere una dottrina particolare, poiché la saggezza non è una disciplina specifica; il suo compito è piuttosto quello di rendere più profondo il rappresentante di un qualsiasi sapere – sia esso teologo, filosofo,industriale, soldato o commerciante – in modo tale da ricollegare ogni specifica forma personale o oggettiva a un contesto di senso più profondo”. Ed è in tale prospettiva che vengono organizzati i contenitori operativi della Scuola – i convegni annuali, i seminari, gli esercizi, i colloqui personali e l’insegnamento individuale – la cui risonanza e il cui influsso sulla cultura della Repubblica di Weimar furono enormi, e che videro la partecipazione di alcune fra le maggiori personalità intellettuali del tempo. Sotto l’instancabile orchestrazione di Keyserling (che però al tempo stesso si sente “il primo allievo” della Scuola), tutto si svolge all’insegna dell’influsso personale e dell’esempio: i relatori dei convegni debbono anzitutto rappresentare in sé un tipo umano “innovativo” nel senso della nuova spiritualità, sicchè è l’essere personale del relatore, non il suo argomento o la sua dottrina, a porsi in primo piano (di qui il “divieto di discussione” imposto da Keyserling). E ciò vale tanto più durante i colloqui e l’insegnamento individuale che, paragonati da Keyserling a un rapporto di suggestione medico-paziente, debbono ispirare all’allievo non già contenuti di conoscenza, ma “un atteggiamento più profondo, un nuovo ritmo di vita, che lo innalzi a un superiore livello di essere”. Ma la conquista della saggezza in quanto “giusto atteggiamento dell’uomo vivente nella sua globalità” è stimolata anche dagli esercizi collettivi, in cui Keyserling, e soprattutto Erwin Rousselle, illustrano il senso delle tecniche di concentrazione, contemplazione e meditazione – sia orientali sia occidentali – che poi devono venire messe in pratica come metodi per un mutamento e un approfondimento psichico, spirituale e corporale. La Scuola è quindi anche una sorta di monastero, o meglio di ritiro, in cui ogni singolo persegue la propria perfezione personale, ma non è né un ente per la cura dell’anima, né un sanatorio. La ricerca della perfezione vale solo ed esclusivamente in funzione della sua efficacia intramondana:
“La facoltà di concentrazione è la vera e propria energia propulsiva del nostro intero meccanismo psichico, non v’è nulla che ne aumenti la capacità operativa quanto il suo potenziamento, e ogni successo, in ogni ambito, è riconducibile allo sfruttamento intelligente di tale energia. Non v’è ostacolo che possa resistere durevolmente a un’energia volitiva eccezionale, concentrata all’estremo”.
Non è un caso che Keyserling e Rousselle vedano nel cavaliere del Gral il simbolo di questo tipo umano al tempo stesso sacerdote e guerriero.
Nell’evocare ancora una volta la sintesi di Seele e Geist, psichismo orientale e attivismo occidentale, questa idea appare difficilmente compatibile con quella di chi nella Scuola voleva vedere un centro esoterico, sede di una chiusa setta malata di esotismo, e nel leader una sorta di Buddha troneggiante: “la scuola della saggezza – scrive Keyserling nel 1925 – è un centro spirituale, un punto di accensione dello spirito. Non è un istituto scolastico. Non ha un programma stabile. Il suo emblema non è il cerchio chiuso, ma l’angolo aperto”. In questa sua veste, la Scuola si presenta negli anni Venti come una delle realtà culturali più feconde e influenti nella vita della Repubblica di Weimar.
La fine del viaggio
Ma che ne è del viaggiatore? Del filosofo errante? Di proteo? Proteo sussiste (ovviamente) sotto altre spoglie, anche se ora, preso dalla sua missione, non veste più i panni del flaneur cosmico disposto ad accogliere in modo femminile ogni forma esteriore, ma quelli maggiormente virili e spirituali del leader carismatico, dell’organizzatore infaticabile, del pedagogo illuminato, dell’oratore veemente, dell’intellettuale engagé, dello stratega, del politico realista, del pubblicista. Oltre a una miriade di interventi sui temi trattati nella Scuola e a testi dedicati ai suoi sviluppi teorici – Philosophie als Kunst (Filosofia come arte), 1920; Wiedergerburt (Rinascita), 1926 -, Keyserling pubblica opere di stringente attualità come Politik, Wirtschaft, Weisheit (Politica, economia, saggezza), 1922, in cui affronta direttamente la “questione” tedesca e analizza il contesto politico-economico dal punto di vista della filosofia del senso, Dieneuentstehende Welt (Presagi di un mondo nuovo), 1926, in cui diagnostica la crisi dell’epoca e auspica un intervento terapeutico della filosofia, Das Spektrum Europas (Lo spettro dell’Europa), 1928, in cui, in’ottica di filosofia e psicologia della cultura, analizza argutamente i caratteri delle singole nazioni nella prospettiva di una futura comunità europea.
Ed esattamente nel nome della dichiarata apertura all’esterno della Scuola della saggezza, e nella necessità di diffondere il verbo universale, Keyserling – anche qui nei panni mutati del condottiero dello spirito – si rimette spesso in viaggio, intraprendendo vorticosi e frequentatissimi cicli di conferenze, che lo portano, oltre che quasi ovunque in Europa ( è particolarmente gradito in Francia e in Spagna), anche negli Stati Uniti (1927-28) e in Sudamerica (1929). Da queste due ultime esperienze nascono Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt (America. L’alba di un mondo nuovo), 1930, una sorta di “psicoanalisi degli Stati Uniti” che è anche una critica della società americana, e soprattutto Sùdamerikanische Meditationen (Meditazioni sudamericane), 1932, che, incarnando per così dire la terza fase nella vita e nel pensiero del filosofo, testimonia del suo essere venuto a contatto, in Sudamerica, con le oscure forze primordiali-telluriche del vivente: è la terra, ora, con la sua energia abissale, l’elemento notturno, refrattario allo spirito creativo ed eternamente condizionante con cui l’uomo deve fare i conti nel suo tentativo di dare senso al mondo. Nello stile del Diario di viaggio, le Meditazioni sudamericane illustrano lo sprofondamento di Proteo nel mondo infero delle pulsioni elementari.
L’attivismo errante di Keyserling sembra inarrestabile, e la sua notorietà è enorme: mentre la scuola della saggezza, a poco a poco, perde di incidenza, ma non di prestigio, nel 1931 il suo fondatore è in Francia, dove espone il suo pensiero di fronte a quasi settemila persone riunite nella sala del Trocadèro, poi è in Spagna, Olanda, Belgio. Egli è senz’altro il filosofo più popolare della Repubblica Weimariana. Ma sono proprio questa sua popolarità, il suo cosmopolitismo, il suo universalismo, il suo liberalismo, la sua disposizione al dialogo e alla comprensione fra le genti, le culture, i popoli, insomma il suo stesso istinto di viaggiatore, a decretarne la condanna.
Lo scontro con il nazismo è inevitabile. Dopo il 1933, alle campagne di sobillazione e di diffamazione orchestrate contro di lui dai nazisti (tra cui il suo ex editore Reichl), seguono i divieti di tenere conferenze e di pubblicare i suoi scritti, le censure, i boicottaggi, con conseguenze economiche disastrose per un intellettuale abituato a vivere della sua parola e della sua penna. Proprio il suo proteiforme protagonismo e il suo ecumenismo hanno procurato al filosofo molti nemici: “per i nazionalisti – scriverà il figlio Arnold – un traditore della patria, per i nazisti un nemico dello Stato, per i filosofi accademici un dilettante aristocratico, per i fondamentalisti un anti-cristo luciferino, per gli intellettuali di sinistra un mistagogo, per gli esoterici un rinnegato”. Infine, nel 1937, con il divieto di comparire pubblicamente e, soprattutto, di recarsi all’estero, il cerchio, quello della barbarie occidentale da lui sempre combattuta, si chiude attorno a Keyserling, e al viaggiatore vengono definitivamente tarpate le ali. A causa della in desiderabilità politica del suo leader, anche la Scuola, pur continuando a sussistere fra mille difficoltà, si trova obbligata suo malgrado a chiudersi sempre più su se stessa, fino a estinzione della sua attività pubblica, nel 1939.
Come nel caso di molti altri intellettuali cosmopoliti (si pensi all’ebreo errante Walter Benjamin, che pure ebbe un destino assai più tragico), anche il viaggio di Keyserling si conclude nella palude della Germania nazista. Su di lui cala uno spesso velo di minaccioso silenzio, che in parte è durato fino a oggi. Lasciata Darmstadt per ragioni di sicurezza personale, ridotto quasi in miseria, malato, nel 1943 Keyserling si trasferisce ad Aurach/Kitzbùhel in Tirolo, dove rimarrà fino a poco prima della morte. Ma fino all’ultimo, fedele al suo demone, egli lavora alacremente alla possibilità di riaprire, nell’immediato dopoguerra, la Scuola della saggezza a Innsbruck. Evidentemente, l’idea, già espressa trent’anni prima nel Diario di viaggio, di combattere il “tramonto dell’Occidente” con le armi dell’anima, dello spirito e della saggezza non lo ha affatto abbandonato: sono senz’altro ancora pochi gli uomini decisivi che hanno raggiunto l’ideale superiore, ma “dispenderà dal loro esempio se la massa sprofonderà nell’abisso o proseguirà alla volta di altezze più libere”. Parole, queste, che nella Germania sconvolta dalla catastrofe bellica acquistano un’attualità ancora più drammatica.
Keyserling muore a Innsbruck il 26 aprile 1946, pochi mesi prima del progettato convegno internazionale (previsto per il settembre dello stesso anno) che avrebbe dovuto consacrare la riapertura della Scuola della saggezza nella città austriaca. Il titolo del convegno, che nelle intenzioni del suo promotore sarebbe dovuto servire “alla comprensione fra i popoli, alla comunicazione fra nuove e vecchie generazioni e alla rifondazione della vecchia cultura occidentale in vista di un futuro migliore, più moderno e più conforme al senso”, riassume, ancora una volta, l’ideale nel nome del quale il filosofo errante ha lottato (e viaggiato) per tutta la vita: “il ricongiungimento di anima e spirito”.
ALEXANDRE KOYRÉ

A cura di D. Romano
“Il pensiero umano, anche quello dei massimi geni, non è mai tanto logico e conseguente. Non dobbiamo stupirci, perciò che Copernico, credendo nell’esistenza di sfere planetarie materiali, di cui abbisognava per spiegare il moto dei pianeti, credesse anche a quella della sfera delle stelle fisse, di cui non aveva più bisogno […] Bisogna ammettere l’evidenza. Il mondo di Copernico è finito. Fra l’altro sembra psicologicamente del tutto normale che chi superò il primo gradino, arrestando il moto delle stelle fisse, esitasse poi a salire il secondo, dissolvendola in uno spazio senza confini; era sufficiente, per un uomo solo, muovere la Terra ed ampliare il mondo fino a renderlo non misurabile: immensum; chiedergli di renderlo infinito è ovviamente troppo. […] La bolla del mondo deve gonfiarsi prima di scoppiare“.
VITA E OPERE
Alexandre Koyré (1892 – 1964), nato a Taganrog (in Russia) da una famiglia russa di origini ebraiche, uditore a Gottinga dei corsi di Husserl e Hilbert, vicino ai primi circoli fenomenologici, e poi all’epistemologia storica di Emile Meyerson e Léon Brunschvicg, è uno dei maestri riconosciuti della storia filosofica delle scienze francese. Insegnò all’Ecole Pratique des Hautes Etudes a Parigi e durante la seconda guerra mondiale emigrò negli Stati Uniti, proseguendo nell’esperienza di insegnamento presso la New School for Social Research di New York. Fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1964 si divise tra l’insegnamento parigino e la ricerca a Princeton. Tra i suoi lavori, Dal mondo chiuso all’universo infinito (Du Monde Clos à l’universe infini), Studi galileiani e La rivoluzione astronomica, e Studi newtoniani. Sotto l’influsso della fenomenologia di Edmund Husserl, Koyré si dedicò alla storia della filosofia e del pensiero religioso medievale, spostando poi i suoi interessi verso l’astronomia, la fisica, la matematica. Rinnovò gli studi di storia della scienza proponendo una visione ricca e complessa del percorso scientifico, inteso quale scontro dialettico tra concezioni globali del mondo e concetti scientifici specifici. Tale idea richiede una storia delle scienze ricca e articolata, che giunge a trovare ampie zone di contatto da un lato con la storia della filosofia, dall’altro con la storia della religione (ma non con quella della tecnica). Nelle sue Lezioni su Cartesio, Koyré esamina il pensiero di Descartes, inteso come antesignano del concetto moderno di scienza. Lo scritto analizza la portata del filosofo francese attraverso tre lezioni: “Il mondo incerto”, “Il cosmo scomparso” e “L’universo ritrovato”; esse ripropongono una riflessione acuta e puntuale, una analisi scientifica che mantiene intatta tutta la verve propria del parlato. Il tributo di conoscenza che secondo Koyré dobbiamo alle analisi cartesiane è enorme; da tre secoli infatti “tutto il pensiero filosofico europeo è orientato e determinato, direttamente o indirettamente, da quello del grande scienziato”. Così, anche se per noi può essere difficile comprendere pienamente la portata dell’opera cartesiana, si tratta senza ombra di dubbio di “una delle più profonde rivoluzioni intellettuali e spirituali che l’umanità abbia conosciuto, vittoria decisiva sull’aspro percorso che conduce l’uomo a quel tipo di libertà che è al contempo liberazione emotiva, razionale e perseguimento della verità”. Koyré ci accompagna in questo viaggio alla ricerca di una chiarezza d’analisi che possa permetterci una comprensione più ricca dell’innovazione che ne è alla base. Le Lezioni su Cartesio ci restituiscono dunque dell’autore, convinto assertore della necessità dell’interazione tra cultura filosofica, matematica e storica, quell’immagine di convincente e accattivante oratore che è stata una delle sue caratteristiche peculiari.
DAL MONDO CHIUSO ALL’UNIVERSO INFINITO
IL PROBLEMA DELL’INFINITO
Il concetto di infinito è collegato alle più profonde domande filosofiche dell’uomo e presenta, inestricabilmente intrecciati, aspetti matematici e metafisici, fisici ed etici, astronomici e teologici. È inevitabile, pertanto che il rinnovamento anche di un solo lato del concetto (per esempio quello matematico) costringa a una revisione complessiva dell’intero sapere scientifico, filosofico e religioso. È quello che avviene, appunto, con la moderna rivoluzione copernicana, che porta a rinnovare profondamente non solo la disciplina astronomica ma l’intera immagine della realtà.
Il nome di Copernico è, in verità, più che altro un simbolo. Se Copernico ebbe, infatti, il merito di rimettere in discussione una modello astronomico venerando, sostenuto non solo da una tradizione scientifico-filosofica e religiosa millenaria ma anche dal senso comune, egli rimase, tuttavia, ancora legato all’idea di un universo finito. Per questo aspetto decisivo, pertanto, lo stesso rivoluzionario astronomo risulta ancora un “conservatore”. A Copernico, tuttavia, durante il secondo Cinquecento, si rifece il filosofo Giordano Bruno (1548-1600), vedendo in lui l’”aurora, che doveva precedere l’uscita di questo sole de l’antiqua vera filosofia”. Bruno, rifacendosi anche alla filosofia di Cusano (1401-1464), sviluppò per la prima volta, a partire dalla teoria copernicana, la nuova dottrina di un universo decentrato, infinito e infinitamente popolato, dottrina che sarà destinata a influenzare profondamente non solo l’immagine del cosmo ma anche quella dell’uomo e del suo destino.
1. L’infinito nella filosofia antica e medievale
Il pensiero greco assume il concetto di “infinito” prevalentemente in un senso negativo, come sinonimo di “indefinito”, “incompiuto”, “illimitato”, “informe” e lo contrappone alla positività dell’essere finito, determinato e perfettamente compiuto.
È questa la concezione che troviamo prima in Parmenide, che paragona l’essere necessario alla totalità finita e compiuta della “massa di una ben rotonda sfera”, e, successivamente, in Platone e soprattutto in Aristotele. Platone vede nel finito e nell’infinito due componenti di tutte le cose e, nel Filebo, li distingue l’uno dall’altro osservando che “in certo modo l’infinito è molteplice” in quanto esso è ciò che è privo di misura e di limite, è “senza fine” e, perciò, indeterminato.
Come tale, l’infinito è ciò che appare sempre suscettibile di un “più” e di un “meno”, di un accrescimento o di una diminuzione illimitata e si contrappone radicalmente alla precisa determinatezza del finito, che è il solo possibile oggetto di conoscenza vera.
Aristotele nega che l’infinito possa mai esistere come una sostanza o un attributo di essa, come una realtà in atto, e gli riconosce solo un’esistenza potenziale. L’infinito, infatti, è ciò che può venire sia diviso sia accresciuto illimitatamente, ossia ciò la cui divisione o composizione risulta inesauribile e interminabile. In questo senso, per esempio, è infinita una linea poiché la sua divisione non può mai raggiungere un termine, dato che ogni segmento, per quanto piccolo esso sia, risulta ancor sempre divisibile. Di conseguenza, l’infinito non è un ente reale, in atto, ma solo un processo potenzialmente inesauribile perché lascia sempre qualcosa fuori di sé: è una “parte” che non arriva mai a essere un “tutto” compiuto.
L’infinito è, dunque, ciò che non ha una fine raggiungibile, ciò che non è determinato, e come tale non ha un’esistenza ontologicamente attuale e positiva. Ciò che, dal punto di vista metafisico, è più vicino all’infinito potenziale della matematica è, pertanto, la materia potenziale che, essendo l’opposto della determinatezza formale, risulta quasi un “non-essere” e, comunque, resta qualcosa di inconoscibile.
Rispetto a questa concezione classica il pensiero tardo-antico conosce una svolta fondamentale, sia attraverso il neoplatonismo sia attraverso il cristianesimo. Già Plotino distingue chiaramente dall’infinito potenziale della matematica, inteso come “inesauribilità” del numero, l’infinito metafisico, inteso come “illimitatezza della potenza” dell’Uno, ossia come l’assenza di limitazione del principio produttivo. Su questa scia, il pensiero cristiano assume il termine in un senso totalmente positivo per indicare la pienezza della divina perfezione.
Tommaso d’Aquino distingue la infinità negativa della materia, e cioè la sua incompiutezza e indeterminatezza ove si prescinda dalla forma, dalla positiva infinità divina che indica la perfetta autosufficienza del creatore rispetto alla realtà finita creata. L’infinito si presenta in tal modo come l’ens perfectissimum, oggetto della teologia.
2. Tolomeo e Aristarco
Che l’universo debba essere di dimensioni finite e avere un centro, non è l’unica teoria cosmologica elaborata dai Greci. È però la concezione vincente. Questa idea poggia su osservazioni empiriche, ma anche su principi filosofici altrimenti fondati. Ad esempio, si basa sul fatto che – per quanto l’uomo può osservare – il Sole, la Luna e le stelle ruotano intorno alla Terra, mentre non è immediatamente percepibile dall’uomo alcun segno della rotazione terrestre (dunque: la Terra è ferma e i cieli le ruotano intorno con movimento costante). Inoltre la perfezione divina dei cieli impone un movimento perfetto e matematicamente definito, come è quello circolare, ed impone allo stesso tempo che il cosmo sia una realtà finita, in sé conclusa. Infatti per la mentalità greca solo il finito – ciò che è compiuto in tutte le sue parti – può essere perfetto. L’infinito è l’indeterminato, ciò che non giunge mai a compimento. L’universo non può che essere perfetto, perché dominato da forze divine, dunque non può essere infinito, aperto, senza limiti.
Che vi sia un centro dell’universo è, d’altra parte, concezione strettamente connessa con la sua finitezza. Si supponga infatti che l’universo fisico sia infinito. È ancora possibile parlare di un centro? Evidentemente no, ed è questa la concezioni di quanti – come Epicuro, ripreso da Lucrezio nel De rerum natura, pensano che la materia che compone l’universo sia infinita e così lo spazio che la contiene.
Quest’ultima concezione non potrà affermarsi, e il dibattito sull’infinito si aprirà nuovamente solo in età moderna, da Cusano e Bruno in poi. Nel mondo greco, prevalsa la tesi della finitezza del cosmo, si confrontano due teorie, l’una che vuole che al centro dell’universo fisico vi sia la Terra (teoria geocentrica), l’altra che vuole vi sia il Sole (teoria eliocentrica).
a. Tolomeo e la teoria geocentrica
Già a partire dall’età classica prevale nettamente la teoria geocentrica, definita poi matematicamente nei dettagli da Tolomeo in un libro – tramandatoci con il titolo di origine araba Almagesto – che è una delle grandi conquiste del pensiero scientifico antico, nonostante il fatto che la teoria in sé sia errata.
Tolomeo è un astronomo vissuto nel periodo dell’ultima fioritura della scienza alessandrina. Non si hanno dati certi sulla sua vita, se non il fatto che nel suo libro compaiono le date delle osservazioni astronomiche da lui compiute, comprese tra il 127 e il 151 d.C.
Tolomeo, venendo al termine del lungo processo di elaborazione filosofica e scientifica dell’antichità, non è certo l’inventore della teoria geocentrica. Egli però raccoglie un’enorme massa di informazioni astronomiche da tutta l’antichità, la arricchisce con nuove osservazioni e interpreta tutto questo materiale alla luce di complesse strutture matematiche, destinate a rendere ragione, in un quadro ordinato e non contraddittorio, di tutte le osservazioni. Si tratta infatti per lui, come sarà per gli astronomi moderni, di elaborare una teoria, matematicamente definita, che sia in grado di salvare i fenomeni, come si dirà nel Seicento, cioè di essere sempre in accordo con i dati desunti dalle osservazioni.
Va qui ricordato che Tolomeo, come poi faranno gli studiosi del Rinascimento, nel suo studio della struttura del cosmo contempla anche la ricerca della corrispondenza tra il moto dei cieli e quanto accade sulla Terra: gli astri, infatti, si supponeva fossero in grado di influenzare anche la vita e il carattere dell’uomo e fosse dunque importante scrutare i cieli per comprendere l’uomo. Astronomia e astrologia ancora per molti secoli saranno strettamente connesse.
b. Aristarco e la teoria eliocentrica
La prima definizione della teoria eliocentrica risale agli ambienti del Liceo. Aristotele non ne è per nulla responsabile, avendo sostenuto una visione del cosmo fondata sul postulato della immobilità della Terra al centro dell’universo. Ma alla sua scuola, attenta alle ricerche di tipo naturalistico, proprio in conseguenza di queste ricerche poterono svilupparsi, dopo la sua morte, teorie nuove.
Già Eraclide Pontico (vissuto circa tra il 390 e il 310 a.C.), un ricercatore della cerchia dell’Accademia platonica, aveva sostenuto che Mercurio e Venere ruotano intorno al Sole, ma non si era spinto più avanti. Aristarco di Samo, vissuto nel III sec. a.C. e appartenente alla scuola peripatetica, è il primo scienziato a formulare compiutamente la teoria eliocentrica, prima di Copernico. Questa dottrina si scontrava contro difficoltà di diversa natura, non ultima la sua grande originalità e la sua distanza dal senso comune (il Sole appare effettivamente ruotare intorno alla Terra, di cui non percepiamo invece alcun movimento). Inoltre l’eliocentrismo di Aristarco non era fondato su un’elaborazione matematica compiuta. Questa teoria, dunque, finiva col salvare i fenomeni meno del geocentrismo. Di fatto non ebbe seguito nel mondo antico.
1. La teoria eliocentrica di Copernico
La teoria eliocentrica di Niccolò Copernico, nome italianizzato dell’astronomo polacco Nikolaj Kopernik (1473-1543), venne presentata dal suo autore nel celebre saggio De revolutionibus orbium coelestium (1543) come un’elaborazione matematica, uno studio puramente teorico.
Alla data di pubblicazione del suo saggio, Copernico era ormai un uomo anziano (sarebbe morto di lì a poco), con grande esperienza. Sapeva bene quali problemi avrebbe suscitato la sua tesi. Ne aveva avuto sentore diversi anni prima, quando una sua breve memoria nella quale era descritto in sintesi il modello eliocentrico aveva incontrato sfavorevole accoglienza presso gli ambienti protestanti. Spostare la Terra dal centro dell’universo e porre il Sole al suo posto si accordava male con la lettera del testo sacro e sembrava un attacco all’autorità della Bibbia. Non lo era, ma lo sembrava, e comunque la circolazione di queste idee avrebbe inevitabilmente avuto l’effetto di rimettere in discussione la “verità” delle Scritture.
Copernico scrive dunque che la sua teoria nasce dalle difficoltà incontrare dai matematici e che a questo ambito deve essere ristretta.
La discussione, strettamente riservata ai matematici e agli astronomi, verte quindi esclusivamente sul migliore sistema matematico per salvare i fenomeni.
Questo era infatti il punto. Copernico aveva studiato per un decennio presso diverse università italiane (Bologna, Padova, Ferrara), che erano i più avanzati centri di ricerca scientifica del tempo. Era dunque molto bene a conoscenza dei problemi di calcolo cui andava incontro il sistema tolemaico di fronte alle osservazioni raccolte in età moderna con la massima precisione possibile.
Una delle ragioni per cui la teoria geocentrica aveva nettamente avuto la vittoria per oltre un millennio era il fatto che Tolomeo era riuscito ad elaborare un modello matematico capace di salvare i fenomeni in modo migliore di quanto non fosse stato fatto per il sistema eliocentrico dai suoi sostenitori. Il modello tolemaico permetteva di prevedere il movimento apparente (cioè il movimento osservato dal punto di vista di un osservatore sulla Terra) dei corpi celesti con maggiore precisione. Osservazioni recenti però hanno messo in luce dei difetti del modello tolemaico. Si trattava di correggerlo nei dettagli oppure di abbandonarlo in favore di un sistema completamente diverso.
Copernico opta per questa seconda soluzione. Non lo fa, però, perché questo gli consente di salvare i fenomeni in maniera migliore. Il modello eliocentrico si dimostra, in realtà, impreciso come l’altro. Le ragioni che glielo fanno preferire sono di natura diversa.
SEMPLICITÀ E LOGICITÀ DELL’ORDINAMENTO DIVINO DEL COSMO
Copernico è fermamente convinto che l’universo abbia un ordine rigoroso e risponda perfettamente al piano semplice e logico con cui Dio governa ogni cosa in natura.
Tutto in natura, infatti, è semplice, nel senso che nelle leggi di natura non vi sono mai complicazioni che non abbiano un preciso scopo. Non c’è nessun organismo ridondante nella struttura del corpo umano e ogni parte risponde ad un preciso scopo. Non ci sono movimenti superflui nell’universo, ma tutto è coordinato con essenzialità per concorrere alla perfezione del cosmo. Le leggi che spiegano il movimento complessivo dei corpi celesti devono dunque essere le più semplici che sia possibile ipotizzare.
Che l’universo, poi, sia regolato in modo logico, secondo un rigoroso logos, è tesi che a Copernico giunge dalla lunga tradizione del pensiero greco. La mente dell’uomo e la realtà cosmica stanno l’una davanti all’altra rispecchiandosi in modo perfetto, almeno in linea di principio. Sono realtà omogenee: mente e universo fanno parte dell’unica realtà del creato, pensiero e materia si corrispondono. Ordo et connexio rerum est idem ac ordo et connexio idearum. Che poi l’uomo non sia ancora giunto alla perfetta definizione delle leggi che governano la materia, ebbene questo dipende solo dall’incompletezza della ricerca e dalla sua difficoltà, non certo dall’incapacità della mente o dal fatto che l’universo sia strutturato in modo non logico, cioè differente dai principi logici che governano la mente.
Se applichiamo queste riflessioni sulla semplicità e logicità dell’universo all’analisi del problema cosmologico, il modello tolemaico risulta perdente. Come è possibile, infatti, che l’immensa macchina del mondo sia in costante rivoluzione intorno a quel minuscolo punto (su scala cosmica) che è il pianete Terra? Non è assai più agevole pensare che occupi la posizione centrale il Sole, che è il corpo più grande?
LA PERFEZIONE DEL SOLE
Su Copernico hanno poi peso decisivo considerazioni di natura filosofica, che derivano dalla tradizione pitagorica.
Che il Sole debba occupare il posto centrale è convinzione che nasce dalla considerazione dell’eccellenza del Sole. Il centro è per Copernico – al contrario che per la tradizione medievale – la posizione eccellente dell’universo, ed essa è propria del corpo dal quale tutti gli astri dipendono. E non è forse dal Sole che dipende tutto l’universo per la luce, per il calore e, in ultima istanza, per la vita stessa?
“Il mondo di Copernico non è affatto privo di caratteristiche gerarchiche: infatti, se afferma che non sono i cieli a muoversi, bensì la Terra, non è soltanto perché gli sembra irrazionale far muovere un corpo enormemente grande, invece di uno relativamente piccolo, “ciò che contiene e situa e non ciò che è contenuto e situato“, ma anche perché “lo stato di quiete è considerato più nobile e divino del mutamento e dell’instabilità; la quale ultima conviene perciò alla Terra più che all’universo“. Ed è in ragione della sua suprema perfezione ed importanza – fonte di luce e di vita – che il posto da essa occupato nel mondo viene assegnato al Sole: posto centrale che, seguendo la tradizione pitagorica e rovesciando così completamente la scala di valori aristotelica e medioevale, Copernico considera il migliore e il più importante” (A. Koyré).
2. Copernico e il problema dell’infinito
La concezione astronomica copernicana è una vera rivoluzione del pensiero, non soltanto una diversa ipotesi sul moto dei corpi celesti. Oggi è difficile rendersi conto di questo, ma si deve ricordare che l’universo era concepito dai medievali, sulla scorta di un’antichissima tradizione, che precede di secoli l’affermarsi del Cristianesimo, come un insieme gerarchico: la Terra occupa il posto inferiore perché è sede della materia corruttibile e dell’instabilità dovuta al mutamento; i cieli occupano invece il posto più elevato perché dotati di movimenti costanti e composti di materia incorruttibile. I cieli erano concepiti come sedi degli dèi dagli antichi, come intelligenze angeliche dai cristiani, e in essi il Medioevo ha visto la sede per eccellenza di Dio. La posizione centrale occupata dalla Terra assume per i medievali una valenza negativa proprio in ragione della sua lontananza da Dio. Dante, ad esempio, concepisce l’inferno – secondo una concezione corrente del suo tempo – nel cuore della Terra, e colloca il principe dei demoni nel perfetto centro della Terra perché questo è, in tutto l’universo, il luogo più lontano da Dio.
Lo spostamento del centro dell’universo dalla Terra al Sole compiuto da Copernico implica la dissoluzione di questo modello. La Terra, infatti, diventa essa stessa un corpo celeste, al pari degli altri, dotata degli stessi movimenti costanti. La materia terrestre e quella celeste di mostrano della stessa natura ed ogni gerarchia degli esseri è destinata ad essere sovvertita. Continua però ad esservi una gerarchia degli esseri.
IL MONDO CHIUSO
In Copernico, non c’è la concezione dell’infinità del cosmo, nemmeno nella forma negativa di Cusano, che parla di universo indefinito. L’universo Copernicano è immenso, smisurato, enormemente più ampio, secondo i suoi calcoli, dell’universo tolemaico. Ma è finito.
Copernico pone esplicitamente questo problema. Concepisce la possibilità di un’estensione spaziale indefinita oltre il confine del cosmo, oltre il cielo delle stelle fisse, ma preferisce rimanere nei limiti delle possibilità offertegli dalle osservazioni. I dati che un astronomo può raccogliere parlano di un universo visibile, e in quanto tale collocato a una distanza finita (potremmo forse vedere la luce di una stella, se essa fosse a una distanza infinita da noi?).
Copernico non abbandona la teoria delle sfere celesti, né pone in crisi, come faranno i suoi successori, la concezione che la sfera delle cosiddette stelle fisse, cioè la volta celeste, sia il “tetto del mondo” (ma non ha più bisogno di concepire questa sfera in movimento, poiché è la Terra a muoversi). Non immagine che una simile volta sia solo un effetto ottico e che in realtà il suo spessore sia immensamente ampio, tanto da configurare un universo aperto e non chiuso.
L’universo copernicano è ancora chiuso: un’immensa sfera al cui centro è il Sole, perfezione del cosmo. Tuttavia l’universo copernicano è smisuratamente grande rispetto a quello tolemaico: il diametro è duemila volte maggiore.
RAYMOND ARON

A cura di F. Gualco e A. Squillace
“Soltanto la rivoluzione, in quanto avventura, o un regime rivoluzionario, poiché fa uso permanente della violenza, sembrano capaci di conseguire il fine ultimo. Il mito della rivoluzione serve di rifugio al pensiero utopistico, diventa il misterioso e imprevedibile mediatore tra reale e ideale“. (L’oppio degli intellettuali)
VITA E OPERE
Il tragitto di Raymond Aron (Parigi 1905 – id. 1983) fu il percorso lineare di un intellettuale attaccato alla tradizione. Nel 1924, entra alla “Scuola Normale” della rue d’ Ulm con la volontà di brillarvi per vendicare le sconfitte universitarie del padre. Ha in particolare come condiscepoli Jean-Paul Sartre e Paul Nizan. Arriva primo al corso di filosofia del 1928 (Sartre sarà respinto ma sarà primo l’anno successivo). Lettore all’università di Colonia (1930), quindi pensionante all’ Accademia di Berlino (1931 -1933), assisterà in diretta all’ascesa del nazismo: «in questa città la crisi tedesca era molo più apparente. Si vedevano i disoccupati. Si era proprio al centro della vita politica. Andavo alle riunioni pubbliche. Evidentemente ho ascoltato Goebbels, che era un oratore e si esprimeva in buon tedesco. Ho ascoltato Hitler, il cui tedesco era spaventoso, e che subito mi ha ispirato una specie di paura e di orrore» (R. Aron, L’etica della libertà, op. cit. ). Di ritorno in Francia, sostiene nel 1938 la sua tesi di dottorato, Introduction à la philosophie de la historie (Introduzione alla filosofia della storia), attraverso cui si sviluppa il problema dei compiti e delle finalità della filosofia della storia in relazione alla vita dell’individuo. Dal 1940 al 1944, Raymond Aron è redattore capo del giornale La France libre, a Londra. Dopo la guerra, non cessa di svolgere parallelamente una carriera di influente editorialista liberale e conservatore ed una, strepitosa, di accademico. È successivamente editorialista a Combat (1946) quindi a Le Figaro, dal 1947 a 1976. Nel 1977, lascia il quotidiano per il settimanale L’Express a cui collaborerà fino alla morte. A partire dall’osservazione delle realtà della sua epoca, questo filosofo ha tentato di spiegare l’attrazione esercitata dal marxismo su molte intelligenze francesi ed europee contro cui egli entrò in conflitto, sulla scorta del fatto che quella potente dottrina socio-economico-politica gli sembrava smentita dalla reale evoluzione economica e sociale della Francia e del mondo. Raymond Aron si fece così sociologo al fine polemico e dottrinale di condurre un raffronto stringente tra il regime sovietico e comunista da un lato e quello di tipo occidentale e capitalista dall’altro, con ciò scontrandosi con buona parte dell’intellighenzia francese fortemente sedotta dal pensiero e dalla prassi marxista. La sua analisi è condotta su tre piani: economico (Diciotto lezioni sulla società industriale, 1963), sociale (Le lotte di classe, 1964) e politico (Democrazia e Totalitarismo, 1965). Aron afferma la continuità del pensiero liberale da Montesquieu a Weber, passando per Tocqueville nel suo lavoro Le tappe del pensiero sociologico scritto nel 1967. Lungo tutto il suo impegno intellettuale Raymond Aron denuncia l’interpretazione della storia data dai marxisti. Scrittore fecondo e di estrema qualità, sia per quanto attiene al nitore argomentativo stilistica sia rispetto alla precisione e alla profondità intellettuale, fra le sue opere possiamo ricordare La sociologie allemande contemparaine del 1935 (trad. it. Introduzione alla sociologia tedesca contemporanea, Milella 1980); la già citata Introduction à la philosophie de l’historie del 1938; il famosissimo Opium des intellectuelles del 1955 (trad. it. L’oppio degli intellettuali, Ideazione Editrice, Roma 1988); gli Études politiques del 1972 (trad. it. parziale Il concetto di libertà, Ideazione Editrice, Roma 1997); Penser la guerre. Clausewitz (1977) e le Mémoires pubblicate nel 1978.
IL PENSIERO
Nella sua carriera universitaria, segue con successo irresistibile il cursus honorum tipico delle grandi Istituzioni culturali della Francia e che va da l’Institut d’études politiques alla Scuola nazionale d’amministrazione (ENA) dove insegna a partire dal 1945, fino al Collège de France dove entra nel 1970 per occupare la cattedra di sociologia della civiltà moderna, passando dalla Sorbona dove è dal 1956 al 1968 e l’École pratique des hautes études che lo accoglie nel 1960. È il grande universitario ai cui corsi si fa la fila, ma anche il “mandarino” tipo, il barone universitario, bersaglio privilegiato della contestazione studentesca del maggio 68. Membro de l’Académie des sciences morales a partire dal 1963, dottore honoris causa di numerose università nel mondo intero, vincitore di molti premi fra cui il premio Érasme nel 1982. Filosofo e sociologo, docente universitario e giornalista, esperto di politica nazionale ed internazionale, studioso di Aristotele, Marx e Machiavelli così come di Montesquieu, Tocqueville e Weber, Raymond Aron rappresenta senza alcun dubbio una figura eminente all’interno della cultura politica francese ed in generale europea. Razionale ma non razionalista, predisposto alla discussione e pronto a riconoscere serenamente i suoi errori eventuali, Aron è favorevole alle società fondate sulle libertà economiche e personali, alla pluralità democratica, alla distinzione fra Stato e Chiesa e quindi fra poteri temporali e poteri spirituali. È un pensatore che non ricorre direttamente alla cifra della trascendenza né esplicitamente fruisce del sostegno di dati metafisici: ciò nonostante si oppone ad ogni forma di immanentismo radicale ed è contrario alla radicalità negativa del fanatismo politico e religioso, che in quanto tale nega la politica responsabile e la verità della religione. La laicità del pensiero di Aron è genuina. E non gli impedisce di riconoscere che l’imperfezione umana e le conseguenti contraddizioni che gli esseri umani esprimono sia sul piano individuale sia su quello sociale e politico, sono verità che la religione rivelata afferma. In tal senso una delle sue preoccupazioni costanti è quella di mantenere uno spazio aperto per i principi trascendenti non riconducibili alla volontà umana. La sua vita è stata quella di un intellettuale impegnato, di un testimone attento e partecipe agli eventi del Novecento. Distante da toni o atteggiamenti dogmatici, profondamente persuaso che la trama della storia è leggibile, ma impossibile da incasellare in formule astratte e definitive, Aron è un liberale convinto la cui intransigenza emerge sul piano dei valori ma non su quello degli studi e delle ricerche. Egli mette in evidenza l’origine ebraico-cristiana dell’escatologia marxista, il legame tra il fascino del marxismo e il bisogno di fede degli intellettuali:
L’escatologia marxista conferisce al proletariato una funzione di salvezza collettiva. I termini usati dal giovane Marx non lasciano dubbi per quanto riguarda l’origine ebraico-cristiana del mito della classe, eletta a causa della sua sofferenza ad operare il riscatto dell’umanità. Missione del proletariato, fine della preistoria grazie alla Rivoluzione, regno della libertà, in tutto ciò sono facilmente riconoscibili i motivi principali del pensiero millenaristico: il Messia, la rottura, il regno di Dio. Non che il marxismo esca sminuito da questi paralleli. La resurrezione delle credenze secolari sotto forma apparentemente scientifica seduce gli spiriti bisognosi d’una fede. Il mito può sembrare prefigurazione della verità, cosí come l’idea moderna può sembrare sopravvivenza di sogni metafisici. L’esaltazione del proletariato in quanto tale non è fenomeno universale. Vi si potrebbe distinguere piuttosto un segno del provincialismo francese. Là dove regna la “Fede nuova”, oggetto del culto è il partito, piú che il proletariato. Nei paesi in cui prevale il laburismo gli operai delle fabbriche, diventati piccoli borghesi, non interessano piú gli intellettuali e non s’interessano piú delle ideologie. Il miglioramento delle loro condizioni di vita toglie loro il prestigio della sofferenza e li sottrae alla tentazione della violenza. (L’oppio degli intellettuali, Editoriale Nuova, Milano, 1978, pp. 73-74)
Ne L’oppio degli intellettuali (il titolo riprende, modificata, la famosa frase di Marx secondo cui la religione è l’oppio del popolo) sottolinea le responsabilità degli intellettuali nella società contemporanea, riprendendo e adattando alla mutata situazione del dopoguerra la polemica di Benda. In questa lettura egli si sente di affermare che il concetto di rivoluzione “non cadrà mai in disuso”, ma osserva preoccupato il persistere del fascino della violenza attraverso il mito della rivoluzione:
Il concetto di rivoluzione, il concetto di sinistra, non cadrà mai in disuso. È l’espressione di una nostalgia che durerà quanto l’imperfezione intrinseca nella società umana e il desiderio degli uomini di riformarla. Non che il desiderio di miglioramento sociale conduca sempre logicamente allo spirito rivoluzionario. È necessaria anche una certa dose d’ottimismo e d’impazienza. I rivoluzionari sono riconoscibili per il loro odio contro il mondo e per la loro mentalità catastrofica; piú spesso ancora peccano di ottimismo. Tutti i regimi sono condannabili, se vengono paragonati a un ideale astratto d’eguaglianza o di libertà. Soltanto la rivoluzione, in quanto avventura, o un regime rivoluzionario, poiché fa uso permanente della violenza, sembrano capaci di conseguire il fine ultimo. Il mito della rivoluzione serve di rifugio al pensiero utopistico, diventa il misterioso e imprevedibile mediatore tra reale e ideale.
La violenza, piú che destare ripugnanza, attrae e affascina. Il laburismo, la “società scandinava senza classi” non hanno mai destato nella sinistra europea, e francese in particolare, gli stessi entusiasmi suscitati dalla rivoluzione russa, nonostante la guerra civile, gli orrori della collettivizzazione e della grande purga. Bisogna dire: nonostante, o: proprio per questo? Le cose a volte procedono come se il costo della rivoluzione fosse segnato a credito anziché a debito dell’impresa. Nessun uomo è tanto irrazionale da preferire la guerra alla pace. Questa osservazione di Erodoto andrebbe adattata alle guerre civili. Il romanticismo della guerra civile séguita a vivere nonostante le segrete della Lubianka. Certe volte viene da chiedersi se il mito della Rivoluzione non giunga a identificarsi, in fondo, con il culto fascista della violenza. Nel finale del dramma di Sartre Le Diable et le bon Dieu, Goetz esclama: “Ecco, il regno dell’uomo comincia. Bell’inizio. Suvvia, Nasty, farò da boia e da carnefice… C’è una guerra da fare, e la farò”. Il regno dell’uomo è dunque quello della guerra? (L’oppio degli intellettuali, Editoriale Nuova, Milano, 1978, pp. 70-71)
L’intelligenza, l’amore per la filosofia e l’ambizione di riuscire avvicinavano Raymond Aron e Jean-Paul Sartre, ma tutto li ha separati, a cominciare dall’impegno politico. Man mano che Sartre andava verso l’estrema sinistra, Aron si ancorava ad un conservatorismo tanto prudente quanto arcigno. Da un lato, il genio prolifico di Sartre, “l’intellettuale totale” secondo la definizione di Pierre Bourdieu, ricercatore frenetico di una morale della libertà il cui magistero accompagnerà molte generazioni di giovani nei loro entusiasmi, speranze e follie. Dall’altro, lo studioso disciplinato, l’intellettuale sobrio e serio se non noioso, e che sarà l’analista scettico della società liberale. Secondo le parole del filosofo François George, «Aron mostrava la storia com’era, mentre Sartre la disegnava come avrebbe dovuto essere». Questi inseguiva il principio di piacere, quello indicava, severo, il principio di realtà. Dopo la morte di Sartre, nel 1980, la rotta del gauchisme ed il fallimento dei maîtres à penser, le incertezze delle ideologie contemporanee hanno fatto avvicinare a Raymond Aron molti giovani intellettuali che lo avevano fino ad allora ignorato se non osteggiato. Dopo la pubblicazione di un libro di interviste, Le Spectateur engagé (Lo spettatore impegnato), nel 1982, e quella delle sue Memorie nel settembre 1983, un omaggio quasi unanime fu reso al rigore del suo pensiero ed al suo fatalismo ben temperato. Quando morì, nel 1983, la Francia era in preda ad un accesso di “aronismo”.
EVANDRO AGAZZI

VITA E OPERE
Evandro Agazzi è nato a Bergamo il 23 ottobre l934. Dopo aver compiuto gli studi di filosofia presso l’Università Cattolica di Milano e di fisica presso la Statale della stessa città, si è perfezionato a Oxford, a Marburg e a Münster. Dal 1963 è stato libero docente in Filosofia della scienza e dal l966 in Logica matematica: ha insegnato, come incaricato di Geometria superiore, Logica matematica e Matematiche complementari presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Genova; ha insegnato anche Logica simbolica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Filosofia della Scienza e Logica matematica presso la Cattolica di Milano. Dal 1970 è professore ordinario di Filosofia della scienza presso l’Università di Genova e dal l979 tiene la cattedra di Antropologia filosofica, Filosofia della scienza e Filosofia della natura presso l’Università di Fribourg. È stato professore invitato nelle Università di Berna, Ginevra, Düsseldorf, Pittsburgh e Stanford ed è dottore honoris causa dell’Università di Cordoba (Argentina). Ha presieduto numerose associazioni filosofiche nazionali e internazionali: Società filosofica italiana, Società italiana di Logica e Filosofia delle scienze, Società svizzera di Logica e Filosofia delle scienze, Federazione internazionale delle Società filosofiche ed ha svolto funzioni direttive in molte altre. Attualmente è presidente dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences e dell’Institut International de Philosophie e membro del Comitato Nazionale Italiano di bioetica. Agazzi è autore e curatore di parecchi volumi di logica e di filosofia della scienza, nonché di circa cinquecento articoli e saggi apparsi in atti di congressi, pubblicazioni collettive, enciclopedie, dizionari, riviste specializzate. Tra le sue opere principali ricordiamo: Introduzione ai problemi dell’assiomatica, l961; La logica simbolica, l964; Temi e problemi di filosofia della fisica, l969; Le geometrie non euclidee e i fondamenti della geometria, 1978; Weisheit im Technischen, l986; Filosofia, scienza e verità, l989; Il bene, il male, la scienza, l992; Cultura scientifica e interdisciplinarità, l994; Filosofia della natura, scienza e cosmologia, l995. Tra le opere da lui curate sono da segnalare: I sistemi tra scienza e filosofia, l978; Studi sul problema del significato, l979; Modern Logic. A Survey, l981; Storia delle scienze, l984; Probability in the Sciences, l988; Logica filosofica e logica matematica, l990; Quale etica per la bioetica, l990; The Problem of Reductionism in Science, l99l; Bioetica e persona, l993; Il tempo nella scienza e nella filosofia, l995; Philosophy and Mathematics Today, l997.
PENSIERO
I settori ai quali Evandro Agazzi ha rivolto prevalentemente i suoi interessi sono stati: la filosofia generale della scienza, la filosofia di alcune scienze particolari (matematica, fisica, scienze sociali, psicologia), logica, teoria dei sistemi, etica della scienza, bioetica, storia della scienza, filosofia del linguaggio, metafisica antropologia filosofica, pedagogia. Le sue ricerche riguardano anche, per un verso, la caratterizzazione dell’oggettività scientifica e la difesa di un “realismo scientifico” basato su un approfondimento delle nozioni di riferimento e di verità, con le relative implicazioni di tipo ontologico; per un altro, l’approfondimento del concetto di persona e delle varie conseguenze che ne derivano, in particolare nel campo della bioetica.
La riflessione di Agazzi assume come punto di partenza la necessità gnoseologica di stabilire nella conoscenza scientifica “la più perfetta forma di conoscenza oggi a disposizione dell’uomo”. Su questa base, anche i metafisici devono necessariamente passare per l’epistemologia, intesa come fondazione delle “strutture metodologiche della scienza”. L’epistemologia come la intende Agazzi assume la scienza come un sapere oggettivamente rigoroso: ma l’oggettività in questione non è quella metafisica delle essenze o quella fisica delle qualità, bensì un’oggettualità e intersoggettività. Sulla base di questi due punti, come Agazzi specifica in Temi e problemi di filosofia della fisica, l’oggetto di una disciplina scientifica è la cosa, esaminata da un punto di vista tale per cui il ricercatore si pone grazie a una precisissima impostazione metodologica, tramite la quale ritaglia su una cosa un aspetto (oggettività), condiviso dai ricercatori che accettano gli stessi criteri di oggettivazione (intersoggettività). Il rigore scientifico cessa di essere inteso in senso dialettico e confutatorio o in senso matematico e quantitativo: è piuttosto inteso nel senso di dar ragione tramite l’immediato empirico o il mediato logico. In questa prospettiva, la scienza assume la forma di un linguaggio che parla di un universo di oggetti. La configurazione della scienza è caratterizzata da quattro peculiarità: a) è realistica, giacché fa costante riferimento alla realtà; b) è relativa, giacché costituisce il proprio oggetto; c) è rigorosa, giacché ha una valenza che è sia logica sia linguistica; d) è responsabile, giacché si pone il problema etico delle conseguenze che da essa scaturiscono. Per Agazzi, la filosofia non deve però limitarsi a fare queste riflessioni sulla scienza: deve anche operare un’incessante “ricerca del fondamento”, sia attraverso la critica dello scientismo e dell’ideologismo, sia attraverso la proposta di quello che Agazzi chiama un “uso costruttivo della ragione: quello che si avvale dell’argomentazione, quello che cerca di comprendere e, al massimo, di persuadere” (I compiti della ragione).
ALBERTO CARACCIOLO

A cura di Biografieonline.it e Diego Fusaro
Alberto Caracciolo nacque il 22 gennaio 1918 a San Pietro di Morubio, in provincia di Verona, dove il padre Ferdinando era medico: ad appena tre anni perse la madre, ma ebbe nel padre
una guida affettuosa, un esempio di rettitudine e di generosità. Compì gli studi liceali a Verona e frequentò l’Università a Pavia, come alunno del Collegio Ghislieri. Qui conobbe il futuro martire della Resistenza, Teresio Olivelli col quale collaborò, scrivendo per i Quaderni del “Ribelle”, e del quale stese, per incarico del Rettore e degli amici del Ghislieri, una significativa biografia.
Alberto Caracciolo iniziò già nel 1940 la carriera di insegnante di italiano e latino nei licei: fu prima a Pavia, poi a Lodi e Brescia.
Nel 1951, ottenuta la libera docenza in Estetica, fu chiamato all’Università di Genova, dove percorse la sua lunga e prestigiosa carriera accademica: docente inizialmente di Estetica, vinse la prima cattedra in Italia di Filosofia della Religione, per passare infine alla cattedra di Teoretica. Queste tre prospettive e questi tre ambiti di ricerca corrispondono a tre momenti fondamentali dello sviluppo della sua ricca riflessione scientifica.
Nel campo estetico, egli si è confrontato soprattutto con il pensiero di Croce, Kant e Heidegger, elaborando una sua autonoma prospettiva, il cui tema di fondo è l’idea della verità nel dominio del poetico; nell’ambito della filosofia della religione si è inserito con originalità nella linea del liberalismo religioso; alla luce di questo orientamento di pensiero ha proposto una visione del Religioso come struttura costitutiva della coscienza; nel campo più propriamente teoretico, colloquiando in particolare con Leopardi, Kant, Jaspers e Heidegger, ha ripensato l’esistenza umana nell’orizzonte del nichilismo, e ha offerto di quest’ultimo un’interpretazione originale e profonda.
Importante anche la sua opera di organizzatore di cultura come attestano: i seminari dedicati a “Musica e Filosofia” (in collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova), e ai “Problemi del linguaggio teatrale” (in collaborazione con il Teatro Stabile di Genova); i tre Convegni su “L’esperienza dell’assenza di Dio nella cultura moderna”, “Anima bella e moi haïssable”, “Il problema della sofferenza inutile”; le molte conferenze programmate in collaborazione con il Goethe-Institut di Genova e con l’Istituto di Filosofia dell’Università.
Il suo pensiero e la sua opera occupano una posizione singolare nel panorama della filosofia italiana della seconda metà del Novecento; singolare come la sua personalità fine e schiva, umanamente mite e aperta, ma fortissima nella difesa della libertà del pensiero e dell’autonomia dell’insegnamento, aliena da ogni cedimento alla seduzione della moda e degli “ismi” dominanti, fedele a una concezione severa della vita. Lavorò fin che lo colse di notte, improvvisa, la morte il 4 ottobre 1990, non molto dopo aver stilato il suo ultimo appunto: “Dal 4 ottobre ’90 letture e appunti per un progetto di ricerca sul tema dell’uguaglianza”. Le sue opere più importanti sono La religione come struttura e come modo autonomo della coscienza (1966), Religione ed eticità. Studi di filosofia della religione (1971), Nulla religioso e imperativo dell’eterno (1991, postumo). Proprio come la spazialità e la temporalità kantianamente intesi, anche la religione, per Caracciolo, è un “modo” della coscienza umana; ma, alla stregua dell’arte e della filosofia, la religione è anche una “struttura” della coscienza umana. Intendendo la religione come “struttura e modo autonomo della coscienza”, Caracciolo assume la filosofia della religione come una riflessione avente per obiettivo l’attingimento della dimensione trascendentale della religiosità. In questa cornice, la filosofia della religione è filosofia in senso autentico: ma è anche religione in senso autentico. Infatti, la filosofia della religione rispetta la dimensione trascendentale della filosofia e, al contempo, attinge strutture e modi del religioso, che sta alla base delle varie religioni. In Religione ed eticità (p. 109), il filosofo veneto ha efficacemente compendiato il proprio pensiero in questo modo:
“La filosofia della religione non ha per proprio oggetto questa o quella religione, nemmeno una reale o presunta religione ‘assoluta’, bensì la religione intesa come un ‘modo’ e una ‘struttura’ costitutivi della coscienza dell’uomo […] un modo in virtù del quale sono possibili le religioni e, anche fuori delle religioni, è possibile, anzi necessario, uno specifico atteggiarsi religioso dell’uomo; una ‘struttura’ in forza della quale ogni possibile determinarsi dell’uomo […] assume necessariamente respiro e orizzonte religioso”.
ITALO MANCINI
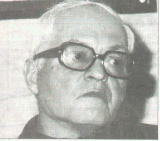
Italo Mancini (1925-1993) si è formato all’Università Cattolica di Milano alla scuola di Gustavo Bontadini (ordinario di Filosofia e poi di Filosofia del Diritto nell’Università di Urbino). Fondatore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose, fu l’unico a rappresentare il coraggioso ritorno della teologia nell’Università italiana, dopo un secolo e mezzo di estradizione e volontario esilio. Ha introdotto D. Bonhoeffer (Bonhoeffer, 1969; Studi introduttivi all’Etica e a Resistenza e Resa, 1969), a ridosso della contestazione studentesca, che ne sentì l’influsso in modo consistente. Tra i filosofi, ha dedicato massima cura a Kant, genio della domanda metafisica (Guida della Ragion pura, 1982). La sua Filosofia della religione ha aperto una strada molto frequentata in questo campo di studi, stabilendo in modo rigoroso quale e quanta filosofia il kerigma sopporti, senza nessuna filosofia. A questo tema va congiunta la Filosofia della prassi(1986) e, con visione globale, L’Ethos dell’occidente (1989): così vengono indicate le due linee della sua elaborazione filosofica. Quella teologica, come fedeltà al senso “paradossale” di Dio (Pascal, Doestoevskij, Barth), rigorizzata come logica dei “doppi pensieri“, e quella giuridica, come fedeltà alle forme etiche, nel preciso nesso, stabilito da Hegel, di morale e diritto. Pensatore presente ai fronti di lotta della gente, Mancini ha portato avanti un confronto spregiudicato con le culture, soprattutto con quella marxista (in rilievo Ernst Bloch), particolarmente con Teologia, ideologia, utopia (1974), Novecento Teologico (1977), Il pensiero negativo e la nuova destra (1983), dove emerge il criterio delle dignità delle ideologie e l’indicazione della prassi efficace per alleggerire la terra. Nell’opera postuma Diritto e Società (1993) è ricorrente il tema dei diritti umani e cosmici, dei diritti all’utopia e alla resistenza della pace e delle democrazia, in cui si sogna “il sogno diurno di una società pacificata”. Tutta la riflessione sviluppata da Mancini può essere letta in chiave ermeneutica: essa assume come punto di partenza una posizione ontologica, che costituisce il momento di precomprensione della sua ricerca ermeneutica; quest’ultima si connota come filosofia della religione, ossia eremeneutica del problema teologico, e filosofia del diritto, ossia ermeneutica del problema etico e sociale. In Filosofia della religione (p. 7), Mancini sostiene esplicitamente che “la filosofia è sempre ‘filosofia di’ e mai filosofia come assoluto astratto”, giacché “i conti con l’essere vanno fatti attraverso settori particolari e specifici”. Sulla scia di queste considerazioni, Mancini può affermare, nel suo Breve discorso del metodo (1974, p. 17):
“Filosofia è l’ermeneutica del senso, soprattutto come dato storico, affinché diventi significato, ossia decisione, attraverso il confronto culturale che supera il piano meramente memorativo, in forza della valutazione (momento teoretico) e dell’incidenza pratico-politica (momento pratico). Confronto critico di forme pratiche, per portare il senso (il dato, potremmo dire) al valore del significato”.
A questo obiettivo ha mirato l’intera riflessione di Mancini: essa trova la sua più alta espressione nella filosofia della religione a caratterizzazione kerygmatica. Come scrive in Teologia, ideologia, utopia, è propriamente un’ermeneutica della religione, quest’ultima concepita come “rivelazione storicamente data, e cioè identificata con il kerygma”: ed è anche un’ermeneutica della filosofia della religione, consistente nella “impresa trascendentale che la religione stessa compie per individuare e strutturare la sua logica”. Dalla scuola di Mancini, raccolta intorno all’Istituto superiore di scienze religiose dell’Università di Urbino e alla rivista “Hermeneutica”, provengono Piergiorgio Grassi e Graziano Ripanti.
ARNOLD JOSEPH TOYNBEE

A cura di Federico Leonardi
Vita
Nato nel 1889 in una famiglia alto-borghese dell’epoca vittoriana, Arnold Joseph Toynbee è avviato precocemente agli studi classici: a sette anni comincia lo studio del latino, a dieci quello del greco; la madre, una delle prime donne a compiere gli studi universitari in Gran Bretagna, si laurea in storia moderna e avvia il figlio alla conoscenza della storia inglese. Nel 1901 il piccolo Arnold accede alla più prestigiosa scuola di allora, il Winchester College, dove familiarizza con molte lingue moderne. Il passo successivo è costituito dal Balliol College di Oxford, nato con la missione di formare la classe dirigente dell’Inghilterra con un duro curriculum intensivo quadriennale di letteratura, storia e filosofia antica, che frequenta dal 1907 al 1911. Qui viene notato da uno dei suoi insegnanti, Gilbert Murray, il grande grecista, la cui visione del ruolo decisivo della religione per comprendere il mondo classico lascerà un profondo segno sul giovane allievo. Dopo aver pubblicato un articolo di taglio filologico su Erodoto, gli viene offerto un posto di insegnante e tutor di filologia classica, che non ricopre subito perché vince una borsa di studio annuale che gli consente di viaggiare fra il settembre 1911 e l’agosto del 1912 per l’Italia e la Grecia, viaggio che affronta spesso a piedi, a volte in compagnia, più spesso da solo. Vuole vedere con i suoi occhi i luoghi che furono teatro della storia greca e romana, cercando di entrare in empatia con essi, tanto da avere alcune intuizioni sugli eventi cardine del passato; viaggiando a piedi, comincia lentamente ad apprezzare la differenza fra i paesaggi selvaggi e quelli invece plasmati dall’uomo, grazie alla quale comincia a ragionare sull’origine e il senso della civiltà. Preso finalmente servizio a Oxford nel 1912, comincia a tenere corsi e seminari, ma avverte anche un profondo iato fra il proprio metodo e quello meramente accademico. Analizzando le guerre puniche in un lungo corso fra il 1913 e il 1914, allarga lo sguardo fino a comprendere tutte le realtà politiche dell’epoca, dal Mediterraneo fino alle porte dell’India, fra loro interconnesse: si profila già qui la sua visione sistemica dei problemi; e poi fino a indagare gli effetti di lunga durata di quelle guerre sul paesaggio, sul modo di vivere, sul costume. In quest’ottica sistemica progetta di scrivere una storia greca a partire dall’origini fino alla fine dell’impero bizantino. Lo scoppio della prima guerra mondiale e la sua escalation pone davanti ai suoi occhi di interprete una analogia via via più stringente con Tucidide, mentre lo commenta ai suoi studenti. E’ in quei momenti che ha l’intuizione della contemporaneità delle civiltà: “Qualunque cosa la cronologia potesse dire, il mio mondo e il mondo di Tucidide dimostravano di essere contemporanei. E se questa era la vera relazione fra la civiltà Greco-Romana e la civiltà Occidentale, non poteva darsi che fra tutte le civiltà da noi conosciute si rivelasse una relazione medesima?” (Civiltà al paragone).
Toynbee svolge il suo servizio durante la guerra presso la propaganda governativa, in particolare come analista della situazione mediorientale. In quegli anni escono: Nationality and the War e una dura denuncia delle atrocità turche, The treatement of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, che negli intenti del governo inglese dovrebbe contribuire a spingere gli USA in guerra. Lasciata ufficialmente la cattedra di Oxford, entra nel dipartimento di intelligence del governo e nel 1919 è membro ufficiale della delegazione inglese agli accordi di pace di Versailles. Intanto una iniziativa concertata di facoltosi privati e del governo greco dà vita al King’s College di Londra alla cattedra “Koraes” di storia e cultura bizantina e della Grecia moderna, che Toynbee viene chiamato a ricoprire.
L’esperienza della guerra lo segna come segna tutta quella generazione. L’idea dell’agonia della civiltà, che anima molti dibattiti, ha il suo culmine nel Tramonto dell’Occidente di Spengler, opera che ha su Toynbee una profondo impatto, misto di ispirazione e di delusione. Ispirazione perché in essa trova teorizzato il metodo analogico, la comparazione fra le civiltà, contro la continuità storica di epoche che procedono verso il progresso; delusione invece non solo perché non viene spiegata la nascita delle civiltà ma anche perché il fatalismo le lega al ciclo che va dalla nascita alla morte.
In una conferenza del 1920, The tragedy of Greece, infatti Toynbee teorizza la necessità dell’analogia, per esempio fra l’antichità e l’oggi, per comprendere la storia, in quanto guardando l’una con gli occhi dell’altra si riesce a guadagnare la distanza prospettica per mettere a fuoco il fenomeno. La comparazione esplicita con la rivoluzione bolscevica permette di vedere più a fondo nel crollo dell’impero romano, dovuto alla crescente spaccatura fra una minoranza dominante e un proletariato interno. La storia greca viene paragonata a una tragedia in tre atti: 1) nascita e sviluppo dall’undicesimo secolo al 431 a.C., ovvero fino alla crisi interna della guerra del Peloponneso 2) il caos dal 431 al 31 a.C., fino alla pacificazione e unificazione sotto Augusto 3) la lunga decadenza e il crollo fino al settimo secolo d.C. L’incarico presso la cattedra “Koraes” gli consente di viaggiare fra Grecia e Turchia, approfondendo e mettendo alla prova la sua visione sistemica e analogica dei fenomeni storici, proprio nel momento in cui la Grecia, approfittando della disgregazione dell’impero ottomano estende il suo dominio sulla regione di Smirne, salvo poi essere risospinta indietro dall’azione di Atatürk, che fonda poi la Turchia moderna. Risultato di questa esperienza è The Western Question in Greece and Turkey: a Study in the Contact of Civilizations, che fa esplodere violente polemiche a causa delle denunce delle atrocità greche in Turchia: nel 1924 Toynbee lascia l’incarico. Nel 1925 ottiene la cattedra di Storia Internazionale presso l’Università di Londra che tiene solo pochi anni, per poi passare, in qualità di direttore degli studi, presso il Royal Institut of International Affairs, dove ogni anno si impegna a pubblicare, insieme al gruppo di studiosi dell’Istituto, un’ampia panoramica della politica mondiale e dell’evoluzione delle relazioni internazionali.
Ormai cerca di ritagliarsi sempre più tempo per dedicarsi all’opus magnum per cui si sente maturo. Intensifica le letture e comincia a scrivere un’opera monumentale che spazia in tutte le civiltà conosciute, morte e vive, una filosofia della storia intitolata A Study of History, complessivamente in 12 volumi. I primi sei volumi escono fra il 1934 e il 1939. Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo vede di nuovo impegnato al servizio del governo inglese, con vari incarichi presso il Foreign Office, fino a che nel 1946 non è ancora fra i membri della delegazione inglese nella Conferenza di pace di Parigi. Lo stesso 1946 è l’anno in cui un suo collega, Sommervell, redige un riassunto, poi approvato da Toynbee, dei sei volumi, che dà all’autore una grande fama in Inghilterra e poi negli successivi negli USA: mai dei libri di storia avevano avuto vendite così alte.
Si cerca nell’opera di Toynbee la risposta ai gravi problemi suscitati dalla seconda guerra mondiale e poi dall’aprirsi della guerra fredda: l’Occidente è destinato alla sconfitta oppure può rigenerarsi? In questa atmosfera da passaggio epocale, A Study of History conosce anche molti studi specialistici: si possono citare i due più celebri, la tesi di laurea di Henry Kissinger, e quella dottorale di Ivan Illich. Su entrambi Toynbee lascia una influenza profonda.
Escono poi i volumi 6 e 7, poi nel 1954 ottavo, nono, decimo, i quali chiudono il piano dell’opera. Con la fama arrivano anche le critiche, soprattutto al tentativo, ritenuto titanico ed eccessivo, di ripensare la storia universale, tentando addirittura di uscire da un paradigma eurocentrico, confrontandosi con la lingua, i costumi, la storia di altre civiltà. Con il volume undicesimo escono mappe e tabelle, invece il dodicesimo e ultimo (1961) costituisce insieme a una risposta ai critici anche un tentativo di bilancio e di ripensamento dei temi centrali.
Nel frattempo, nel 1955, Toynbee lascia la direzione dell’Istituto, che ha tenuto per trent’anni. Scrive ancora moltissimo, tiene conferenze in tutto il mondo. Ha ancora molti progetti da portare a termine, in particolare quello sulla visione complessiva del mondo greco-romano che comprenda anche il mondo bizantino. Le sue ultime monografie storiche infatti sono: Hellenism. History of a Civilization (1959), una visione sintetica della civiltà greco-romana; Hannibal’s Legacy, due volumi sulle conseguenze delle guerre puniche e le origini dell’impero romano; Some problems of Greek History (1969), su varie questioni, dalle origini delle civiltà greca fino a una indagine sui motivi della sua mancata unificazione politica; Constantine Porphirogenitus and his World (1973), sul X secolo, il periodo d’oro dell’impero bizantino.
Toynbee muore nel 1975. Postumo uscirà Mankind and Mother Earth, A Narrative History of the World, uno sforzo di sintesi della storia universale, trattata non più per temi, ma secondo la sua scansione cronologica.
Opere
Nationality and the War, Dent, 1915
The Armenian Atrocities, The Murder of a Nation, with a speech delivered by Lord Bryce in the House of Lords, Hodder & Stoughton, 1915
The New Europe, Some Essays in Reconstruction, with an Introduction by the Earl of Cromer, Dent, 1915
Contributor, Greece, in The Balkans, A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey, various authors, Oxford, Clarendon Press, 1915
Editor, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-16: Documents Presented to Viscount Grey of Fallodon by Viscount Bryce, with a Preface by Viscount Bryce, Hodder & Stoughton and His Majesty’s Stationery Office, 1916
The Belgian Deportations, with a statement by Viscount Bryce, T Fisher Unwin, 1917
The German Terror in Belgium, An Historical Record, Hodder & Stoughton, 1917
The German Terror in France, An Historical Record, Hodder & Stoughton, 1917
Turkey, A Past and a Future, Hodder & Stoughton, 1917
The Western Question in Greece and Turkey, A Study in the Contact of Civilizations, Constable, 1922
Introduction and translations, Greek Civilization and Character, The Self-Revelation of Ancient Greek Society, Dent, 1924
Introduction and translations, Greek Historical Thought from Homer to the Age of Heraclius, with two pieces newly translated by Gilbert Murray, Dent, 1924
Contributor, The Non-Arab Territories of the Ottoman Empire since the Armistice of the 30th October, 1918, in HWV Temperley, editor, A History of the Peace Conference of Paris, Vol 6, OUP, Issued under the auspices of the British Institute of International Affairs, 1924
The World after the Peace Conference, Being an Epilogue to the “History of the Peace Conference of Paris” and a Prologue to the “Survey of International Affairs, 1920-1923”, OUP, Issued under the auspices of the British Institute of International Affairs, 1925
With Kenneth P Kirkwood, Turkey, Benn, in Modern Nations series edited by HAL Fisher, 1926
The Conduct of British Empire Foreign Relations since the Peace Settlement, OUP, Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, 1928
A Journey to China, or Things Which Are Seen, Constable, 1931
Editor, British Commonwealth Relations, Proceedings of the First Unofficial Conference at Toronto, 11-21 September 1933, with a Foreword by Robert L Borden, OUP, Issued under the joint auspices of the Royal Institute of International Affairs and the Canadian Institute of International Affairs, 1934
A Study of History
Vol I: Introduction; The Geneses of Civilizations
Vol II: The Geneses of Civilizations
Vol III: The Growths of Civilizations
OUP, 1934 (trad. it., solo dei primi due volumi, Panorami della storia, Milano, 1954-1955)
Editor, with JAK Thomson, Essays in Honour of Gilbert Murray, George Allen & Unwin, 1936
A Study of History
Vol IV: The Breakdowns of Civilizations
Vol V: The Disintegrations of Civilizations
Vol VI: The Disintegrations of Civilizations
OUP, 1939
DC Somervell, A Study of History, Abridgement of Vols I-VI, with a Preface by Toynbee, OUP, 1946
Civilization on Trial, OUP, 1948 (trad. it. Civiltà al paragone, Milano, 1983)
The Prospects of Western Civilization, New York, Columbia University Press, by arrangement with OUP, 1949
Albert Vann Fowler, editor, War and Civilization, selections from A Study of History, with a Preface by Toynbee, New York, OUP, 1950
Introduction and translations, Twelve Men of Action in Graeco-Roman History, Boston, Beacon Press, 1952 (Extracts from Thucydides, Xenophon, Plutarch and Polybius.)
The World and the West, OUP, 1953 (trad. it. Il mondo e l’Occidente, Palermo, 1993)
A Study of History
Vol VII: Universal States; Universal Churches
Vol VIII: Heroic Ages; Contacts between Civilizations in Space
Vol IX: Contacts between Civilizations in Time; Law and Freedom in History; The Prospects of the Western Civilization
Vol X: The Inspirations of Historians; A Note on Chronology
OUP, 1954
An Historian’s Approach to Religion, OUP, 1956 (Based on Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh in 1952 and 1953.) (trad. it. Storia e religione, Milano, 1984)
DC Somervell, A Study of History, Abridgement of Vols VII-X, with a Preface by Toynbee, OUP, 1957
Christianity among the Religions of the World, New York, Scribner, 1957; London, OUP, 1958
Democracy in the Atomic Age, Melbourne, OUP, Issued under the auspices of the Australian Institute of International Affairs, 1957
East to West, A Journey Round the World, OUP, 1958
Hellenism, The History of a Civilization, OUP, Home University Library, 1959 (trad. it. Il mondo ellenico, Torino, 1967)
With Edward D Myers, A Study of History, Vol XI: Historical Atlas and Gazetteer, OUP, 1959
DC Somervell, A Study of History, Abridgement of Vols I-X combined in one volume, with a new Preface by Toynbee and new tables, OUP, 1960 (trad. it. -parziale- Le civiltà nella storia, Torino, 1950, a cura di Cesare Pavese!; trad. it. -integrale- Storia comparata delle civiltà, 3 voll., Roma, 1974)
A Study of History, Vol XII: Reconsiderations, OUP, 1961
Between Oxus and Jumna, OUP, 1961
The Present-Day Experiment in Western Civilization, OUP, 1962
America and the World Revolution, OUP, 1962
The Economy of the Western Hemisphere, OUP, 1962 (The three sets of lectures published separately in the UK in 1962 appeared in New York in the same year in one volume under the title America and the World Revolution and Other Lectures, OUP.)
Universal States, New York, OUP, 1963 (Separate publication of part of Vol VII of A Study of History.)
Universal Churches, New York, OUP, 1963 (Separate publication of part of Vol VII of A Study of History.)
With Philip Toynbee, Comparing Notes, A Dialogue across a Generation, Weidenfeld & Nicolson, 1963 (trad. it. L’urto tra i padri e i figli, Milano, 1964)
Between Niger and Nile, OUP, 1965
Hannibal’s Legacy, The Hannibalic War’s Effects on Roman Life
Vol I: Rome and Her Neighbours before Hannibal’s Entry
Vol II: Rome and Her Neighbours after Hannibal’s Exit
OUP, 1965 (trad. it. L’eredità di Annibale, Torino, 1981-1983)
Change and Habit, The Challenge of Our Time, OUP, 1966
Acquaintances, OUP, 1967
Between Maule and Amazon, OUP, 1967
Editor, Cities of Destiny, Thames & Hudson, 1967 (trad. it. Le città del destino, Roma, 1069)
Editor and principal contributor, Man’s Concern with Death, Hodder & Stoughton, 1968
Editor, The Crucible of Christianity: Judaism, Hellenism and the Historical Background to the Christian Faith, Thames & Hudson, 1969
Experiences, OUP, 1969
Some Problems of Greek History, OUP, 1969
Cities on the Move, OUP, 1970 (trad. it. La città aggressiva, Bari, 1972)
Surviving the Future, OUP, 1971
With Jane Caplan, A Study of History, new one-volume abridgement, with new material and revisions and, for the first time, illustrations, Thames & Hudson, 1972
Constantine Porphyrogenitus and His World, OUP, 1973 (trad. it. Costantino Porfirogenito e il suo mondo, Milano, 1977)
Editor, Half the World, The History and Culture of China and Japan, Thames & Hudson, 1973
Toynbee on Toynbee, A Conversation between Arnold J Toynbee and GR Urban, New York, OUP, 1974
Mankind and Mother Earth, A Narrative History of the World, OUP, 1976, posthumous (trad. it. Il racconto dell’uomo, Milano, 1977)
With Daisaku Ikeda; Richard L Gage, editor; Choose Life, A Dialogue, OUP, 1976, posthumous (trad. it. Dialoghi. L’uomo deve scegliere, Milano, 1988)
EWF Tomlin, editor, Arnold Toynbee, A Selection from His Works, with an introduction by Tomlin, OUP, 1978, posthumous
The Greeks and Their Heritages, OUP, 1981, posthumous
Christian B Peper, editor, An Historian’s Conscience, The Correspondence of Arnold J Toynbee and Columba Cary-Elwes, Monk of Ampleforth, OUP, Boston, Mass, 1987, posthumous
A Study of History
Toynbee fin da giovane si convince che per comprendere qualsiasi fenomeno storico occorre collocarlo nell’insieme di altri fenomeni che influiscono su di esso e che quindi non può darsi storia se non come storia universale. Per questo i suoi autori sono Vico, Ranke, Meyer.
Forte della sua esperienza di consulente del governo inglese per il Medio Oriente, dell’incarico di direttore dell’Istituto di Affari Internazionali e della sua ormai vasta competenza di storia greca e romana, matura l’idea di scrivere uno studio che codifichi e studi tutte le civiltà, vive e morte, il ritmo di nascita-sviluppo-decadenza-disgregazione, le eventuali filiazioni dell’una rispetto all’altra, gli imperi e le chiese universali, concepiti sulla scia di Spengler (anche se quest’ultimo ha quasi tralasciato il ruolo delle religioni nel suo studio) come istituzioni che, collocandosi proprio nella fase della disgregazione, arrestano temporaneamente l’auto-lacerazione nel corpo sociale, grazie alla pacificazione imposta dall’esterno da una minoranza dominante; poi i contatti fra le civiltà nello spazio (in un processo a ritroso fra Occidente e le altre civiltà, poi fra civiltà ellenica e le altre civiltà antiche) e nel tempo (i rinascimenti, che sgorgano dall’incontro fra una società ancora viva e una ormai morta, ad esempio fra l’Europa del Quattrocento e la cultura greca, che vi giunge dopo la caduta di Bisanzio); infine, a mo’ di conclusione, una disamina del rapporto fra determinismo e libertà nella storia e poi un volume specifico sulle prospettive dell’Occidente, dato che esso ha dal Cinquecento in poi dominato tutte le altre civiltà ma ora la sua supremazia è al tramonto ed è in corso una reazione all’occidentalizzazione, nonostante l’aspetto principale di essa, la tecnologia, sia nelle mani di tutti, che la sfruttano e la riprendono. Il frutto di questa visione poderosa della storia è A Study of History, in 12 volumi usciti fra il 1934 e il 1961 (i primi dieci esauriscono il piano dell’opera, mentre gli ultimi due contengono rispettivamente atlanti, tavole comparative, parole chiave e risposte a critici).
Questo è il piano dell’opera:
1) INTRODUZIONE
2) COME NASCONO LE CIVILTA’
3) COME SI SVILUPPANO
4) COME CROLLANO
5) COME SI DISGREGANO
6) STATI UNIVERSALI
7) CHIESE UNIVERSALI
8) ETA’ EROICHE
9) CONTATTI FRA LE CIVILTA’ NELLO SPAZIO
10) CONTATTI FRA CIVILTA’ NEL TEMPO
11) LEGGE E LIBERTA’ NELLA STORIA
12) LE PROSPETTIVE DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE
13) CONCLUSIONI
Dunque per Toynbee le civiltà sono l’autentico soggetto storico e queste, come per Spengler, sono sincroniche e parallele. Rispetto a quest’ultimo però, Toynbee cerca di mostrare alcuni, seppure non univoci, segnali di trascendenza nel ciclo vitale delle civiltà, gli elementi appunto che rallentano la decadenza, che dilazionano la morte e che creano, pur o proprio dileguandosi, una prospettiva, anzi, di più, una base di rinascita: sulle rovine delle istituzioni universali, altri possono trovare stimolo alla creazione di un’altra civiltà. Filiazioni di una civiltà con un’altra, contatti non estemporanei, tensioni universali mostrano dei segnali di trascendenza rispetto al ciclo. Ruolo decisivo assumono dunque le religioni universali, che pur nascendo in epoche di decadenza e di scissione nel complesso sociale, garantiscono una base su cui nascono altre civiltà: il caso su cui Toynbee insiste di più è quello del cristianesimo che si afferma quando il declino del mondo ellenico ha visto sorgere l’impero romano, ma, quando quest’ultimo crollerà decretando la fine di quella civiltà, sarà la linfa per i popoli della Völkerwanderung per costruire un’altra civiltà, quella occidentale appunto.
Seguiamo il piano dell’opera tappa dopo tappa. Il meccanismo attorno al quale ruota l’interpretazione della vita di una civiltà è quello di sfida-risposta: quando un gruppo, che poi costituirà la minoranza dominante, o un uomo solo, un futuro leader, riescono a rispondere alla sfida che le difficoltà dell’ambiente, naturale e/o umano (umano soprattutto nelle fasi più avanzate), lanciano, si dà la civiltà, proprio come soluzione a questi problemi; quando invece non si riesce più a rispondere alle sfide, quando la creatività si sclerotizza e si fissa sulle istituzioni che avevano portato alla vittoria precedente, senza produrre niente di nuovo, si dà la decadenza, quasi una nemesi della creatività originaria. Dunque la nascita delle civiltà avviene quando si sa rispondere alle avversità: 1) paesi difficili 2) territori nuovi, non già plasmati da altri 3) gravi sconfitte subite come stimolo a ripartire 4) la vita ai confini quindi più esposta alle pressioni dall’esterno 5) la condizione di minorazione, emarginazione o schiavitù in un particolare contesto. La vittoria su ostacoli materiali mette le energie della società in grado di di dar risposte a sfide che ormai saranno interne più che esterne, spirituali più che materiali. Questa spiritualizzazione (o “eterizzazione” nel lessico di Toynbee) è un progresso che porta all’autodeterminazione, al di là della determinazione dell’ambiente che fondava la civiltà. Questa fase di sviluppo è contraddistinta dall’azione o di individui creatori o di una minoranza creatrice che hanno un duplice compito: primo la riuscita, la realizzazione della loro ispirazione o scoperta, secondo la conversione della società cui appartengono a questo nuovo modo di vita. Siccome la massa non può partecipare integralmente dell’esperienza degli individui creatori, rispetto alla condivisione interiore si afferma l’imitazione esteriore, una mimesi, che è più meccanica e in perdita rispetto al modello. Il ritiro e ritorno dell’individuo è simile a quello del mito della caverna platonico, quello invece delle minoranze o sotto-società è costituito da una sorta di ritiro, di periodo di incubazione nel quale essa quasi scompare dalla scena della storia per poi ripresentarsi più forte (esempi: Atene prima delle guerre persiane, l’Italia prima del Rinascimento, l’Inghilterra prima del Cinquecento). Lo sviluppo per di più imprime alle civiltà una forte differenziazione fra le parti sociali, sulla base del maggiore o minore avvicinamento al modello creatore; e poi tende a differenziare la civiltà fra loro sulla base della direzione dell’inventiva dei fondatori: arte, religione, industria, ecc. Col passare del tempo cominciano a manifestarsi i segni del crollo: 1) diminuzione o perdita di potenza creatrice nella minoranza, che da creatrice scade a dominante, esercita potere senza il carisma creatore 2) di conseguenza viene meno la fedeltà della maggioranza, che abbandona la, pur meccanica ed esteriore, mimesi 3) quindi si rompe l’unità sociale. Questo è un altro punto nel quale Toynbee si discosta da Spengler e dalla sua visione organicista e determinista. La perdita di controllo sull’ambiente fisico (decadenza tecnica) o umano (decadenza sociale, esempio nel caso dell’impero romano, “barbarie e cristianesimo”, come sosteneva Gibbon – in realtà l’epoca degli Antonini, da lui considerata l’acme dell’antichità, l’età dell’oro, era già una fase di decadenza, il cui crollo la creazione dell’impero poté soltanto procrastinare – per Toynbee come per Spengler l’età dell’impero o del cesarismo è la fase di decadenza in cui il tempo viene come sospeso e il crollo spostato molto in là nel tempo) sono conseguenze non tanto cause del crollo. Causa vera e profonda è nel fallimento dell’autodeterminazione. L’unico modo in cui la maggioranza non creatrice può seguire la guida dei capi creatori è la mimesi, che però si configura come una scorciatoia, essendo meccanica e superficiale, non è basata sul rivivere un’esperienza dall’interno: i capi possono allora scadere anch’essi, quasi per contagio della massa, nel meccanicismo, accomodarsi nell’abitudine e quindi ne risulta una civiltà arrestata; d’altra parte possono sostituire il carisma dell’autorevolezza o della persuasione con l’uso della forza, nel qual caso la minoranza creatrice diventerà dominante e il resto della società una massa proletaria (nel senso di alienata) riluttante a seguire i capi. Quando ciò accade la società è sulla strada della disgregazione, perde la capacità di autodeterminarsi e si indebolisce rispetto alle sollecitazioni esterne (anzi molti cominciano a guardare a modelli esterni e quindi lo scisma si approfondisce). Si aprono due strade possibili, a fronte di un mancato adattamento alle nuove sfide: o la rivoluzione, via molto rischiosa perché si profila come un atto di mimesi ritardato e quindi potenzialmente esplosivo (si impone un modello che invece si sarebbe dovuto seguire prima; qualcuno l’ha bloccato, quindi scoppia la rivoluzione); oppure l’istituzione diventa più spietata nella gestione del potere, soffocando però alla radice la mimesi stessa che teneva unito il complesso sociale. La storia mostra che la tendenza più frequente nei gruppi che felicemente rispondono alle prime sfide, raramente riescono a rispondere alle successive, come se si riposassero sugli allori. E’ quella che Toynbee chiama nemesi della creatività, che ha tre manifestazioni fondamentali: 1) idolizzazione di un io effimero, ovvero quello che ci ha portato alle prime vittorie 2) idolizzazione di un istituto effimero, per esempio la città-stato, alla quale i Greci rimasero legati come a una trappola, non sapendo cogliere gli elementi di novità, che avrebbero richiesto un rinnovamento politico 3) idolizzazione di una tecnica effimera.
Al crollo segue necessariamente la disgregazione? No, può succedere anche una pietrificazione, come capitò anche al mondo ellenico e potrebbe capitare all’Occidente. Il criterio essenziale della disgregazione è lo scisma del corpo sociale in tre frazioni: 1) minoranza dominante (non più creatrice) 2) proletariato interno 3) proletariato esterno. Criticando la visione marxiana per cui dalla lotta di classe fra queste fazioni nascerà un ordine nuovo, Toynbee sostiene a sua volta che ognuna di queste fazioni partorisce una sua creazione caratteristica (la forza creativa si disperde, non è più unificata): la minoranza dominante uno Stato universale, il proletariato interno una chiesa universale, il proletariato esterno bande guerriere barbariche. Minoranze dominanti sono: le figure tiranniche o militariste, oppure i legislatori o gli amministratori che cercano di dare sostanza alle leggi o alla burocrazia che devono tener legato lo stato universale oppure ancora i filosofi che cercano una soluzione teorica a queste società così vaste. Il proletariato interno, costituito da cittadini diseredati o rovinati da catastrofi politiche, popoli vinti o vittime della tratta, raccoglie dunque una massa che si sente mera componente della società, non partecipe, si è rotto il legame con la minoranza creatrice che teneva unito il complesso. Alle reazioni violente e ai tentativi di imporre la rivoluzione con la forza, segue invece la creazione di religioni universali, come giudaismo, zoroastrismo, mitraismo o cristianesimo nel mondo greco-romano. Proletariato esterno: finché una civiltà è in sviluppo, il suo influsso culturale irradia e permea i vicini primitivi a distanza indefinita (vedi l’ellenizzazione e l’ellenismo). Questi divengono parte della maggioranza non creatrice che segue la guida della minoranza creatrice. Ma quando una civiltà è crollata, il potere di irradiazione scema fino all’esaurimento, i barbari (cioè i popoli limitrofi, esclusi dalla cittadinanza) maturano ostilità e si stabilisce una frontiera militare prima temporanea e che poi diventa stazionaria. A questo stadio la pressione dall’esterno fa crollare l’edificio che ormai già scricchiolava: il risultato è che i barbari producono una poesia epica dove protagonista è una banda guerriera che ha lottato contro un nemico molto più forte, vincendo.
La “religioni superiori” o universali pongono però un problema: esse nascono da un influsso di una civiltà straniera, dunque devono essere prese in considerazione almeno due civiltà (quella da cui viene tratta l’ispirazione, quella in cui si radica il nuovo credo), la qual cosa mette in crisi l’idea di partenza per cui le civiltà prese isolatamente costituiscano un “campo intelligibile di studio”.
Lo scisma però, oltre che nel corpo sociale, si profila anche nell’anima di ognuno: ai vari modi di condotta tipici della fase di sviluppo creativo sottentrano sostituti alternativi, uno passivo, l’altro attivo.
1) senso d’abbandono e autocontrollo, sostituti alternativi della creatività 2) diserzione e martirio, sostituti alternativi della disciplina mimetica 3) senso d’andare alla deriva e senso del peccato come sostituti alternativi dello slancio che accompagna lo sviluppo 4) senso di promiscuità e senso dell’unità che sostituiscono il senso dello stile, ovvero il riscontro soggettivo dell’oggettivo differenziamento che accompagna lo sviluppo. Il senso dell’unità produce l’impero universale.
Sul piano della vita ci sono due coppie di varianti alternative nel movimento verso lo spostamento del campo d’azione dal macrocosmo al microcosmo, che è alla base del processo di spiritualizzazione che contraddistingue lo sviluppo: 1) arcaismo e futurismo, che non compiono lo spostamento e generano violenza 2) distacco (spiritualizzazione dell’arcaismo) e trasfigurazione spiritualizzazione del futurismo): il primo è un ritiro dal mondo nella roccaforte dell’anima, il secondo è un’azione dell’anima che produce le religioni universali.
Fra società in disgregazione e individui si danno sei tipi di figure: 1) genio creatore come salvatore, che non danno più risposte felici a sfide successive, ma appaiono come salvatori di o da una società in disgregazione 2) salvatore con la spada, fondatori di stati universali, che risultano essere però effimeri 3) salvatore con la macchina del tempo, arcaisti e futuristi, che, a causa delle armi, incorrono nello stesso destino 4) filosofo mascherato da re, rimedio platonico, che fallisce per l’incompatibilità fra il distacco del filosofo e i metodi coercitivi del tiranno 5) dio incarnato dell’uomo: Cristo.
La disgregazione ha il suo segno nella standardizzazione, una sorta si scimmiottatura della creatività autentica, dove si continua a spremere le vecchie istituzioni e i gli stili di vita conosciuti, senza accorgersi che a problemi nuovi occorrerebbe rispondere in modo nuovo.
Dopo aver analizzato le cause della disgregazione e della scissione, Toynbee esamina i tre corpi in cui una civiltà si scinde nella sua fase terminale, appunto Stati universali, Chiese universali, proletariati esterni (anche detti “bande da guerra barbariche”).
Qui si apre la questione più problematica ma anche più interessante nell’immensa architettura di A Study of History: gli Stati universali devono essere visti come le fasi finali della civiltà oppure come prologhi per successivi sviluppi? Dunque fini o mezzi?
Data la secolare età d’agonia, di caos, di torbidi e di guerre la dominazione tirannica dell’impero viene accolta come soluzione, percepita quasi come salvifica: da qui il senso di immortalità che i suoi abitanti gli attribuiscono, tanto che pare rinascere anche dopo la sua morte, tanto che l’Impero Bizantino o il Sacro Romano Impero sono visti come una sua reincarnazione. Per quanto anche gli imperi siano destinati a crollare, essi preparano il terreno ad altre istituzioni, le chiese universali create dai proletariati interni. Gli Stati universali, imponendo ordine e uniformità, creano un modello di unione e di conduttività sia dei vari stati locali prime in lotta, sia dei vari strati sociali in tensione; fanno poi nascere una sorta di psicologia della pace perché devono comporre in modo tollerante varie visioni del mondo. Molte delle istituzioni create dalle minoranze dominanti risulteranno poi utili a concretizzare la visione ecumenica delle religioni superiori dei proletariati interni: l’esempio più clamoroso – quello anche più seguito da Toynbee come modello di confronto è quello dell’Impero Romano e della Chiesa Cristiana: 1) Comunicazioni: strade e rotte commerciali sempre più estese e ramificate consentono la diffusione di un messaggio come quello cristiano 2) Guarnigioni e colonie: abituano alla mescolanza e al sentimento di uguaglianza 3) Province: l’organizzazione provinciale viene sfruttata dalle chiese 4) Le capitali: una città centrale, percepita come punto di riferimento per molti popoli, diventa, anche quando l’impero è caduto, quartier generale o luogo simbolico di una religione 5) La lingua: la diffusione di una lingua consente insieme alla rete di comunicazione anche la diffusione di un messaggio 6) Il diritto: un sistema di leggi viene usato anche da altri, come ad esempio quello romano usato dai musulmani o dalla Chiesa Cattolica, oppure il Codice di Hammurabi usato da chi ha composto la legge mosaica 7) Eserciti permanenti: l’esercito romano fu modello d’ispirazione per l’idea cristiana della vita come mobilitazione (parabole evangeliche dell’attesa) 8) Amministrazione o burocrazia: modello di organizzazione e fedeltà a un istituzione 9) Cittadinanza: (forse il concetto più interessante e approfondito) pur essendo causa di contesa per chi è escluso da questo diritto, fa nascere e diffonde l’idea di uguaglianza.
Le Chiese universali, dai più considerate elementi patologici e disgregatori, sono comunque il sostegno occulto con cui, sulle rovine di una civiltà disgregata, può nascere una civiltà nuova, figlia della precedente: un esempio è fornito dalla fine dell’Impero Romano, sfruttando le cui istituzioni i barbari che da tempo premevano sui confini e soprattutto avendo come guida e modello vivo la Chiesa Cattolica, nata in seno all’Impero, diedero vita alla civiltà occidentale. Le civiltà da una parte si presentano come preludi, tanto che le Chiese debbono molto della loro architettura concettuale ed organizzativa alle civiltà di partenza, ma anche come regressioni, quando riusano invece, in modo non creativo, ma schematico e semplicemente mutandone il contesto semantico d’uso, i termini tecnici rielaborati creativamente dalle chiese (ad esempio la secolarizzazione di concetti teologici): da questo punto di vista Toynbee legge ed indaga le fratture e il progressivo distacco fra la civiltà occidentale e la Chiesa cattolica dalla quale ha pure tratto origine.
Dopo aver analizzato le cosiddette “Età eroiche”, cioè quella in cui la morte di una civiltà ha lasciato il campo libero a orde barbariche (proletariati esterni) che poi creeranno sulla base di una religione universale (creata dal proletariato interno) una civiltà nuova, si passa ad un’altra parte dell’opera: quella dei contatti fra le civiltà nello spazio e nel tempo, che costituisce una vera e propria filosofia degli incontri-scontri fra i popoli e della conflittualità insita nel loro relazionarsi; per di più questa parte dell’opera segnala un ulteriore elemento di trascendenza del ciclo vitale delle civiltà perché la loro spinta ad uscire da sé lascia dei segni nelle altre, generando comunque, pur in un stimolo reattivo, delle eredità che rimangono al di là della loro morte. Lo studio si concentra, in un procedimento a ritroso: 1) i contatti fra il moderno occidente e la Russia, il corpo principale della cristianità ortodossa, il mondo indù, il mondo islamico, gli ebrei, l’estremo oriente, le civiltà americane indigene: siccome la caratteristica del moderno occidente è quella della classe media, anche le altre hanno cercato di costruire, spesso artificialmente e dall’alto una classe media, che però spesso è diventa una classe rivoluzionaria che si volta contro il potere centrale che l’aveva creata 2) i contatti fra fra l’occidente medievale nel caso delle Crociate, poi con l’aria siriaca e la cristianità greco-ortodossa 3) incontri con la civiltà ellenica post-alessandrina e prealessandrina: è questo una delle parti su cui Toynbee insiste maggiormente, istituendo un amplissimo ventaglio di analogie, che spazia in tutti i campi, fra la diffusione della cultura ellenica in questa fase e l’espansione dell’Occidente nel Cinquecento, grazie alle quali intravvede somiglianze e differenze, ma soprattutto gli consente di tentare una profezia sull’Occidentalizzazione del mondo. Ora riesprimendo con una proporzione l’idea, civiltà ellenica: resto delle civiltà = civiltà occidentale: resto del mondo; siccome il primo è un processo compiuto, il secondo incompiuto il paragone consente sulla base del primo di prevedere il compimento del secondo (molte sono le analogie, metodiche come di contenuto con lo stesso Spengler). Questo discorso per altro viene ripreso in molte altre opere di Toynbee, come Civiltà al paragone o Il mondo e l’Occidente.
Comincia qui una lunga disamina delle grandi guerre e degli incontri-scontri fra “est” e “ovest” a partire dall’assalto dell’impero Achemenita sulla Grecia per arrivare fino al ventesimo secolo, alla reazione opposta all’imperialismo occidentale dai popoli non-occidentali. Prima vengono considerate le vittorie che non conducono alla eliminazione completa dell’avversario o alla sua sottomissione. Dal punto di vista del vincitore: i mezzi con cui si vince una guerra anziché essere smantellati per tornare alla situazione precedente vengono invece mantenuti e addirittura ingranditi, sia perché si tende a sopravvalutare la vittoria (il che però è normale di fronte uno scontro duro e lungo) sia perché a volte quei mezzi da temporanei diventano permanenti (diventa meglio mantenere l’esercito con il bottino di guerra che dover reintegrare i reduci): il risultato è la militarizzazione che però ha esiti finali disastrosi (proprio così avvenne per la società ellenica, che crollò dopo una cinquantina d’anni dopo aver conseguito la vittoria sull’Impero Achemenita invasore, autodistruggendosi nella guerra del Peloponneso. Dal punto di vista del più debole o dello sconfitto: la reazione bellica non è l’unica possibile, la Russia nella guerra fredda rafforzò gli armamenti per una guerra soltanto ideologica; dove la risposta militare si è rivelata impossibile, oppure fu tentata ma fallì, alcuni dei popoli conquistati reagirono mantenendo la loro identità come comunità coltivando intensamente la religione, come gli ebrei all’epoca della diaspora; la risposta più efficace è data dalla creazione di una religione superiore, che mescola elementi dei popoli aggrediti con quelli degli aggressori, come nel caso del cristianesimo o del buddismo mahayana che risultano da sintesi creative di elementi orientali con elementi ellenici e vengono poi adottate dagli stati aggressori, specie nella fase di decadenza quando l’impero si presenta come soluzione ad un’epoca di torbidi e di scontri interni.
Ora le conseguenze di assalti riusciti. La più clamorosa è il prezzo sociale che una civiltà aggressiva deve pagare in caso di vittoria, ovvero l’infiltrazione della cultura straniera delle sue vittime all’interno della propria vita, il che intacca l’unità del corpo sociale; poi si pone il problema dell’integrazione delle vittime, esempi della quale sono la Lega di Delo fra Atene e alleati, l’impero alessandrino, la doppia cittadinanza sotto l’impero romano, dove la polis greca o la civitas romana vengono estese al contempo snaturandosi in imperi, ma facendo nascere l’idea della cittadinanza universale. Partendo invece dall’effetto dell’assalto sulle vittime Toynbee elabora la teoria della rifrazione: la cultura dell’aggressore come un raggio si rifrange, l’idea di riplasmare una cultura da zero risulta un’illusione; anche l’Occidentalizzazione (ricostruire il mondo a immagine e somiglianza dell’Occidente) o la globalizzazione (un insieme di regole economiche che applicate abbatteranno ogni differenza). Nel vincitore, gonfiato dalla hybris, s’innesca un meccanismo di disumanizzazione dei conquistati visti di volta in volta o come “pagani” (che quindi dovranno convertirsi) o come “barbari” (che quindi devono acquisire i modi di vita dei vincitori per acquisire lo status di uomini a tutti gli effetti) oppure, caso estremo, come “indigeni”, senza possibilità di accedere allo status di uomini o cittadini a pieno diritto se non ribellandosi o convertendo a sua volta i dominatori.
La risposta dei conquistati o delle vittime di una aggressione si gioca in tre modi diversi in rapporto alla cultura dell’aggressore, codificati secondo un paragone con la cultura ebraica: 1) erodianesimo: accettare in toto la cultura dell’aggressore cercando di cancellare la propria (come Erode il Grande, sovrano ellenizzante, o in tempi più recenti Pietro il Grande di Russia, zar che cercò di imporre la cultura europea ai suoi sudditi, o Mustafa Kemal Ataturk che cercò di eliminare l’Islam dalla Turchia moderna); 2) zelotismo: tentativo, sempre fallito, di rifiutare in toto la cultura dell’aggressore rispondendo militarmente con una ideologia basata sulla purezza delle proprie tradizioni, la cui ricostruzione è sempre arbitraria 3) evangelismo: come nell’antico ebraismo, a fronte della sconfitta dei progetti di Erode o degli zeloti si stagliò il cristianesimo, che risultò, certo dopo lunghe vicissitudini, vincente, così si può codificare una terza risposta, quella vincente delle religioni universali, vere sintesi creatrici, tese a superare sia l’accoglienza sie il rifiuto senza riserve, posizioni non realistiche, in una visione dei rapporti fra culture senza barriere fra amico e nemico, combinando la propria religione di partenza con elementi della cultura del vincitore (per esempio nel cristianesimo si combina il monoteismo ebraico con la cultura umanistica greca nella figura di Cristo, che si presenta appunto come Dio-uomo).
Toynbee dedica poi una lunga disamina ai Rinascimenti, ovvero ai contatti fra le civiltà nel tempo, quando una civiltà viva viene a contatto con una già morta, di cui però sopravvivono le idee e la cultura nei libri. Considera dunque i rinascimenti di idee politiche e di istituzioni, di sistemi di legge, di filosofie, di linguaggi e letterature, di arti figurative, di ideali religiosi e istituzioni.
Dopo il volume su “Legge e libertà nella storia”, molto teorico e dedicato anche all’analisi delle posizioni di altri grandi storici sulla questione appunto delle leggi della storia, ma anche di leggi economiche, sociali, oppure dei cicli di guerra e pace in cui sembra riscontrarsi una certa regolarità.
L’ultima parte, prima delle conclusioni, s’intitola “Le prospettive della civiltà occidentale”: questa indagine segna un allontanamento rispetto al punto di vista adottato e mantenuto durante tutto il lavoro, cioè di trattare le civiltà conosciute in modo sinottico. Il mutamento è giustificato dal fatto che la società occidentale finora è l’unica che sopravvive senza dare manifesti segni di dissoluzione; che sotto certi aspetti si era ormai estesa in tutto il mondo e che le sue speranze stavano in un mondo “in via di occidentalizzazione”. Anche se l’oggi sembra dare qualche segno di tramonto della supremazia occidentale e una reazione delle altre culture.
L’analisi precedente sui collassi e le dissoluzioni delle civiltà può gettare una certa luce e soprattutto la storia della civiltà greco-romana, le sue soluzioni di integrazione delle altre culture e le reazioni che quelle hanno costruito (per esempio la dialettica di erodianesimo-zelotismo-evangelismo). Il militarismo e la guerra, ma anche la costruzione di imperi universali si pongono come potenti illusioni di immortalità ma che però risultano essere le cause di caduta delle civiltà. L’Occidente sembra proprio su questa via ma ha saputo però produrre elementi che vanno in senso contrario: l’abolizione della schiavitù, lo sviluppo della democrazie e dell’istruzione. Però l’Occidente presenta una divisione infausta fra minoranza dominante, proletariati interni e esterni, che è la situazione tipica delle fasi di decadenza, ma ha anche ottenuto successi considerevoli nell’affrontare i problemi della diversità dei proletariati del mondo in via di occidentalizzazione. Toynbee analizza infine i problemi della tecnologia, riprendendo la teoria della rifrazione culturale, ma anche della lotta di classe.
In conclusione le civiltà sono prove, tentativi di ovviare a dei problemi, nessuna definitiva perché i problemi si rinnovano e nessuna soluzione può essere definitiva. Esse muoiono suicide, quando non sono più capaci di rispondere a delle sfide che la situazione storica lancia loro. Unicamente quando non sono in grado di mobilitare risorse fresche, di inventare nuove vie d’uscita dalle difficoltà, allora la condanna è sicura. Esse si sfaldano, si disintegrano oppure ristagnano, si mummificano, si sclerotizzano, perdono in energia e elasticità. Ma il paradigma “sfida-risposta”, non va confuso con quello comportamentistico “stimolo-risposta”. Non si tratta qui di reagire semplicemente agli stimoli, ma di andare al di là delle situazioni di partenza, di immaginare soluzioni non contenute nei termini dati. Lo stesso concetto di mimesi è collegato a quello di modello, poiché si imita sempre un modello e spesso in difetto, in maniera meccanica, non creativa, ma i modelli di volta in volta devono essere riformulati, plasmati di nuovo.
Il soggetto della storia e una storia senza centro: il policentrismo delle civiltà e il metodo analogico
Il soggetto della storia è plurale: le civiltà. Esse non hanno un centro da cui la loro storia si diparte e dove converge, sia esso spirituale (la libertà) o geografico (l’Occidente) o una cultura (il cristianesimo occidentale). La visione della storia secondo il paradigma delle civiltà si presenta come riedizione di Voltaire (Saggio sui costumi e sullo spirito delle nazioni), ma ancora più radicale, perché tende a rompere con l’eurocentrismo verso cui tenderebbe il progresso. Non essendoci una linea precisa della storia, gli eventi delle varie civiltà non si possono disporre l’uno dopo l’altro in una sequenza di epoche, dato che fra ogni civiltà c’è una frattura: esse possono essere contemporanee ed entrare in rapporto fra loro, ma il loro modo di dar forma alle cose, a livello spirituale come materiale, è diverso e le sospende in una sorta di incomunicabilità; possono succedersi come la greco-romana o l’occidentale, ma soltanto con una frattura in mezzo che le separa profondamente, per cui anche le riedizioni di forme antiche, come la democrazia ad esempio, sono poi profondamente diverse. La rottura del continuum rende ragione però della possibilità di paragonare fra loro le varie civiltà.
Il relativismo diventa il fondamento delle comparazioni: le civiltà non si succedono su una linea temporale ma sono sincroniche e dunque possono essere comparate, anzi l’analogia diventa il modo in cui possono essere conosciute, perché istituendo paragoni posso mettere a fuoco le caratteristiche dell’una o dell’altra. L’una mi fa vedere meglio l’altra.
Pur in questa visione relativista, rimane una questione aperta: il rapporto fra la civiltà greco-romana e l’Occidente e il loro rapporto con le altre. L’Occidente è erede della civiltà ellenica o, per dirla con Toynbee, è una civiltà affiliata, che sorge sulla fase di disintegrazione dell’altra, quando il mondo ellenico si scinde appunto in un impero (minoranza dominante), una chiesa (proletariato interno), dei popoli considerati barbari (proletariato esterno)? L’una e l’altra sembrano avere come caratteristiche peculiari la tensione universale, che le porta ad uscire dal proprio ambito geografico per estendere il proprio modo di vita alle altre civiltà, anzi a tutto il mondo conosciuto. Non solo sembra esserci un rapporto privilegiato fra le due ma sembra correre anche una somiglianza non superficiale.
Spengler paragona l’attuale momento dell’Occidente all’antico cesarismo, pensando di poter prevedere appunto il crollo dell’Occidente sulla stessa base del mondo antico.
Toynbee attribuisce al mondo antico tre caratteristiche: 1) la storia greco romana è una storia conclusa, di cui si conoscono gli esiti finali 2) costituisce una materia dominabile perché risulta da una selezione equilibrata di documenti 3) fornisce una visione ecumenica, universale piuttosto che particolaristica e regionale, perché è una unione di vari popoli. Per di più greci e romani fanno parte della stessa civiltà, detta appunto ellenica, perché gli uni continuano gli altri. Prendendo coscienza di questa analogia, Toynbee infatti studia a fondo i contatti fra le civiltà, la psicologia degli incontri e degli scontri, ponendo al centro appunto la civiltà ellenica (greco-romana) e quella occidentale e la loro tensione all’unificazione del mondo nel tentativo di costruire una civiltà unica.
L’Occidente e il mondo greco-romano
Dunque dopo aver capito se e come è possibile questo relativismo delle civiltà, si presenta un’altra questione, che sembra diventare centrale, ovvero quella della preminenza della civiltà greco-romana fra quelle antiche e di quella Occidentale fra le moderne. Sono vari i punti in gioco: 1) continuità fra Grecia e Roma (che Toynbee chiama con un termine unico civiltà ellenica) 2) analogia o eredità fra mondo ellenico e occidentale 3) l’una nel mondo antico, l’altra nel moderno si pongono come civiltà universali, che tendono a unificare il mondo, quindi superando la spaccatura fra le civiltà. 4) soprattutto il mondo ellenico in Toynbee diventa anche il modello di comparazione delle civiltà: da una parte, su un piano potremmo dire gnoseologico e soggettivo, perché i vari elementi sopra descritti (genesi, sviluppo, decadenza, morte, poi la scissione in impero, chiesa, pressione dall’esterno di barbari, da cui poi si genera una “civiltà affiliata”, poi lo studio del suo protendersi all’esterno sia con la diffusione di modelli culturali sia con l’imposizione armata) configurano un modello epistemologico, non categoriale e fisso, ma processuale, dinamico con cui studiare tutte le civiltà ma anche e soprattutto quella civiltà che tende a superare questa spaccatura sia culturale che politica nel tentativo di fondare un’unica civiltà mondiale; dall’altra su un piano più oggettivo, perché molte altre civiltà nella storia hanno eletto quella ellenica come modello di riferimento, da quella occidentale (compresa da un certo punto in poi anche quella americana), in vari modi e fasi, a quella bizantina, a quella russa.
Fin dalle origini e quindi dalle fondamenta la civiltà ellenica ha posto i germi del proprio futuro: 1) una identità non basata su un elemento fisico come una terra definita o una lingua. “Come definire la civiltà ellenica, se non è possibile circoscriverla in una particolare regione, né identificarla con una lingua particolare? La sua essenza non era geografica o linguistica, ma sociale e culturale; era un caratteristico sistema di vita realizzato in un’istituzione capitale, la “città-stato”: chiunque si acclimatasse al modo di vivere delle città-stato elleniche, era considerato Elleno, qualunque fosse la sua origine e l’ambiente da cui proveniva” (Toynbee, Il mondo ellenico). La sfida infatti a cui i Greci devono far fronte è doppia: un ambiente ristretto, ma proteso verso il mare e l’anarchia nella convivenza fra loro, fra popoli della montagna e della pianura. Per ovviare a entrambi si mettono assieme (sinecismo) e costruiscono una costellazione di città-stato e organizzano la colonizzazione di altri territori, sfruttando il mare. La risposta a questa sfida denota il carattere specifico ellenico: quello di essere un modello aperto, non identificabile fisicamente (quindi potenzialmente universale?), esportabile tramite il mare, quindi espansiva (quindi potenzialmente mondiale?), basato però su una istituzione particolaristica, la polis appunto.
La città-stato non è però una creazione originale ellenica (se ne trovano testimonianze in tutte le civiltà coeve), originale è semmai la specifica declinazione che i greci le conferiscono, ovvero il culto dell’uomo. La stessa religione greca oscilla fra il culto dell’uomo (comunque sentito come insufficiente, basti pensare alla hybris) e il culto del potere collettivo(e qui fra polis – ovvero delle divinità protettrici della polis, ma anche della antiche famiglie che hanno operato il sinecismo – e l’altra grande prospettiva collettiva, l’impero) ma anche fra queste due e la religione naturale tradizionale (nella natura e nella famiglia si rivede, a mo’ di simbolo, il mistero della morte e della rinascita); infine fra la religione naturale e quella olimpica, aristocratica ed eroica, meno legata alla famiglia, dove ad essere adorato è l’uomo singolo, visto come signore rispetto agli altri. (Secondo Toynbee la soluzione di queste contraddizioni si avrà con l’ellenismo, ovvero quando il mondo greco entrerà in contatto con altre religioni, specialmente il giudaismo e il buddismo. Dall’incontro fra giudaismo-religione trascendente, nuova per i greci- e il culto ellenico dell’uomo sorge il cristianesimo, dove divinità e uomo si mescolano in una sintesi nuova; dalla mescolanza di buddismo-religione dell’abbandono totale del mondo, nuova per i greci- e visione greca del mondo sorge il buddismo mahayana, religione dell’uscita e del ritorno nel mondo, basata sulla compassione per l’uomo. All’analisi approfondita di tutti questi aspetti Toynbee dedica la una monografia tradotta in italiano col titolo Storia e religione).
Altro elemento caratterizzante è la stretta connessione fra guerra e civiltà, ma anche fra queste e l’ingiustizia sociale: certamente le guerra è un aspetto di tutte le civiltà, ma nel caso greco (poi anche romano) pare che essa sia fortemente legata al processo di civilizzazione. Le sfide originarie erano rappresentate dalla severità dell’ambiente, fertile ma molto ristretto, e dall’anarchia della convivenza, lascito della primitiva Völkerwanderung (momenti che Toynbee studia a fondo nel libro Some Problems of Greek History). “La vittoria degli abitanti della pianura su quelli della montagna era stata ottenuta con la forza delle armi, e la guerra – il procedimento mediante il quale si era compiuto il primo passo nell’aurora della civiltà ellenica – divenne, al pari della città-stato un’istituzione fondamentale della vita ellenica. Questo precoce connubio della guerra con la civiltà fu nella storia dell’Ellade ancora più infausto perché l’ordine nuovo, contrariamente a quello antico, si basava su di un gran numero di centri locali politicamente indipendenti l’uno dall’altro e perciò più facili a venire in conflitto fra loro” (Toynbee, Il mondo ellenico). Grazie alla guerra e alla città-stato vengono risolte le sfide originarie, ma anche le seguenti. Comincia qui l’intreccio di vari elementi caratterizzanti la civiltà greca: il culto dell’uomo, la città-stato, la guerra, l’identità culturale e sociale, non fisica, la spinta all’espansione. Dunque la cittadinanza si presenta come soluzione al problema del conflitto fra varie comunità con mentalità diverse e diversi interessi: organi fissi e rappresentanti al posto del conflitto fra comunità che appunto operano il sinecismo. Questo comporta comunque una ingiustizia sociale, sia perché si creano delle gerarchie, sia perché a fronte di alcuni che hanno diritti ve ne sono altri esclusi. Il cittadino per di più è colui che è in grado, economicamente e per capacità militari, di difendere la città. La guerra verrà usata come mezzo per risolvere però i problemi legati all’espansione coloniale, ma anche i problemi fra greci (basti pensare alla tremenda guerra del Peloponneso, un vero e proprio conflitto totale che non esclude nessun greco, Sicilia compresa). Sparta, la città egemone della prima fase della classicità, fa della guerra il perno della sua visione del mondo, delle sue istituzioni, delle sue manifestazioni culturali: disciplina ferrea, competizioni, sottomissione, senso della gerarchia, sobrietà, coesione basata sullo spirito di corpo (Toynbee dedica un vasta sezione, di circa 240 pagine, di Some Problems of Greek History a “rise and decline of Sparta”). L’espansione marittima che aveva risolto alcuni problemi della prima ora viene però arrestata dalla reazione dei concorrenti, in particolare fenici ed etruschi; i fenici in particolare accettano l’unificazione sotto Cartagine e si trovano alle spalle non più un impero ostile come quello babilonese ma uno che lo coopta tramite accordi nel proprio sistema come quello persiano. Il freno all’espansione spinge la tensione verso l’interno. La contemporanea invenzione della moneta e della falange induce una rivoluzione sociale: con la prima nasce e si potenzia l’economia di scambio (grazie anche alle rotte marittime) che sostituisce gradatamente il sistema autarchico; con la seconda anche i contadini entrano nelle fila dell’esercito. L’indebitamento dei contadini parallelamente alla loro crescita d’importanza spinge verso soluzioni dittatoriali, dove la massa si appoggia a una figura di riferimento per superare l’aristocrazia oligarchica. Soltanto Sparta ne rimane esente perché nel suo sistema v’era già uguaglianza agricola-militare-civile. Mentre Sparta cerca di frenare la rivoluzione facendosi garante dell’alleanza fra la vecchia aristocrazia egemone nelle poleis e il nuovo ceto commerciante, Atene grazie a Solone si rifonda sul patto fra opliti contadini e ceti nullatenenti, ovvero grazie alla democrazia, che diventa via via più radicale. Si gettano le basi del bipolarismo Sparta-Atene, che segna i due più importanti eventi successivi, le guerre persiane e la guerra del Peloponneso, ma anche la mancata unificazione politica fra greci e l’aumento della conflittualità sia interna che verso l’esterno. Atene si pone dapprima come rivale nell’egemonia rispetto a Sparta nella comune difesa dall’aggressione persiana, fondando l’egemonia marittima contro quella terrestre spartana. Terra e mare diventano però anche simboli di due visioni del mondo: da una parte commercio, democrazia, cultura, ricchezza, filosofia, rischio e impresa; dall’altra agricoltura, oligarchia, tradizione, austerità, laconismo, conservazione della proprietà. Entrambe però imperiali, l’una con la Lega del Peloponneso, l’altra con la Lega di Delo (quest’ultima nasce proprio per la difesa contro la Persia, ma imitando il modello persiano della cooptazione e dei rapporti commerciali: “Il tentativo greco di raggiungere un ordinamento politico internazionale fu la cosiddetta Lega di Delo (…). Ed è importante notare, frattanto che la Lega di Delo è organizzata su modello persiano. Questo si vede confrontando gli elementi che lo statista ateniese Aristide indusse le città liberate ad accettare con quelli (vedi Erodoto, VI, 42) del sistema già imposto alle stesse città dalle autorità persiane, dopo la repressione della così chiamata “Rivolta Jonica”, circa quindici anni prima” – Toynbee, Civiltà al paragone). La dinamica del conflitto ci mostra una caratteristica interessante: la sua capacità di costruire un terreno comune con l’altro proprio mentre ci sentiamo quanto più opposti rispetto a lui e proprio mentre ci stiamo organizzando per eliminarlo. Infatti proprio mentre nasce la grande propaganda del persiano visto come barbaro e come despota, se ne desumono molte delle caratteristiche, proprio quelle più dispotiche (la lega di Delo che nasce su modello persiano appunto); poi proprio mentre nasce lo scontro per l’egemonia greca anti-persiana e quindi Sparta e Atene si percepiscono come opposte (opposizione appunto fra terra e mare), le loro caratteristiche cominciano a somigliarsi o addirittura a scambiarsi le caratteristiche(“Così, nel giro di trent’anni, la democrazia ateniese si era messa sulla stessa strada del suo predecessore spartiata. Era diventata una “potenza” militare parassita coi propri iloti (gli alleati pagatori di tributi) e perieci (gli alleati ancora privilegiati che contribuivano squadre navali)” – Toynbee, Il mondo ellenico).
Atene però fonda un modello ancor più espansivo e ancor meno radicato alla terra. La Lega di Delo estende la cittadinanza attica ma a prezzo della dominazione imperiale. Per di più dato il nuovo sistema economico non più autarchico le poleis sono diventate economicamente interdipendenti: l’anarchia locale era stata superata con l’instaurazione della città-stato che però aveva lasciato intatta quella fra Greci, che però stavolta cominciava a risultare mortale, data la connessione economica.
La tensione unitaria si compie, ma in ritardo soltanto in epoca ellenistica con Roma, ma l’unità fisica dell’impero è segno di decadenza, come già Toynbee rileva in A Study of History, quando cioè una minoranza creatrice che viene imitata senza imposizione, anche se la mimesi avviene per difetto ed più esteriore che interiore, scade a minoranza dominante, impone il proprio modello perché gli altri ormai sono restii a seguirla. “La rovina della civiltà greco-romana a causa della fallita instaurazione di una legge e di un ordinamento internazionali, in luogo di una internazionale anarchia, occupa la storia per ben quattrocento anni, dal 431 al 31 a. C. Dopo questi secoli di fallimento e di miseria ci fu nella generazione di Augusto una parziale e temporanea ripresa. L’Impero Romano, che in realtà era una lega internazionale di polis greche e di altre città-stato unite fra loro da relazioni culturali, può essere considerato come la tardiva soluzione del problema che la Lega di Delo non aveva saputo risolvere. Ma l’epitaffio dell’Impero Romano è “troppo tardi”. La società greco-romana si era pentita soltanto dopo essersi inflitta ferite mortali con le sue stesse mani. La Pax Romana fu una pace di esaurimento, non fu creativa, e perciò non poté essere duratura. Quella pace e quell’ordine arrivavano con quattro secoli di ritardo. Bisogna studiare la storia dei melanconici quattro secoli intermedi per poter capire che cosa è stato l’impero romano e perché è crollato. La mia conclusione è che occorre guardare a questa storia come a un tutto. Soltanto se vista nella sua completezza, getta una luce sulla nostra odierna situazione nel mondo. E allora, si tratta di una luce, experto crede, sorprendentemente rivelatrice”. (Toynbee, Civiltà al paragone).
Toynbee dunque vede il mondo greco e romano come una civiltà unica, ellenica appunto, il che è comprovato da molte fonti antiche. E insiste a lungo sull’ellenismo, cioè sul periodo di contaminazione culturale, di tentativi di unificazione politica, dell’esportazione di costumi ellenici e dell’importazione di religioni orientali dopo l’impresa di Alessandro Magno, periodo nel quale si colloca anche l’ascesa di Roma. Ad essa Toynbee dedica appunto una massiccia analisi,L’eredità di Annibale, in cui da una parte Roma è vista in rapporto a tutte le civiltà del mondo ellenistico, dal Mediterraneo fino all’India, dall’altra viene studiata la struttura imperiale che sorge in maniera decisiva proprio dopo le guerre puniche.
C’è un’altra somiglianza profonda fra la Grecia e Roma: entrambe non hanno un’identità rigida e definita, nemmeno da un territorio. Ciò che contraddistingue Roma è l’istituto della doppia cittadinanza: più Roma cresce, più si estende la doppia cittadinanza (il processo di completerà con la Constitutio antoniniana del 212 d.C.), il che sembra mostrare che chiunque può diventare cittadino romano, che Roma potenzialmente è estensibile in tutto il mondo. Il problema è dare una conformazione all’estensione, partendo dalla cittadinanza romana che compete alle antiche famiglie, integrando i cittadini di altre città. Si configura col tempo una gamma di status civici, municipi romani (città al di fuori di Roma con diritti simili a quelli romani), città latine, città alleate e soggette, cantoni e zone tribali, che si dispone gerarchicamente sul parametro della maggior o minore prossimità alla cittadinanza piena. La grande visione romana è un mondo di libere città, per cui Roma è soltanto punto di riferimento. La guerra è giusta se difensiva o fatta per portare la civiltà. Dove delle città vengono distrutte si cerca di ricostruirle e fare in mondo che si acquisisca o ri-acquisisca la cultura e l’abitudine civica (Pompeo, anche per evitare che rinascano regni ostili a Roma, riorganizza l’Asia legando alle città alle campagne, creando appunto un insieme di distretti: le campagne imparano la cultura civica e si liberano dal bisogno di avere un re-protettore; Cesare stesso ricostruirà molte città nella Grecia). L’ideale che penetra in Roma (tramite Posidonio prima, Cicerone poi) è quello stoico, per cui c’è un logos originario che ispira tutte le culture e tutte saranno unificate nell’ideale cosmopolitico, in cui il parametro rimane appunto quello del cittadino comunque (cosmo – polis appunto). Rimangono spinose contraddizioni, quella fra l’impero-sudditi e insieme di città, fra guerra e cittadinanza, che esplodono già dopo la grande vittoria su Cartagine. Anche Roma esce definitivamente dall’autarchia, grazie all’immenso patrimonio economico che si trova a gestire. La rivoluzione economica è dovuta all’accresciuta produzione delle campagne (che quindi ormai producono per la vendita) e al commercio (grazie al controllo delle rotte commerciali principali). Ma si aprono tre grossi problemi: 1) la campagna dopo le guerre puniche passa nelle mani dello Stato, che la riorganizza lasciandola a nuovi ricchi (commercianti che si sono arricchiti con le guerre) o alla classe senatoriale; nascono dunque latifondi che lavorano la terra con schiavi, il che spinge i piccoli proprietari verso la disoccupazione 2) questa massa rurale, che va perdendo le sue prerogative, tende a riguadagnarle con l’impegno bellico: infatti il nuovo impero ha continuo bisogno di difendere i confini e la coscrizione viene fatta soprattutto presso i contadini, che legano sempre più le loro sorti, con la speranza di riconquistare la piena cittadinanza, o ai vari “signori della guerra” (Silla, Mario, Pompeo, Cesare) o a “rivoluzionari” che si battono per la distribuzione della terra (Tiberio e Caio Gracco) 3) queste varie figure tendono sempre più a fondare il loro consenso in maniera carismatica, quindi tendono a mantenere la situazione nella quale hanno costruito il loro potere; i cittadini pongono invece le loro speranze non più nelle vecchie istituzioni e abitudini civiche ma o nelle figure rivoluzionarie o nella guerra.
La classe dirigente romana cerca di amministrare un impero senza un esercito professionista e senza una burocrazia professionista, rimanendo legata alle vecchie istituzioni. Così qualcuno, l’homo novus Mario, comincia a reclutare l’esercito fra i cittadini che hanno perso le terre e che quindi erano esentati dal servizio militare obbligatorio. “Così l’esercito romano fu trasformato da una “associazione” di proprietari terrieri in un “sindacato” di proprietari spossessati dei loro beni e in cerca di nuovi poderi. E questo, a sua volta, portò come conseguenza la trasformazione dei comandanti militari in capipartito politici che compravano l’appoggio delle truppe per combattere i propri rivali, promettendo ai soldati lotti di terre espropriate in Italia, come ricompensa per le vittorie riportate sui propri concittadini” (Toynbee, Il mondo ellenico).
La vittoria contro Cartagine genera le guerre civili fra romani (dato che l’espansione, pur resa necessaria da una mera difesa, aveva fatto saltare gli equilibri interni), le guerre sociali fra romani e alleati (alleati che si rivoltano pretendendo la piena cittadinanza) e le guerre servili fra romani e schiavi. L’architettura delle polis legate a una polis di riferimento sembra esplodere. E’ nel mondo ebraico che si profila la novità: alla reazione nazionalistica e violenta si comincia a intravedere in una setta eretica, quella cristiana, una reazione universale e pacifica.
Si apre quella che Toynbee chiama l’Età dell’agonia e che Spengler definisce invece degli Stati in lotta. Essa trova soluzione con Augusto ed è la soluzione del principato. Ma la pax augusta è appunto soltanto il ritardo di un crollo. La linfa del mondo ellenico era stata la città-stato, la cui struttura è ben chiarita ad esempio da Aristotele nella Politica: il cittadino è colui che partecipa attivamente, quindi creativamente alla vita comunitaria, e quindi 1) ha una proprietà privata 2) si dedica alla vita politica 3) alla difesa della città 4) ai riti religiosi; quanto al governo il migliore è la costituzione media o mista, una democrazia su base oligarchica. Questo circolo virtuoso di ingredienti si spezza nel momento in cui questa condizione tende a estendersi e a svilupparsi al di fuori dei confini (sulla limitatezza geografica della polis è ancora Aristotele a ragguagliarci). Il nuovo ordine augusteo rimane rivoluzionario, per due motivi: 1) le figure plenipotenziarie secondo la costituzione romana potevano essere elette soltanto in casi di emergenza e dovevano essere temporanee: il fatto che diventino durature sembra significare che il principato è visto come “stato d’eccezione permanente” 2) si continua con la vecchia costituzione, tanto che non c’è nemmeno una regola fissa per l’elezione dell’imperatore. La sua funzione è tutto sommato negativa, nel senso che porta pace e sicurezza, blocca le possibilità di conflitto ma lascia in piedi formalmente le antiche istituzioni, la vita cittadina va morendo, l’unità impressa a quel mondo dilaniato non gli restituisce slancio, l’armonia di attività, quella sintesi di ingredienti presentata da Aristotele vien meno.
Nel sistema augusteo la religione civica è superata dalla figura del re salvatore (Divo Cesare); la polis dallo stato mondiale; il cittadino che decide e amministra dalla burocrazia professionale; il cittadino combattente dall’esercito di professione. Si approfondisce la frattura fra minoranza dominante, proletariato interno (tutti coloro che chiedono parità di diritti) ed esterno (l’esercito posto ai confini tende a mescolarsi con le popolazioni indigene, queste invece tendono a imparare il modo di combattere romano, per poi usarlo contro Roma stessa, per di più l’esercito diventa sempre più decisivo nell’elezione degli imperatori). Cresce la tensione fra città e campagna, fra le città e la burocrazia, fra la burocrazia e l’esercito: il circolo virtuoso dell’antica polis diventa un circolo vizioso. Dopo la grande crisi del terzo secolo gli imperatori illirici cercano una svolta: Diocleziano potenzia la burocrazia, Costantino accetta il cristianesimo.
“La forza d’attrazione del cristianesimo riuniva in sé quella delle altre religioni rivali. Il Dio dei cristiani era l’unico onnipotente vero Dio del giudaismo e dello zoroastrismo; e, nel devoto timore da lui ispirato, la divinità poteva apparire quasi inaccessibile. Tuttavia per i cristiani, il Dio ebraico della giustizia era anche il Padre amoroso, e nel Figlio il Padre porgeva la mano ai suoi devoti nella persona di Gesù. Come un bodhisattva, il Figlio era il salvatore che sacrifica se stesso; ma il suo sacrificio era più meraviglioso. Per amore delle sue creature Per amore delle sue creature Dio si era spogliato della sua divina potenza e beatitudine per farsi uomo in Gesù e affrontare la morte per torture dei criminali. Come i miti martiri di Sparta e di Roma, il re Agide e l’aristocratico Tiberio Gracco, Gesù aveva dato la vita per il suo popolo senza ricorrere alla forza neppure per difendersi. Ma, al contrario dei due rappresentanti della classe dominante ellenica, Gesù era nato dal popolo e la sua gente era l’umanità intera. Come Agide e Tiberio e il re degli schiavi Trifone e il gladiatore ribelle Spartaco era stato condannato a morte; ma come l’assassinato dio della fertilità, Osiride-Addone-Attis-Tammuz, aveva vinto la morte ritornando alla vita (…). Come Augusto, Alessandro e i faraoni, Gesù era figlio di un Dio concepito da una madre umana; ma il Padre celeste di Gesù non faceva parte di un pantheon: era l’unico vero Dio; e Gesù stesso era Dio, e Gesù stesso era Dio, unico e vero, in quell’aspetto della divinità il cui nome è amore. Al pari di Mitra, aveva vinto i bassi istinti della natura resistendo dapprima alla tentazione di una carriera politica come leader del proletariato, e poi alla tentazione maggiore di cedere sgomento davanti alla crocifissione. Come Hadad, il dio della tempesta dolicheno, sarebbe ritornato nella sua potenza, cavalcando le nubi. E per tutto il tempo egli rimaneva anche l’Eterna Ragione Creatrice (il Logos), in cui gli intellettuali ellenici, dai tempi di Anassagora, riconoscevano e riverivano la realtà ultima dietro l’apparenza fenomenica dell’universo. L’ineffabile aspetto di Dio, incarnato nella figura di Gesù, dava al cristianesimo una forza propulsiva che da sola sarebbe bastata a trionfare sulle religioni rivali. Ma la madre terrena di Gesù, Maria, stava di riserva, in attesa del suo tempo per prendere il posto di Iside e Cibele come Gran Madre di Dio (Theotokos). E le tombe dei martiri cristiani non avrebbero tardato a prendere il posto di quelle degli eroi ellenici. Gli eroi erano personaggi di leggenda, o, se appartenevano alla storia, erano poco edificanti figure di guerrieri barbari dell’età preellenica di anarchia. I martiri erano uomini e donne comuni dell’età presente, che avevano dato la vita per testimoniare la propria fede cristiana” (Toynbee, Il mondo ellenico).
Mentre nel mondo ellenico la minoranza dominante (non più creativa) continuava a elogiare i vecchi modelli senza però trovare in essi reale fonte d’ispirazione per rispondere alle nuove sfide, i cristiani invece cercano nella cultura ellenica nuovo alimento: usano la lingua greca o latina, esprimono il contenuto della loro fede con i termini della filosofia greca, specialmente neoplatonico, prendono spunto dalle istituzioni imperiali.
L’impero poi prendendo la via di Bisanzio cambia profondamente i suoi connotati (a questo Toynbee dedica la corposa monografia Costantino Porfirogenito e il suo mondo). La spaccatura fra due mondi, praticamente due imperi, rende ancor più profondo il senso di decadenza. Ormai l’impero orientale ha costruito un modo di vita profondamente diverso da quello ellenico, quello occidentale crolla, ma portando in eredità la cultura ellenica, quello che il cristianesimo selezionerà: ma questo sarà poi stimolo per altre rinascite.
L’analogia fra l’oggi e l’antichità, fra l’Occidente e il mondo greco-romano rimane dunque non soltanto una prospettiva metodologica ma anche il fondamento di una possibile prognosi sul tramonto dell’Occidente e lo scontro di civiltà.
AUGUSTO GUZZO

Augusto Guzzo nacque a Napoli il 24 gennaio 1894 e rimase giovanissimo orfano di padre. Si iscrisse al corso di laurea in Lettere presso l’Università di Napoli e contemporaneamente all’Istituto orientale, ma dopo due anni passò a Filosofia dove ebbe come maestro Sebastiano Maturi. Nel 1915 conseguì la laurea con una tesi su “I primi scritti di E. Kant” (pubblicata subito parzialmente e nel 1920 interamente). Nel 1918 iniziò l’insegnamento al liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, finché nel ’24 ottenne la cattedra di Filosofia e di Storia della filosofia nella facoltà di Magistero a Torino, dove rimase fino al ’32. Nel ’29 fondò la rivista «Erma», che diresse fino al ’32. Dopo una breve parentesi a Pisa (1932-34), dove insegnò Filosofia morale e fu direttore del seminario di filosofia della scuola Normale, nel 1934 Guzzo fece ritorno a Torino sulla cattedra di Filosofia morale, succedendo a Erminio Juvalta. Nel 1939 passò a Filosofia teoretica, succedendo ad Annibale Pastore e conservando per incarico la cattedra di Filosofia morale. Nel novembre dello stesso anno fondò, insieme con Nicola Abbagnano, la Sezione piemontese dell’Istituto di Studi filosofici che aveva sede in via Po 18 presso l’Istituto di Filosofia. Nel ’43, persa tragicamente la figlia Luisa, iniziò un lungo periodo appartato. Dal ’50 pubblicò la rivista «Filosofia», alla quale aggiunse nel ’59 un fascicolo internazionale trasformato nel ’69 negli annali «Studi internazionali di filosofia». Oltre che di numerosi scritti storiografici (tra cui Il pensiero di Spinoza, 1924; Kant precritico, 1924; Idealisti ed empiristi, 1935; Agostino e Tommaso, 1958; Giordano Bruno, 1960; Storia della filosofia e della civiltà per saggi, 1975), è autore di vari scritti teorici, nei quali l’idealismo è ripensato criticamente (Verità e realtà. Apologia dell’idealismo, 1925). Tra il 1947 e l’’80 pubblicò l’ampia opera sistematica L’uomo: I. L’io e la ragione; II. La moralità; III. La scienza; IV. L’arte. V-VI. La religione. La filosofia. Si spense a Torino il 23 agosto 1986. L’itinerario filosofico percorso da Guzzo si configura come un idealismo teistico di ispirazione fortemente platonica e agostiniana, che rivendica l’irriducibilità dei singoli, l’oggettività sovrastorica della norma come valore e la totale trascendenza dell’Assoluto. Guzzo polemizza contro lo storicismo, per il quale veritas filia temporis: a tale tesi egli oppone, sulla scia di Agostino, che veritas mater temporis e che solamente nella incessante tensione veritativa interiore può realizzarsi la persona.
PIETRO PRINI

VITA E OPERE
Pietro Prini è nato a Belgirate, in provincia di Novara, nel 1915. Dopo la maturità classica, vinto un posto d’Alunno all’Almo Collegio Borromeo di Pavia, ha compiuto gli studi universitari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia dal 1937 al 1941. E proprio nel 1941 ha conseguito la laurea in Filosofia con una tesi su Il problema dell’essere e delle categorie nella Teosofia di Antonio Rosmini, elaborata sotto la guida di Michele Federico Sciacca. Dopo la guerra, durante la quale prese parte alla lotta di Liberazione facendo parte del Comitato di liberazione della scuola dal 1943 al 1945, ha insegnato in vari licei classici di Genova. Nel 1950, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri, trascorre a Parigi nove mesi, durante i quali entra in contatto con Jean Wahl, René Le Senne, Louis Lavelle e, soprattutto, Gabriel Marcel. Dopo aver conseguito la libera docenza in Filosofia teoretica nel 1951, diviene Incaricato di Storia della Filosofia Antica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova dal 1953 al 1959 e Incaricato di Filosofia Morale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia dal 1959 al 1961. In quest’ultima università assume la cattedra di Filosofia teoretica, dopo aver vinto nel 1961 il concorso di Filosofia teoretica. Nel 1964 viene chiamato a coprire la cattedra di Storia della Filosofia nella Facoltà di Magistero dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma dove rimarrà fino al pensionamento, dopo avervi fondato e diretto la Scuola di Perfezionamento in Filosofia e di preparazione all’insegnamento della filosofia. Ha diretto varie riviste di filosofia: “Proetus. Rivista di filosofia”, dal 1970 al 1975; “Cultura e politica”, dal 1967 al 1971; “Giornale di metafisica”, dal 1978 al 1980. Tra le sue opere principali, ricordiamo Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, Studium, Roma, 1950; Esistenzialismo, Studium, Roma, 1952; Introduzione alla metafisica di Antonio Rosmini, Sodalitas, Domodossola, 1953; Verso una nuova ontologia, Studium, Roma, 1957; Rosmini postumo, Armando, Roma, 1960; Discorso e situazione, Studium, Roma, 1961; Umanesimo programmatico, Armando, Roma, 1967; Introduzione critica alla storia della filosofia, Armando, Roma, 1967; Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Abete, Roma, 1968; Alle origini della filosofia greca, Abete, Roma, 1970; Storia dell’esistenzialismo, Studium, Roma, 1971; Cristianesimo e ideologia, Esperienze, Fossano, 1973; Il paradosso di Icaro, Armando, Roma, 1976; La scelta di essere, Città Nuova, Roma, 1982; Storia dell’esistenzialismo da Kierkegaard a oggi, Studium, Roma, 1989; L’ambiguità dell’essere, Marietti, Genova, 1989; Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, SEI, Torino, 1991; Il cristiano e il potere, Studium, Roma, 1993; La filosofia cattolica italiana del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1997; Lo scisma sommerso, Studio g. due, 1998.
PENSIERO
Pietro Prini nei suoi lavori storiografici – specialmente in quelli che congiungono in una linea ermeneutica unitaria il tema della ‘contemplazione creatrice’ di Plotino, quello del ‘sintesismo delle forme ontologiche’ di Rosmini e quello del ‘mistero dell’Essere di Gabriel Marcel – è pervenuto a richiedere dalle moderne scienze umane, specialmente dalla biogenetica e dalla linguistica, dalla psicologia analitica e dalla fenomenologia del profondo, un effettivo rinnovamento dell’antropologia. Le principali posizioni che egli ritiene di avere raggiunto sono: un concetto nuovo dell’originaria intersoggettività linguistico-comunicativa dell’umano, con l’abbandono degli equivoci legati alla dottrina scolastico-suareziana della ‘natura’; la portata educativa di una dialettica del desiderio e del bisogno; la scoperta del vincolo speculativo che lega insieme la struttura del pensiero tecnologico, o dell’intelligenza artificiale, al metalinguaggio del religioso, come intelligenza speculativa o dell’ascolto. In particolare, Prini si fa portavoce di un platonismo riletto in chiave esistenzialistica, con forti sfumature religiose: in particolare, egli risulta influenzato da Gabriel Marcel, da lui personalmente conosciuto in Francia. Sulla base di questi presupposti, egli si propone di rinnovare anche l’ontologia, come emerge già dal titolo del suo scritto del 1957, Verso una nuova ontologia. L’inaggirabile ufficio della filosofia dev’essere per Prini quello di “portare alla verità, fin dove sarà possibile, la coscienza cifrata – ossia il mondo dei significati e delle preferenze, o come anche si è soliti dire, il mondo dei valori” (Il tradimento dei chierici, pp. 141 ss.). Alla luce di questa considerazione, appare evidente che “pensare filosoficamente non è descrivere, ma interpretare, e interpretare il senso dell’esistenza – lo vogliano o no le nuove filosofie del decadentismo – è decidere di essa”. Per questa ragione, “non si sfugge alla decisione del nostro rapporto con la verità”. Prini non intende venir meno al “domandare assoluto” e al “riconoscimento di quella e vera e propria ‘intelligibilità metafisica’ che esso implica”: a ciò è invece venuta meno, come egli non si stanca mai di ripetere, gran parte della filosofia italiana a lui contemporanea. Prini mette inoltre in chiaro come “non c’è incompatibilità tra la fede e la problematica radicale”: in forza di ciò, occorre evitare accuratamente i due scogli del tradimento della fede nel filosofare e del tradimento del filosofare nella fede.
JEAN BAUDRILLARD

A cura di Mai Saroh Tassinari
“L’astrazione oggi non è più quella della mappa, del doppio, dello specchio o del concetto. La simulazione non è più quella di un territorio, di un essere referenziale o una sostanza. È piuttosto la generazione di modelli di un reale senza origine o realtà: un iperreale. Il territorio non precede più la mappa, né vi sopravvive. […] È la mappa che precede il territorio – precessione dei simulacri – è la mappa che genera il territorio […]. L’età della simulazione comincia con l’eliminazione di tutti i referenti – peggio: con la loro resurrezione artificiale in un sistema di segni, che sono una materia più duttile dei significati perché si prestano a qualsiasi sistema di equilvalenza, a ogni opposizione binaria, e a qualsiasi algebra combinatoria. Non è più una questione di imitazione, né di duplicazione o di parodia. È piuttosto una questione di sostituzione del reale con segni del reale; cioè un’operazione di cancellazione di ogni processo reale attraverso il suo doppio operazionale. […] sarà un iperreale, al riparo da ogni distinzione tra reale e immaginario, che lascia spazio solo per la ricorrenza di modelli e per la generazione simulata di differenze.” (Simulacres et simulation)
PRESENTAZIONE
Il pensatore francese Jean Baudrillard è una delle principali figure intellettuali dell’epoca contemporanea; il suo lavoro combina la filosofia, la teoria sociale e una metafisica culturale idiosincratica che riflette sugli avvenimenti chiave dell’era presente. Critico tagliente della società, della cultura e del pensiero contemporanei, è spesso considerato come un leader carismatico della teoria postmoderna francese, sebbene possa essere visto anche come un pensatore che combina la teoria sociale e la filosofia in modi originali e provocatori e come uno scrittore che ha sviluppato uno stile e delle forme di scrittura proprie. È un autore estremamente prolifico che ha pubblicato oltre trenta libri e commentato alcuni dei fenomeni culturali più salienti dell’epoca contemporanea, inclusa l’eliminazione delle distinzioni di genere, razza e classe sociale che avevano strutturato le società moderne, eliminazione che si è avuta con l’entrata in una nuova società postmoderna, governata dal consumo, dai media e dall’alta tecnologia. Ha scritto inoltre sui ruoli mutevoli di arte ed estetica, sui cambiamenti fondamentali nella politica, nella cultura e negli esseri umani e anche sull’impatto dei nuovi media, dell’informazione e delle tecnologie cibernetiche nella creazione di un ordine sociale qualitativamente differente e che presenta dei cambiamenti sostanziali nella vita umana e sociale. Dopo essere stato per qualche anno una figura di culto della teoria postmoderna, a partire dagli anni ottanta fino a ad oggi Baudrillard è andato oltre il discorso postmoderno e ha sviluppato una maniera di analisi filosofica e culturale che risulta altamente idiosincratica. Questa introduzione al suo pensiero si incentra sullo sviluppo unico dei suoi modi di pensiero e su come sia passato dalla teoria sociale a quella postmoderna e, infine, a un tipo provocativo di analisi filosofica. In generale, Baudrillard può essere visto come un teorico che ha tracciato in maniera originale la vita dei segni e l’impatto della tecnologia sulla vita sociale e che ha criticato sistematicamente le correnti principali del pensiero moderno, sviluppando nello stesso tempo le proprie prospettive filosofiche.
VITA E PRIMI SCRITTI
Jean Baudrillard nacque nella città vescovile di Reims (Francia) nel 1929. In un’intervista dichiarò che i suoi nonni erano dei contadini e i suoi genitori degli impiegati statali. Affermò anche che fu il primo membro della sua famiglia a ottenere un grado di istruzione avanzato e che questo comportò una rottura con i suoi genitori e con l’ambiente culturale da cui proveniva. Nel 1956, incominciò a lavorare come professore in un liceo francese e nei primi anni sessanta lavorò presso la casa editrice francese Seuil. Inizialmente, Baudrillard era uno studioso della lingua e della cultura tedesca che pubblicò saggi sulla letteratura nella rivista Les temps modernes tra il 1962 e il 1963 e che tradusse opere di Peter Weiss e Bertold Brecht in francese, oltre a un libro di Wilhelm Mühlmann sui movimenti messianici rivoluzionari. Durante questo periodo, conobbe e studiò le opere di Henri Lefebvre, le cui critiche sulla vita quotidiana lo impressionarono, e Roland Barthes, le cui analisi semiologiche sulla società contemporanea ebbero un’influenza duratura sulla sua opera.
Nel 1966, Baudrillard incominciò a lavorare nell’università di Paris-Nanterre e divenne assistente di Lefebvre, studiando allo stesso tempo le lingue, la filosofia, la sociologia e altre discipline. Discusse la sua ‘Thèse de Troisième Cycle’ in sociologia a Nanterre nel 1966 con una dissertazione intitolata “Il sistema degli oggetti”, e incominciò a insegnare sociologia nell’ottobre dello stesso anno. Opponendosi all’intervento francese e americano nelle guerre d’Algeria e del Vietnam, negli anni sessanta si unì alla sinistra francese. Nanterre era un punto strategico per la politica radicale e il ‘movimento del 22 marzo’, associato a Daniel Cohn-Bendit e agli enragés, iniziò nel dipartimento di sociologia di Nanterre. Baudrillard rese noto più tardi che prese parte agli eventi del maggio 1968, che sfociarono in massicce rivolte studentesche e in uno sciopero generale che portò quasi alla destituzione di de Gaulle.
Durante la seconda metà degli anni sessanta, Baudrillard incominciò a pubblicare una serie di libri che alla fine lo fecero conoscere in tutto il mondo. Influenzato da Lefebvre, Barthes e una serie di pensatori francesi il cui influsso sarà discusso più avanti, intraprese uno studio approfondito nel campo della teoria sociale, della semiologia e della psicoanalisi e pubblicò il suo primo libro intitolato Il sistema degli oggetti nel 1968 (1996), seguito da un altro libro, La società consumistica nel 1970 (1998), e da Per una critica dell’economia politica del segno nel 1972 (1981). Queste prime pubblicazioni erano dei tentativi, nell’ambito della sociologia critica, di combinare gli studi della vita quotidiana iniziati da Lefebvre con una semiologia sociale che studiava la vita dei segni nella vita sociale. Questo progetto, influenzato da Barthes, si incentrava sul sistema degli oggetti nella società consumistica (il punto centrale dei suoi primi due libri) e sul punto di incontro tra l’economia politica e la semiotica (il nucleo del suo terzo libro). Queste opere furono tra le prime ad analizzare come gli oggetti sono codificati all’interno di un sistema di segni e di significati che costituisce le società mediatiche e consumistiche contemporanee. Combinando gli studi semiologici, l’economia politica marxiana e la sociologia della società consumistica, Baudrillard cominciò l’impresa di tutta una vita di esplorare il sistema degli oggetti e dei segni su cui si basa la nostra vita quotidiana.
Il primo Baudrillard descriveva i significati implicati negli oggetti quotidiani (es. il valore derivato dall’identificazioe con la propria automobile mentre si guida) e il sistema strutturale attraverso cui gli oggetti erano organizzati in una società nuova e moderna (es. il prestigio di una nuova auto sportiva). Nei suoi primi tre libri, Baudrillard sostenne che la critica marxiana classica dell’economia politica avesse bisogno di essere integrata da teorie semiologiche del segno che articolavano i diversi significati espressi dai significanti quali un linguaggio organizzato in un sistema di significato. Baudrillard, dopo Barthes e altri, ritenne che anche la moda, gli sport, i media e altri modi di significato producessero dei sistemi di significato articolati da regole, codici e logiche specifiche (questi termini, che venivano usati in maniera piuttosto intercambiabile da Baudrillard, sono spiegati più dettagliatamente più avanti).
Collocando la sua analisi dei segni e della vita quotidiana in una cornice storica, Baudrillaud sostenne che la transizione da uno stadio precedente di un capitalismo di mercato competitivo allo stadio di un capitalismo di monopolio richiedesse una maggiore attenzione verso il controllo della domanda e del consumo. A questo stadio storico, dal 1920 circa agli anni sessanta, il bisogno di intensificare la domanda dipendeva dall’abbassamento dei costi di produzione e dall’espansione della produzione. In quest’epoca di sviluppo capitalista, la concentrazione economica, le nuove tecniche di produzione e lo sviluppo di nuove tecnologie acceleravano la capacità di produzione di massa e le corporazioni capitaliste si concentravano sull’accresciuta attenzione nei confronti del controllo del consumo e della creazione di bisogni per nuovi beni di lusso, producendo in questo modo il regime di ciò che Baudrillard denominò segno-valore.
Secondo l’analisi di Baudrillard, la pubblicità, la presentazione, l’esposizione, la moda, la sessualità ‘emancipata’, i mass media, la cultura e la proliferazione di prodotti avevano moltiplicato la quantità di segni e prodotto un aumento di segno-valore. D’ora innanzi, dichiarava egli, i prodotti non erano più caratterizzati semplicemente dal valore d’uso e dal valore di scambio, come nella teoria dei beni di Marx, ma il segno-valore – l’espressione e la marca di stile, prestigio, lusso, potere e così via – diventava una parte sempre più importante del prodotto e del consumo. In questa prospettiva, Baudrillard affermava che i prodotti venivano comprati e mostrati tanto per il loro segno-valore che per il loro valore d’uso e che il fenomeno del segno-valore era diventato un elemento essenziale del prodotto e del consumo nella società consumistica. Questa posizione era stata influenzata dalla nozione di Veblen di ‘consumo cospicuo’ e di esposizione dei beni analizzata nella sua Teoria della classe del tempo libero che Baudrillard ritenne che si fosse estesa a ogni membro della società consumistica. Per Baudrillard, l’intera società era organizzata attorno al consumo e all’esposizione dei beni, attraverso i quali gli individui acquisivano prestigio, identità e reputazione sociale. In questo sistema, più prestigiosi sono i beni di una persona (case, automobili, vestiti e via dicendo), più è elevata la sua reputazione sociale nell’ambito del segno-valore. Così, proprio come le parole assumono un significato a seconda della loro posizione in un sistema differenziale di linguaggio, allo stesso modo i segni-valore assumono un significato a seconda del loro posto in un sistema differenziale di prestigio e di status sociale.
Ne La società consumistica, Baudrillard concluse decantando le ‘molteplici forme di rifiuto’ delle convenzioni sociali, del consumo cospicuo e del pensiero e del comportamento conformisti, forme che potevano essere riunite in una ‘pratica di cambiamento radicale’ (1998:183). Egli alludeva qui alle aspettative di ‘violente rivolte e di improvvisa disintegrazione che avrebbero distrutto, nella stessa maniera imprevedibile e certa che contraddistinse il maggio del 1968, questa bianca massa’ [di consumo]. Dall’altra parte, Baudrillard descrisse anche una situazione dove l’alienazione era così totale che non poteva esser risolta perché ‘è la struttura stessa della società di mercato’. Secondo lui, in una società dove tutto è un bene che può essere comprato e venduto, l’alienazione è totale. Infatti, il termine ‘alienazione’ originariamente significava ‘vendere’ e in una società completamente commercializzata dove tutto è un bene, l’alienazione è ovunque. Inoltre, Baudrillard postulava ‘la fine della trascendenza’ (una frase presa mutuata da Marcuse) laddove gli individui non potevano né percepire i propri bisogni autentici, né un’altra maniera di vivere (1998:190ff).
A partire dal 1970, Baudrillard prese le distanze dalla teoria rivoluzionaria marxista per postulare solo la possibilità di rivolta contro la società consumistica in una forma ‘imprevedibile ma certa’. Nella seconda metà degli anni sessanta, si unì a un gruppo di intellettuali che ruotavano attorno al giornale Utopie, che cercava di superare le costrizioni disciplinari e, nello spirito di Guy Debord e del Situazionismo internazionale, di combinare riflessioni su società alternative, architettura e modi di vita quotidiana. Riunendo assieme gli individui sui margini dell’architettura, dell’urbanistica, del criticismo culturale e della teoria sociale, Baudrillard e i suoi seguaci si separarono dalle altre correnti politiche e teoretiche e svilupparono un discorso idiosincratico e marginale che andava oltre i limiti delle discipline stabilite e delle tendenze politiche. Questa affiliazione con Utopie durò solo fino ai primi anni settanta, ma potrebbe aver contribuito a far nascere in Baudrillard un desiderio di lavorare ai margini, di non lasciarsi coinvolgere dalle tendenze del tempo e da mode passeggere e di sviluppare le proprie posizioni teoretiche.
Quindi, durante i primi anni settanta Baudrillard aveva una relazione ambivalete con il marxismo classico. Da una parte, continuava la critica marxiana della produzione dei beni che delineava e criticava varie forme di alienazione, dominio e sfruttamento prodotti dal capitalismo. In questo senso, sembrava che la sua critica si originasse dal modello della posizione vantaggiosa neo-marxiana che assumeva che il capitalismo fosse colpevole perché omogenizzava, controllava e dominava la vita sociale, privando gli individui della loro libertà, della loro creatività, del loro tempo e delle loro risorse umane. Dall’altra parte, però, egli non era in grado di indicare nessuna forza rivoluzionaria e in particolare non discuteva la situazione e il potenziale della classe operaia in quanto agente di cambio nella società consumistica. In effetti, Baudrillard non aveva alcuna teoria del soggetto in quanto agente attivo del cambiamento sociale, seguendo in questa maniera la critica strutturalista e poststrutturalista del soggetto filosofico e pratico categorizzato da Cartesio, Kant e Sartre che ha dominato a lungo il pensiero francese. Gli strutturalisti e i poststrutturalisti ritenevano che la soggettività fosse prodotta dal linguaggio, dalle istituzioni sociali e dalle forme culturali e che non fosse indipendente dalla sua costruzione in queste istituzioni e pratiche.
Allo stesso modo, Baudrillard non sviluppò una teoria di classe o di rivolta di gruppo, o una qualsiasi teoria di organizzazione politica, di lotta, o di strategia del genere che fu frequente nella Francia post-anni sessanta. Eppure, la sua opera è particolarmente vicina all’operato della scuola di Francoforte, specialmente quello di Herbert Marcuse, che aveva già delineato alcune delle prime critiche marxiste della società consumistica. Come Lukàcs (1971) e la scuola di Francoforte, Baudrillard analizzò come il prodotto e la commercializzazione permeassero la vita sociale e riuscissero a dominare il pensiero e il lavoro individuale. Seguendo la linea generale del marxismo critico, Baudrillard sosteneva che il processo della omogeneizzazione sociale, della alienazione e dello sfruttamento costituisse uno sviluppo della reificazione dei beni e delle tecnologie e che le cose (‘oggetti’) giungessero a dominare le persone (‘soggetti’) privandole delle loro qualità e capacità umane.
Per Lukàcs, la scuola di Francoforte e Baudrillard, la reificazione – il processo per mezzo del quale gli esseri umani sono dominati dalle cose e diventano simili a delle cose essi stessi – governava la vita sociale. Le condizioni di lavoro imponevano la sottomissione e la standardizzazione della vita umana, così come lo sfruttamento dei lavoratori e la loro alienazione da una vita libera e auto-determinante.
In un certo senso, l’opera di Baudrillard può essere considerata come una descrizione di uno stadio più avanzato di reificazione e di dominazione sociale di quello descritto dalla scuola di Francoforte, che descriveva come gli individui venissero controllati dalle istituzioni e dai modi di pensiero dominanti. Baudrillard si spinse oltre la scuola di Francoforte applicando la teoria semiologica del segno per descrivere come i beni, i media e le tecnologie creassero un universo di illusione e fantasia in cui gli individui diventavano preda di valori consumistici, ideologie mediatiche, modelli da seguire e tecnologie seduttive come i computer che fornivano mondi di ciberspazio. Alla fine, portò questa analisi del dominio dei segni e del sistema degli oggetti a conclusioni addirittura più pessimistiche, nelle quali sosteneva che la tematica della ‘fine dell’individuo’ anticipata dalla scuola di Francoforte aveva raggiunto il suo adempimento con la sconfitta totale della soggettività umana da parte del mondo degli oggetti.
Eppure in alcuni scritti, Baudrillard sostenne una teoria di consumo in qualche modo più attiva di quella della scuola di Francoforte, che generalmente dipingeva il consumo come una maniera passiva di integrazione sociale. Al contrario, nei primi scritti di Baudrillard il consumo stesso era una sorta di lavoro, ‘una manipolazione attiva dei segni’, un modo di inserirsi all’interno della società consumistica e di cercare di differenziarsi dagli altri. Tuttavia, questa manipolazione non equivaleva a postulare un soggetto umano attivo che potesse resistere, ridefinire, o produrre i propri segni, perciò egli non riuscì a sviluppare una autentica teoria di azione.
In quest’ottica, le prime tre opere di Baudrillard possono essere lette all’interno della cornice di una critica neo-marxiana delle società capitalistiche. Si potrebbe considerare la sua enfasi sul consumo come un’integrazione dell’analisi di Marx sulla produzione e il suo concentrarsi sulla cultura e sui segni come un’importante aggiunta all’economia politica del marxismo classico, ciò che aggiungeva una dimensione culturale e semiologica al progetto marxiano. Ma nella sua provocazione del 1973, Lo specchio della produzione, Baudrillard attaccò sistematicamente il marxismo classico, dichiarando che non era che uno specchio della società borghese e che poneva la produzione al centro della vita, naturalizzando così l’organizzazione capitalista della società.
Anche se negli anni sessanta Baudrillard partecipò ai tumultuosi eventi del maggio 1968 e fu collegato alla sinistra rivoluzionaria e al marxismo, si staccò definitivamente da quest’ultimo nei primi anni settanta, ma in politica rimase radicale, anche se non si associò più a nessun movimento per il resto del decennio. Come molti nella sinistra, fu deluso dal fatto che il partito comunista francese non avesse appoggiato i movimenti radicali degli anni sessanta e diffidò anche del marxismo ufficiale di teorici come Louis Althusser che egli trovava dogmatico e riduttivo. Di conseguenza, Baudrillard incominciò una critica radicale del marxismo che sarebbe stata ripresa da molti dei suoi contemporanei che, come lui, avrebbero preso una svolta postmoderna.
Baudrillard riteneva che il Marxismo, in primo luogo, non illuminasse adeguatamente le società premoderne che erano organizzate attorno alla religione, alla mitologia e all’organizzazione tribale e non attorno alla produzione. Sosteneva inoltre che il marxismo non procurasse una critica sufficientemente radicale delle società capitaliste, così come non forniva dei discorsi e delle prospettive critiche alternative. A questo punto, prese in considerazione le prospettive antropologiche sulle società premoderne per ottenere degli spunti riguardanti alternative di maggiore emancipazione. Ad ogni modo, è importante notare che questa critica del marxismo venne suggerita dalla sinistra, che riteneva che il marxismo non fornisse una critica abbastanza radicale, o un’alternativa alle società capitaliste e comuniste contemporanee organizzate attorno alla produzione. Baudrillard concluse sostenendo che il fatto che il comunismo francese non avesse appoggiato i movimenti del maggio del 1968 fosse dovuto in parte a un conservatorismo che aveva le sue radici nello stesso marxismo. Per cui, Baudrillard e altri della sua generazione incominciarono a cercare delle posizioni critiche alternative.
SCAMBIO SIMBOLICO E ROTTURA POSTMODERNA
Lo specchio della produzione e il libro successivo, Lo scambio simbolico e la morte (1976) sono tentativi di fornire delle prospettive estreme che superino le limitazioni di quella tradizione economista marxista che privilegiava la sfera economica. Tuttavia, questa fase di “estrema sinistra” del percorso di Baudrillard durò poco, anche se ne Lo scambio simbolico e la morte, egli diede vita a una delle sue provocazioni più clamorose.
Il testo si apre con una Prefazione che riassume il tentativo di Baudrillard di approcciarsi in maniera significativamente differente alla società e alla cultura. Basandosi sulla teoria culturale francese di Georges Bataille, Marcel Mauss e Alfred Jarry, Baudrillard sostenne la causa dello ‘scambio simbolico’, che si opponeva ai valori capitalisti di utilità e profitto monetario in favore di quelli culturali. Baudrillard sosteneva che nell’affermazione di Bataille che il consumo e l’eccesso sono connessi con l’autorità, nelle descrizioni di Mauss del prestigio sociale del dono nella società premoderna, nel teatro di Jarry che ridicolizza la cultura francese e negli anagrammi di Saussure, c’era una rottura con i valori capitalisti di scambio e produzione, o con la produzione di significato nello scambio linguistico. Questi casi di ‘scambio simbolico’, secondo Baudrillard, causavano una rottura con i valori di produzione e descrivevano lo scambio poetico e l’attività culturale creativa che forniva delle alternative ai valori capitalistici della produzione e dello scambio.
L’espressione ‘scambio simbolico’ deriva dalla nozione di Georges Bataille di un’‘economia generale’, in cui si ritiene che il consumo, la perdita, il sacrificio e la distruzione siano più fondamentali per la vita umana delle economie di produzione e di utilità. Il modello di Bataille era il sole che espande liberamente la sua energia senza chiedere niente in cambio. Egli pensava che se gli individui avessero voluto essere davvero indipendenti (p.es. liberi dagli imperativi del capitalismo) avrebbero dovuto adottare un’‘economia generale’ di consumo, elargizione, sacrificio e distruzione per sfuggire alla determinazione causata dagli imperativi di utilità.
Per Bataille, gli esseri umani sono esseri di eccesso, dotati di energie, fantasie, impulsi, bisogni esorbitanti e di desideri eterogenei. Baudrillard presupponeva la verità dell’antropologia e dell’economia generale di Bataille. In una recensione del 1976 di un volume delle Opere complete di Bataille, Baudrillard scrisse:
“L’idea centrale è che l’economia che governa le nostre società risulta da una appropriazione indebita del principio umano fondamentale, che è un principio solare di consumo”.
Nei primi anni Settanta, Baudrillard fece propria la posizione antropologica di Bataille e ciò che egli definiva la ‘critica aristocratica del capitalismo’ di Bataille, che egli dichiarava essere basata su delle grossolane nozioni di utilità e di risparmio piuttosto che su quella più ‘aristocratica’ di eccesso e consumo. A questo riguardo, Bataille e Baudrillard ritenevano che ci fosse una contraddizione tra la natura umana e il capitalismo. Essi asserivano che le persone per natura ottengono piacere da cose come il consumo, lo spreco, le feste, i sacrifici e così via, che le fanno sentire indipendenti e libere di spendere gli eccessi della loro energia (e seguire in questo modo la loro ‘vera natura’). Gli imperativi capitalisti di lavoro, profitto e risparmio sono implicitamente ‘innaturali’ e vanno contro la natura umana.
Baudrillard sosteneva che la critica marxiana del capitalismo, al contrario, attaccava solamente il valore di scambio, mentre esaltava il valore d’uso e quindi il profitto e la razionalità strumentale, cercando in tal modo ‘un buon uso dell’economia’. Per Baudrillard:
“Il marxismo è quindi solo una limitata critica piccolo-borghese, solo un passo in più verso la banalizzazione della vita alla volta del ‘buon uso’ del sociale! Bataille, invece, elimina tutta questa dialettica schiava fornendosi di un punto di vista aristocratico, quello del padrone che combatte contro la propria morte. Si potrebbe accusare questa prospettiva di essere pre- o post-marxista. Ad ogni modo, il marxismo è solo l’orizzonte disincantato del capitale – tutto ciò che lo precede o lo segue è più radicale di quanto esso non sia”.
Questo passaggio è altamente sintomatico e segna la svolta di Baudrillard verso una ‘critica aristocratica’ dell’economia politica profondamente influenzata da Bataille e Nietzsche. Infatti, Bataille e Baudrillard presentano una versione dell’aristocratica ‘moralità del padrone’ di Nietzsche, in cui gli individui ‘superiori’ producono i propri valori e la loro vita si esprime attraverso un eccesso, una sovrabbondanza e un’intensificazione delle energie creative ed erotiche. Per qualche tempo, Baudrillard continuò ad attaccare la borghesia, il capitale e l’economia politica, ma da una prospettiva che prendeva le difese del consumo ‘aristocratico’ e dei valori suntuari, estetici e simbolici. Il lato oscuro di questo cambiamento nelle realtà teoretiche e politiche era quella valorizzazione del sacrificio e della morte che permea Lo scambio simbolico e la morte (in cui il sacrificio fornisce un’elargizione che inverte i valori borghesi di profitto e autoconservazione).
In generale, nei suoi lavori della metà degli anni settanta, Baudrillard si allontanò dall’universo marxiano della produzione e della lotta di classe per giungere a una visione neo-aristocratica e metafisica del mondo. Egli sembrava assumere, a questo punto, che le società pre-capitaliste fossero governate da forme di scambio simbolico simili alla nozione di un’economia generale di Bataille.
Influenzato dalla teoria del dono e del controdono di Mauss, Baudrillard affermava che le società pre-capitaliste fossero governate da leggi di scambio simbolico piuttosto che dalla produzione e dal profitto.
Sviluppando queste idee, Baudrillard tracciò una linea divisoria fondamentale nella storia tra le società simboliche – organizzate attorno allo scambio premoderno – e quelle produttivistiche – organizzate attorno alla produzione e allo scambio di beni. Così facendo, egli rifiutò la filosofia marxiana della storia che presupponeva il primato della produzione in tutte le società e rifiutava inoltre il concetto marxiano di socialismo, ritenendo che esso non rinnegava in maniera sufficientemente radicale il produttivismo capitalista, proponendosi semplicemente come una organizzazione più efficiente ed equa della produzione piuttosto che un tipo di società completamente diversa, con valori e forme di cultura e di vita differenti.
In seguito, Baudrillard contrappose il suo ideale di scambio simbolico ai valori di produzione, profitto e razionalità strumentale che governano le società capitaliste (e socialiste). Lo ‘scambio simbolico’ emerse così come l’alternativa ‘rivoluzionaria’ di Baudrillard rispetto ai valori e alle pratiche della società capitalista e rappresentò una varietà di attività eterogenee nei suoi scritti degli anni settanta. Ad esempio, egli scrisse nella Critica:
“Lo scambio di apparenze, il presente che viene e se ne va, sono come l’aria che le persone inspirano ed espirano. Questo è il metabolismo dello scambio, della prodigalità, della festa – e anche della distruzione (che a sua volta risulta in un non-valore di ciò che la produzione ha eretto, valorizzato). In questo campo, il valore non è nemmeno riconosciuto”.
Egli descrisse anche la sua concezione di scambio simbolico ne Lo specchio della produzione, in cui scrisse:
“La relazione sociale simbolica è il ciclo ininterrotto del dare e del ricevere che, nello scambio primitivo, include il consumo del ‘surplus’ e dell’anti-produzione intenzionale”.
Il termine, perciò, si riferisce a delle attività simboliche o culturali, che non contribuiscono alla produzione capitalista, e all’accumulo di beni che potenzialmente costituisce una ‘negazione radicale’ della società produttivistica.
A questo stadio del suo pensiero, Baudrillard rientrava in una tradizione francese che esaltava una cultura ‘primitiva’ o premoderna rispetto a un razionalismo e un utilitarismo astratti, tipici della società moderna. In questo modo, la difesa di Baudrillard dello scambio simbolico nei confronti della produzione e della razionalità strumentale si collocava sulla linea della difesa di Rousseau del ‘buon selvaggio’ nei confronti dell’uomo moderno, della contrapposizione di Durkheim tra le solidarietà organiche delle società premoderne e l’astratto individualismo e l’anomia di quelle moderne, della valorizzazione di Bataille del consumo delle società premoderne, o del fascino di Mauss o Levi-Strauss per la ricchezza delle ‘società primitive’ o della ‘mente selvaggia’. Dopo aver smantellato il pensiero dei principali pensatori moderni e quello dei suoi padri teoretici (Marx, Freud, Saussure e i suoi contemporanei francesi) perché non erano riusciti a cogliere la ricchezza dello scambio simbolico, Baudrillard continuò a prendere le difese delle forme simboliche e radicali del pensiero e della scrittura in una ricerca che lo condusse a un discorso ancor più esoterico.
Così, in opposizione alle forme organizzatrici del pensiero e della società moderna, Baudrillard sosteneva lo scambio simbolico come alternativa. Andando contro le richieste moderne di produrre valore e significato, Baudrillard invocava il loro sterminio e il loro annullamento, fornendo come esempi lo scambio di doni di Mauss, gli anagrammi di Saussure e il concetto di Freud della pulsione di morte. In tutti questi esempi, c’è una rottura con le forme di scambio (di beni, significati ed energie pulsionali) e, di conseguenza, una fuga dalle forme di produzione, capitalismo, razionalità e significato. Il concetto paradossale di Baudrillard di scambio simbolico può essere spiegato come un’espressione di un suo desiderio di liberarsi dalle moderne posizioni e di cercarne una che fosse rivoluzionaria e al di fuori della società moderna. Opponendosi ai valori moderni, Baudrillard era a favore del loro annientamento.
Nelle sue opere della metà degli anni Settanta, tuttavia, Baudrillard pose un’altra linea di demarcazione nella storia tanto radicale quanto la rottura tra le società simboliche premoderne e quelle moderne. Sulla scia della teoria sociale classica, sviluppò sistematicamente le distinzioni tra le società premoderne organizzate attorno allo scambio simbolico, quelle moderne organizzate attorno alla produzione e quelle postmoderne organizzate attorno alla ‘simulazione’, termine con il quale egli designa i modi culturali di rappresentazione che ‘simulano’ la realtà come nella televisione, nel ciberspazio dei computer e nella realtà virtuale. La distinzione di Baudrillard tra il modo di produzione e il profitto che organizzavano le società moderne e il modo di simulazione che egli riteneva fosse la forma organizzatrice delle società postmoderne ipotizzava una frattura tra le società moderne e quelle postmoderne profonda quanto quella tra società moderne e premoderne. Nel teorizzare la rottura epocale tra società postmoderne e moderne, Baudrillard dichiarò la ‘fine dell’economia politica’ e di un’era in cui la produzione era stata la forma organizzatrice della società. D’accordo con Marx, Baudrillard sosteneva che questa epoca moderna fosse stata l’era del capitalismo e della borghesia, in cui i lavoratori erano stati sfruttati dal capitale e avevano posseduto la forza rivoluzionaria del sollevamento sociale. Baudrillard dichiarò la fine dell’economia politica e, quindi, la fine della problematica marxista e della modernità stessa:
“La fine del lavoro. La fine della produzione. La fine dell’economia politica. La fine della dialettica significante/significato che facilita l’accumulo di conoscenza e di significato, del sintagma lineare del discorso cumulativo. E, nello stesso tempo, la fine dello scambio valore/uso che è la sola cosa che rende possibili l’accumulo e la produzione sociale. La fine della dimensione lineare del discorso. La fine della dimensione lineare dei beni. La fine dell’era classica del segno. La fine dell’era della produzione”.
Il discorso ‘della fine’ significa che egli sta annunciando una rottura postmoderna nella storia. In questo momento, per Baudrillard, le persone sono in una nuova era di simulazione in cui la riproduzione sociale (l’elaborazione delle informazioni, la comunicazione e via dicendo) sostituisce la produzione in quanto forma organizzatrice della società. In questa epoca, il lavoro non è più una forza di produzione, ma è esso stesso un “segno tra i tanti”. Il lavoro non è primariamente produttivo in questa situazione, ma è un segno della posizione sociale di una persona, del suo modo di vivere e del suo modo di sottomissione. Anche gli stipendi non hanno più nessuna relazione con il lavoro di un individuo e con ciò che uno produce, ma sono collegati alla posizione che uno occupa all’interno del sistema. Tuttavia, in maniera decisiva, l’economia politica non è più la base, il determinante sociale, o addirittura la ‘realtà’ strutturale in cui altri fenomeni possono essere interpretati e spiegati. Piuttosto, le persone vivono in una ‘iperrealtà’ di simulazioni in cui le immagini e l’attività dei segni sostituiscono i concetti di produzione e di conflitto di classe in quanto elementi chiave delle società contemporanee.
Da questo punto in poi, il capitale e l’economia politica scompaiono dalla storia di Baudrillard, o ritornano in forme completamente nuove. I segni e i codici proliferano e producono altri segni in cicli senza fine. Quindi, la tecnologia sostituisce il capitale in questa storia e la semiurgia (interpretata da Baudrillard come la proliferazione di immagini, informazioni e segni) prende il posto della produzione. La sua svolta postmoderna è perciò collegata a una forma di determinismo tecnologico e a un rifiuto dell’economia politica come principio esplicativo esauriente – una mossa che molti dei suoi critici rifiutavano.
Lo scambio simbolico e la morte e gli studi successivi in Simulazione e Simulacri articolano il principio di una rottura fondamentale tra le società moderne e postmoderne e segnano l’allontanamento di Baudrillard dalla problematica della teoria sociale moderna. Per lui, le società moderne sono organizzate attorno alla produzione e al consumo di beni, mentre le società postmoderne sono organizzate attorno alla simulazione e all’attività di immagini e segni, che denota una situazione in cui i codici, i modelli e i segni sono le forme organizzatrici di un nuovo ordine sociale dove domina la simulazione. Nella società della simulazione, le identità sono costruite tramite l’appropriazione di immagini e codici e i modelli determinano come gli individui si percepiscono e si relazionano ad altre persone. L’economia, la politica, la vita sociale e la cultura sono tutte governate dal modo di simulazione, tramite il quale i codici e i modelli determinano come i beni siano consumati e usati, come sia spiegata la politica, come la cultura sia prodotta e consumata, e come la vita quotidiana sia vissuta.
Il mondo postmoderno di Baudrillard è anche un mondo in cui legami e distinzioni che precedentemente erano importanti – come quelli tra classi sociali, generi, tendenze politiche e domini, un tempo autonomi, della società e della cultura – perdono potere. Se le società moderne, per la teoria sociale classica, erano caratterizzate dalla differenziazione, per Baudrillard le società postmoderne sono caratterizzate dalla de-differenziazione, dal ‘collasso’ delle distinzioni, o dall’implosione. Nella società della simulazione di Baudrillard, i campi dell’economia, della politica, della cultura, della sessualità e del sociale implodono tutti quanti l’uno dentro l’altro. In questa miscela implosiva, l’economia è plasmata dalla cultura, dalla politica e da altre sfere; invece l’arte, un tempo una sfera di potenziale differenza e opposizione, è assorbita nell’ambito economico e politico, mentre la sessualità è ovunque. In questa situazione, le differenze tra gli individui e i gruppi implodono in una rapida e mutevole dissoluzione del sociale e delle precedenti strutture sulle quali la teoria sociale si era un tempo concentrata.
In aggiunta, questo universo postmoderno è un universo di iperrealtà in cui l’intrattenimento, l’informazione e le tecnologie comunicative forniscono esperienze più intense e coinvolgenti delle scene banali della vita di tutti i giorni, così come forniscono dei codici e dei modelli che strutturano la vita quotidiana. Il reame dell’iperreale (p. es. le simulazioni mediatiche della realtà, Disneyland e i parchi dei divertimenti, i centri commerciali e altre escursioni in mondi ideali) è più reale del reale e attraverso di esso i modelli, le immagini e i codici dell’iperreale controllano il pensiero e il comportamento. Eppure, la determinazione stessa è aleatoria in un mondo non lineare dove è impossibile pianificare meccanismi casuali in una situazione in cui gli individui sono confrontati con un flusso incontenibile di immagini, codici e modelli, ognuno dei quali può influenzare il pensiero o il comportamento.
In questo mondo postmoderno, gli individui fuggono dal “deserto del reale” per provare le estasi dell’iperrealtà e del nuovo regno dei computer, dei media e dell’esperienza tecnologica. Le soggettività sono frammentate e perdute, e si profila un nuovo terreno di esperienze che, per Baudrillard, rende le precedenti teorie sociali e politiche obsolete e irrilevanti. Delineando le vicissitudini del soggetto nella società presente, Baudrillard dichiarò che i soggetti contemporanei non sono più afflitti da patologie moderne come l’isteria o la paranoia. Piuttosto, essi vivono in uno
“stato di terrore che è caratteristico dello schizofrenico, una promiscuità oscena di tutte le cose che lo assilla e lo penetra senza incontrare nessuna resistenza e nessuna aura, neppure quella del suo stesso corpo. A discapito di se stesso, lo schizofrenico è aperto a qualsiasi esperienza e vive nella più totale confusione”.
Per Baudrillard, l’“estasi della comunicazione” significa che il soggetto è vicino alle immagini istantanee e all’informazione, in un mondo sovraesposto e trasparente. In questa situazione, il soggetto “diventa un mero schermo, una semplice superficie che assorbe e riassorbe le reti influenti”. In altre parole, un individuo nel mondo postmoderno diventa semplicemente un’entità influenzata dai media, dall’esperienza tecnologica e dall’iperreale.
Così, le categorie di simulazione, implosione e iperrealtà si combinano per creare una condizione postmoderna emergente che richiede modi totalmente nuovi di teoria e di politica per pianificare e rispondere alle novità dell’era contemporanea. Le strategie di stile e di scrittura di Baudrillard sono anch’esse implosive (cioè vanno contro distinzioni che prima erano importanti), combinando materiale proveniente da campi nettamente diversi, guarnito di esempi presi dai mass media e dalla cultura popolare successivamente messi insieme in una maniera innovativa tipica della teoria postmoderna, che non rispetta i limiti disciplinari. La sua stessa scrittura tenta di simulare le nuove condizioni, catturando le sue originalità attraverso l’uso creativo del linguaggio e della teoria. Tali interrogativi radicali sulla teoria contemporanea e il bisogno di nuove strategie teoretiche sono così legittimati da Baudrillard per mezzo di un ampio numero di cambiamenti nell’era presente.
Ad esempio, egli dichiarò che la modernità operava con un modo di rappresentazione in cui le idee rappresentavano la realtà e la verità, concetti che erano i postulati chiave della teoria moderna. Una società postmoderna scredita questa epistemologia creando una situazione in cui i soggetti perdono il contatto con il reale, si frammentano e si dissolvono. Questa situazione preannuncia la fine della teoria moderna che operava con una dialettica soggetto-oggetto in cui il soggetto rappresentava e controllava l’oggetto. Nella storia della filosofia moderna, il soggetto filosofico tenta di discernere la natura della realtà, per assicurarsi una conoscenza fondata, e di applicare questa conoscenza per controllare e dominare l’oggetto (cioè la natura, le altre persone, le idee e così via). Baudrillard seguiva la critica poststrutturalista, secondo la quale il pensiero e il discorso non possono più essere ancorati saldamente in strutture a priori o privilegiate del ‘reale’. Reagendo contro il modo di rappresentazione nella teoria moderna, il pensiero francese, specialmente quello di qualche decostruzionista (i “testualisti forti” di Rorty), si orientò maggiormente verso l’attività della testualità, del discorso, che, presumibilmente, si riferiva solo ad altri testi o discorsi in cui il ‘reale’ era bandito dal regno della nostalgia.
In maniera simile, Baudrillard, convinto sostenitore della teoria dei simulacri, dichiarò che nella società mediatica e consumistica le persone sono catturate dalle attività delle immagini e hanno sempre meno relazioni con una ‘realtà’ esterna, al punto che i concetti stessi di sociale, politico, o addirittura di ‘realtà’ non sembrano più avere nessun significato. La coscienza drogata e mesmerizzata (alcune tra le metafore di Baudrillard), satura dei media, è in uno stato tale di adorazione dell’immagine che il concetto del significato stesso (che dipende da limiti stabili, strutture fisse, consenso condiviso) si dissolve. In questa allarmante e nuova situazione postmoderna, il referente, ciò che sta oltre e al di fuori, assieme a ciò che sta in profondità, che costituisce l’essenza e la realtà, sparisce, causando la dissoluzione anche di ogni potenziale opposizione. Nella misura in cui le simulazioni proliferano, esse finiscono col riferirsi solo a se stesse: una fiera di specchi che riflettono immagini proiettate da altri specchi sulla televisione onnipresente, sullo schermo del computer e su quello della coscienza, che a sua volta rinvia l’immagine al magazzino da dove proveniva, magazzino pieno di altre immagini, anch’esse prodotte da specchi simulatori. Imprigionate nell’universo delle simulazioni, le ‘masse’ sono “immerse in un bagno mediatico” privo di messaggi o di significati, un’era di massa dove le classi scompaiono e la politica è morta, come lo sono i grandi sogni di disalienazione, liberazione e rivoluzione.
Baudrillard ritiene che, da questo punto in poi, le masse cerchino un’immagine e non un significato. Esse implodono in una “maggioranza silente”, che rappresenta “la fine del sociale”. La teoria sociale perde il suo stesso obiettivo nel momento in cui i significati, le classi e le differenze implodono in un “buco nero” di non-differenziazione. Le distinzioni tra gruppi sociali e ideologie implodono anch’esse e le concrete relazioni sociali faccia a faccia regrediscono nella misura in cui gli individui scompaiono nei mondi della simulazione – i media, i computer e la stessa realtà virtuale. In questo modo, la teoria sociale perde il suo oggetto, il sociale, mentre la politica radicale perde il suo soggetto e la sua funzione.
Tuttavia, a questo punto della sua traiettoria (tra gli anni Settanta e Ottanta), quel rifiuto del significato e della partecipazione da parte delle masse era una forma di resistenza. Indeciso tra la nostalgia e il nichilismo, Baudrillard eliminò in un colpo solo le idee moderne (p. es. il soggetto, il significato, la verità, la realtà, la società, il socialismo e l’emancipazione) e affermò un modo di scambio simbolico che sembrava manifestare un desiderio nostalgico di ritornare a forme culturali premoderne. Nonostante ciò, questa disperata ricerca di un’alternativa veramente rivoluzionaria venne abbandonata nei primi anni ottanta. Da allora in poi, egli sviluppò prospettive ancora più innovative sul periodo contemporaneo, vacillando tra il delineare modi alternativi di pensiero e di comportamento e il rinunciare alla ricerca di un cambiamento politico e sociale.
In un certo senso, in Baudrillard c’è un’inversione parodica del materialismo. Al posto dell’enfasi di Marx sull’economia politica e sul primato dell’economia, per Baudrillard è il modello, la sovrastruttura, che genera il reale in una situazione che egli definisce come la “fine dell’economia politica”. Secondo lui, i segni-valore predominano sui valori d’uso e sui valori di scambio; la materialità dei bisogni e i valori d’uso dei beni che servono per soddisfare tali bisogni scompaiono nel suo immaginario semiologico, in cui i segni hanno la precedenza sul reale e sono in grado di ricostruire la vita umana. Rivolgendo le categorie marxiste contro se stesse, le masse assorbono le classi, il soggetto della prassi è frantumato e gli oggetti dominano gli esseri umani. La rivoluzione è fagocitata dall’oggetto della critica e l’implosione tecnologica sostituisce la rivoluzione socialista nel produrre una frattura nella storia. Per Baudrillard, in contrasto con Marx, la catastrofe della modernità e l’eruzione della postmodernità sono prodotte dall’esplosione della rivoluzione tecnologica. Di conseguenza, Baudrillard sostituisce la rigida economia di Marx, il determinismo sociale e la sua enfasi sulla dimensione economica, la lotta di classe e la prassi umana, con una forma di “idealismo semiologico” e di “determinismo tecnologico” dove i segni e gli oggetti dominano il soggetto.
Baudrillard conclude così, sostenendo che “la catastrofe è avvenuta”, che la distruzione della modernità e della teoria moderna, che egli aveva previsto nella metà degli anni Settanta, è stata completata dallo sviluppo della stessa società capitalista, che la modernità è scomparsa e una nuova situazione sociale ha preso il suo posto. Contro le tradizionali strategie di ribellione e rivoluzione, Baudrillard incomincia a sostenere quelle che definisce “strategie fatali” che spingono i valori del sistema al limite, nella speranza di un collasso o di un rovesciamento, e alla fine adotta uno stile di discorso metafisico altamente ironico che rinnega l’emancipazione, il discorso e le speranze di una trasformazione sociale progressiva.
PATAFISICA E TRIONFO DELL’OGGETTO
Il pensiero di Baudrillard, dalla metà degli anni Sessanta in poi, mette in discussione le teorie di varie discipline. Durante gli anni Ottanta, le sue opere principali scritte nel decennio precedente furono tradotte in molte lingue e i nuovi libri furono a loro volta tradotti in inglese e nelle altre lingue più diffuse poco tempo dopo. Di conseguenza, egli divenne famoso in tutto il mondo come uno dei più influenti pensatori della postmodernità. Era una sorta di celebrità accademica, che si diffondeva per il mondo promuovendo la sua opera e guadagnandosi un seguito significante, anche se più al di fuori dell’ambito della teoria accademica che all’interno della disciplina della sociologia.
Mentre il suo lavoro stava diventando estremamente popolare, la sua scrittura divenne sempre più oscura. Nel 1979, Baudrillard pubblicò Seduzione, un testo di difficile interpretazione che rappresentò una svolta fondamentale all’interno del suo pensiero. Questo libro denota un allontanamento dal discorso più prettamente sociologico delle sue opere precedenti per avvicinarsi a delle aree più filosofiche e letterarie. Se ne Lo scambio simbolico e la morte Baudrillard indicò delle prospettive ultra-rivoluzionarie come alternativa radicale, considerando lo scambio simbolico come il suo ideale, ora trovava la sua alternativa alla produzione e all’interazione comunicativa nella seduzione. Tuttavia, la seduzione non indeboliva, invertiva, o trasformava le relazioni sociali o le istituzioni esistenti, ma era un’alternativa moderata, un gioco con le apparenze e con il femminismo, una provocazione che diede origine a una critica graffiante. Per Baudrillard, il concetto di seduzione era idiosincratico e implicava dei giochi con i segni che facevano della seduzione un aristocratico ‘ordine di segni e rituali’, in contrasto con l’ideale borghese della produzione; nel medesimo tempo, questo ordine favoriva l’artificio, l’apparenza, il gioco e la sfida contro il lavoro eccessivamente serio, finalizzato alla produzione. Baudrillard interpretava la seduzione soprattutto come un rituale e un gioco con regole, attrattive, insidie e lusinghe proprie. A questo punto, il suo diventò un estetismo neo-aristocratico dedicato a modi stilizzati di pensiero e di scrittura, che presentava una serie di categorie – la reversibilità, la sfida, il duello – che conducevano il suo pensiero verso forme aristocratiche di estetismo e metafisica.
Le prolifiche speculazioni metafisiche di Baudrillard sono evidenti in Strategie fatali (1983), un’altra pietra miliare nella sua carriera. Questo testo presenta un bizzarro scenario metafisico riguardante il trionfo degli oggetti sui soggetti all’interno della proliferazione ‘oscena’ di un mondo oggettificato talmente fuori controllo da oltrepassare tutti i tentativi di capirlo, concettualizzarlo e dominarlo. Questo scenario concerne la proliferazione e la crescente supremazia degli oggetti sui soggetti e il trionfo finale dell’oggetto. In una discussione in Estasi e inerzia, Baudrillard discute su come gli oggetti e gli eventi nella società contemporanea si superino continuamente, espandendo il loro potere. l’ ‘estasi’ degli oggetti consiste proprio in questa loro immensa espansione; è l’estasi intesa come l’andare al di fuori o oltre se stessi: è il bello che nella moda diventa più bello del bello, il reale che in televisione diventa più reale del reale, il sesso che nella pornografia diventa più sessuale del sesso. L’estasi è dunque la forma di oscenità (pienamente esplicita, nulla è nascosto) e di iperrealtà descritta precedentemente da Baudrillard e qui considerata a un altro livello, raddoppiata e intensificata. La sua visione della società contemporanea mostra una crescita altalenante, una escrescenza (croissance et excroissance) che espande e secerne beni, servizi, informazioni, messaggi, o richieste sempre più numerosi – superando tutti i limiti razionali in una spirale di crescita e riproduzione incontrollate.
Eppure, secondo Baudrillard, la crescita, l’accelerazione e la proliferazione hanno raggiunto estremi tali che l’estasi dell’escrescenza (cioè il crescente numero di beni) è accompagnata dall’inerzia. Il processo di crescita presenta una catastrofe per il soggetto, poiché non solo l’accelerazione e la proliferazione del mondo oggettificato intensificano la dimensione aleatoria del caso e dell’indeterminazione, ma gli oggetti stessi finiscono con il dominare il soggetto esausto, il cui interesse per il gioco degli oggetti si trasforma in apatia, stordimento e inerzia.
Il crescente potere del mondo degli oggetti sul soggetto è stata fin dall’inizio una delle tematiche principali di Baudrillard, il quale sottolineava così una soggiacente unità nel suo progetto. Nei suoi primi scritti, egli studiò i modi in cui i beni incantavano gli individui nella società consumistica e i modi in cui il mondo dei beni assumeva un nuovo e maggior valore attraverso l’intervento del segno-valore e del codice – che erano parti del mondo delle cose, il sistema degli oggetti. Le sue polemiche contro il marxismo furono alimentate dalla convinzione che il segno-valore e il codice fossero più importanti, nel costituire la società contemporanea, dei tradizionali elementi di economia politica come il valore di scambio, il valore d’uso, la produzione e così via. Perciò, le riflessioni sui media occuparono il primo posto nei suoi pensieri: nel pensiero iniziale di Baudrillard, la televisione in quanto elettrodomestico era situata nel centro della casa e i media, le simulazioni, l’iperrealtà e l’implosione finivano per cancellare le distinzioni tra privato e pubblico, dentro e fuori, media e realtà. Dunque tutto era pubblico, trasparente e iperreale nel mondo oggettificato, il quale, con il passare degli anni, stava diventando sempre più seducente e affascinante.
In Strategie fatali e negli scritti successivi, l’oggetto domina o ‘sconfigge’ il soggetto. Le ‘strategie fatali’ suggeriscono che gli individui dovrebbero semplicemente sottomettersi alle strategie e agli artifici degli oggetti. Nelle ‘strategie banali’, “il soggetto pensa di essere più intelligente dell’oggetto, mentre nelle altre [le strategie fatali] si ritiene che l’oggetto sia più sagace, più cinico, più brillante del soggetto”. Precedentemente, nelle strategie banali, il soggetto credeva di essere più abile e indipendente dell’oggetto. Una strategia fatale, invece, riconosce la supremazia dell’oggetto e perciò parteggia per l’oggetto e si arrende alle sue strategie, ai suoi stratagemmi e alle sue regole.
In queste opere, sembra che Baudrillard conduca la sua teoria nel regno della metafisica, ma è un tipo particolare di metafisica, ispirata profondamente dalla patafisica sviluppata da Alfred Jarry. Per Jarry
“La patafisica è la scienza di ciò che si trova oltre la metafisica. […] Essa studia le leggi che governano le eccezioni e spiega un universo supplementare a quello in cui ci troviamo noi; oppure, meno ambiziosamente, descrive un universo che si può vedere – si deve vedere, forse – al posto di quello tradizionale.
Definizione: la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie, che attribuiscono simbolicamente le proprietà degli oggetti, descritti dalla loro virtualità, alle loro caratteristiche”.
Come l’universo di Ubu Roi, le gesta e le opinioni del Dottor Faustroll (1969) di Jarry, e altri testi letterari – e anche le spiegazioni più teoretiche della patafisica di Jarry – quello di Baudrillard è un universo totalmente assurdo, dove gli oggetti comandano in modi misteriosi e dove le persone e gli eventi sono governati da interconnessioni assurde e dalla predestinazione (il drammaturgo francese Eugène Ionesco fornisce un altro buon esempio di questo universo). Come la patafisica di Jarry, l’universo di Baudrillard è dominato dalla sorpresa, dal capovolgimento, dall’allucinazione, dall’empietà, dall’oscenità e dal desiderio di scandalizzare e oltraggiare.
Così, in vista della crescente supremazia dell’oggetto, Baudrillard voleva che si abbandonasse il soggetto per schierarsi dalla parte dell’oggetto. Patafisica a parte, sembra che Baudrillard stesse tentando di porre una fine alla filosofia della soggettività, che aveva controllato il pensiero francese fin dai tempi di Cartesio, prendendo una direzione totalmente opposta. Il malin genie di Cartesio era uno stratagemma del soggetto che cercava di convincerlo ad accettare ciò che non era né chiaro né distinto, ma sul quale, in ultima istanza, egli era in grado di prevalere. Il ‘genio maligno’ di Baudrillard è l’oggetto stesso che è addirittura peggio degli inganni meramente epistemologici del soggetto affrontati da Cartesio e che costituisce un destino fatale che richiede la fine della filosofia della soggettività. Perciò, per Baudrillard, le persone vivono in un’era caratterizzata dal dominio dell’oggetto.
CAPOVOLGIMENTO IMMANENTE E SCAMBIO IMPOSSIBILE
Negli anni Ottanta, Baudrillard postulò un “capovolgimento immanente”, un rovesciamento di fronte dei significati e degli effetti, in cui le cose si trasformassero nei loro opposti. Per cui, secondo lui, la società della produzione stava andando verso la simulazione e la seduzione; il potere onnicomprensivo e repressivo teorizzato da Michel Foucault stava diventando il potere cinico e seduttivo dei media e della società dell’informazione; la liberazione sostenuta negli anni Sessanta era diventata una forma di schiavitù volontaria; la sovranità era passata dalla parte del soggetto a quella dell’oggetto; e la rivoluzione e l’emancipazione erano diventate i loro opposti, intrappolando gli individui in un ordine di simulazione e virtualità. Il concetto di Baudrillard di “capovolgimento immanente” era quindi una variante della “dialettica dell’illuminismo” di Horkheimer e Adorno, dove tutto diventa l’opposto. Per Adorno e Horkheimer, all’interno delle trasformazioni del capitalismo organizzato e all’avanguardia, i modi dell’illuminismo diventano una dominante, la cultura diventa l’industria culturale, la democrazia una forma di manipolazione di massa, e la scienza e la tecnologia una parte cruciale di un apparato di dominio sociale.
Baudrillard continuò a ribadire questo concetto di capovolgimento e la sua visione metafisica paradossale e nichilistica fino agli anni Novanta, quando il suo pensiero si fece ancora più ermetico e frammentario. Durante questo decennio, egli continuò a rivestire il ruolo di superstar accademica e mediatica, viaggiando per il mondo a tener conferenze e partecipando a eventi intellettuali. Alcune delle sue esperienze sono racchiuse nelle sue collezioni di aforismi, Bei ricordi (1990), Bei ricordi II (1996), Frammenti. Bei ricordi III, 1990-1995, e Bei ricordi IV, 1995-2000. Questi testi combinano riflessioni su viaggi ed esperienze con lo sviluppo delle sue idee e percezioni. I suoi diari frammentari spesso forniscono delle introspezioni rivelatrici all’interno della sua vita personale e della sua psicologia, catturando allo stesso tempo esperienze e scene che generano o incarnano alcune delle sue idee. Anche se spesso ripetitivi, questi diari danno accesso diretto all’uomo e alle sue idee, e lo confermano nel suo ruolo di superstar intellettuale e globale che viaggia attorno alla terra e di cui ogni annotazione è meritevole di essere pubblicata e presa in considerazione.
Dopo essersi ritirato dall’università di Nanterre nel 1987, Baudrillard divenne un intellettuale indipendente che si dedicava a riflessioni caustiche sull’epoca contemporanea e a meditazioni filosofiche che coltivavano la sua peculiare teoria sempre in evoluzione. Dal giugno 1987 fino al maggio dello stesso anno, pubblicò riflessioni su eventi e fenomeni di attualità nel giornale parigino Liberation, una serie di scritti raccolti in Eliminati e che introducevano a un laboratorio di idee che vennero sviluppate più tardi nei suoi libri.
Il ritiro di Baudrillard dalla facoltà di sociologia sembra aver liberato i suoi impulsi filosofici e, in aggiunta ai suoi diari e a incursioni occasionali in argomenti di attualità, egli produsse una serie di testi teorici sempre più filosofici e densamente teoretici. Durante gli anni Novanta, i suoi lavori inclusero L’evidenza del male (1990), La guerra del Golfo non c’è mai stata (1991), L’illusione della fine (1992), Il crimine perfetto (1995) e Lo scambio impossibile (1999). Questi testi proseguono le sue escursioni nella metafisica dell’oggetto, la sconfitta del soggetto e l’impegno ironico nella storia e nella politica contemporanee. Riunendo le riflessioni che sviluppano le sue idee e commentano eventi contemporanei, questi testi continuano a postulare una rottura all’interno della storia nell’ambito di una coupure postmoderna, anche se Baudrillard stesso di solito prendeva le distanze da altre versioni della teoria postmoderna.
I testi successivi agli anni Novanta, sono anch’essi caratterizzati da uno stile frammentario e rapsodico, e fanno uso di brevi saggi, aforismi, storie che Baudrillard incominciò a impiegare negli anni Ottanta e che spesso ribadivano gli stessi concetti. Mentre i libri sviluppavano le prospettive quasi metafisiche degli anni Ottanta, generavano anche alcune idee nuove. Essi sono spesso divertenti, ma possono essere anche oltraggiosi e scandalosi. Questi scritti possono essere letti come un mix di prospettive teoretiche originali con commenti sulle condizioni della società contemporanea, accompagnati da un dialogo continuo con il marxismo, la teoria post-strutturalista e altre forme di pensiero contemporaneo. Eppure, dopo le polemiche taglienti degli anni settanta contro i modelli competitivi di pensiero, il dialogo di Baudrillard con la teoria consisteva, in questo momento, soprattutto in digressioni occasionali e nel recupero di idee precedenti, che forse illustravano ironicamente le sue tesi riguardo il declino della teoria e della politica nell’era contemporanea.
Ne L’evidenza del male (1993), Baudrillard descrisse una situazione in cui i domini, una volta separati, dell’economia, dell’arte, della politica e della sessualità si ripiegavano gli uni sugli altri. Dichiarava che l’arte, ad esempio, si era diffusa in tutte le sfere dell’esistenza, perciò i sogni dell’avanguardia artistica di pervadere la vita si erano realizzati. Tuttavia, secondo lui, con la concretizzazione dell’arte nella vita di tutti i giorni, l’arte stessa in quanto fenomeno separato e trascendente era scomparsa.
Baudrillard definiva questa situazione “transestetica” e la collegava a fenomeni simili di “transpolitica”, “transessualità” e “transeconomia”, nei quali tutto diventava politico, sessuale ed economico, cosicché questi domini, come nel caso dell’arte, perdevano la loro specificità, i loro confini e il loro essere distinti gli uni dagli altri. Il risultato era una condizione confusa in cui non c’erano più criteri di valore, di giudizio, o di gusto, e la funzione normativa sprofondava in questa maniera in una palude di indifferenza e inerzia. E così, anche se Baudrillard vedeva l’arte proliferare ovunque e ne L’evidenza del male scrisse che “discutere d’Arte sta diventando sempre più popolare”, il potere dell’arte – dell’arte come avventura, negazione della realtà, illusione redentrice, dimensione alternativa, e via dicendo – era scomparso. L’arte era dappertutto, ma “non ci sono più regole fondamentali” per differenziare l’arte da altri oggetti e “non ci sono più criteri di giudizio o di piacere”. Per Baudrillard, gli individui contemporanei sono indifferenti al gusto e manifestano solo disgusto: “i gusti non sono più determinati”.
Tuttavia, in quanto proliferazione di immagini, forme, linee, colori, disegni, l’arte è più fondamentale che mai per l’ordine sociale contemporaneo:
“la nostra società ha dato vita a una esteticizzazione generale: tutte le forme di cultura – senza escludere quelle anti-culturali – sono ammesse e tutti i modelli di rappresentazione e anti-rappresentazione sono accettati”.
Perciò, Baudrillard concludeva:
“Si dice spesso che la grande impresa dell’Occidente è la commercializzazione del mondo intero, il balzo dal fato del tutto al fato del prodotto. Quella grande impresa risulterà poi essere stata l’esteticizzazione del mondo intero – la sua spettacolarizzazione cosmopolita, la sua trasformazione in immagini, la sua organizzazione semiologica”.
Nella società postmoderna mediatica e consumatrice, tutto diventa un’immagine, un segno, uno spettacolo, un oggetto transestetico – nella stessa misura in cui tutto diventa anche trans-economico, trans-politico e trans-sessuale. Questa “materializzazione dell’estetica” è accompagnata da un tentativo disperato di simulare l’arte, di riprodurre e mischiare forme e stili artistici precedenti e di creare immagini e oggetti artistici ancora più numerosi. Ma questo “eclettismo frastornante” di forme e piaceri genera una situazione in cui l’arte non è più arte in senso classico o moderno, ma è una semplice immagine, un artefatto, un oggetto, una simulazione, o un prodotto (Baudrillard era consapevole dei prezzi in aumento esorbitante per le opere d’arte, ma lo considerava una prova del fatto che l’arte era diventata qualcos’altro nell’iperspazio orbitale del valore, era diventata un’estasi di dimensioni immense in “una sorta di opera spaziale”).
Esempi dello stile paradossale e ironico delle meditazioni filosofiche di Baudrillard abbondano ne Il crimine perfetto. In questo libro, egli afferma che la negazione di una realtà trascendente nella presente società mediatica e tecnologica è un “crimine perfetto” che implica la “distruzione del reale”. In un mondo di apparenza, immagine e illusione, la realtà scompare anche se le sue tracce continuano a nutrire un’illusione del reale. Guidate verso la virtualizzazione in una società altamente tecnologica, tutte le imperfezioni della vita umana e del mondo sono eliminate nella realtà virtuale, ma questa è l’eliminazione della realtà stessa, il Crimine Perfetto. Questo stato ‘post-critico’ e ‘catastrofico’ rende il mondo concettuale precedente irrilevante, costringendo il criticismo a diventare ironico e a trasformare la scomparsa del reale in una forma d’arte.
Baudrillard si era introdotto in un mondo di pensiero lontano dalla filosofia accademica, un mondo che metteva in discussione i tradizionali modi di pensiero e di discorso. La sua ricerca di nuove prospettive filosofiche gli aveva procurato un pubblico globale leale, ma anche critiche per la sua eccessiva ironia, i suoi giochi di parole e i suoi svaghi intellettuali. Ad ogni modo, il suo lavoro è una provocazione alla filosofia tradizionale e contemporanea e sfida i pensatori ad affrontare antichi problemi filosofici quali la verità e la realtà in modi nuovi, all’interno del mondo contemporaneo.
Baudrillard sviluppò questa linea di pensiero nel suo testo del 1999 Lo scambio impossibile. In tre parti contenenti una serie di brevi saggi, egli delinea dapprima il suo concetto di “scambio impossibile” tra i concetti e il mondo, la teoria e la realtà, il soggetto e l’oggetto. In seguito, attacca i tentativi filosofici di afferrare la realtà, ritenendo che ci sia incommensurabilità tra i concetti e i loro oggetti, i sistemi di pensiero e il mondo. Quest’ultimo sfugge sempre alla presa da parte dei primi, quindi la filosofia è uno “scambio impossibile”, perché è impossibile cogliere la verità del mondo, avere delle certezze, stabilire un fondamento per la filosofia, e produrre un sistema filosofico giustificabile.
Il gioco filosofico di Baudrillard con la distinzione soggetto/oggetto, il suo abbandono del soggetto, e il suo accostamento all’oggetto è un aspetto fondamentale del suo pensiero. Egli identifica questa dicotomia con la dualità del bene e del male nella quale la coltivazione del soggetto e il suo dominio da parte dell’oggetto è considerata come il bene nell’ambito del pensiero occidentale, mentre la sovranità dell’oggetto è associata al principio del male. Il pensiero di Baudrillard è radicalmente dualistico, quasi manicheo, ed egli parteggia per il polo in una serie di dicotomie del pensiero occidentale che generalmente sono state derise poiché considerate inferiori, come sostenere l’apparenza rispetto alla realtà, l’illusione rispetto alla verità, il bene rispetto al male, e la donna rispetto all’uomo. Ne Il crimine perfetto, Baudrillard dichiarò che la realtà era stata distrutta e perciò le persone vivevano in un mondo di mera apparenza. In questo universo, la certezza e la verità erano impossibili e quindi Baudrillard prendeva le difese dell’illusione, ritenendo, ne Lo scambio impossibile, che “l’illusione è la regola fondamentale”.
Baudrillard sosteneva anche che il mondo era senza significato e che affermarne l’insensatezza era liberatorio:
“se potessimo accettare questa insensatezza del mondo, allora potremmo giocare con le forme, le apparenze e i nostri impulsi senza preoccuparci della loro meta finale. […] Come dice Cioran, non siamo dei fallimenti fino a quando crediamo che la vita abbia un significato – e da quel punto in avanti siamo dei fallimenti, perché la vita non ha un significato”.
In maniera controversa, Baudrillard classificava anche il principio del male, definito come ciò che si oppone al bene. Certamente, c’è una dimensione manichea e gnostica nel suo pensiero, oltre a un profondo cinismo e nichilismo. La decostruzione, tuttavia, smonta la dicotomia soggetto/oggetto suggerendo l’impossibilità di sostenere il soggetto o l’oggetto, il bene o il male, in quanto essi sono legati gli uni agli altri e non ci può essere un oggetto senza un soggetto e viceversa; un’argomentazione, questa, già proposta da Adorno. Il pensiero di Baudrillard è intrinsecamente dualistico e non dialettico; esso è esplicitamente polemico e attacca le teorie rivali. Le contraddizioni non preoccupavano Baudrillard poiché egli stesso le enfatizzava. Perciò era rischioso discutere con lui su basi strettamente filosofiche e bisognava comprendere il suo modo di scrivere, la sua nozione di narrative teoriche e tenere conto della loro importanza e dei loro effetti.
LA NARRATIVA TEORICA E LE ILLUSIONI DELLA STORIA
Baudrillard sviluppò ciò che definì la “narrativa teorica”, o “teoria di simulazione”, o “teoria anticipatoria”. Tale ‘teoria’ intendeva simulare, cogliere e anticipare gli eventi storici, che egli riteneva precedessero sempre di molto ogni teoria contemporanea. Secondo lui, la situazione presente era più fantastica della fantascienza, o delle proiezioni teoriche di una società futurista. Nel saggio Rovine anoressiche pubblicato nel 1989, considerò il muro di Berlino come un segno di una storia congelata, anoressica, in cui nulla poteva più accadere, segnata da una “mancanza di eventi” e dalla fine della storia stessa; in questo contesto, il muro di Berlino era un segno di una stasi tra comunismo e capitalismo. Poco dopo, eventi piuttosto significativi distrussero quel muro che Baudrillard vedeva come permanente e inaugurarono una nuova epoca storica.
Lo stallo della Guerra Fredda rafforzò per molto tempo in Baudrillard l’idea che si stesse stabilendo una “storia congelata” in cui nessun cambio significativo potesse avere luogo. Già nelle sue riflessioni della metà degli anni Settanta, egli affermò che la guerra del Vietnam fosse un pretesto per incorporare la Cina, la Russia e alla fine anche il Vietnam in un mondo economico e in un ordine politico più razionalizzati e modernizzati, e nel suo libro sulla guerra del Golfo ribadì questa convinzione. Per Baudrillard, anche le torri gemelle del World Trade Center di New York simbolizzavano la storia congelata e la stasi tra i due sistemi del capitalismo e del comunismo. In generale, egli vedeva la storia come lo sviluppo della razionalità tecnologica, la quale si trasformava nel suo opposto, mentre il sistema incorporava sempre più elementi, producendo un ordine tecnologico migliore, che in seguito diventava irrazionale a causa dei suoi eccessi, delle sue illusioni e delle sue conseguenze imprevedibili. Questa analisi altamente astratta, tuttavia, occludeva fattori storici più specifici che sarebbero stati utili per analizzare come fosse costruita e come funzionasse la razionalità tecnologica, e come e perché essa non riuscisse nel suo intento. L’analisi trattava anche del tumulto creato da fenomeni come le crisi e le ristrutturazioni del capitalismo globale, l’ascesa del fondamentalismo, il conflitto etnico e il terrorismo globale che, in parte, si erano sprigionati in quanto reazione a una razionalizzazione globalizzata del sistema di mercato e allo smantellamento dell’ordine bipolare del mondo.
Le riflessioni di Baudrillard sulla guerra del Golfo presentavano un approccio simile, poiché vedevano in essa un tentativo del nuovo ordine mondiale di razionalizzare ancora di più il mondo; infatti egli riteneva che la guerra del Golfo in realtà servisse per introdurre l’Islam nel nuovo ordine mondiale. Il primo saggio sull’argomento, intitolato La Guerra del Golfo non c’è mai stata, fu inizialmente pubblicato pochi giorni prima dell’effettivo scoppio delle ostilità militari e ribadiva il concetto già considerato precedentemente di “eventi deboli” e “storia congelata”. A discapito di ciò che pensava Baudrillard, la guerra del Golfo ci fu davvero, ma questo non gli impedì di pubblicare altri studi, mentre il conflitto era in atto, nei quali dichiarava che la guerra “non stava accadendo davvero” e studi, dopo la fine dell’evento, nei quali asseriva che “non era accaduta” – sostenendo che era stata un’illusione mediatica e non una guerra vera. Ridurre eventi complessi come le guerre in categorie come la simulazione o l’iperrealtà chiarisce gli eventi mediatici alla luce della dimensione virtuale e tecnologicamente avanzata, ma ne cancella tutti gli aspetti concreti. Tuttavia, le categorie postmoderne di Baudrillard aiutano a comprendere alcune delle dinamiche della cultura del vivere nei mondi mediatici e computerizzati, dove sembra che alle persone piaccia immergersi in eventi simulati (ne è prova l’interesse per la guerra del Golfo nel 1991, i processi di O.J. Simpson tra il 1994 e il 1996, gli scandali a sfondo sessuale del presidente Clinton, vari altri spettacoli mediatici durante gli anni Novanta e gli attacchi terroristici dell’11 settembre nei primi giorni del terzo millennio).
Ne La fine dell’illusione, Baudrillard attaccò frontalmente quelle che egli considerava essere le illusioni comuni della storia, della politica e della metafisica, e cercò scherzosamente di spiegare le proprie previsioni politiche, che poi si erano rivelate sbagliate, secondo le quali la storia appariva in uno stato congelato, glaciale, in stallo tra l’Oriente e l’Occidente, e secondo le quali la guerra del Golfo non poteva accadere e la fine della storia era già avvenuta. Baudrillard diede libero sfogo ai suoi artifici retorici e alle analisi filosofiche per tentare di continuare a sostenere queste ipotesi a dispetto dei drammatici eventi degli anni 1989-1991, che egli riteneva essere degli “eventi deboli”, poiché gli eventi veri erano ancora “in sciopero” e la storia era scomparsa davvero. Egli continuava a essere dell’opinione che la modernità in quanto epoca storica era finita, con i suoi conflitti e scombussolamenti politici, le sue innovazioni e le sue rivoluzioni, il suo soggetto autonomo e creativo e i suoi miti del progresso, della democrazia, dell’illuminismo e simili. Egli dichiarava che questi miti, queste idee forti, erano terminati e perciò l’era del banale eclettismo, dell’implosione inerziale e dell’eterno ritorno delle stesse cose diventavano le caratteristiche delineanti.
Con il crollo del comunismo, l’era delle “idee forti”, di un mondo conflittuale di rivoluzione ed emancipazione universale, era finita. Secondo Baudrillard, il comunismo crollò a causa della sua stessa inerzia, si autodistrusse dall’interno, implose, più che morire nella battaglia ideologica o nella guerra militare. Con l’assorbimento dei suoi dissidenti nel potere, non c’era più un contrasto di idee forti, di opposizione e resistenza, di trascendenza critica. Con l’integrazione degli ex regimi comunisti nel sistema del mercato mondiale capitalista e della democrazia liberale, l’Occidente non aveva più un Altro contro cui combattere, non c’era più nessuna tensione creativa o ideologica, né una alternativa globale al mondo occidentale.
Baudrillard celebrò la venuta del nuovo millennio riproponendo alcune delle sue vecchie idee sulla clonazione, la fine della storia e la sparizione del reale in una serie di lezioni riunite ne L’illusione vitale (2000). Per lui, la clonazione era connessa al desiderio di immortalità, volto a sconfiggere il ciclo della vita. Perciò, non c’è da stupirsi se la criogenetica – il congelamento dei cadaveri umani nella speranza che possano rigenerarsi in futuro grazie ai progressi della medicina – è un’industria globale in completa espansione. Similmente, in un’era digitale, Baudrillard dichiarava che la storia era giunta alla fine e la realtà era stata uccisa dalla virtualizzazione, mentre la specie umana si preparava a un’esistenza virtuale. Egli si lamentava del fatto che l’era contemporanea era caratterizzata da eventi deboli, che nessun fatto storico cruciale aveva avuto luogo e che, quindi, la vita e il pensiero stavano diventando sempre più noiosi.
Subito dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, Baudrillard scrisse un articolo, Lo spirito del terrorismo pubblicato il 2 novembre 2001 su Le Monde. In questo articolo, egli sosteneva che gli assalti al World Trade Center e al Pentagono costituivano un “evento forte”, che gli attacchi erano “l’evento principale, quello da cui sono derivati tutti gli altri, l’evento perfetto che unisce in sé tutti gli eventi che non sono mai accaduti”. Baudrillard affermò che “lo sciopero degli eventi” era finito e da allora in poi ha continuato a concentrarsi intensamente sulle dinamiche e gli accadimenti della società contemporanea.
Il pensiero di Baudrillard fu riacceso dall’11 settembre e dalla successiva Guerra del Terrore: egli dimostrò la continua importanza di alcune delle sue categorie chiave e produsse alcune delle sue opere più provocative. Aveva scritto a lungo sul terrorismo e stava concentrando le sue riflessioni sulla globalizzazione quando accaddero gli attacchi dell’11 settembre. Replicò prontamente con l’articolo di Le Monde, subito dopo tradotto e ampliato in uno dei libri più provocatori e controversi sul terrorismo, Lo spirito del terrorismo: requiem per le Torri Gemelle (2002). Per Baudrillard, gli attacchi dell’11 settembre rappresentavano un nuovo tipo di terrorismo, che mostrava una
“forma di azione che sta alle regole del gioco, che le stabilisce, esclusivamente con l’obiettivo di infrangerle […] si sono impossessati di tutte le armi del potere dominante”.
Ciò significa che i terroristi, nell’opinione di Baudrillard, avevano usato gli aereoplani, i computer e i media, associati alle società occidentali, per produrre uno spettacolo di terrore. Gli attacchi avevano evocato uno spettro di terrore che faceva credere che il sistema stesso della globalizzazione e il capitalismo e la cultura occidentali fossero minacciati dallo “spirito del terrorismo” e da possibili attacchi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Per Baudrillard,
“i discorsi e i commenti fatti dopo l’11 settembre sono indice di un’enorme abreazione post-traumatica sia nei confronti dell’evento stesso, sia nei confronti dell’interesse che esso esercita. La condanna morale e l’unione sacra contro il terrorismo sono direttamente proporzionali alla prodigiosa esultanza provata nell’aver visto questa superpotenza globale distrutta”.
Baudrillard comprese che i terroristi speravano che il sistema reagisse in maniera spropositata in risposta alle molteplici sfide del terrrorismo: “è il modello terrorista che provoca un eccesso di realtà e fa crollare il sistema al di sotto di quell’eccesso”.
Secondo Baudrillard, gli attacchi dell’11 settembre rappresentavano “lo scontro della globalizzazione trionfante in guerra contro se stessa” e inauguravano una “quarta guerra mondiale”:
“La prima aveva posto fine alla supremazia europea e all’era del colonialismo; la seconda al nazismo; e la terza al comunismo. Ciascuna ci ha portato sempre più vicini all’ordine mondiale unitario di oggi, che si sta ora avvicinando alla sua fine, in ogni parte, ad ogni lato in lotta contro forze ostili. Questa è una guerra di complessità frattale, condotta su scala mondiale contro realtà singole ribelli che, come gli anticorpi, oppongono resistenza in ogni cellula”.
Sokal e Bricmont hanno criticato Baudrillard per tale uso metaforico della terminologia scientifica. Riguardo l’iniziale pubblicazione della sua risposta sui giornali francesi e la sua immediata traduzione in inglese e in altre lingue, Baudrillard fu accusato di giustificare il terrorismo quando affermò nell’articolo apparso su Le Monde:
“Poiché era questa superpotenza intollerabile [gli Stati Uniti] che aveva originato sia la violenza che si sta diffondendo in tutto il mondo e l’immaginazione terrorista che (senza che ne siamo consci) è presente in ognuno di noi. Che il mondo intero senza eccezione alcuna ha sognato questo evento, che nessuno ha potuto fare a meno di sognare la distruzione di un’egemonia così potente – questo fatto è inaccettabile per la coscienza morale dell’Occidente. Cionondimeno, è un fatto, un fatto che si oppone alla violenza emotiva di tutta la retorica che cospira per nasconderlo. In fin dei conti, sono loro che l’hanno fatto, ma noi che lo speravamo”.
Baudrillard si difese dalle accuse secondo le quali tali riflessioni costituivano un anti-americanismo virulento o una legittimizzazione del terrorismo dichiarando:
“non elogio gli attacchi assassini – sarebbe da idioti. Il terrorismo non è una forma contemporanea di rivoluzione contro l’oppressione e il capitalismo. Nessuna ideologia, nessuna lotta per un obiettivo, neppure il fondamentalismo islamico, possono spiegarlo. […] Non ho glorificato niente, non ho accusato nessuno, non ho giustificato nulla. Non si dovrebbe confondere il messaggero con il suo messaggio. Io ho cercato di analizzare il processo attraverso il quale l’illimitata espansione della globalizzazione crea le condizioni per la propria distruzione”.
Infatti, Baudrillard fu anche l’autore di alcune riflessioni provocatrici sulla globalizzazione.
Ne La violenza del Globale, distinse tra il globale e l’universale, associando la globalizzazione alla tecnologia, al mercato, al turismo e all’informazione, in opposizione all’identificazione dell’universale con “i diritti umani, la libertà, la cultura e la democrazia.” Mentre “la globalizzazione sembra essere irreversibile, […] è probabile che l’universalizzazione sia sulla via del tramonto”. Altrove, egli scrisse:
“l’idea di libertà, un’idea recente, sta già svanendo dalle menti e dalle usanze, e la globalizzazione liberale sta prendendo una forma totalmente opposta – indicativa di una globalizzazione da stato-poliziotto, di un controllo totale, di un terrore basato su misure volte al mantenimento dell’ordine pubblico. La deregolamentazione si risolve in un valore massimo di obblighi e restrizioni, simile a quelli della società fondamentalista”.
Molti vedono la globalizzazione come la matrice dell’economia di mercato, della democrazia, della tecnologia, della migrazione e del turismo, e della circolazione su scala mondiale delle idee e della cultura. Baudrillard, curiosamente, prese le parti dei movimenti anti-globalizzazione che condannavano la globalizzazione come l’opposto della democrazia e dei diritti umani. Per lui, la globalizzazione era fondamentalmente un processo di omogeneizzazione e standardizzazione che era in contrasto con ‘il singolo’ e l’eterogeneità. Questa posizione, tuttavia, non riusciva a mettere in risalto le contraddizioni per le quali la globalizzazione produceva allo stesso tempo omogeneizzazione, ibridizzazione e differenza, e per le quali il movimento anti-globalizzazione corporativa stava combattendo per la giustizia sociale, la democratizzazione e maggiori diritti, fattori che Baudrillard collegava a una universalizzazione morente. In effetti, la lotta per i diritti e la giustizia costituiva una parte importante della globalizzazione, e la prefigurazione di Baudrillard dei diritti umani, della democratizzazione e della giustizia in quanto facenti parte di un’universalizzazione, obsoleta distrutta dalla globalizzazione, era teoricamente e politicamente problematica.
Prima dell’11 settembre, Baudrillard vedeva la globalizzazione e lo sviluppo tecnologico produrre la standardizzazione e la virtualizzazione che stavano eliminando l’individualità, la lotta sociale, la critica e la realtà stessa, mentre sempre più persone venivano assorbite nelle realtà iperreali e virtuali dei media e del ciberspazio. Questa sparizione della realtà costituiva il “crimine perfetto” che è il soggetto del libro dallo stesso titolo e che venne approfondito ne L’illusione vitale (2000). In quest’ultimo lavoro, Baudrillard si presentava in veste di “investigatore privato” in cerca dell’autore del “crimine perfetto”, l’assassino della realtà, “l’evento più importante della storia moderna”. La sua tematica ricorrente era la distruzione e la sparizione del reale nel regno dell’informazione e delle immagini, e il susseguente regno dell’illusione e dell’apparenza. In maniera nitzscheana, egli suggeriva che da allora in poi la verità e la realtà erano soltanto più delle illusioni, che le illusioni regnavano sovrane, e che quindi le persone avrebbero dovuto rispettare l’illusione e l’apparenza e rinunciare all’ingannevole ricerca della verità e della realtà.
Eppure, negli attacchi dell’11 settembre e nella successiva Guerra del Terrore, la differenza e il conflitto erano apparsi sul palcoscenico globale ed erano emerse forze eterogenee che il capitalismo sembrava incapace di assorbire e assimilare, forze che avevano prodotto quella che appariva come un’era di conflitto intenso. Gli apologeti ideologici della globalizzazione, come Thomas Friedman, furono obbligati a riconoscere che la globalizzazione aveva i suoi lati oscuri e che produceva conflitti, oltre a reti di collaborazione, interrelazioni e progresso. Naturalmente, restava da vedere come la Guerra del Terrore e gli intensificati conflitti globali sarebbero stati risolti.
CONCLUSIONE
Baudrillard non è mai stato tanto influente in Francia quanto lo era nel mondo anglofono e altrove. È un esempio del ‘popolare-globale’, un pensatore che ha i suoi seguaci e i suoi lettori in tutto il mondo. La sua influenza è stata più che altro ai margini di svariate discipline che spaziano dalla teoria sociale, alla filosofia, alla storia dell’arte, perciò è difficile valutare il suo impatto sulla visione tradizionale delle discipline accademiche. Egli è forse più importante in quanto parte della svolta postmoderna contro la società moderna e i suoi pensieri tradizionali. Egli sfida la saggezza convenzionale e mette in discussione dogmi e metodi tradizionali. Mentre le sue prime opere sulla società consumistica, l’economia politica del segno, la simulazione e i simulacri, e l’implosione dei fenomeni precedentemente separati gli uni dagli altri possono essere inserite all’interno della filosofia critica e della teoria sociale, molti dei suoi lavori scritti dopo gli anni Ottanta vanno, piuttosto consapevolmente, oltre la tradizione classica e nella maggior parte delle interviste del decennio passato Baudrillard ha preso le distanze dalla “filosofia critica” e dalla teoria sociale, dichiarando che l’energia della critica si è ormai spenta.
In questa maniera, egli emerge come un teorico interdisciplinare della fine della modernità. Si possono leggere le sue opere successive agli anni Settanta come se si trattasse di fantascienza che anticipa il futuro esagerando le tendenze attuali e fornendo così degli avvertimenti tempestivi riguardo ciò che potrà accadere se le propensioni correnti continuano. Non è una coincidenza che Baudrillard sia un aficionado della fantascienza e che egli stesso abbia influenzato un largo numero di scrittori e registi di fantascienza dell’epoca contemporanea, incluso quello di The Matrix (1999), in cui la sua opera è citata.
Comunque, in vista della sua esagerazione della presunta rottura con la modernità, non è chiaro se sia meglio considerare gli ultimi vent’anni del suo lavoro come fantascienza o come teoria.
Ovviamente, Baudrillard vuole tenere il piede in due staffe con i teorici sociali che ritengono che fornisca rilevanti prospettive sulle realtà sociali contemporanee e che riveli cosa sta realmente accadendo. E gli anti-sociologi ancora più cinici sono incoraggiati a unirsi alle sue narrative, al suo discorso sperimentale, ai suoi giochi. Nello stesso modo, a volte egli incoraggia i metafisici culturali a leggere i suoi libri come serie riflessioni sulle realtà del nostro tempo, ammiccando contemporaneamente, con il suo lato patafisico, a coloro che sono più scettici nei confronti di tali opere. Inoltre, i suoi scritti filosofici incitano i filosofi a difendere le loro posizioni contro le sue e a ripensare a certe questioni tradizionali alla luce delle realtà contemporanee.
Dunque, è difficile decidere se sia meglio leggere Baudrillard come fantascienza o come patafisica, o come filosofia, teoria sociale, metafisica culturale, e se le sue opere successive agli anni Settanta debbano essere considerate sotto il segno della realtà o della finzione. Le sue prime esplorazioni critiche del sistema degli oggetti e della società consumistica contengono alcuni dei suoi contributi più importanti alla teoria sociale contemporanea. Importante e originale è anche la sua analisi risalente a metà degli anni Settanta della mutazione drammatica all’interno delle società contemporanee e della comparsa di un nuovo modo di simulazione, che delineava gli effetti dei media e dell’informazione sull’intera società. Ma a questo punto del suo lavoro, Baudrillard cade preda di un determinismo tecnologico e di un idealismo semiologico che ipotizzano una tecnologia autonoma e un gioco di segni che generano una società di simulazione che crea una rottura postmoderna e la proliferazione di segni e simulacri. Egli cancella le sfere autonome e differenziate dell’economia, della politica, della società e della cultura postulate dalla teoria sociale classica, in favore di una teoria implosiva che valica anch’essa i confini disciplinari, unendo così la filosofia e la teoria sociale in una forma più ampia di diagnosi sociale e gioco filosofico.
In ultima analisi, Baudrillard è forse più utile come provocatore che sfida e mette in discussione la tradizione della filosofia classica e della teoria sociale che come qualcuno che fornisce dei concetti e dei metodi che possono essere applicati nell’analisi filosofica, sociale o culturale. Egli dichiara che l’oggetto della teoria sociale classica – la modernità – è stato superato da una nuova postmodernità e che perciò sono necessari strategie teoretiche, modi di scrittura e forme di teoria alternativi. Mentre il suo lavoro sulla simulazione e la rottura postmoderna, muovendo dalla metà degli anni Settanta fino ad arrivare agli anni Ottanta, fornisce una teoria postmoderna paradigmatica e un’analisi della postmodernità che è stata altamente influente, e che a discapito delle sue esagerazioni continua a essere impiegata per interpretare le tendenze sociali attuali, il suo lavoro successivo è probabilmente più di interesse letterario. In definitiva, Baudrillard va oltre la teoria sociale, in una nuova sfera del modo di scrittura che fornisce delle introspezioni occasionali all’interno dei fenomeni sociali contemporanei e critiche provocatorie della filosofia contemporanea e di quella classica e della teoria sociale.
LO SPIRITO DEL TERRORISMO
A cura di Alberto Rossignoli
Jean Baudrillard, Lo spirito del terrorismo, Cortina Editore, Milano, 45 pagine.
Con l’attentato dell’11 settembre 2001, ci si trova di fronte ad un evento storico, che imprime una svolta considerevole ai fatti mondiali… Ma, come saggiamente consiglia l’autore, è opportuno fare una pausa di riflessione…. In particolar modo, si rende necessario capire il gioco di responsabilità che sta dietro a tutto questo. Baudrillard asserisce con piena convinzione che è la “potenza insopportabile” degli Stati Uniti che ha provocato l’attentato…già, perché le Torri Gemelle appaiono come il simbolo di una potenza definitiva, di un Impero, che ingloba (o comunque intende inglobare) tutto dentro di sé, in un processo di fagocitosi geo-politica. E, dunque, il processo è fisiologico:di fronte ad una massiccia concentrazione e monopolizzazione del potere è naturale che si operi quello che l’autore chiama “transfert terroristico di situazione”, strumento di vendetta di chi è stato soffocato dal Sistema. Attualmente è in corso la “quarta guerra mondiale”, una guerra che rompe gli schemi delle guerre passate, poiché ora (fermo restando unicamente che la posta in gioco è sempre la libertà e l’assenza di condizionamenti) lo scenario che si presenta ai nostri occhi è “il mondo stesso che resiste alla mondializzazione”…vale a dire una resistenza continua all’accentramento del potere, resistenza compiuta non solo colpendo concretamente, facendo vittime concrete e reali, colpendo bersagli reali e palpabili, bensì, in certo qual modo, idealizzando allo stesso tempo queste azioni, essendo consci della convinzione di stare al contempo colpendo un simbolo, anche (e soprattutto) mediante l’auto-immolarsi… Questo è, secondo Baudrillard, l’autentico spirito del terrorismo…azioni concrete, dunque, ma allo stesso tempo cariche e pregne di autentico simbolismo. Tuttavia, ci si trova davanti ad un terrorismo nuovo, in quanto vengono utilizzate anche le armi della potenza dominante e, soprattutto, i terroristi si sono serviti della più banale quotidianità per nascondersi agli occhi del mondo, per poi, un bel giorno, agire come delle perfette macchine per uccidere, come delle bombe a tempo, con l’unica differenza, rispetto alle potenze occidentali, che gli attentatori sono disposti (anzi ansiosi) di sacrificarsi, di annullarsi, disprezzando la loro stessa vita in nome di un ideale, immolandosi per esso. Hanno poi sfruttato il potere dei media e il potere dell’immagine in particolare, facendo in modo che l’attentato fosse sotto gli occhi del mondo intero, affinché tutti potessero sapere e soprattutto affinché tutti fossero colpiti da questa irruzione del reale all’interno del mondi virtuale dei media, con tutte le ripercussioni che ci sono successivamente state anche in ambito economico e finanziario. Illuminante è la considerazione del filosofo sul sistema liberale occidentale:”…l’idea di libertà, idea nuova e recente, sta già scomparendo dai costumi e dalle coscienze, e la mondializzazione liberale sta per realizzarsi in forma esattamente inversa:quella di una mondializzazione poliziesca, di un controllo totale, di un terrore sicuritario. La deregulation finisce in un massimo di vincoli e restrizioni, equivalente a quello di una società fondamentalista”. E certamente, non avendo alcuna intenzione di cambiare i programmi politici, il Sistema altro non può fare se non rispondere con la guerra.
GIULIO PRETI

Copyright di Luca M. Scarantino e SWIF (24.06.2005). Pubblicato in queste pagine su autorizzazione dell’autore e dello
SWIF, Edizioni Digitali di Filosofia.
Dopo un iniziale interesse per gli studi di glottologia e di filologia indiana, Giulio Preti si laurea nel 1933 a Pavia, sua città natale, con una tesi sul pensiero di Husserl. Fra i suoi maestri Adolfo Levi, Guido Villa e, per l’indianistica, Luigi Suali. Durante gli anni di università l’amicizia con Enzo Paci, anch’egli studente a Pavia, lo conduce a frequentare quella generazione di giovani filosofi, letterati, poeti e artisti che si riuniva a Milano intorno ad Antonio Banfi. La vicinanza con il fervore intellettuale milanese, la cui vivacità attrae anche altri circoli letterari e artistici italiani (a cominciare dagli ermetisti fiorentini e dai pittori della scuola romana), si svolge sotto il segno di un antifascismo dapprima culturale poi apertamente militante, e condiziona l’origine del percorso filosofico di Preti. Preti partecipa in misura marginale all’avventura di Corrente, ma entra sin dall’inizio nella redazione di Studi filosofici, la rivista che esprime le posizioni filosofiche di Banfi e del suo gruppo (oltre a Preti, Paci, Cantoni, Bertin e la Denti) e che, dal 1940 al 1944 e in seguito dal 1946 al 1949, promuove un profondo rinnovamento della filosofia italiana. Da Banfi, Preti eredita il senso acuto della crisi spirituale e morale della cultura contemporanea, e con esso un sentimento di precarietà storica da cui trae origine la ricerca di una “razionalità nuova” in grado di esprimere teoreticamente le profonde trasformazioni in atto nella vita contemporanea. Nel perseguire tale programma, che si fa in Preti identità tra razionalità scientifica e cultura democratica (Praxis ed empirismo, 1957), Preti si rivolge alle correnti teoriche più significative del pensiero contemporaneo, procedendo ad un’originalissima sintesi tra tradizione “trascendentale” e formale di marca banfiana (neokantismo e fenomenologia) e “filosofie della prassi” (empirismo logico e pragmatismo, cui, almeno sino alle violente polemiche scatenate dall’apparizione di Praxis ed empirismo, Preti tenta di accostare anche la riflessione di Feuerbach e del giovane Marx). Già negli anni di apprendistato banfiano, d’altra parte, si svolge un attento confronto con le correnti filosofiche italiane, a cominciare dall’attualismo gentiliano, che trova una prima, interessantissima occasione per manifestarsi in occasione del dibattito sull’immanenza condotto con Carmelo Ottaviano intorno alla metà degli anni ’30. Emergono qui con chiarezza sia la formazione neo-kantiana (di tradizione marburghese) e husserliana di Preti, sia la sua attenzione verso il pragmatismo. Ma nel corso degli anni ’40 Preti si accosta con sempre maggior decisione alle tematiche dell’empirismo logico, in cui ravvisa quella tecnicità filosofica, condensata essenzialmente nelle tesi convenzionaliste e nell’analisi della verificazione, mediante cui integrare i preesistenti tratti banfiani di quella “risoluzione razionale del reale” che costituisce il cuore del suo pensiero critico. A questa complementarità fra tradizione razionalista, fenomenologica e kantiana, ed istanze empiristiche è dedicato il volume del 1943 Idealismo e positivismo. Finita la guerra, durante la quale prende parte ai movimenti resistenziali nel pavese, la maturità speculativa di Preti, dal 1954 docente all’Università di Firenze, si afferma con crescente risolutezza. Risalgono a questi anni, oltre ad una mai interrotta collaborazione a periodici di cultura e di attualità (dal Politecnico di Vittorini alla Fiera letteraria a Paese sera), i suoi contributi forse più significativi : le grandi indagini sulla logica stoica e terministica medievale, il Newton ed il Leibniz, gli scritti teoricamente più impegnativi come Linguaggio comune e linguaggi scientifici, sino ai due grandi volumi del 1957, Praxis ed empirismo e Adam Smith. Ad essi Preti aggiunge una cospicua serie di collaborazioni a voci di enciclopedie e dizionari (tra cui il Dizionario di filosofia di Abbagnano, di cui curerà le voci logiche) e ad opere di divulgazione (ricordiamo fra queste soltanto la collaborazione al Calendario del popolo all’inizio degli anni Cinquanta). Nel riassumere brevemente i caratteri generali del pensiero pretiano, due ci sembrano dunque essere gli elementi salienti. Anzitutto, la fondamentale tensione etica che lo percorre, e che spinge Preti a considerare compito e responsabilità del filosofo quella di agire “per modificare l’ethos” di una data civiltà. Da tale sostrato, che costituisce una delle eredità più durature dell’insegnamento di Banfi, discende poi la concezione del ruolo della filosofia, che si fa in Preti disciplina socialmente impegnata e funzionante, cassirerianamente, da teoria generale delle forme culturali. L’intera sua impresa teorica si orienterà in tal modo a ricostruire le strutture culturali proprie di una coesistenza umana libera e democratica – un programma in cui l’ideale di una “cultura democratica” si salda alla nozione di “scientificità” del sapere, sola in grado di assicurare una comunicazione fondata su di una “persuasione razionale”. L’attenzione ai motivi etici, che permea l’intera sua opera, trova d’altra parte importanti disamine tematiche nei due volumi che Preti dedica alla filosofia della morale e alle espressioni contemporanee della problematica dei valori: Fenomenologia del valore del 1942 e Adamo Smith del 1957. A quest’ideale etico, sempre presente nell’opera sua, risponde l’ideale di scientificità del sapere, inteso come forma di organizzazione razionale delle conoscenze, mediante la quale vengono rese significanti e comunicabili le esperienze che formano il mondo della nostra vita, il mondo della “carne” o, banfianamente, l’inesauribile molteplicità del Lebenswelt. Proprio in quest’articolazione tra piano pragmatico e piano teoretico si svolge l’intera risoluzione razionale della realtà, che, partendo da una critica radicale ad ogni metafisica di stampo sostanzialistico, si sviluppa attraverso una costituzione degli oggetti della conoscenza incentrata sulla distinzione funzionale tra piano pragmatico della “carne” e piano razionale della conoscenza comunicabile (un impianto in cui sono tra l’altro riscontrabili assonanze comportamentiste). Su di essa si incentra, d’altronde, l’originale interpretazione del principio di verificazione, che diviene in Preti “teorema fondamentale di una teoria della conoscenza” e che, concepito alla luce degli esiti olistici ed hempeliani dell’empirismo logico, viene interpretato operativamente come capacità di un sistema di dar luogo a conseguenze operativamente valide – un punto in cui l’empirismo si incontra con il pragmatismo e con la fenomenologia, e in cui la lettura operazionista del principio di verificazione viene estesa sino alla singole, ultime esperienze vitali – le Erlebnisse vitali –, saldandosi alla nozione husserliana di Erfüllung o “riempimento di senso”. Quest’attenzione al mondo della vita, che conduce Preti a fare del “senso comune” un ben preciso concetto epistemologico (differenziandosi, in tal modo, dalla tradizione mooreana e analitica di “ricostruzione” del senso comune), lo conduce d’altro canto ad affrontare il problema della storicità del sapere e dell’esperienza – un tema ove l’influsso pragmatista informa in modo particolare la concezione degli a priori e della loro evolutività storica. Ed è in questa dinamica tra carattere formale del sapere razionale e dimensione storica di esso che risiede uno dei grandi contributi di Preti alla riflessione contemporanea. Tuttavia sembrerebbe, soprattutto nell’ultima fase del suo pensiero, che Preti tenti una ricerca ulteriore circa l’effettivo ruolo del pensiero scientifico nella civiltà contemporanea. Tale indagine, se pare aver spinto Preti ad esplorare molte direzioni (come risulta ad esempio dai manoscritti e dalle ultime lezioni, pubblicate postume) non sembra però averlo condotto a descrivere in modo soddisfacente quella “anti-scienza” adombrata nella nozione di “discorso propagandistico” che chiude Praxis ed empirismo e che si ritrova in Retorica e logica, l’ultimo grande volume pubblicato nel 1968. Si è così talvolta parlato (Migliorini) di “anni del silenzio” a proposito dell’opera pretiana negli anni ’60, in cui, oltre al crescente isolamento culturale ed accademico, Preti sembra aver voluto intraprendere un confronto tra conoscenza scientifica e persuasione razionale, da una parte, e rapporto con le molteplici forme della cultura contemporanea, i cui caratteri, talvolta descritti banfianamente come “risentimento”, talaltra denunciati nel loro antiscientificismo in scritti d’occasione, vengono da lui intravisti ma mai sistematicamente descritti. In questo tragico sentimento di inafferrabilità del contemporaneo, sembra suggerire Maria Corti, starebbe anche la radice dell’inconsapevole ma “puntiglioso suicidio” messo in atto da Preti, partito già malato nell’estate del 1972 per l’isola tunisina di Djerba, ove la morte lo colse repentinamente. Ed in quest’apertura inconclusa verso il confronto con la cultura più attuale consiste anche l’estremo motivo d’interesse dell’opera di Preti.
DE LUBAC
Henri De Lubac (20 febbraio 1896 – 4 settembre 1991) è uno dei più insigni teologi cattolici del Novecento, oltre che uno dei principali ispiratori del Concilio Vaticano II; egli godette delle simpatie di Giovanni Paolo II, che lo volle cardinale, ma fu poi oggetto di ostilità da parte di Pio XII e dei teologi di ispirazione neotomista. Con Jean Daniélou (1905-1974), De Lubac diresse l’importante collana intitolata “Sources chrétiennes”. Compì studio vari e approfonditi, che spaziavano dalla tradizione cristiana patristica e medievale alle filosofie non cristiane e contemporanee. Al cuore della sua riflessione sta l’attenzione per la tradizione, specialmente quella patristica: da essa egli trae i motivi ispiratori del proprio pensiero, che sono la centralità del sovrannaturale, la Chiesa come mistero di unità, la Bibbia come vivente ricchezza di significati simbolici. A partire dalla sua prima opera, Cattolicismo (1937), De Lubac mette in luce la propria abilità nel far affiorare nuove dimensioni e nuovi scorci dei problemi filosofici e religiosi. Egli rifiuta, soprattutto nel saggio del 1946 sul tema della grazia (intitolato Soprannaturale), la “dottrina dei due piani” invalsa col Concilio di Trento, la quale sosteneva il carattere estrinseco dell’ambito della grazia rispetto a quello della natura. Secondo tale dottrina, la natura avrebbe un proprio ordinamento e un suo fine specifico e autonomo. Facendo valere una posizione fortemente unitaria, De Lubac recupera la prospettiva di Tommaso d’Aquino, secondo la quale è possibile parlare di naturale desiderio nell’uomo della visione beatifica. Superando con risolutezza ogni concezione dicotomica dell’essere umano e, insieme, ponendo l’accento sull’autonomia assoluta della realtà naturale, collocata non più su un piano inferiore rispetto a quello sovrannaturale, De Lubac fa valere una posizione unitaria e di forte sapore tomistico. Con la pubblicazione dell’opera Il dramma dell’umanesimo ateo, del 1944, De Lubac si confronta con la problematica dell’ateismo filosofico nelle sue molteplici declinazioni: di esso, il pensatore francese accoglie alcune tesi, ma rigetta totalmente la convinzione secondo la quale l’affermazione di Dio implicherebbe necessariamente la negazione dell’uomo. In rottura con questa tesi, De Lubac guarda a Kierkegaard e a Dostoevskij per capovolgere le posizioni dell’ateismo filosofico, sostenendo a più riprese che è la negazione di Dio a produrre la negazione dell’uomo. Come prove lampanti del suo asserto, De Lubac può portare tutte le tragedie che hanno costellato il Novecento e che sono state compiute ogni qual volta l’uomo ha preteso di negare Dio e fare da sé. In opposizione con l’ateismo, è possibile secondo De Lubac mettere in luce come umanesimo e cristianesimo, lungi dall’elidersi mutuamente, siano coessenziali.
ANTONIO NEGRI

A cura di Mai Saroh Tassinari e Diego Fusaro
“Siete soltanto un mucchio di anarchici, ci dirà qualche nuovo Platone. Ma non è vero. Saremmo degli anarchici (come Trasimaco e Callicle, gli immortali interlocutori di Platone) se non ragionassimo dal punto di vista della materialità costituita nelle reti della cooperazione produttiva – o, in altre parole, se non ragionassimo dalla prospettiva di un’umanità che si costituisce produttivamente attraverso il ‘nome comune’ della libertà. No, non siamo anarchici, siamo comunisti che hanno visto in quale misura la repressione e la distruzione dell’umanità siano state portate avanti dai big government socialisti e liberali. E abbiamo anche visto come tutto ciò venga ora riesumato nel governo imperiale, nel momento in cui i circuiti della cooperazione produttiva hanno reso la forza lavoro nel suo complesso capace di autocostituirsi in governo” (Impero, p. 325).
Antonio (Tony) Negri, nato a Padova nel 1933, è stato uno dei soci fondatori di “Potere Operaio” e, successivamente, del gruppo Autonomia. Ha lavorato al fianco di molti altri autonomisti famosi, studenti e femministe degli anni 60 e 70, inclusi Raniero Panzieri, Mario Tronti, Sergio Bologna, Romano Alquati, Mariarosa Dalla Costa e François Berardi. Inoltre, ha scritto per Futur Antérieur con persone del calibro di Paolo Virno.
Meglio conosciuto come il co-autore, con Michael Hardt, di Impero (Rizzoli, Milano 2002), Negri è libero (ma non gli è permesso di prendere parte alle elezioni, né di insegnare) dalla primavera del 2003, dopo aver trascorso un periodo in carcere per propositi criminosi, con l’accusa che egli e i suoi scritti fossero ‘moralmente colpevoli’ in atti di violenza che erano causati dal suo sostegno all’ ‘insurrezione armata’ contro lo stato italiano durante gli anni 60 e 70. Nel 1997, Negri è ritornato volontariamente da un esilio di quattordici anni in Francia, dopo essere stato eletto nel 1983 al corpo legislativo, mentre veniva imprigionato e poi rilasciato per immunità parlamentare.
Le sue opere prolifiche, iconoclastiche, cosmopolite, altamente originali e spesso di densa e difficile filosofia tentano di attuare una critica nei confronti della maggior parte dei principali movimenti intellettuali degli ultimi cinquant’anni, in difesa di una nuova analisi marxista del capitalismo. La polemica tesi di Impero, secondo la quale la globalizzazione e l’informatizzazione dei mercati mondiali a partire dalla fine degli anni 60 hanno prodotto uno sviluppo storico mai visto prima – ciò che egli chiama “la vera sottomissione dell’esistenza sociale per opera del capitale” – tocca in maniera piuttosto diretta un numero di temi collegati alla Società dell’Informazione, alla Network Economy e alla globalizzazione, che forse possono spiegare il grado relativamente alto di interesse che hanno attratto quando il libro è stato pubblicato nel 2000.
Impero, che come sottotitolo recita Il nuovo ordine della globalizzazione, è diventato sempre più influente col passare degli anni e ha ispirato molti progetti in tutto il mondo. Alcuni di questi includono i no-borders, Libre Society, KEIN.ORG, NEURO-Networking Europe, D-A-S-H e molti altri.
Il seguito di Impero, Moltitudine, è stato pubblicato nell’agosto 2004: in esso, Negri recupera molti punti trattati soprattutto quando s’era accostato al pensiero di Spinoza (L’anomalia selvaggia, 1991; Spinoza sovversivo, 1992; Democrazia ed eternità in Spinoza, 1995); nella sua lettura, il filosofo veneto stringe il pensiero spinoziano in un rapporto unitario di produzione-costituzione. Il problema che Spinoza pone è, per Negri, quello della rottura della unidimensionalità dello sviluppo capitalistico e dell’istituzione del suo potere. L’opera di Spinoza è la definizione di un progetto rivoluzionario che attraversa il moderno, nell’ontologia, nella scienza, nella politica. L’immaginazione produttiva è potenza etica: Spinoza la descrive come una facoltà che presiede alla costruzione e allo sviluppo della libertà, che sostiene la storia della liberazione. Essere vuol sempre dire essere partecipi della moltitudine. La nostra esistenza è sempre, in sé, comune. Spinoza insegna che vivere è la selvaggia scoperta di sempre nuovi territori dell’essere, territori costituiti dall’intelligenza, dalla volontà etica, dal piacere dell’innovazione, dallo slargarsi del desiderio, mostra la vita come sovversione – è questo il senso dello spinozismo quale Negri lo intende.
Forse la sintesi più significativa del progetto filosofico di Negri è quella del critico neoliberale John Reilly, che definisce Impero “una congiura postmoderna per abbattere la Città di Dio.”
In effetti, l’adesione di Negri, nei primi anni Cinquanta, al movimento dei cattolici lavoratori e alla teologia liberale sembra aver lasciato un marchio indelebile nel suo pensiero: una delle sue opere più recenti, Il tempo per la rivoluzione (2003), riguarda soprattutto temi tratti da Agostino di Ippona e Baruch Spinoza, e può essere descritto come un tentativo di trovare la Città di Dio senza l’aiuto delle ‘illusioni trascendentali’ e della ‘teologia di Potere’, che egli trova in pensatori come Martin Heidegger e John Maynard Keynes, ampliando e tentando di correggere la critica dell’ideologia in quanto falsa coscienza esposta da Karl Marx.
Tra le tematiche centrali di Negri ci sono il marxismo, l’anti-globalizzazione, l’anti-capitalismo, il postmodernismo, il neoliberalismo, la democrazia, la proprietà comune e le masse. Anche se riconosce l’influenza di Michel Foucault, de La condizione della Postmodernità (1989) di David Harvey, de Il postmodernismo o la cultura logica del tardo capitalismo (1991) di Fredric Jameson e de L’anti-edipo: schizofrenia e capitalismo di Gilles Deleuze e Felix Guattari, in generale Negri ha una considerazione molto scarsa nei confronti del postmodernismo, di cui il solo merito, secondo lui, è quello di essere stato un sintomo della transizione storica le cui dinamiche egli stesso e Hardt hanno cercato di spiegare in Impero. Il mondo sorto dopo il crollo del blocco sovietico è, secondo Negri e Hardt, il mondo del libero mercato che ha travolto le frontiere dei vecchi stati-nazione: la sovranità è passata a una nuova entità, l’Impero, che non accetta limiti né confini, non ha centro né periferie, vuole controllare tutti gli aspetti del corpo e della mente, superare la storia e porsi come la fonte della pace, della legittimità, della giustizia. L’Impero, come lo stato romano secondo Polibio, è una sintesi delle tre fondamentali forme di governo: la monarchia è impersonata in primo luogo dal monopolio della forza militare da parte degli Stati Uniti, e poi dal potere politico delle nazioni del G8, da agenzie militari come la Nato, dagli organismi di controllo dei flussi finanziari come la Banca mondiale o il Fondo monetario. L’aristocrazia è quella del denaro: le grandi multinazionali che organizzano la produzione e la distribuzione dei beni, e in generale i detentori del potere economico. La democrazia è costituita dagli organismi che tutelano gli interessi popolari: le organizzazioni non governative, non-profit, per la difesa dei diritti umani sono i moderni tribuni della plebe. E alla moltitudine – l’incarnazione postmoderna del popolo, cioé gli individui che vivono nel mercato globale, ne subiscono le ineguaglianze, sono espropriati del loro lavoro, anzi della loro vita – si aprono gli spazi per una rivoluzione dell’ordine mondiale. Dopo alcune premesse di tipo generale, il saggio si articola in quattro parti e un “Intermezzo” dal titolo suggestivo, “Il controImpero”. Se la prima sezione ha come tematica su cui poggiare l’analisi “La costituzione politica del presente”, la seconda esamina i “Passaggi di sovranità” e prende in considerazione Europa e Stati Uniti, mentre nella terza il tema è prevalentemente economico, titolo della sezione è appunto, “Passaggi di produzione”. La quarta e ultima parte è particolarmente coinvolgente e merita approfondite riflessioni, trattando appunto non solo del presente, quanto di quello che sta germinando del prossimo futuro sia come possibili contromisure che come progetto. Ed è proprio questa parte che vede numerose consonanze con l’elaborazione teorica di quello che è ormai universalmente definito “il popolo di Seattle”, nuovo soggetto politico di cui non è più possibile non tenere conto. È questa la visione di “Impero”, il libro di Michael Hardt e Antonio Negri che è stato salutato dai giornali americani, inglesi, francesi come il più importante tentativo di interpretazione della nostra epoca, addirittura accostato al Capitale di Marx, la ‘grande idea’ che dominerà la scena culturale del decennio. È una profonda riflessione teorica, fondata sugli strumenti d’indagine di molte discipline, dalla filosofia alla storia, dall’economia all’antropologia, dalla sociologia alla politica alla storia delle idee. È analisi del presente, storia del passato e utopia rivolta al futuro. Ma che cosa intende esattamente Negri quando parla di Impero, di questo “nuovo soggetto politico che regola gli scambi mondiali, il potere sovrano che governa il mondo”? Col crollo dell’Unione Sovietica, come abbiamo detto, è venuta meno la dicotomia che aveva caratterizzato la situazione politica mondiale del dopoguerra e che aveva trovato espressione nella “Guerra fredda”: all’idea dei due “blocchi” contrapposti in una guerra imminente ma mai combattuta, salvo nei “punti caldi” (Korea, Vietnam, ecc), si è allora sostituita l’idea di un unico grande Impero, rizomatico e dotato di innumerevoli gangli più che di una sola testa; un Impero che, profilandosi come una “nuova forma di sovranità globale”, assorbe ogni angolo del mondo entro i suoi confini in espansione: alla vecchia distinzione tra Paesi allineati con un blocco anziché con l’altro, si sostituisce quella tra ciò che è interno all’Impero e ciò che ancora non lo è e che, pertanto, è combattuto come un nemico pericoloso perché non ancora riassorbito. Di per sé, tuttavia, l’Impero non deve essere visto come il male assoluto: non diversamente da quel che scriveva Marx nel Manifesto a proposito della borghesia, Negri e Hardt scrivono che l’Impero è sicuramente “meglio di ciò che l’ha preceduto” (p. 56), nella misura in cui esso spazza via “i crudeli regimi del potere moderno” e incrementa “i potenziali di liberazione” (p. 56). Nella prefazione all’opera, Negri spiega l’inconfutabile realtà dell’Impero:
“L’impero si sta materializzando proprio sotto i nostri occhi. Nel corso degli ultimi decenni, con la fine dei regimi coloniali e, ancora più rapidamente, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica e delle barriere da essa opposte al mercato mondiale capitalistico, abbiamo assistito a un’irresistibile e irreversibile globalizzazione degli scambi economici e culturali. Assieme al mercato mondiale e ai circuiti globali della produzione sono emersi un nuovo ordine globale, una nuova logica e una nuova struttura di potere: in breve, una nuova forma di sovranità”.
Chiarita la realtà fattuale dell’Impero, Negri ne esamina da vicino il concetto:
“Il concetto di Impero è caratterizzato, soprattutto, dalla mancanza di confini: il potere dell’Impero non ha limiti. In primo luogo, allora, il concetto di Impero indica un regime che di fatto si estende all’intero pianeta, o che dirige l’intero mondo «civilizzato». Nessun confine territoriale limita il suo regno. In secondo luogo, il concetto di Impero non rimanda a un regime storicamente determinato che trae la propria origine da una conquista ma, piuttosto, a un ordine che, sospendendo la storia, cristalizza l’ordine attuale delle cose per l’eternità”.
E Negri precisa che l’impero non dev’essere confuso con l’imperialismo:
“L’Impero emerge al crepuscolo della sovranità europea. Al contrario dell’imperialismo, l’impero non stabilisce alcun centro di potere e non poggia su confini e barriere fisse. Si tratta di un apparato di potere decentrato e deterritorializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio mondiale all’interno delle sue frontiere aperte e in continua espansione. L’Impero amministra delle identità ibride, delle gerarchie flessibili e degli scambi plurali modulando reti di comando. I singoli colori nazionali della carta imperialista del mondo sono stati mescolati in un arcobaleno globale e imperiale”.
Contro questa forma di dominio sempre più assoluta e onnifagocitante si muove non più la sola classe operaia (come pensava un tempo Marx), bensì poteri alternativi, forze di resistenza, in particolare la “moltitudine”, eco postmoderna dell’antagonismo tipico della modernità: il popolo. In questo senso la filosofia torna con Negri ad essere intesa come prassi, come “proposizione soggettiva, desiderio e prassi che si applicano all’evento” (p. 60). Impero si chiude appunto con una suggestiva descrizione della prassi del rivoluzionario che lotta contro l’Impero e che Negri accosta a San Francesco, giacchè come il frate umbro deve identificarsi “nella condizione comune della moltitudine” e impegnarsi per “contrapporre la gioia di essere alla miseria del potere”.
UMBERTO ECO

A cura di Andrea Pesce
“L’Anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall’eccessivo amor di Dio o della verità, come l’eretico nasce dal santo e l’indemoniato dal veggente. Temi, Adso, i profeti e coloro disposti a morire per la verità, ché di solito fan morire moltissimi con loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro.” (Il nome della rosa)
Una delle doti principali che contraddistingue la personalità e il lavoro intellettuale di Umberto Eco è l’ironia. Se si sfogliano le prime pagine del suo Trattato di semiotica generale, opera rigorosa nell’analisi dei processi comunicativi e considerata tra le più importanti pubblicazioni del filosofo, si può leggere una frase a dir poco singolare: “la semiotica è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire” . Non è pura casualità se l’illustre semiologo è stato più volte sollecitato per un maggiore impegno in ambito politico-sociale nel nostro paese: non è forse l’ironia una virtù che fin dall’antica Grecia è stata glorificata per la sua capacità di far emergere la verità sugli eterni abusi perpetrati dai potenti? Nato ad Alessandria il 5 Gennaio del 1932, Eco si laurea nel 1954 presso l’Università di Torino (suo compagno di studi è il filosofo Gianni Vattimo) con una tesi sul Problema estetico in Tommaso d’Aquino, poi accresciuta e pubblicata nel 1970 dalla casa editrice Bompiani. Essendo allievo dell’illustre filosofo piemontese Luigi Pareyson, è forte l’influenza sul pensiero di Eco della teoria sull’interpretazione artistica contenuta nell’opera Estetica del 1954. In questo testo Pareyson propone di considerare l’interpretazione come “conoscenza di forme da parte di persone”, modalità infinitamente molteplice, non mai univoca, specchio della multiformità del soggetto interpretante e dell’oggetto contemplato. Questo passo risulta essere decisivo se applicato anche alla verità e ad ogni forma di rapporto che l’essere umano intrattiene con essa. Pareyson si accorse ben presto di avere in Eco e Vattimo due allievi dotati di un acume straordinario: a loro affidò l’indagine del pensiero medievale in Tommaso d’Aquino (Eco) e del concetto di fare in Aristotele (Vattimo). Dopo aver lavorato dal 1954 al 1959 come editore dei programmi culturali della Rai, negli anni Sessanta ha insegnato prima, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano, poi, presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze ed infine presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Inoltre, ha fatto parte del Gruppo 63, rivelandosi un teorico acuto e brillante. Dal 1959 al 1975 ha lavorato, presso la casa editrice Bompiani, come senior editor. Nel 1975 viene nominato professore di Semiotica all’Università di Bologna, dove impianta una vivace e agguerrita scuola. Negli anni 1976-’77 e 1980-’83 ha diretto l’Istituto di Discipline della Comunicazione e dello Spettacolo, presso l’Università di Bologna. È stato insignito di molti titoli onorifici da parte delle università di tutto il mondo, presso le quali ha tenuto diversi corsi. Dal 1989 è presidente dell’International Center for Semiotic and Cognitive Studies, e dal 1994 è presidente onorario dell’International Association for Semiotic Studies, di cui negli anni precedenti è stato segretario generale e vicepresidente. Dal 1999 è inoltre presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici, presso l’Università di Bologna. Ha collaborato con l’Unesco, con la Triennale di Milano, con l’Expo 1967 – Montreal, e con la Fondation Européenne de la Culture, e con molte altre organizzazioni, accademie, e testate editoriali nazionali e internazionali. Numerose inoltre sono le sue collaborazioni, non solo a quotidiani («II Giorno», «La Stampa», «Il Corriere della Sera», «La Repubblica», «Il Manifesto») e a settimanali («l’Espresso»), ma anche a periodici artistici e intellettuali («Quindici», «Il Verri», ed altri). Ha svolto indagini in molteplici direzioni: sulla storia dell’estetica, sulle poetiche d’avanguardia, sulle comunicazioni di massa, sulla cultura di consumo, ecc. Spaziando dall’estetica medievale alla semiotica ai vari codici di comunicazione artistica, la sua produzione saggistica appare, dunque, estremamente varia e vasta. Per Umberto Eco il modo ermeneutico (ereditato da Pareyson) di accostarsi alle manifestazioni artistiche sarà addirittura esteso al concetto fondamentale per la semiotica: il segno. Come approfondiremo in seguito, la correlazione che si istituisce tra significante (la parola scritta o parlata) e il referente (la cosa reale a cui il segno si riferisce) è puramente convenzionale; così come i criteri che istituiscono il concetto di somiglianza tra il segno e la cosa sono sempre decisi dal soggetto che opera la comparazione. Sulla scia di questo discorso, nel 1962 esce Opera aperta edito da Bompiani, in cui l’autore riesce a spaziare dalla musica seriale a Joyce, dallo Zen al film dopo Antonioni e Godard, applicando ad ogni ambito d’indagine lo stesso rigore e serietà. Attraverso queste analisi, Eco dimostra che l’opera d’arte (da quella “alta” a quella di massa e popolare) non è dotata di un significato unico e definitivo, ma abbisogna di continue integrazioni da parte di critici e dei fruitori più comuni. Nel 1979 tutto ciò è stato ampiamente sviluppato nel saggio Lector in fabula, attraverso la definizione del romanzo come “macchina pigra”, bisognosa di cooperazione interpretativa da parte del lettore . Anche nel saggio successivo – Apocalittici e integrati – del 1964 egli si spinge all’analisi del fumetto, della narrativa popolare o della canzone di consumo con il rigore dell’indagine scientifica. Da molti considerato oltraggioso e irrispettoso verso l’arte con la maiuscola, oggi addirittura il titolo di questo lavoro è divenuto espressione proverbiale per identificare due differenti visioni della cultura e della società. Se, in queste prime opere teoriche, l’ironia è presente ancora in forma sottile, quasi impalpabile, nascosta sotto il ben più ampio strato dell’approccio filosofico-scientifico, nel 1963 diventa la vera protagonista con Diario minimo, raccolta di brevi saggi su osservazioni di costume e parodie ispirate dall’attualità. Di questo libro, divenuto un best seller e tradotto in molte lingue, è doveroso citare almeno lo scritto dal titolo: Fenomenologia di Mike Bongiorno. In queste sei paginette viene descritto il personaggio televisivo che in quell’epoca imperava sugli schermi del paese, Mike Bongiorno appunto. L’analisi è condotta con una tale eleganza, chiarezza e accuratezza nella descrizione dei particolari, tanto che lo stesso Mike si è detto più volte lusingato dello sforzo di Eco nel raccontarlo, implicitamente confermando le tesi esposte dallo studioso. Rileggiamone alcuni divertenti passaggi:
“Il caso più vistoso di riduzione del superman all’everyman lo abbiamo in Italia nella figura di Mike Bongiorno e nella storia della sua fortuna. […] quest’uomo deve il suo successo al fatto che in ogni atto e in ogni parola del personaggio cui dà vita davanti alle telecamere traspare una mediocrità assoluta. […] Mike Bongiorno non si vergogna di essere ignorante e non prova il bisogno di istruirsi. […] In compenso Mike Bongiorno dimostra sincera e primitiva ammirazione per colui che sa. […] professa una stima e una fiducia illimitata verso l’esperto. […] Mike Bongiorno parla un basic italian. Il suo discorso realizza il massimo di semplicità. Abolisce i congiuntivi, le proposizioni subordinate, riesce quasi a rendere invisibile la dimensione sintassi. Evita i pronomi, ripetendo sempre per esteso il soggetto, impiega un numero stragrande di punti fermi. […] Non è necessario fare alcuno sforzo per capirlo. Qualsiasi spettatore avverte che, all’occasione, egli potrebbe essere più fecondo di lui. […] Mike Bongiorno è privo del senso dell’umorismo. Ride perché è contento della realtà, non perché sia capace di deformare la realtà. Gli sfugge la natura del paradosso […] Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti”.
Questo tipo di scritto darà il via ad una lunga serie di pubblicazioni come Dalla periferia dell’impero (1977), Il superuomo di massa (1978), Sette anni di desiderio (1983), Il secondo diario minimo (1992) e La bustina di Minerva (1999), quasi tutte raccolte di ironiche digressioni sui più svariati temi d’attualità, alternate con profonde analisi di stampo filosofico e sociologico. Nel 1983 il fondatore del “pensiero debole”, Gianni Vattimo, pubblica Il pensiero debole, una sorta di manifesto programmatico del nuovo movimento filosofico: tra i tanti saggi che compongono l’opera (scritti, tra gli altri, da Pier Aldo Rovatti, da Maurizio Ferraris, da Diego Marconi), ne compare uno firmato da Eco, intitolato L’antiporfirio. In questo scritto, Eco scorge nell’allievo di Plotino, Porfirio, l’esempio paradigmatico di quel “pensiero forte” (cfr. Giuseppe Girgenti, Il pensiero forte di Porfirio, Milano, 1996) che, poggiando su categorie metafisiche, pretende di cogliere la verità in via definitiva: ad esso si contrappone l’ideale di un “pensiero debole” che, consapevole dei propri limiti congeniti, si pone in ascolto degli altri e si mette ermeneuticamente in cerca di una verità mai definitivamente conquistabile. Dal 1975, Eco è professore di Semiotica all’Università di Bologna, forse la prima vera facoltà italiana di questa disciplina. Ma che cosa è la semiotica? A differenza della Semiologia, che ha come base teorica il lavoro di Ferdinand de Saussure (1857-1913) col suo Corso di linguistica generale pubblicato nel 1913, considerata una naturale estensione della linguistica, la semiotica si fonda sull’opera del filosofo statunitense fondatore del pragmatismo, Charles Sanders Peirce (1839-1814), impegnato più in ambito logico e filosofico e maggiormente interessato ai processi cognitivi che stabiliscono le regole per la trasmissione di messaggi. Malgrado in entrambe le discipline alla base sia presente il semeion, il segno degli antichi greci , nel suo libro Semiotica del 1932, Peirce distinse tre tipi di segno visivo: icona, possiede più di una qualità con l’oggetto denotato (es. un ritratto, una fotografia), indice, si trova in rapporto di contiguità con l’oggetto (es. il fumo che indica fuoco, ma anche il sintomo di una malattia) e il simbolo che si riferisce all’oggetto per via di convenzioni (es. il tricolore simbolo di patria, immagini in cui possono convergere valori condivisi da una comunità). Per Peirce nei casi di indice e simbolo il rapporto tra segno e referente è convenzionale, regolato da un codice interpretativo; nei segni iconici, invece, i rapporti sarebbero motivati per somiglianza con l’oggetto stesso. Eco assume, inversamente, una posizione antireferenzialista affermando che ciò che è iconico, solo apparentemente mostra il suo significato per natura interna: si tratta sempre di attribuzione di significati da parte del soggetto, derivanti da condizionamenti eminentemente culturali. Il significato di un segno non va ricercato all’interno del segno stesso ma nella sua relazione con il codice nel quale esso agisce: la natura del segno è dunque fondamentalmente arbitraria. Egli porta esempi tratti dalla ricerca antropologica che hanno ben dimostrato che la competenza nel leggere un’immagine fotografica varia presso i popoli che non conoscono la prospettiva, diversificando la descrizione delle figure presenti nella foto. Su queste ostiche basi teoriche, Eco costruisce un romanzo giallo che gli conferirà fama a livello mondiale e l’attribuzione di molti premi letterari, tra cui il premio Strega nel 1980. Stiamo ovviamente parlando de Il nome della rosa, in cui ciò che il filosofo ha chiamato “semiosi”, ovvero il processo di produzione dei segni e le loro vicissitudini attraverso i codici, è fortemente presente. D’altronde quale migliore dimostrazione della teoria echiana della semiotica come disciplina della menzogna, se non un romanzo, un testo che è sempre premeditata bugia? Per di più un romanzo ambientato in quel Medioevo in cui Eco si era già addentrato a partire dai tempi della sua tesi di laurea. Il nome della Rosa è un giallo teologico e narra l’avventura investigativa di Guglielmo da Baskerville (cognome espressamente riferito a Il mastino dei Baskerville di Conan Doyle) e il novizio Adso da Melk, per smascherare il responsabile di una serie di omicidi all’interno di un monastero benedettino dell’Italia del nord nell’anno 1327. Possiamo subito dire che il romanzo non è altro che la prosecuzione letteraria delle teorie sulla “semiosi illimitata” esposte da Eco nelle sue opere accademiche, princìpi contenuti nel già citato Trattato e in Lector in fabula. Per addentrarsi con piacere nella fitta trama del testo, al lettore è richiesta un’altissima dose di “cooperazione interpretativa” e “conoscenza intertestuale”, tenendo sempre ben presente che ogni libro vive e si alimenta grazie al continuo rinvio e dialogo con altri libri. Citando in modo ironico il Wittgenstein de il Tractatus logico-philosophicus che scriveva che “di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”, l’autore, dichiarando nelle ultime parole del risvolto di copertina che “ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare”, lancia la sua sfida fin dal titolo, che può così essere interpretato: Il nome della rosa è il nome della rosa e il nome della rosa è una rosa. Ogni segno, linguistico e non, è definibile e interpretabile solo attraverso altri segni in una catena infinita, come quando apriamo il dizionario per cercare il significato di una parola e troviamo altre parole per descriverci il senso del termine indagato, in una serie interminabile di rimandi. Andamento circolare anche nel romanzo che si chiude con la frase: “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”, tradotto con “permane la rosa originale con il nome, abbiamo poi soltanto nudi nomi”. Frase da intendere in senso nominalista, con la parola “rosa” che non avrebbe alcun significato se le rose dei nostri giardini smettessero di esistere. Se la rosa come tale scompare, scompare anche il suo nome. Ecco, allora, il significato del labirinto del romanzo: metafora della continua ricerca della verità – secondo l’insegnamento dell’ermeneutica – , nella sempre incombente possibilità di smarrirsi in una catastrofica perdita di coordinate spazio-culturali. L’esperienza romanzesca non si ferma a Il nome della rosa. Nel 1988 segue un altro romanzo dal titolo Il pendolo di Foucault, opera altrettanto affascinante, costruita come un puzzle tra gli oscuri meandri del tempo e dello spazio. Nel 1994 esce il terzo romanzo di Eco, L’isola del giorno prima, nel 2000 Baudolino e, nel 2004, La misteriosa fiamma della regina Loana. Si è accennato, agli esordi di questo scritto, che con Umberto Eco la questione del ruolo dell’intellettuale all’interno della società in cui vive, si è più volte riproposta sotto forma di esortazioni, da parte di altri personaggi di spicco del panorama culturale, per un maggiore impegno, soprattutto nei confronti della difficile situazione politica italiana. Il tema è vecchio e risale almeno agli scritti dal carcere di Antonio Gramsci: in particolare: Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Il Risorgimento, Letteratura e vita nazionale, Passato e presente. Il problema che viene affrontato in queste opere è il rapporto tra gli intellettuali e il popolo, arrivando addirittura a modificare il senso della parola “nazionale” che dovrà essere intesa come “popolare”, in aperta polemica con il cosiddetto “uomo di cultura” che, dal Quattrocento in poi, si è distaccato dai problemi inerenti lo sviluppo economico e sociale dell’Italia, comportandosi in modo altezzoso e indifferente. Scrive Gramsci: “in Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla nazione, e sono invece legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare o nazionale dal basso: la tradizione è libresca e astratta, e l’intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal Caro o a Ippolito Pindemonte che a un contadino pugliese o siciliano.” Anche Gramsci, come lo stesso Eco, indirizzerà molti dei suoi interessi alla letteratura popolare, al romanzo d’appendice, al melodramma, tutti generi letterari che facilitavano il contatto con la grande massa dei lettori. Sulla sponda opposta troviamo la posizione di Asor Rosa che, con la pubblicazione del saggio Scrittori e popolo del 1965, sferra un potente attacco all’intellettuale nazional-popolare bollato di provincialismo, conservatorismo, di essere l’incarnazione piccolo borghese della cultura paesana, lontana anni luce dai fermenti europei. Perché Umberto Eco sarebbe, da alcuni suoi colleghi, accusato di snobismo nei confronti dei problemi politico-sociali? La ragione potrebbe risiedere nel fatto che Eco è l’intellettuale italiano più conosciuto al mondo, uno studioso con una capacità retorica e discorsiva incredibilmente efficace ed, infine, perché la sua posizione politica è dichiaratamente di sinistra. Nel nostro paese, oggi, mancano quelle figure culturali di riferimento (il citato Gramsci, Croce, Pasolini), capaci di scuotere le coscienze, alimentare il dibattito, accusare direttamente i responsabili delle eventuali aberrazioni democratiche, suggerire strategie per possibili correzioni di rotta nella gestione politica del paese. La deriva cui stiamo assistendo del mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, ovvero la televisione, seguita quotidianamente da milioni di persone, usata scorrettamente ormai solo come mezzo di propaganda politica, forse, attraverso un maggiore impegno da parte di tutti gli intellettuali (soprattutto quelli designati alla gestione dei palinsesti), avrebbe potuto evitare, almeno sulle reti pubbliche, il ripugnante e vergognoso spettacolo quotidiano gettato in pasto agli onnivori utenti.
BRONISLAW MALINOWSKI

A cura di Studioantropologico.it
“L’analisi funzionalistica della cultura ha come obiettivo la spiegazione dei fatti antropologici, a ogni livello di sviluppo, mediante la loro funzione, mediante la parte che essi svolgono all’interno del sistema culturale complessivo, mediante la modalità secondo cui essi sono connessi l’un l’altro nel sistema e mediante il modo in cui il sistema stesso è connesso all’ambiente fisico” (Social Anthropology, in Encyclopaedia Britannica, 14° ed., p. 864).
Nei primi decenni del Novecento, dopo un periodo di incertezza teorica, l’attività etnografica era condotta principalmente da antropologi di formazione britannica. Alcuni di questi non erano di nazionalità inglese, tuttavia nelle università inglesi avevano ricevuto una solida formazione teorica e avevano trovato il clima più adatto per intraprendere le loro ricerche sul campo. Tra costoro il più celebre fu senza dubbio Bronislaw Malinowski. Allievo di C. G. Seligman, Bronislaw Malinowski (1884 – 1942), d’origine polacca, ebbe una influenza grandissima sulle generazioni successive, tanto che il suo stile di fare etnografia (la cosiddetta “osservazione partecipante”) divenne presto un modello e Malinowski stesso fu a lungo considerato l’Antropologo per eccellenza, colui che attraverso la pratica di una ricerca intensiva sul campo era in grado di cogliere dall’interno la vita delle popolazioni studiate.
Dal 1921 al 1934 Malinowski insegnò alla London School of Economics; dal 1938 fino alla morte fu professore alla Yale University. Uno dei suoi maestri, Marett, considerava Malinowski “un uomo capace di farsi strada nel cuore del più diffidente selvaggio”. Firth, che fu suo allievo, lo riteneva in grado “di raggiungere una eccezionale identificazione con la gente da lui studiata”. Di fatto, se l’antropologia è uscita da un ristretto ambito di specialisti si deve anche all’investimento d’immaginazione nei confronti di quest’uomo dalla raffinata cultura mitteleuropea che partì per studiare gli abitanti di isole lontane. Malinowski rappresentò per molti un’alternativa possibile al vissuto quotidiano: rappresentò l’uomo avventuroso che, sciolti i legami col proprio gruppo, si lasciava dietro le spalle le convenzioni sociali, compiendo una vera e propria fuga dalla civiltà.
A mettere in discussione il mito Malinowski fu lo stesso antropologo polacco, e, meglio, la pubblicazione postuma (1967, a venticinque anni dalla morte) dei suoi diari sul campo. Ne uscì un’immagine di Malinowski assai diversa rispetto a quella affermata di uomo controllato in grado di adattarsi a qualsiasi estraneità culturale. L’antropologo dei “diari” era un uomo spesso “a disagio”, di volta in volta duro, compassionevole, intollerante e volgare nei confronti dei nativi; un’immagine che fece scalpore nel mondo dell’antropologia e ne ridimensionò moltissimo il mito. Alla luce dei suoi diari, Clifford Geertz scrisse che Malinowki passò gran parte del suo tempo sul campo desiderando di essere altrove.
Anche le sue teorie furono accusate di eccessive semplificazioni. Se Malinowski influenzò senza dubbio l’antropologia americana comportamentistico-empirista, dura resta, invece, l’opinione dell’inglese Evans-Pritchard, che gli riconosceva indubbie capacità sul campo ma trovava che i suoi libri fossero “una caterva di chiacchiere e di banalità”.
Ciò nonostante è opinione oggi diffusa riconoscere a Malinowski un contributo decisivo alla definizione dei caratteri dell’antropologia moderna. Il “funzionalismo”, l’indirizzo antropologico di cui è l’esponente di maggior spicco, rappresenta un evidente salto di qualità rispetto all’evoluzionismo britannico di tipo Frazeriano. La svolta è evidente proprio sul piano della teoria. Uno dei principi-guida che informava l’opera di Frazer era l’ordine di successione secondo il quale nel processo evolutivo dell’umanità facevano la loro comparsa dapprima la magia, poi la religione ed infine la scienza, quest’ultima assente nella fase primitiva, posta sotto il segno del magico. La formazione del pensiero scientifico si situava per Frazer al culmine del processo evolutivo. Per Malinowski, invece, magia, religione e scienza erano da sempre coesistenti, distinte ma unite da reti di relazioni reciproche. La conoscenza scientifica, inoltre, era la spina dorsale della cultura, da sempre, ed era da estendere con pieno diritto anche all’uomo primitivo, di cui era guida determinante nel suo rapporto con l’ambiente. Nonostante abbia più volte professato profonda ammirazione per Frazer, con le sue teorie Malinowski metteva in discussione l’intero edificio evoluzionistico.
Per Malinowski la produzione di cultura trae impulso dall’esigenza di soddisfare i bisogni umani, a cominciare da quelli considerati primari e comuni anche agli altri animali (il bisogno di nutrirsi, procreare, proteggersi). Lo specifico dell’uomo consiste nella sua peculiare prerogativa di rispondere in maniera “indiretta” agli imperativi vitali. Ad esempio, il bisogno di nutrirsi non si risolve per l’uomo nel semplice atto di consumare da solo i frutti che crescono spontaneamente nella foresta; al contrario, in tutte le fasi del processo della nutrizione (dalla ricerca del cibo alla sua preparazione, dalla cottura all’ingerimento) vigono precise regole umane. Inoltre gli alimenti sono ottenuti attraverso procedimenti praticati collettivamente, in cui fondamentale è l’uso di un apparato prodotto artificialmente (armi, attrezzi agricoli, arnesi della tecnica) così come determinanti sono la cooperazione organizzata e i valori economici e morali. La risposta “indiretta” è dunque un modo culturale di soddisfare le esigenze d’ordine naturale. Ma questo soddisfacimento culturale dei bisogni fondamentali comporta per Malinowski l’insorgenza di nuovi bisogni di ordine culturale. Malinowski distingue allora tra imperativi fondamentali, concernenti i bisogni biologici dell’uomo, e gli imperativi del sistema o “derivati” (ma non nel senso di secondaria importanza), corrispondenti alle regole cui gli uomini devono sottostare per vedere adeguatamente soddisfatti i loro bisogni. Vi è poi una terza categoria di imperativi che Malinowski chiamò “integrativi”, tra cui l’antropologo polacco annovera la conoscenza, la magia e la religione.
La religione ha una funzione positiva autonoma, quella di rispondere al bisogno umano di fronteggiare le situazioni di crisi sparse lungo l’arco dell’esistenza individuale e collettiva. Tra le crisi la più inquietante è quella connessa alla morte, l’evento che sconvolge calcoli e progetti umani. La religione interviene con varie modalità, che vanno dall’affermazione della non realtà della morte all’elaborazione di teorie come quella dell’immortalità dell’anima umana. In ogni caso la religione interviene sulle situazioni di crisi al fine di modificarle secondo paradigmi sociali sanciti dalla tradizione (un tema successivamente ripreso ed rielaborato da Ernesto De Martino). La religione manipola gli accadimenti critici assumendoli, in modo da eliminare i fattori di squilibrio e di disintegrazione, operando a favore della coesione sociale.
Anche la magia ha una sua funzione. Malinowski rifiuta la teoria di Frazer secondo la quale la magia era una forma primitiva e distorta di conoscenza scientifica, una pseudo-scienza. Per Malinowski il ricorso al magico è funzionale a far fronte a quei rischi che dipendono da fattori derivanti dal caso (e sono perciò imprevedibili) rispetto ai quali il peso della scienza è irrilevante. Il sapere scientifico e la tradizione magica sono per Malinowski strumenti per sottoporre a controllo umano la realtà esterna nella totalità dei suoi aspetti. Il senso ultimo della magia è quello di far sì che l’uomo non desista dall’operare, offrendogli una via d’uscita là dove si profila il rischio dell’impasse.
L’approccio etnografico di Malinowski, venato dal sospetto che le interpretazioni dell’antropologo siano continuamente influenzate dalle interpretazioni degli informatori, è una teoria che, come egli stesso ebbe a scrivere, “nata sul campo, conduce ancora nuovamente sul campo”.
I suoi libri più famosi e importanti sono quelli in cui l’antropologo polacco ha organizzato e interpretato i dati raccolti sul “terreno”. Tra il 1915 e il 1918 Malinowski aveva consacrato grande parte delle proprie ricerche all’universo socio-culturale degli abitanti delle isole Trobriand, arcipelago a nord est della Nuova Guinea, dove aveva raccolto la gran parte del materiale etnografico che sta alla base delle sue pubblicazioni. Argonauts of the Western Pacific (Argonauti del Pacifico Occidentale), uscirà nel 1922; The sexual Life of Savages in North-western Melanesia (La vita sessuale dei selvaggi della Melanesia Nord-occidentale), nel 1929. I due libri non costituiscono dei saggi sulla cultura nelle isole Trobriand considerata nella sua totalità ma partono da un aspetto della vita di esse per poi aprirsi agli altri.
L’oggetto di Argonauti nel Pacifico Occidentale era costituito da una forma di scambio, il kula, praticata da comunità stanziate su una trentina di isole disposte su un cerchio compreso in un’area geografica precisa. Tra le isole abitate dai gruppi partecipanti allo scambio circolavano due tipi di oggetti: collane di conchiglie rosse e braccialetti di conchiglie bianche. Le prime circolavano solo in senso orario, i secondi solo in senso contrario. Ne seguiva che gli oggetti appartenenti ad una categoria potevano essere scambiati solo con oggetti dell’altra categoria. Gli oggetti circolavano in continuazione, restando nelle mani del loro possessore solo per un periodo limitato di tempo. Gli oggetti venivano barattati nel corso di visite che gli abitanti delle isole si scambiavano periodicamente. Sia i preparativi per la partenza che le trattative e gli scambi avvenivano secondo rituali precisi. Durante le visite, gli scambi di tipo kula erano accompagnati da un commercio di tipo profano mediante il quale venivano scambiati oggetti in possesso di un valore d’uso.
L’analisi condotta da Malinowski fece emergere l’esistenza di una rete di rapporti tra individui, clan e tribù fondati su ciò che da allora in poi sarebbe entrato a far parte del repertorio concettuale dell’antropologia col nome di “principio di reciprocità”. Tutte le operazioni connesse alle spedizioni kula si presentavano infatti come regolate da una logica sociale che nei suoi effetti tendeva a promuovere la solidarietà sociale. Più in generale, per Malinowski il principio di reciprocità costituiva la base delle relazioni sociali e del diritto vigente presso le società primitive. L’utilizzazione del principio di reciprocità come principio esplicativo della dinamica sociale primitiva migrerà nella teoria del dono di Marcel Mauss e da questi, in seguito, nell’antropologia strutturale di Claude Lévi-Strauss.
Ne La vita sessuale dei selvaggi della Melanesia Nord-occidentale Malinowski prende invece in considerazione un altro aspetto della cultura delle isole Trobriand. L’ideologia religiosa trobriandese induceva a considerare ogni nuovo nato come la reincarnazione dello spirito di un parente materno deceduto: in questa cornice la nascita di un individuo acquistava un valore preciso. Quando un uomo moriva, il suo spirito (baloma) lasciava il corpo e si trasferiva nell’Isola dei Morti, dove conduceva un tipo di esistenza simile a quella dei vivi, invecchiando e ringiovanendo periodicamente. Quando era stanco di ringiovanire, il baloma si trasformava in un embrione umano e, via mare, tornava nel mondo dei vivi per iniziare una nuova esistenza. L’embrione, di solito grazie alla mediazione di un altro spirito imparentato con la futura madre, veniva poggiato sulla testa di una donna appartenente alla stessa linea di discendenza della persona morta, e da qui penetrava nel ventre. La donna restava incinta e la sua prole assicurava la continuità del gruppo sociale materno.
La caratteristica più sorprendente di questo edificio culturale consiste nella negazione della paternità fisiologica. Nella società trobriandese matrilineare il rapporto tra padre e figlio era decretato dalla legge come un rapporto tra estranei e tutti gli obblighi familiari erano assicurati dalla successione materna. I figli dunque appartenevano al clan della madre, che aveva nel proprio fratello maggiore (e non nel marito) un capo e un protettore (ruoli che il marito rivestiva nei confronti della propria sorella e dei figli di quest’ultima). Non sarebbe convincente attribuire questo tipo di sistemazione di un aspetto così importante della realtà all’ignoranza dei Trobriandesi circa il rapporto causa/effetto tra accoppiamento sessuale e gravidanza. Più che una semplice ignoranza della paternità fisiologica appare un voluto disconoscimento di quest’ultima. Per i Trobriandesi l’accoppiamento sessuale uomo/donna era senza dubbio necessario, ma al solo fine di produrre l’apertura della vagina, mentre il potere generativo dello sperma veniva negato.
Prima del matrimonio la donna trobriandese viveva una fase dell’esistenza caratterizzata da ampia libertà sessuale; fase che non poteva estendersi oltre un certo limite, altrimenti la donna sarebbe incorsa nel disprezzo sociale. La funzione del marito era quindi quella di disciplinare la vita sessuale della moglie e, al tempo stesso, di farne valere i diritti; il marito era anche colui che assisteva la moglie durante il parto e che aveva cura dei bambini dalla nascita fino al momento in cui questi, divenuti adolescenti, sarebbero stati sottoposti all’autorità dello zio materno. Quest’ultimo, tuttavia, non recitava soltanto un ruolo “positivo” ma anche un ruolo “negativo”, sanzionato da un tabù che gli impediva in modo assoluto di pensare a qualche cosa che fosse in rapporto con il sesso della sorella. Era proprio in relazione a questa sfera che si rendeva ancor più necessaria la figura del marito.
Il sistema socio-culturale trobriandese fornisce un esempio di ciò che Malinowski intende quando parla di modo culturale “indiretto” di soddisfare i bisogni biologici, quale il bisogno di continuità della specie. Un modo culturale che reinterpreta gli impulsi fisiologici in termini di regole sociali, avallate dalla tradizione.
FRANCIS FUKUYAMA

A cura di Valerio Martone
Francis Fukuyama (nato nel 1952 a Chicago, Illinois) è Senior Researcher alla Rand Corporation. Ha raggiunto una vasta notorietà con il suo libro La fine della storia e l’ultimo uomo (1992, tradotto in oltre 20 lingue) cui è seguito Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) e The Great Disruption. Fukuyama insegna anche all’istituto di politica estera della scuola per studi internazionali avanzati della John Hopkins University dove è direttore del progetto sulle telecomunicazioni. Scienziato politico specializzato sugli affari politico-militari del Medio Oriente e la politica estera dell’ex-Unione sovietica, ha ricoperto vari incarichi negli ultimi 15 anni sia all’interno della Rand Corporation che al Dipartimento di Stato americano. Si è occupato lungamente di questioni riguardanti la democratizzazione e la politica internazionale e, negli ultimi anni, si è concentrato sul ruolo della cultura e del capitale sociale nella vita economica moderna. La fine della storia e l’ultimo uomo (1992) ripropone fondamentalmente alcuni temi e concetti significativi dello storicismo che, a detta dello stesso autore, erano stati trascurati nella produzione filosofica degli ultimi anni. Tutta l’opera si basa infatti sulla giustificazione della validità di una nuova “storia universale”, in polemica con una filosofia del ‘900 ritenuta eccessivamente pessimista e incapace di rivalutare la possibilità di un percorso storico necessario e volto all’affermazione del migliore dei mondi possibili. Questa nuova storia universale avrebbe poi (e ciò è sicuramente uno dei punti più dibattuti) una vera e propria fine, delineata in un ben preciso sistema sociale, politico ed economico, ossia la liberaldemocrazia e, in particolare, la versione di essa oggi esistente negli Stati Uniti. Ma quali sono più precisamente le giustificazioni di Fukuyama rispetto ad un’idea così radicale come quella della fine della storia nel sistema liberaldemocratico? Egli porta avanti parallelamente due tesi: da una parte cerca di dimostrare come il progresso scientifico-tecnologico sia indice di una storia progressiva e direzionale, dall’altra indica nel meccanismo del riconoscimento hegeliano il motore del processo storico che porta necessariamente ad un sistema politico liberaldemocratico. Entrando maggiormente nello specifico, Fukuyama parte dalla considerazione che l’unica attività umana, che può essere definita come costantemente cumulativa e progressiva, sia lo sviluppo della scienza e della tecnica. Tale attività diviene quindi, di riflesso, indice di uno sviluppo costante nell’ambito della storia umana poiché impone, tramite il continuo aumento qualitativo e quantitativo della produzione di beni, un continuo e parallelo allargamento del sistema dei bisogni che si fanno sempre più raffinati e complessi. D’altra parte, oltre allo sviluppo dei bisogni, vi è anche un contemporaneo sviluppo nella capacità di soddisfarli, visto il costante aumento della produzione facilitato, per esempio, dalla creazione di mezzi di comunicazione sempre più veloci e precisi. Secondo Fukuyama lo sviluppo tecnico-scientifico esprime al massimo le sue possibilità proprio nell’ambito di un sistema produttivo capitalistico e, in particolare, nell’attuale sistema neoliberista e globalizzato: tale convinzione gli deriva in particolare dalla vittoria che il sistema capitalistico ha riportato sul sistema comunista sovietico, capace quest’ultimo di creare quasi dal nulla un potente apparato industriale, ma intrinsecamente incapace di reggere sul lungo periodo la concorrenza del sistema capitalistico. Tuttavia, come nota lo stesso Fukuyama, se il progresso scientifico è capace di giustificare una storia progressiva e finalizzata al liberismo economico, non è altrettanto efficace nel giustificare il passaggio necessario ad un sistema politico democratico. Vi sono infatti numerosi paesi in cui si assiste a un impetuoso sviluppo delle capacità produttive, non accompagnato però da un parallelo sviluppo verso istituzioni politiche democratiche. Entra qui in gioco il secondo elemento ritenuto capace di giustificare la fine della storia nel sistema liberaldemocratico occidentale: la lotta per il riconoscimento. Di tale concetto, fondamentale nella filosofia hegeliana, Fukuyama accoglie, più che la visione originale di Hegel, la rivisitazione datane da Kojève e la “arricchisce” con una reinterpretazione della dottrina platonica: se infatti è la parte concupiscibile dell’anima umana che porta ad un costante sviluppo dei mezzi di produzione e della scienza, si deve invece alla parte timocratica (caratterizzata dal thymòs) la spinta verso il sistema democratico. Il riconoscimento reciproco ed eguale, che avviene tra due autocoscienze nell’ambito di un sistema democratico, è quindi, secondo Fukuyama, la migliore possibile soluzione di compromesso per tutti. Se infatti in democrazia la “isotimia” garantita dal diritto formale non consente lo sviluppo abnorme di singole “megalotimie”, è anche vero che il reciproco ed eguale riconoscimento di ognuno consente, proprio per la sua universale diffusione, una soddisfazione ampia e per tutti. La fine della storia sarebbe insomma, secondo Fukuyama, nell’attuale sistema liberaldemocratico e, se in alcuni paesi (U.S.A., Europa Occidentale, etc.) si assisterebbe già ad una fase “post-storica”, in altre parti del mondo saremmo ancora in una fase storica più o meno avanzata, ma comunque sempre inquadrabile nell’ambito del percorso già compiuto dalle liberaldemocrazie occidentali. Di fronte alla radicalità delle proprie tesi lo stesso Fukuyama ammette la possibilità di critiche e, nell’ultima parte del suo libro, cerca di immaginare una possibile critica da sinistra, riconducendola al filone di pensiero marxista, e una critica da destra, facendola risalire al filone nietzscheano. La questione di riferimento per tali critiche è se la liberaldemocrazia possa essere un effettivo punto di arrivo della lotta per il riconoscimento, ossia se in essa vi possa essere un effettivo soddisfacimento del thymòs. Nell’ipotesi di critica marxista il riconoscimento sarebbe imperfetto perché solo formale e non accompagnato da un’effettiva uguaglianza di possibilità; nell’ipotesi di critica nietzscheana, invece, l’isotimia democratica sarebbe frustrante, visto che l’uguaglianza del riconoscimento non sarebbe specchio reale delle differenze tra uomo e uomo. Alla critica marxista Fukuyama risponde che in verità il sistema capitalistico garantisce uguaglianza di diritti e di possibilità di successo; a quella nietzscheana (ritenuta maggiormente pertinente) che, se l’isotimia può essere frustrante per i più dotati, è anche vero che il sistema liberaldemocratico consente in campi quali lo sport e, soprattutto, la politica, la riproposizione di sfide capaci di soddisfare la megalotimia nei termini di un riconoscimento diseguale, pur nell’ambito più generale di garanzie dettate da una costituzione democratica. In conclusione, il problema che pone Fukuyama nell’arco delle sue pubblicazioni, oltre alla validità del “pensiero unico” di cui si presenta come alfiere, è, più in generale, la validità oggi di un sistema storicistico e di categorie quali “storia universale” e “fine della storia”, questioni poste con forza da studiosi fra loro anche molto diversi (pensiamo, tra gli altri, a Lo scontro delle civiltà di Huntington e a Impero di Tony Negri), nell’ambito dell’acceso dibattito su La fine della storia e l’ultimo uomo. D’altra parte, ripensando alle critiche immaginate da Fukuyama nell’ultima parte del suo libro e partendo da quest’ultime, il rifiuto di “dire cinesemente sempre sì di fronte alla potenza della storia” espresso da Nietzsche, può, e forse deve procedere parallelamente, seppure in un orizzonte teoretico ben diverso, con la necessità di “spazzolare la storia contropelo” e di non “nuotare con la corrente” espressa da Benjamin e da gran parte del marxismo del Novecento. Il problema è insomma, partendo da Nietzsche o da Benjamin, sempre quello di riuscire ad immaginare un rapporto soggetto-storia aperto e problematizzante, che non si risolva cioè in una passiva accettazione del dato. Indicativo e incoraggiante in questo senso è il fatto che, fino ad oggi, nonostante i numerosi tentativi teorici e pratici in tal senso, piaccia o non piaccia a Fukuyama, la storia si è sempre rivelata refrattaria ad ogni chiusura.
MASSIMO CACCIARI

A cura di Silvia Crupano ( www.pantarei.co.uk )
“La Luce rivela che l’uomo è straniero a se stesso. E poichè non si conosce, compie atti che non doveva compiere – il primo, che tutti comprende: nasce e non avrebbe dovuto“.
Massimo Cacciari nasce a Venezia il 5 giugno 1944 e fin dagli anni del liceo manifesta la propria specialissima predisposizione per la filosofia, confrontandosi precocemente con testi complessi quali, ad esempio, lo Zarathustra di Nietzsche e la Città di Dio di Agostino.
Frequenta l’università a Padova durante gli anni delle contestazioni studentesche ed emerge quella vis politica che, accanto alla filosofia, segnerà per sempre la inscindibile duplicità del suo carattere. Sono di questi anni i primi scritti, naturalmente dedicati a tematiche politico-economiche: Ciclo capitalistico e lotte operaie: Montedison, Fiat, Pirelli, Padova, Marsilio, 1969; Dopo l’autunno caldo ristrutturazione e analisi di classe, Marsilio, 1973; Piano e composizione di classe, Feltrinelli, Milano, 1975.
Sempre in quegli anni, Cacciari fonda un’importante rivista di Estetica, “Angelus Novus” (1964-1971) ed una di critica politica, “Contropiano” (1968-1971).
Nel 1967 egli si laurea con una tesi sulla Critica del Giudizio di Kant e intensifica le sue collaborazioni – già da tempo esistenti, anche in veste di docente – con i professori Carlo Diano in Letteratura e Filosofia greca e Sergio Bettini in Storia dell’Arte. Diviene assistente del professor Dino Formaggio presso la cattedra di Estetica di Padova e, in questi stessi anni, lavora al fianco del professor Giuseppe Mazzariol presso cattedra di Letteratura artistica di Venezia. Dall’anno accademico 1970-71 riceve un incarico di Letteratura artistica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e si inaugura la sua feconda amicizia e collaborazione con Manfredo Tafuri.
Accanto agli studi di architettura – mai accantonati e che gli varranno, diversi anni dopo (15 ottobre 2003), il conferimento della laurea honoris causa in Architettura da parte dell’Università di Genova – compaiono, negli anni Settanta, i suoi primi scritti filosofici: Pensiero negativo e razionalizzazione. Problemi e funzione della critica del sistema dialettico, 1973; Metropolis, Roma, Officina, 1973; Piano economico e composizione di classe, Feltrinelli, 1975; Oikos. Da Loos a Wittgenstein (con F. Amendolagine), Roma, 1975; Krisis, Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Feltrinelli, 1976 (ottava edizione nel 1983); Pensiero negativo e razionalizzazione, Marsilio, 1977; Il dispositivo Foucault, Venezia, Cluva, 1977; Dialettica e critica del politico. Saggio su Hegel, Feltrinelli, 1978; Walter Rathenau e il suo ambiente, De Donato, 1979.
Nel 1975 prende avvio la sua collaborazione con le riviste filosofiche “Aut aut” e “Nuova corrente”. A testimonianza della sua mai spenta né affievolita vis politica, è deputato al Parlamento italiano dal 1976 al 1983.
Nel 1980 diviene Associato di Estetica e nel 1985 Ordinario della stessa materia presso l’Università di Venezia.
Durante gli anni Ottanta si intensifica la sua attività pubblicistica: inizia a scrivere sulla nota rivista di architettura “Casabella” (con la quale tuttora collabora), fonda la rivista di filosofia “Il Centauro” (1981-1986) e “Laboratorio politico” (1981-1985), pubblica saggi su “Politica ed economia”, “Esodo” e “Micromega”. Numerosi ed impegnativi anche i suoi libri di questo periodo: Crucialità del tempo: saggi sulla concezione nietzscheana del tempo, et al, Liguori, 1980; Dallo Steinhof, Adelphi, 1980 (nuova edizione 2005); Adolf Loos e il suo angelo, Electa, 1981; Il potere : saggi di filosofia sociale e politica, con G. Penzo, Roma, Città Nuova, 1985; Icone della legge, Adelphi, 1985 (nuova edizione 2002); Zeit ohne Kronos, Ritter Verlag, Klagenfurt, 1986; Angelo necessario, Adelphi, 1986 (nuova edizione 1992); Drama y duelo, Tecnos, Madrid, 1989; Le forme del fare, con M. Donà e R. Gasparotti, Liguori, 1989.
Nel 1990 pubblica la sua opera teoretica più importante, Dell’Inizio, Adelphi (nuova edizione nel 2001), che consolida definitivamente la sua posizione di filosofo tra i più importanti in Italia e che ancora oggi è ritenuta un contributo al pensiero imprescindibile e insuperato. In questo lavoro Cacciari avvia quella sistematizzazione della propria filosofia che, attraverso studi approfonditi in ambiti teologici, letterari, politici, economici e artistici, troverà nel volume Della cosa ultima, Adelphi, 2004, il suo perfetto compimento – in sintonia con il detto schellinghiano per cui «un sistema è compiuto quando è ricondotto al suo punto d’avvio».
Sempre degli anni Novanta sono: Dran, Méridiens de la décision dans la pensée contemporaine, Ediotions de L’Eclat, 1992; Architecture and Nihilism, Yale University Press, 1993; Desde Nietzsche: Tiempo, Arte, Politica, Biblios, Buenos Aires, 1994; Geofilosofia dell’Europa, Adelphi, 1994 (nuova edizione 2003); Großstadt, Baukunst, Nihilismus, Ritter, Klagenfurt, 1995; Migranten, Merve, Berlino, 1995; Arcipelago, Adelphi, 1997; Emilio Vedova. Arbitrii luce, Catalogo della mostra, Skira, 1998.
Nel 1990 fonda, insieme a Umberto Curi, Sergio Givone, Carlo Sini, Vincenzo Vitello e Giacomo Marramao, la rivista di filosofia “Paradosso” (1990-2002)
Dal 1993 al 2000 è Sindaco di Venezia e deputato europeo; nel 1999 gli viene conferito il premio Hannah Arendt per la filosofia politica.
Dal 2000 ad oggi, ha pubblicato i seguenti libri: Arte, tragedia, tecnica, con M. Donà. Raffaello Cortina, 2000; El Dios que baila, Paidos, Buenos Aires, 2000; Duemilauno. Politica e futuro, Feltrinelli, 2001; Wohnen. Denken. Essays über Baukunst im Zeitalter der völligen Mobilmachung, Ritter Verlag, Klagenfurt und Wien, 2002; Della cosa ultima, Adelphi, 2004; La città (conferenza), Pazzini, 2004; Il dolore dell’altro. Una lettura dell’Ecuba di Euripide e del libro di Giobbe (conferenza), Saletta dell’Uva, 2004; Magis Amicus Leopardi, Saletta dell’Uva, 2005.
Nell’estate del 2004 istituisce a Milano un Centro di Formazione Politica (www.formazionepolitica.org) con il quale collaborano personalità del calibro di Alberto Abruzzese, Aldo Bonomi, Gad Lerner, Salvatore Natoli, Michele Salvati.
In più di trent’anni di appassionata attività filosofica e politica, tiene corsi e conferenze in tutte le più importanti sedi del dibattito filosofico europeo; vede i suoi libri tradotti nelle principali lingue europee, alcuni anche in giapponese ed altri pubblicati esclusivamente all’estero; riceve nel 2002 il premio dell’Accademia di Darmstadt per la diffusione della cultura tedesca all’estero e, sempre in quell’anno, fonda la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presso la quale è ordinario di Estetica.
Stretto collaboratore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e del Collége de Philosophie di Parigi, riceve nel 2005 la Medalla de Oro del Circolo delle Belle Arti di Madrid e dall’aprile dello stesso anno è Sindaco di Venezia (terzo mandato).
La ricerca filosofica di Cacciari prende avvio dallo studio del “pensiero negativo”, anti-dialettico, tra Schopenhauer e Nietzsche, di cui analizza le connessioni con la cultura letteraria, artistica e scientifica del primo Novecento, soffermandosi in particolare sulla finis Austriae. In particolare, l’approfodimento del Nietzsche di Heidegger lo ha portato a una riconsiderazione dell’intera storia della metafisica e dello stesso paradigma interpretativo heideggeriano. Nei suoi ultimi lavori, la problematica filosofica si intreccia con quella teologica, secondo una linea che si potrebbe definire di rivisitazione critica della tradizione platonica. Parafrasando Heidegger, il suo problema potrebbe essere sintetizzato così: che cosa significa “pensare”, in un’epoca in cui la filosofia appare definitivamente specializzata in ambiti particolari ? Vi è “inizio” del pensare, nel senso che il pensare possa assumere proprio l’“inizio” a suo problema? La storia filosofico-teologica europea incentrata sulla nozione di “Deus-Esse” quale “principio” è interrogata dall’Autore alla luce di questa domanda.
Dell’Inizio dichiara già nel titolo la volontà di volgere lo sguardo a quel “cominciamento” che è il problema del pensiero filosofico (ogni altro sapere presuppone l’“oggetto” da cui inizia). A questa tranquilla inattualità nel porre senza indugi – e senza sentire il bisogno di darsi giustificazioni – il problema di sempre della filosofia, corrisponde una novità perentoria nella articolazione della forma, che si compone sottilmente dei tre modi della scrittura filosofica: il dialogo (quindi l’ironia, la ricerca) – il trattato (quindi la sistematicità) – il “parergon” (quindi la frammentazione aforistica, il Dio nel dettaglio). Da questi tratti, appare evidente una certa, voluta, arcaicità dell’architettura formale, che implica in sé, pur non dichiarandola, una vis polemica contro ogni discorso filosofico rassegnato all’inerzia e convinto che quest’ultima sia anche la più ragionevole medicina. Qui, al contrario, non si sfugge al riconoscere che, se pensiero filosofico deve esserci, non può che riproporsi perennemente le domande del Parmenide platonico. È questo il “compito del pensare”, quello che Hegel chiamava il “lavoro del concetto”. Dell’inizio però vuole proporsi quel compito non più in termini dialettici (come nella dialettica dell’essenza di Hegel), ma nemmeno in quelli del loro presunto superamento (in ogni specie di Uberwindung). Avviene così che una “filosofia negativa” sia condotta a ripercorrere una linea di tutt’altra origine – e cioè una “certa” discendenza platonica: Proclo – Damascio – Scoto Eriugena – Eckhart – Cusano – Schelling. Producendovi così, come già questi nomi indicano, un affascinante chassé-croisé tra filosofia e teologia, obbligate finalmente a confondere di nuovo le loro acque, dalle quali emergerà nelle pagine di quest’opera una “doppia” eresia.
In Della cosa ultima, a compimento del sistema cacciariano, l’interrogativo di fondo è: “quale cosa attinge, ‘in ultimo’, l’anima dopo essersi aperta, attraverso l’angoscia, alla ricerca di sé?”.
Tre voci in dialogo tra loro e con i Maggiori Loro, da Platone a Husserl, cercano di rispondere a tale domanda, ognuna seguendo il proprio “demone custode”: la voce portatrice di un radicale scetticismo dell’Intelletto, la voce che incarna l’atto di fede in lotta contro se stesso e quella dell’Autore, che agli amici si rivolge anche attraverso due lunghe serie di lettere, riprendendo e sviluppando le idee della sua più importante opera teoretica: Dell’Inizio. Infatti, dopo aver indagato, in Geofilosofia dell’Europa e nell’Arcipelago, l’irriducibile pluralità delle radici culturali presenti nel paesaggio europeo, l’attenzione di Cacciari torna a volgersi a quel “cominciamento” che è il “problema” filosofico fondamentale. La “cosa ultima”, quindi, non è che l’Inizio: qui però non è più semplicemente inteso come indifferente insieme di tutte le possibilità, bensì come “l’infinità” stessa della cosa nella sua inalienabile e intramontabile singolarità. Solo attingendo alla “cosa ultima”, toccandone l’essenza divina, l’anima esprime la propria unica, possibile libertà. E il fare filosofia si manifesta allora per ciò che sempre, e ancora una volta, dovrebbe essere: movimento di liberazione.
De Silvia Crupano. Trad. de Antonio J. Antón
“La Luz revela que el hombre es extranjero para sí mismo.Y puesto que no se conoce, realiza acciones que no debería realizar; la primera, que comprende todas las demás: nace, y no debería“.
Massimo Cacciari nace en Venecia el 5 de Junio de 1944 y desde los años del Instituto manifiesta su especial predisposición para la filosofía, enfrentandose precozmente a textos complejos como por ejemplo, el Zaratustra de Nietzsche y la “Ciudad de Dios” de San Agustín. Asiste a la universidad de Padua durante los años de las revueltas estudiantiles y emerge entonces aquella vis política que, junto a la filosofía, marcará para siempre la inseparable duplicidad de su carácter. Son de estos años los primeros escritos, naturalmente dedicados a temas político-económicos: Ciclo capitalistico e lotte operaie: Montedison, Fiat, Pirelli, Padova, Marsilio, 1969; Dopo l’autunno caldo ristrutturazione e analisi di classe, Marsilio, 1973; Piano e composizione di classe, Feltrinelli, Milano, 1975. Siempre en aquellos años, Cacciari funda una importante revista de estética; “Angelus Novus” (1964-1971), y otra de crítica política, “Contropiano” (1968-1971). En 1967 se doctora con una tesis sobre la Crítica del Juicio de Kant e intensifica sus colaboraciones –desde hace tiempo frecuentes– con los profesores Carlo Diano en Literatura y Filosofía Griega y Sergio Bettini en Historia del Arte. Pasa a ser asistente del profesor Dino Formaggio en la cátedra de estética de Padua , y, en los mismos años , trabaja junto al profesor Giuseppe Mazzariol en la cátedra de Literatura artística de Venecia. Desde el año académico 1979-’71 recibe el cargo de Literatura artística en el instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y se inaugura la fecunda amistad y colaboración con Manfredo Tafuri.
Junto a los estudios de arquitectura, -jamás dejados de lado y que le valdrán, varios años después (15-Oct.-2003), la entrega del Doctorado Honoris Causa en Arquitectura por la Universidad de Genova- aparecen, en los años setenta, sus primeros escritos filosóficos: Pensiero negativo e razionalizzazione. Problemi e funzione della critica del sistema dialettico, 1973; Metropolis, Roma, Officina, 1973; Piano economico e composizione di classe, Feltrinelli, 1975; Oikos. Da Loos a Wittgenstein (con F. Amendolagine), Roma, 1975; Krisis, Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Feltrinelli, 1976 (ottava edizione nel 1983); Pensiero negativo e razionalizzazione, Marsilio, 1977; Il dispositivo Foucault, Venezia, Cluva, 1977; Dialettica e critica del politico. Saggio su Hegel, Feltrinelli, 1978; Walter Rathenau e il suo ambiente, De Donato, 1979. En 1975 comienza su colaboración con las revistas filosóficas “Aut aut” y “Nuova Corrente”. Como testimonio de su carrera política, nunca extinguida ni desinflada, es diputado en el parlamento italiano desde 1976 hasta el 1983. En 1983 es nombraod Profesor Asociado de Estética y en el 1985 Porf. Ordinario de la misma asignatura en la Universidad de Venecia. Durante los años ochenta se intensifica su producción ensayística: comienza a escribir en la conocida revista de arquitectura “Casabella” (con la que todavía colabora), funda la revista de filosofía “Il Centauro” (1981-1986) y “Laboratorio politico” (1981-1985), publica ensayos; “Politica ed economia”, “Esodo” y “Micromega”. Numerosos y trabajados son tambien los libros de éste período: Crucialità del tempo: saggi sulla concezione nietzscheana del tempo, et al, Liguori, 1980; Dallo Steinhof, Adelphi, 1980 (nuova edizione 2005); Adolf Loos e il suo angelo, Electa, 1981; Il potere : saggi di filosofia sociale e politica, con G. Penzo, Roma, Città Nuova, 1985; Icone della legge, Adelphi, 1985 (nueva edición 2002); Zeit ohne Kronos, Ritter Verlag, Klagenfurt, 1986; Angelo necessario, Adelphi, 1986 (nuova edizione 1992); Drama y duelo, Tecnos, Madrid, 1989; Le forme del fare, con M. Donà y R. Gasparotti, Liguori, 1989. En 1990 publica su obra teórica más importante, “Dell’inizio”, en Adelphi (reed. en 2001), que consolida definitivamente su posición como uno de los filósofos más importantes de Italia , y que todavía hoy es considerada una contribución al pensamiento imprescindible e insuperable. En éste trabajo Cacciari da inicio a la sistematización de su propia filosofía que, a través de estudios profundizados en ámbitos teológicos, literarios, políticos, económicos y artísticos, encontrará en el libro titulado “Della cosa ultima” (Adelphi-2004), su perfecto complemento – en sintonía con el dicho Schellinguiano para el que “un sistema se ha completado cuando es reconducido a su punto de partida” . Aún de los años noventa son: Dran, Méridiens de la décision dans la pensée contemporaine, Ediotions de L’Eclat, 1992; Architecture and Nihilism, Yale University Press, 1993; Desde Nietzsche: Tiempo, Arte, Politica, Biblios, Buenos Aires, 1994; Geofilosofia dell’Europa, Adelphi, 1994 (nuova edizione 2003); Großstadt, Baukunst, Nihilismus, Ritter, Klagenfurt, 1995; Migranten, Merve, Berlino, 1995; Arcipelago, Adelphi, 1997; Emilio Vedova. Arbitrii luce, Catalogo della mostra, Skira, 1998. En 1990 funda, junto a Umberto Curi, Sergio Givone, Carlo Sini, Vincenzo Vitiello y Giacomo Marramao, la revista de filosofía “Paradosso” (1990-2002). Desde 1993 hasta el año 2000 ha sido alcalde de Venecia y diputado europeo; en 1999 le fue concedido el premio Hannah Arendt de Filosofía Política. Desde el 2000 hasta hoy ja publicado los siguientes libros:Arte, tragedia, tecnica, con M. Donà. Raffaello Cortina, 2000; Duemilauno. Politica e futuro, Feltrinelli, 2001; Wohnen. Denken. Essays über Baukunst im Zeitalter der völligen Mobilmachung, Ritter Verlag, Klagenfurt und Wien, 2002; Della cosa ultima, Adelphi, 2004; La città (conferenza), Pazzini, 2004; Il dolore dell’altro. Una lettura dell’Ecuba di Euripide e del libro di Giobbe (conferenza), Saletta dell’Uva, 2004; Magis Amicus Leopardi, Saletta dell’Uva, 2005. En el verano de 2004 instituye en Milán un Centro de formación Política (www.formazionepolitica.org) con el que colaboran personalidades conocidas como Alberto Abruzzese, Aldo Bonomi, Gad Lerner, Salvatore Natoli, Michele Salvati. En más de treinta años de apasionada actividad filosófica y política, imparte cursos y conferencias en todas las sedes importantes del debate filosófico europeo; ve traducidos sus libros a las principales lenguas europeas, algunos también al japonés y otros publicados exclusivamente en el exterior; recibió en 2002 el premio de la Academia de Darmstadt por la difusión de la cultura alemana en el extranjero y , siempre en ése mismo año, funda la Facultad de Filosofía de la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán, en la cuál es profesor de Estética. Estrecho colaborador del Instituto Italiano de estudios filosóficos de Nápoles y del Collège de Philosophie de París, recibió en 2005 la medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y desde Abril del mismo año es Alcalde de Venecia en su tercera legislatura como tal. [NdT.: Algunos libros publicados en Castellano de Massimo Cacciari son:
Paraíso y naufragio.Musil y el hombre sin atributos,ABADA 2005
Soledad Acogedora, Abada 2005
Desde Nietzsche , Biblos, 1994
El Angel Necesario , La Balsa de la Medusa,1989
El Dios que baila, Paidos, Buenos Aires, 2000
Drama y duelo, Tecnos, 1989
Krisis , SigloXXI , 1982
Diálogo sobre la solidaridad, Herder, 1997
Hombres póstumos, Península, 1989 ]
La búsqueda filosófica de Cacciari toma impulso desde el estudio del “pensamiento negativo”, anti-dialéctico, entre Schopenhauer y Nietzsche, del cual analiza las conexiones con la cultura literaria, artística y científica de principios del siglo XX, deteniendose en particular en la “finis Austriae”. En concreto, la profundización de Nietzsche y Heidegger lo han llevado a una reconsideración de la entera historia de la metafísica y del mismo paradigma interpretativo heideggeriano. En sus últimos trabajos, la problemática filosófica se entrecruza con la teológica, siguiendo una línea que se podría definir de revisitación crítica de la tradición platónica. Parafraseando a Heidegger, su problema podría ser sintetizado así: ¿ qué significa “pensar”, en una época en la que la filosofía aparece definitivamente especializada en ámbitos particulares? ¿ Se da un “inicio” del pensar, en el sentido de que el pensar pueda asumir justamente el “inicio” como su problema? La historia filosófico-teológica europea centrada en la noción de “Deus-Esse” como “principio” es interpelada por el autor a la luz de ésta pregunta. Dell’inizio declara ya en el título la voluntad de dirigir la mirada a aquel “comenzar” que es el problema del pensamiento filosófico (cada otro saber presupone el “objeto” desde el que comienza). A esta tranquila extemporaneidad del poner sin vacilaciones -y sin la necesidad de darse justificaciones- el problema de siempre de la filosofía, corresponde una novedad perentoria en la articulación de la forma, que se compone sutilmente de los tres modos de la escritura filosófica: el diálogo (es decir la ironía, la búsqueda) –el tratado (luego la sistematicidad) — el “parergon” (esto es, la fragmentación aforística, el “Dios en los detalles” ). De estos trazos surge de modo evidente una cierta, pretendida, arcaicidad de la arquitectura formal, que implica en sí, pese a no declararla, una vis polémica contra cada discurso filosófico resignado a la inercia y convencido de que ésta última sea también la medicina más razonable. Aquí, al contrario, no se rehuye el reconocer que , si el pensamiento filosófico debe existir, no puede ser sino reproponiendose perennemente las preguntas del Parménides platónico. Es ésta la “tarea del pensar”, aquello que Hegel llamaba “el trabajo del concepto”. Dell’inizio sinembargo quiere proponerse aquella tarea ya no en términos dialécticos (como en la dialéctica de la esencia de Hegel), sino ni siquiera en aquellos de su presunta superación (en cada especie de überwindung). Sucede así que cierta “filosofía negativa” es conducida por una línea de tipo muy diferente, es decir a una “cierta” descendencia platónica: Proclo- Damasceno- Escoto Eriúgena- Eckhart – De Cusa -Schelling. Produciendose así, como ya éstos nombres indican, un fascinante cross-over entre filosofía y teología, obigadas finalmente a confundir de nuevo sus aguas, de las cuales emergerá en las paginas de ésta obra una doble herejía. En Della cosa ultima, como cierre del sistema de Cacciari, el interrogante de fondo es: “¿qué es lo que alcanza en última instancia el alma, después de haberse abierto, a través de la angustia, a la búsqueda de sí?”. Tres voces en diálogo entre ellas y con sus Maggiori Loro (sus mayores) , de Platón a Husserl, intentan responder a tal pregunta, cada una siguiendo su propio “demonio de la guarda”: la voz portadora de un radical escepticismo del intelecto, la voz que encarna el acto de fe en lucha contra sí mismo y la del autor, que se dirige a los amigos también a travñes de una larga serie de cartas, retomando y desarrollando las ideas de su obra teórica más importante: Dell’inizio. De hecho, después de haber investigado, en Geofilosofia dell’Europa y en Arcipelago, la irreductible pluralidad de las raíces culturales presentes en el paisaje europeo, la atención de Cacciari vuelve a dirigirse hacia aquel “comenzar” que es el “problema” filosófico fundamental. La “Cosa última”, por consiguiente, no es más que el Principio; aquí sin embargo no es ya sencillamente entendido como conjunto indiferente de todas las posibilidades , sino como “la infinitud” misma de la cosa en su inalienable e indeclinable singularidad. Solo alcanzando la “Cosa última”, tocando la esencia divina, el alma expresa su propia y única posible libertad. Y el hacer filosofía se manifiesta entonces por lo que siempre y aún otra vez más debe ser: movimiento de liberación.
FRIEDRICH MEINECKE

A cura di Enrico Gori
Friedrich Meinecke nacque a Salzwedel, libera città anseatica della Sassonia-Anhalt, nel 1862, figlio di un impiegato delle poste. Studiò germanistica, storia e filosofia a Berlino e Bonn, avendo tra i docenti anche Droysen, von Sybel, von Treitschke e Bresslau. Nel 1886 conseguì il dottorato discutendo con Reinhold Koser la tesi sui rapporti di Stralenburg e la questione della successione del 1609 in Jülich. Impiegato nel 1887 nell’archivio statale prussiano, nel 1896 Meinecke sottopose a von Sybel la sua tesi post-dottorale a Berlino. Nel 1893 fu editore, e dal 1896 pubblicista dell’Historischer Zeitschrift. Nel 1901 gli fu offerta un posto a Strasburgo, e dal 1906 tenne cattedra a Friburgo. Mentre inizialmente Meinecke aveva seguito le orme dei suoi maestri, come nella sua opera biografica in due volumi sul riformatore dell’esercito von Boyen [1771-1848], apparsa nel 1896/99, le sue ricerche successive denotano una maggior indipendenza dal metodo di von Sybel e degli altri storici, come si vede nel suo La borghesia mondiale e lo stato nazionale. Studi sulla genesi dello Stato nazionale tedesco, pubblicato nel 1907. L’opera rappresentava la storia dello Stato tedesco dal periodo prussiano di riforma all’era di Bismarck come un rapido sviluppo in cui il cancelliere di ferro diede corpo e impersonò il concetto di “Stato nazionale”. La notorietà fu assicurata, e Meinecke divenne, con Dilthey e Troeltsch, uno dei fondatori della storia intellettuale politica. Nel 1914, a 52 anni, entrò nell’ateneo berlinese Federico Guglielmo, dove insegnò fino al 1932, quando si ritirò, a 69 anni. Temperamento originale, era sostenitore della storia politica intellettuale, e in politica un repubblicano per ragioni pratiche nella Repubblica di Weimar. La sua permanenza nell’Università di Berlino si distingue per il gran numero di allievi che Meinecke seguì, di cui molti divennero personalità importanti. Ma più che il suo ruolo accademico, gli interessi di Meinecke riguardavano la sua posizione politica: morendo nel 1954, egli fu “il solo storico tedesco della sua generazione ad aver vissuto i cambiamenti intercorsi tra il 1914 ed il 1945 e 1948/49 e ad averli discussi pubblicamente” (Ernst Schulin). Dopo la morte, fu spesso chiamato in causa come esempio del ruolo dello storico in Germania dall’Impero al nazionalsocialismo. Oltre alla sua capacità – rara tra gli storici – di mutare opinione, diventando così un coerente repubblicano da fermo monarchico qual era, è da segnalare la continuità delle sue idee liberali. Nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra, da lui inizialmente salutata con entusiasmo, Meinecke ottenne una cattedra a Berlino. Egli era uno dei pochi docenti che sosteneva la necessità di una pace negoziata e riforme interne. Con queste idee, continuava la sua attività, iniziata nel 1910, di commentatore storico-politico con Naumann, Weber e Troeltsch, promovendo una rinascita del liberalismo inserito nello Stato sociale. Solo così si poteva, a suo avviso, giungere alla totale unità della nazione. Questo lo portò ad appoggiare la Repubblica di Weimar nel 1918, malgrado la riprovazione del suo stesso circolo; “non per solo prematuro amore per la repubblica, ma per motivi legati al buonsenso e all’amor patrio”. Nel 1924 pubblicò la sua seconda opera più importante per capire la Storia intellettuale: Il concetto di “ragion di Stato” nella storia moderna, su etica e Realpolitik da Machiavelli ai suoi giorni. Meinecke contestava qui la politica di potere portata avanti a partire dal 1848 dagli storici politici nazional-liberali, con un appello alla ragione di Stato contro il pericolo di una politica di potere rigorosa. Dopo essersi ritirato per ragioni di età nel 1932, nel 1934, a causa dell’avvento del nazismo perse il posto di membro della Historiche Reichskommission, che ricopriva dal 1928, e nel 1935 si dimise da pubblicista dell’Historischer Zeitschrift. Anche se in apparenza era un accademico in pensione di scarsa rilevanza, Meinecke continuò a pubblicare le sue opere, come L’origine dello storicismo del 1936, in cui metteva in discussione regole e principi fondamentali della storiografia e del pensiero storico. Nel 1946, a 84 anni, pubblicò la sua grande opera La catastrofe tedesca, in cui tentava di spiegare, con l’ausilio della storia intellettuale collettiva, la vicenda tedesca a partire dal XIX secolo. Ma soprattutto, la pretesa di ritornare all’idealismo dell’età di Goethe fu soggetta a critiche e talvolta a derisione, poiché la si intendeva come un sintomo dell’incapacità degli intellettuali borghesi di confrontarsi con il recente passato nazista. Nel 1948 Meinecke, simbolo dell’altra Germania, fu eletto rettore onorario della Libera Università di Berlino; nel 1951 si chiamò con il suo nome il dipartimento di Storia dell’ateneo. Questo perché prima del 1945, Meinecke era un’eccezione nella sua professione. Ma già alla fine degli anni ’50, in prospettiva di un “conformismo costituzionale a Bonn” (Stefan Meinecke), la sua luce cominciò ad offuscarsi. A partire dalla fine degli anni ’60 fu condannato dalla DDR a causa delle sue posizioni “reazionarie”, mentre la Repubblica Federale lo giudicò positivamente, legittimando così il suo approccio metodico alla storia politica intellettuale. Rinasceva contemporaneamente l’interesse per la storia intellettuale, grazie ai suoi allievi emigrati negli Stati Uniti, che gli riconobbero, indirettamente, il merito di aver spianato la via. Contemporanea anche la rivalutazione delle sue vedute politiche e accademiche, cui hanno contribuito i recenti dibattiti sul ruolo degli storici nel periodo nazista, epoca che il Professore Emerito passò senza cadute di sorta. Il Meinecke può così essere preso a esempio di come, grazie all’elasticità delle proprie idee, la coscienza storica sia criterio di valutazione per le generazioni successive di studiosi. Qualche considerazione ulteriore merita l’analisi meineckiana dello storicismo, racchiusa nell’Origine dello storicismo: Meinecke denota l’opera come un tentativo di correggere l’accezione negativa che il termine ha assunto, a detrimento dei progressi di questo atteggiamento culturale nella storia intellettuale. L’opera fa parte della trilogia composta dalla Borghesia mondiale e lo Stato nazionale e L’idea di ragion di Stato nella Storia moderna, che rappresenta l’eredità di Meinecke in quanto storico intellettuale tedesco più celebre della prima metà del XX secolo. L’origine dello storicismo porta avanti il progetto delineato dai primi due libri; La borghesia mondiale e lo Stato nazionale prende in esame due fenomeni: le origini del nazionalismo e l’unificazione della Germania sotto Bismarck; infine, L’idea di ragion di Stato nella Storia moderna si occupa del secondo tema, l’unità tedesca, discutendo l’origine della ragion di Stato e della Realpolitik nella Storia moderna. L’origine dello storicismo esplora la problematiche legate allo Stato nazionale prendendo le mosse dalla nuova, secondo Meinecke, concezione di Storia affermatasi tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, che ha rivoluzionato il modo di intendere e rapportarsi alla stessa. Il frutto della ricerca è l’applicazione dei principi che governano la vita, da Leibniz alla morte di Goethe. Meinecke faceva risalire l’origine dello storicismo al collasso dei sistemi filosofici legati al giusnaturalismo. Con il proprio caratteristico approccio genetico, lo storicismo promuoveva il crollo, o meglio, lo sfondamento di quelle che Meinecke definiva le “pastoie del pensiero storico” dai suoi inizi. Meinecke confessa che il suo metodo necessita una vista a volo d’uccello, che gli permetta di sorvolare determinate cime, sebbene auspichi che i suoi lettori possano scorgere anche altre sommità e magari intere vallate, affermazione, questa, di eccessiva modestia. Si può non condividere le sue posizioni, ma gli va riconosciuto un importante livello di pensiero e analisi. La chiave della rivoluzione del pensiero storico è, per Meinecke, nella commistione di due idee: l’importanza dell’individuo e la nozione di sviluppo, che insieme hanno allentato la morsa in cui il giusnaturalismo costringeva il pensiero storico, poiché l’idea di legge naturale non considera l’individuo. Malgrado le pretese dell’Illuminismo di promuovere l’individuo e i suoi diritti, Meinecke sosteneva che l’idea illuminista dello stesso fosse statica. La filosofia illuminista generalizzava la nozione di essere umano, che voleva provvisto di una sola immutabile essenza valida per tutti i luoghi e tempi; la ragione è posta al di sopra di ogni altra facoltà, e ciò che non è razionale viene scartato o superato.
FRIEDRICH POLLOCK

A cura di Giacomo Grasso
Vita e opere
Friedrich Pollock nacque a Freiburg im Breisgau nel 1894. Apparteneva alla ricca borghesia ebraica della città: il padre, “estremamente autoritario e tendenzialmente antisemita”, era titolare di una ditta e si era ‘assimilato’ da tempo convertendosi al protestantesimo. La sua famiglia si trasferì nel 1911 a Stoccarda, e lì si instaurò il forte legame che lo tenne legato a Horkheimer: si è spesso data molta rilevanza al rapporto fra i due, in particolare in riferimento alla comune “sensibilità per l’ingiustizia sociale e la nostalgia per un mondo altro da quello in cui crebbero e vennero educati”. Allo scopo di mantenere questa amicizia stilarono un ‘contratto’ che venne poi aggiornato diverse volte lungo il corso della loro vita, nonostante fossero caratterialmente molto diversi, e uno di questi costituì i Materialen zur Neuformulierung von Gründsätzen del 1935. Pollock assunse ben presto un ruolo relativamente subordinato ad Horkheimer e, pur risultandogli tale posizione talvolta scomoda o fastidiosa, non cercò mai di cambiarla.
È del ’23 la sua tesi di laurea sulla teoria del denaro in Marx, che sancisce il punto di arrivo di un corso di studi incentrato sull’economia politica e integrato con corsi paralleli di filosofia. Proprio in quegli anni intanto, si vengono creando i presupposti per la fondazione dell’Institut für Sozialforschung, e quella che nel ’22 era stata una semplice settimana di studio sul marxismo, la Erste Marxistische Arbeitwoche, divenne un’istituzione il 3 febbraio 1923 grazie ai finanziamenti di Felix Weil.
Il discorso inaugurale tenuto nel 1924 da Grünberg, probabilmente primo professore universitario apertamente marxista in Austria e Germania, è un primo passo nell’approccio al nostro autore, che fu suo assistente insieme a Henryk Groβmann in quei primi anni: esso volse a stabilire, sostenendo il carattere non collegiale della sua direzione, le linee essenziali del metodo scientifico e della Weltanschauung alla base degli studi, evitando così che la pluralità di visioni conducesse all’estraniazione di alcuni singoli collaboratori o a cattivi compromessi, mettendo a rischio l’identità stessa dell’Istituto. Non si trattava più, come nel caso del Grünberg-Archiv, di un “informale scambio di idee” ma di una “reale comunanza nella ricerca”: l’orizzonte teoretico è il materialismo storico marxiano, il metodo la dialettica.
L’ottimismo del direttore era evidente nella sua relazione iniziale. Se ad alcuni sembrava di vedere nella crisi non solo “le macerie del loro mondo, ma le macerie del mondo in genere”, in realtà si trattava “dell’esaurirsi di ciò che è nato, si è sviluppato ed è giunto a maturazione in maniera storicamente condizionata e che appunto perciò deve scomparire”. In base all’esperienza storica infatti, egli era “scientificamente e fermamente convinto” della transitorietà della situazione attuale e dell’inevitabile sbocco nel socialismo in base allo sviluppo dialettico della realtà storica. Scientificità voleva dire, per Grünberg, osservazione del processo storico e delineamento delle leggi come “ultime cause concepibili di questo processo di rivolgimento”, indipendentemente dai presupposti ideologici della ricerca stessa.
Il metodo infatti non doveva essere invalidato dalla visione del mondo, ma il problema dell’obiettività della conoscenza non fu mai preso troppo in considerazione. Era probabilmente fin troppo chiara la difficoltà di isolare la ricerca dai diversi ‘valori’ dell’interesse pratico, e ciò valeva a maggior ragione per le correnti socialiste. Così la Weltanschauung marxiana avrebbe dovuto necessariamente essere alla base di ogni ricerca senza però vincolarla nei risultati: se da un lato dunque, “jeder wird durch seine Weltanschauung geleitet” (Grünberg 1924, 12), dall’altro lato era forte il richiamo all’autocontrollo allo scopo di porre dei limiti alle influenze esterne.
Il principio di ricerca è l’interpretazione del marxismo come scienza sociale empirica, sicuramente un elemento importante verso la Soziaforschung horkheimeriana, eterodosso rispetto al classico ‘Diamat’ e una risposta forte all’ortodossia kautskiana: sotto questa prima direzione, venne evitata ogni tematica filosofica teorica propria del marxismo, così come ogni approfondimento di questioni epistemologiche. Si stabilirono sei ambiti di ricerca: materialismo storico e fondamenti filosofici del marxismo, economia politica, problemi dell’organizzazione economica di una società socialista, condizione della classe operaia nel passato e nel presente, e storia delle dottrine e dei partiti socialisti. Questa molteplicità dei temi d’indagine gioca a favore dell’ apertura di vedute della ricerca di quel primo periodo e a sfavore di quelle accuse di dogmatismo che hanno portato spesso a considerare l’Istituto una sorta di “cittadella marxista”, ermeticamente isolata, omogenea e intollerante all’interno. Importante ricordare che fu curata in quegli anni, per la prima volta, l’edizione delle opere complete di Marx ed Engels con l’aiuto di Rjazanov. Nel 1928 Grünberg dovette abbandonare la sua funzione per motivi di salute, e nel ’30 Horkheimer assunse definitivamente il ruolo di direttore.
All’interno di questo ricco panorama si inserisce la «Sombarst Widerlegung» des Marxismus, come confutazione de Der proletarische Sozialismus (Marxismus) del 1924 in cui l’autore declassava la dialettica materialistica, colonna della ‘metafisica della storia’ marxista (Sombart 1924 I,28), a semplice visione del mondo sovrapposta alla realtà, in grado solo di impedirne un’indagine e una verifica empirica. A ciò Pollock replica definendo e riconoscendo la dialettica come perpetuo movimento della realtà, un continuo trapassare di tutto nel proprio contrario, e soprattutto come il metodo per rendere scientificamente feconda tale assunzione di fondo. Secondo C.Campani, la risposta risulta in parte incompleta in quanto non affronta il problema del rapporto tra ‘schema ‘ e costituzione dell’oggetto e tra Weltanschauung e metodo; e il rimando ai risultati concreti della ricerca non è in grado di risolvere, insomma, il problema epistemologico. Nonostante ciò, è proprio il metodo di Sombart a rilevare le carenze maggiori. Egli ha infatti adottato il metodo della Wesenschauung – sul modello di Scheler-, che vuole essere una immediata ‘visione d’essenza’ della realtà delle cose, mentre invece, in questo modo, si svincola da qualsiasi possibile verifica empirica. Basterebbe infatti sostenere l’incapacità dell’interlocutore critico di vedere l’‘idea’alla base della realtà, per smorzare ogni obiezione. Si tratta di un approccio il cui potenziale analitico è pressoché nullo, e che Pollock definì aprioristico, dogmatico e assolutamente non scientifico poiché deduttivo.
Una critica allo stesso modo di impostare l’analisi del reale si ripropone nel ’32, anno in cui Horkheimer compila uno dei suoi primi saggi introduttivi alla “teoria critica”: in Osservazioni sulla scienza e la crisi infatti, trova spazio un aperto attacco ai tentativi ‘metafisici’ – Husserl, Scheler – che avevano identificato la realtà concreta con la vita anziché con la società viva, isolando l’uomo e ipostatizzandolo, minimizzando allo stesso tempo l’importanza dei processi sociali. L’errore era stato chiaramente nel metodo eidetico. “Sorse così un’antropologia filosofica fiera della sua indipendenza che assolutizzò, nell’uomo, alcuni caratteri, e all’intelligenza critica venne contrapposta l’intuizione libera dalla coazione di criteri scientifici, sicura del proprio sguardo geniale”.
Diventa dunque essenziale un ritorno alla dottrina dello stesso Marx per capire come in realtà esista una vera e propria solidità e continuità epistemologica all’interno dell’Istituto: Pollock e gli altri intellettuali non aggiungeranno molto all’originale, che viene conservato e applicato nella sua integrità da molti di loro. Marx nel Capitale afferma: “ogni scienza sarebbe superflua se l’essenza delle cose e la loro forma fenomenica strettamente coincidessero”. Ed è infatti importante vedere, in particolare nell’Introduzione a Per la critica dell’economia politica del 1857, come l’autore stesso ci sveli l’inganno del ‘concreto’ come oggetto immediato di ricerca: nell’avvicinarsi ad esso, si scopre che questa realtà non è nient’altro che una semplificazione del reale stesso. In esso si danno infatti una molteplicità di concetti astratti sempre più sottili fino a raggiungere determinazioni elementari, considerate le quali “si tratterebbe di (compiere) un nuovo il viaggio all’indietro” verso il reale, pervenendo ad una chiara comprensione dello stesso. Qui l’astrazione non è assolutamente un ricorrere all’universale indifferente al particolare, ma un processo d’analisi del concreto e il suo dissolvimento nelle sue determinazioni specifiche astratte – cioè non immediatamente evidenti alla percezione. “Per la prima via (quella dell’economia politica), la rappresentazione piena viene volatizzata ad astratta determinazione; per la seconda (quella giusta), le determinazioni astratte conducono alla riproduzione del concreto nel cammino del pensiero […]. Il metodo di salire dall’astratto al concreto (quindi) è solo il modo in cui il pensiero si appropria il concreto, lo riproduce come spiritualmente concreto. Ma mai e poi mai il processo di formazione del concreto stesso”.
La stessa cosa vale per l’Isolierungsmethode, per definire il quale Henryk Groβmann, punto di riferimento imprescindibile per Pollock e per l’Istituto di Ricerca Sociale in quei primi anni, si rifà concretamente all’ortodossia: il “concreto è troppo complesso per venire immediatamente conosciuto”, perciò si deve preporre ad esso uno studio dei presupposti semplificanti propri dell’oggetto, che intermedino tra noi e il suo nucleo strutturale. L’uso degli schemi di riproduzione come punto di partenza dell’analisi permette dunque di rappresentarsi la struttura a fondamento di un fenomeno o processo storico, un tratteggiarsi della situazione che viene inizialmente riconosciuto dall’autore come “presupposto fittizio” e provvisorio; ma “ad ogni presupposto semplificante appartiene una correzione successiva che prende in considerazione gli elementi della realtà empirica”.
Tutti i fenomeni e i problemi vengono trattati così con due diversi criteri: prima separati dalla situazione che li caratterizza, definiti e spiegati con schemi astratti e non direttamente verificati, solo successivamente in rapporto alla realtà concreta. E questo doppio rapporto con il concreto spiegherebbe, oltretutto, la contraddizione che venne messa in luce da Böhm-Bawerk nel 1896 tra il I e il III libro del Capitale: non si tratterebbe assolutamente di una contraddizione teorica insolubile, bensì di un diverso criterio di analisi e di approccio al reale che avrebbe portato a due ‘risultati’ diversi.
Nel 1933, in piena sintonia con questo metodo, Pollock scrive: “questo saggio riporta delle riflessioni che sono sorte dalle discussioni scientifiche e dallo studio dei fatti e di una parte della letteratura teorica divenuta poco chiara per gli stessi specialisti, e che dovrebbero servire a inquadrare alcuni di questi enigmatici fenomeni in un contesto intelligibile”. L’oggetto è la struttura fondamentale di queste crisi, di ciò che non è casuale ma intimamente legato e assolutamente determinante, senza però perdersi o ridursi a concetti economici puri. Questo schema servirà da “filo conduttore nel labirinto dei fatti e delle opinioni”.
In questo contesto, si inserisce Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion, compilato da Pollock nella seconda metà degli anni ’20 con l’aiuto di D. Rjasanow. Egli ha modo di studiare sul campo teoria e prassi dell’economia pianificata sovietica per alcuni mesi ed entrare in contatto con dirigenti ed esperti ex-menscevichi o non iscritti al partito, impostando il lavoro in modo maggiormente oggettivo, notevole esempio di realgeschichtliche Betractung dello spirito grünberghiano. Lo scopo è quello di identificare elementi che possano contestare le accuse di inefficienza opposte dai teorici non socialisti, e fornire concetti su un argomento che non era ancora stato affrontato sufficientemente. Lo studio della realtà sovietica chiarì le lacune teoriche e pratiche: innanzitutto, mancava un meccanismo che orientasse e regolasse il mercato indicando i possibili obiettivi e costi; poi, venne meno il profitto aziendale e ciò condusse al ristagno economico, spingendo così l’ideologia marxista dell’altruismo nella glorificazione del lavoro e del ‘sacrificio’. Ma tutto ciò rafforzò la consapevolezza della difficoltà dell’esperimento, ma non ne smorzò l’entusiasmo.
La teoria del valore
Pollock pubblicò Die markschen Geldtheorie nel 1928 nel Grünberg Archiv.: il testo costituì inizialmente la tesi di laurea scritta nel 1923, poi rivista e riadattata allo scopo di chiarificare i termini epistemologici essenziali del pensiero marxiano che erano stati travisati e mal interpretati nell’omonima opera compilata da H. Block nel 1926. È il primo passo del sistema teorico che si può riassumere nei tre momenti teorici di valore, crisi e pianificazione; ossia comprensione del sistema di mercato, analisi degli antagonismi interni che in qualche modo ne minano la stabilità, e infine formulazione di una soluzione possibile in grado di supplire a queste mancanze. L’analisi finale del nazionalsocialismo del 1941, è il riconoscimento della fallibilità della nuova proposta.
In questo testo è riconosciuto il ruolo centrale che la dottrina del denaro gioca all’interno del sistema marxiano e, preso atto della sua sostanziale incompletezza, diventa un’occasione per l’autore di affrontare in maniera concisa anche il rapporto essenza – fenomeno, fondamentale nel discorso più ampio sulla possibilità e sul metodo si un’analisi che si voglia dire scientifica.
“Il punto di partenza è costituito naturalmente dagli individui che vivono in società…,vale a dire dalla produzione socialmente determinata”: l’individualismo rappresenta un non-senso, un momento inspiegabile di un processo storico che tende alla socializzazione. Solo nel XVIII° secolo, ossia nella società borghese, i rapporti sociali si presentano al singolo come strumenti per assolvere ai propri fini privati, ossia “come una necessità esteriore”. Così come Marx, Pollock concentra l’attenzione sull’elemento sociale dei rapporti di produzione: “ all’insieme dei rapporti sociali degli uomini spetta una funzione, il cui esercizio costituisce il presupposto di tutti gli altri atti sociali: la produzione e riproduzione della vita reale”. Dunque, alla base dell’apparente ‘lotta per l’esistenza’ che il pensiero economico già postulava da tempo e che appare ovvia ad un primo approccio alla società odierna, è possibile riconoscere un sistema di reciproca dipendenza dei produttori -consumatori, occultata da norme giuridiche che all’opposto garantiscono fenomeni di concorrenza e di libero mercato improntati sull’autonomia dei produttori e la privatizzazione dei mezzi di produzione. Ed è appunto su questa rappresentazione fenomenica che insiste sul carattere oggettivo e a-storico delle categorie dell’analisi economica la quale, evitando quello studio penetrante del processo sociale di produzione capitalistico, non riesce a vedere, oltre la divisione sociale del lavoro, la sostanziale identità dei diversi soggetti e della loro prestazione.
Se questa è la struttura sociale, e se i rapporti tra individui diventano “rapporti di cose tra persone e rapporti sociali tra cose”, il valore di scambio a suo fondamento, risulta essenziale per capire la possibilità stessa di una comunità. Pollock riprende brevemente il discorso sul feticismo della merce, ma per l’autore, il problema del valore di scambio risulta essenziale non solo a livello sociale, bensì anche in chiave più strettamente economica: se esso infatti si presenta come forma fenomenica della merce, quindi puramente sociale e qualitativamente indifferente, il suo essere equivalente universale tende da un lato a nascondere quella peculiarità propria d’ogni oggetto che è il valore d’uso, ma dall’altro permette di sistematizzare e organizzare qualsiasi forma di commercio tra produttori.
I presupposti teorici da cui l’analisi pollockiana prende le mosse sono la proprietà privata dei mezzi di produzione e l’autonomia dei produttori: si è detto che il primo motore di tutto è il bisogno di conservazione della vita materiale della società, e che il modo di produzione capitalista separa e pone in antagonismo il fabbisogno sociale e la produzione, interessata solo alla valorizzazione del capitale e quindi fine a se stessa, senza un diretto interesse al consumo. Il produttore così isolato, non è in grado “né, in linea generale, di influenzare, né addirittura di considerare nei particolari l’intero processo sociale di scambio”, e giunge a conoscere il valore di scambio del suo manufatto solo nel momento stesso della compravendita: ecco che si pone dunque il problema dell’interpretazione del concetto marxiano di lavoro socialmente necessario, per il quale il valore non incarna neanche più il numero di ore lavorative impiegate per produrlo singolarmente, ma giunge a rappresentare una porzione della produzione totale scambiata. Nel mercato esso assume la forma del denaro.
Dunque, “solo quando il tempo di lavoro socialmente necessario regola lo scambio di merci, una società di produttori di merci è vitale”, cioè solo nell’equilibrio produzione-consumo essa è in grado di sopravvivere; ma nel sistema attuale “questa regolazione non avviene per via razionale” (72). Ecco il carattere anarchico ed sostanzialmente disordinato del capitalismo, ed ecco anche la necessità non solo di cogliere il valore-denaro come equivalente universale, ma di interpretarlo considerando che “la sua essenza diviene accessibile solo a chi l’abbia colto come rapporto di produzione” (71). É ben vero e fondamentale il suo ruolo nella commensurabilità del valore di tutte le merci, “una necessità, dunque, che s’impone alla società come costrizione tecnica esteriore”; ma ciò che risulta nascosto ma risolutivo in questa rilettura pollockiana, è l’attenzione alla funzione regolativa che il concetto di lavoro socialmente necessario e la sua incarnazione nella forma denaro riveste nel mettere in relazione la produzione e il Bedürfniss sociale.
Marx infatti non riconosce alcun ruolo al meccanismo della domanda e dell’offerta, e rifacendosi all’identità dialettica di termini apparentemente antitetici afferma: “vendita e compera sono un atto identico come relazione reciproca fra due persone polarmente opposte, possessore di merce e possessore di denaro”. Solo se la merce è ritenuta inutile dal mercato, per cui non viene convertita in denaro, non si realizza subito nello scambio e mette in moto un processo si squilibrio sociale di produzione, da cui ha origine la crisi come sproporzione, ossia come non realizzazione dialettica dello scambio. È allora il calcolo del valore delle singole merci, stabilito mediante la quantità di ore di lavoro necessario alla produzione di tutte le merci scambiate diviso il numero delle stesse, a regolare ed equilibrare produttore e consumatore.
Avendo così posto le basi del discorso, la critica di Pollock si concentra su alcuni punti essenziali fraintesi da H. Block nel suo saggio. In particolare, egli riconosce una doppia valenza al concetto di lavoro socialmente necessario, come lavoro tecnicamente medio e come lavoro necessario ad assolvere le esigenze della società, ma non potendo esprimere queste ultime in ore lavorative, prende in considerazione la “grandezza oggettivamente fissa, determinata dai mezzi finanziari di cui la domanda dispone” (76), ossia la quantità di denaro disponibile alla domanda aggregata. Ne scaturisce una teoria quantitativa della moneta, fortemente avversa dallo stesso Marx, per il quale invece la somma del denaro circolante corrisponderebbe alla somma dei prezzi delle merci – e non viceversa. Allo stesso modo, si verrebbe portati a considerare il valore come effetto delle dinamiche concorrenziali interne al mercato, rischiando così di dover “introdurre elementi soggettivistici nella teoria oggettivistica del valore”(77).
Il testo è molto schematico e riassuntivo, e in mancanza del testo blockiano risulta difficile ricostruire interamente i punti criticati. Ma ciò che ci interessa è il fatto che Pollock abbia ristabilito, rimanendo inscindibilmente legato alla dottrina originaria, le caratteristiche essenziali del mercato. Così, la moneta-oro ha un valore stabilito che è inerente alla sua produzione in quanto merce, la velocità di circolazione media è data, e non è essa a determinare il livello dei prezzi, ma corrisponde alla somma del valore di tutte le merci. E benché la discussione verta su diversi punti dettagliatamente, un fattore sembra essenziale alla nostra trattazione, e cioè la centralità del concetto di lavoro socialmente necessario, e di conseguenza del valore, come elemento flessibile e variabile dipendente, in grado di regolare, determinandosi ogni volta nuovamente al momento dello scambio, l’intreccio di produzione e consumo e l’incontro di innumerevoli produttori ignari di tutto: insomma, come un meccanismo del mercato.
L’economia come ‘Hilfwissenschaft’
Nello stesso testo, Pollock rimprovera anche a Block di distinguere “ un modo di vedere da ‘filosofia sociale’ e uno da ‘teoria economica’”, ossia di separare teoria e prassi, attribuendo alla scienza economica specializzata un’autonomia e una validità esenti da problematiche sociali. In questo modo, anticipa alcune conclusioni che Horkheimer trarrà solo successivamente in Bemerkungen über Wissenschaft und Krise e che verranno riprese nella formulazione del metodo. Il problema economico è innanzitutto un problema della scienza economica, ed infatti esso ricompare in ogni suo saggio, a dimostrare sia la stretta dipendenza delle seppur diverse discipline, sia l’influenza diretta che l’economista ebbe nei confronti dell’amico, soprattutto nel primo periodo dell’Istituto.
Infatti, nel 1931 Horkheimer assume l’incarico di direttore e sancisce con la sua Antrittsvorlesung il nuovo metodo di ricerca -definito da Habermas un materialismo interdisciplinare-, e la lunga serie di saggi comparsi sulla rivista dell’istituto mirarono a strutturare nelle sue linee essenziali il carattere della teoria critica come metodo di ricerca sociale, ricercando quella fondazione dei principi assolutamente estranea al discorso grünberghiano. E in questo metodo, critica sociale, economica ed epistemologica si diramano nei loro ambiti specifici per poi riconoscersi come facce della stessa medaglia, trovando un denominatore comune sia nell’oggetto che nel soggetto dell’indagine, entrambi mutevoli in quanto momenti storici.
Horkheimer risolve innanzitutto il problema dell’oggetto: “le contraddizioni tra le parti della teoria prese per sé non risultano quindi, poniamo, da errori o definizioni trascurate, bensì dal fatto che la teoria ha un oggetto che muta storicamente ma, nonostante tutte le lacerazioni, rimane uno”.
Dall’altro lato invece, si pone la questione del soggetto – e quindi dell’identità dell’Istituto-, che si articola nel suo rapporto problematico con il tempo e con il suo oggetto, cioè la società. Il discorso viene affrontato in Materialismo e Metafisica del 1933, in cui la contraddizione della scienza borghese è ricondotta alle incertezze e ai dubbi che la soluzione kantiana al problema gnoseologico lascia irrisolti. Infatti, se in Kant il tempo viene ricondotto e ridotto a categoria a priori ineliminabile della conoscenza umana limitata e finita, e quindi assolutamente soggettiva, ciò avviene per liberare l’oggetto da qualsiasi forma di divenire e decretare così la possibilità della scienza. Il rapporto soggetto-oggetto viene appositamente descritto con l’immagine di due grandezze costanti, perfettamente chiarite sul piano concettuale, che si muovono l’una verso l’altra senza entrare però in un rapporto strettamente dialettico, il che vorrebbe anche dire un modificarsi dello stesso soggetto nei confronti del suo aliud, e di conseguenza una sempre meno possibile scientificità.
Ciò che Horkheimer vuole dunque dimostrare e spiegare, è l’infondatezza della concezione lineare della conoscenza kantiana e dell’idea di un costante avvicinamento progressivo della scienza alla natura in grado di mantenere inalterati i due estremi. Kant parla a proposito di un’attività supraindividuale (l’io penso), di cui il singolo individuo empirico è inconsapevole, “nella forma idealistica di una coscienza in sé, cioè di un’istanza puramente spirituale”; un’apologia, insomma, alla concezione borghese dell’io che vede il soggetto riconosciuto da una necessità logica e autonoma, assolutamente indipendente dalla situazione storica e sociale che lo circonda..
Paradossalmente fu proprio Hegel a invalidare questa visione statica della conoscenza con il metodo della dialettica. Egli forgiò lo strumento idoneo a far sì che il materialismo prendesse coscienza della tensione, in perenne trasformazione eppure insuperabile, tra il proprio pensiero e la realtà. E il passaggio fondamentale del metodo dialettico dalla metafisica al reale (Feuerbach, Marx e Engels) avvenne in base ad un “bisogno di critica”, e permise anche di chiarire in che misura il soggetto venisse determinato o influenzato dall’oggetto, ossia dalla sua situazione sociale. Va sottolineato che questa reciproca influenza riguarda anche lo studio dei fenomeni naturali, apparentemente esonerato dalle dinamiche sociali, per affrontare i quali è necessaria “la consapevolezza che sia questa descrizione che le categorie in essa impiegate sono connesse con il lavoro e con l’indirizzo di interessi degli uomini”.
Le critiche rivolte alle altre dottrine diventano allo stesso tempo dei problemi da affrontare e superare con un nuovo impianto gnoseologico. È questa l’esigenza che induce Horkheimer a recuperare il materialismo, liberandolo dalle diverse critiche che lo rimproverano di sostenere semplicisticamente la realtà della sola materia (F.A.Lange) e di ridurre i processi psicologici stessi a mero fenomeno della stessa. In opposizione a qualsiasi metafisica deduttiva nel metodo e normativa nell’azione, il materialismo mira a formulare principi induttivamente conclusivi “che contengono l’estratto più generale e più vuoto delle loro esperienze, e in nessun caso una norma per la loro azione…”, diventando così un sistema “dove la tesi è tanto poco determinante ai fini delle decisioni relative ai contenuti, che ad esempio alcuni influenti materialisti dell’illuminismo, primo fra tutti Diderot, poterono per tutta la vita essere incerti rispetto a questi oggetti generali, senza che per questo il carattere della loro presa di posizione pratica ne fosse in qualche modo modificato”. L’autore mette perciò in risalto il carattere dubitativo e perciò stesso critico della dottrina: il materialismo è “non solo quella dubbia enunciazione sulla totalità del reale, ma tutta una serie di idee e di modi di comportamento pratici”, estraneo ad ogni altra metafisica e nella sua variante realistica dello spiritualismo o dell’esistenzialismo.
Questa fu la posizione di Horkheimer nel 1933, ripresa e sostanzialmente mantenuta fino agli anni ’40. Bisogna ora chiarire il rapporto fra scienza, economia e società, che lo stesso Pollock contribuì a sviluppare, pur non affrontando direttamente l’argomento in nessuno dei suoi testi.
I. In Osservazioni sulla scienza e la crisi, il problema viene posto nei seguenti termini. È un dato di fatto lo smarrimento della scienza, e questa situazione ha origine nella separazione e allontanamento di teoria e prassi, dove la prima degenera in costruzioni filosofiche che non tengono conto del procedere delle scienze empiriche,dei loro risultati e problemi, e la seconda si dissolve nel “caos della superspecializzazione” orientata da interessi esterni che, sembrano inalienabili ad ogni ricerca.
È chiaro infatti che la scienza, in generale, collabora come forza produttiva al processo della vita sociale. “Si tratta di una fecondità immanente ad essa”, e non cioè di una semplice “gnoseologia pragmatica” ossia attenta e orientata da interessi esterni; ma oggi questo è trascurato. La crisi che si sta vivendo in questo momento non è data dall’eccessiva razionalizzazione all’interno delle scienze, ma dalla restrizione del principio razionale al suo puro ambito di ricerca, come conseguenza dell’atteggiamento prettamente meccanicistico degli studi, scevro d’ogni preoccupazione extrascientifica che impedisce di inserire e inquadrare l’analisi specifica all’interno di un discorso più generale. Il metodo scientifico, che inizialmente aveva avuto un ruolo di emancipazione dai vincoli della mentalità dogmatica scolastica, diventa quindi oggi un limite che porta ad eternizzare il presente limitandosi a registrare e classificare la realtà, rimanendo indifferente all’essenziale, ossia al divenire storico-sociale e allo stretto rapporto dialettico, benché inconsapevole, tra i due elementi della ricerca, il soggetto e l’oggetto. Si instaura cioè un “metodo orientato sull’essere e non sul divenire, il cui procedimento imperniato sulla registrazione di ciò che è ripetutamente presente, proprio della vecchia scienza naturale, non riesce affatto a rendere conto (della struttura dinamica della realtà sociale)”.
II. E in particolare, e con ciò arriviamo al punto nodale della nostra trattazione, nella generale crisi economica si rivela l’incapacità dell’ economia politica di adempiere alla sua funzione, ossia di organizzare adeguatamente le consistenti risorse sia conoscitive che tecniche al fine di soddisfare i bisogni della società. Per quanto infatti essa si riveli molto efficace in rapporto agli scopi che essa stessa si è posta –valorizzazione del capitale-, non lo è nel momento in cui viene inserita all’interno Weltanschauung più universale. Horkheimer coglie due contraddizioni essenziali. “Da un lato ( per la scienza economica) vale il principio che ciascuno dei suoi passi deve avere un fondamento gnoseologico, ma il passo più importante, e cioè la determinazione stessa dei suoi compiti, manca di fondazione teorica e sembra abbandonata all’arbitrio. In secondo luogo, la scienza ha a che fare con la conoscenza di ampie connessioni; ma la grande connessione da cui dipende al propria esistenza e la direzione del proprio lavoro, e cioè la società, essa non è in grado di comprenderla nella sua vita reale”.
Così dunque, la contraddittorietà del reale economico viene colta nella contrapposizione tra monopolio e mercato anarchico, tra l’adeguamento dei mezzi al fine weberiano e il disordine caotico del laissez-faire, ossia come tensione irresolubile tra particolare razionale e universale irrazionale. Quest’inadeguatezza epistemologica a cogliere il tutto equivale, caeteris paribus, all’incapacità di organizzare la totalità dell’economia di mercato, che invece viene abbandonata al suo destino disegnato un’improbabile mano invisibile. Quando Pollock sostituirà il meccanismo di mercato con un controllo diretto di un apposito ufficio, avrà in mente proprio questo ideale utopico della razionalizzazione universale horkheimeriano.
III. Rimane il problema alla base dello scritto del ’37, ossia quali siano le aspirazioni più giuste e più vere in grado disorientare la ricerca, e ciò risulta essere basilare in quanto non è assolutamente possibile affrontare alcuni temi, in particolare quelli sociali, rimanendo imparziali. Così anche la stessa teoria critica non si esime dall’influenza della situazione presente, e il problema degli interessi e dei valori che devono stare alla base della stessa viene risolto con una forte presa di posizione ‘politica’, “sulla cui verità occorre decidere non con una riflessione apparentemente neutrale, ma ancora una volta agendo e pensando, appunto nell’attività storica concreta”.
Anzi, la stessa neutralità è un concetto illusorio: essa consiste semplicemente in un’autoconoscenza astratta da ogni legame con il reale, strettamente connessa con l’idea di un ego definito concentrato in un solo punto (Cartesio e Kant), tipico del pensiero borghese. Se per Durkheim la classificazione degli eventi sociali sulla base di inventari empirici completi è impossibile, la soluzione non sta nello “scegliere dei tratti particolarmente essenziali”. Anche la teoria critica comincia con delle determinazioni astatte ma “ il rapporto delle prime connessioni concettuali con il mondo dei fatti non è essenzialmente quello di generi ed esemplari…, e l’introduzione di tali determinazioni (elementi specifici)…, non ha luogo per semplice deduzione come nella teoria specialistica chiusa in se stessa”.
Se la centralità della ricerca consiste nella ricostruzione e comprensione del presente storico, il problema della situazione economica e della rispettiva scienza si pone in tutta la sua gravità: gli accenni a tale argomento sono sparsi negli scritti dei primi anni ’30 in rapporto a diversi problemi più o meno teorici. Così nel ’32 egli scrive che “non dobbiamo dimenticare che la situazione economica degli uomini agisce fin nelle fibre più profonde e sottili della loro vita psicologica”: una presa di posizione è inevitabile.
La situazione attuale del capitalismo
I riferimenti alle statistiche dell’Insitut für Konjunkturforschung a cui Pollock accenna all’inizio del saggio del 1932 non sono casuali, e l’illogicità strutturale del sistema di produzione oramai in recessione appare evidente: il crollo della fiducia conduce alla tesaurizzazione dei crediti e al crollo degli investimenti, ma ciò che colpisce e interessa sono sia “l’immane dispersione delle forze produttive materiali e umane e l’annientamento di una parte dei prodotti”, sia la “quantità di valori economici che si sarebbero potuti produrre con i mezzi attualmente disponibili” (87). Pollock denominò ‘metodo di Procuste’ il processo di distruzione di capitali e delle materie prime, evidenziandone l’aspetto tragico. La crisi da sovrapproduzione quindi, si presenta come il paradosso della società moderna, e “la stridente contraddizione tra l’impoverimento di strati sempre più larghi e la mancanza di mezzi per la stessa soluzione dei più urgenti problemi di civilizzazione dall’una parte, e le possibilità tecniche prodotte dal rivoluzionamento dei metodi produttivi impiegati nell’economia agricola e dai progressi dirompenti nella produttività del lavoro industriale dall’altra, costringono vastissimi strati a riflettere sull’opportunità dell’ordinamento economico capitalistico”(87)
Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung, scritto nel ’32 e pubblicato solo nel ’36, anticipa i temi essenziali del sistema teorico, dove però il discorso del piano rimane ancora in via di sviluppo. Nonostante il metodo fosse ancora quello grünberghiano dell’analisi empirica classica, sorse una forte polemica con Groβmann, che concludeva il suo saggio dichiarando l’ineluttabilità della crisi in base alla teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto, prendendo quindi le mosse dall’analisi esegetica del testo del capitale e limitandosi ad esso. Quest’opera si colloca infatti storicamente al di qua della crisi economica e delle colossali trasformazioni economiche e sociali.
La critica di Pollock si avvia nel considerare due insiemi di cause: innanzitutto quelle d’ordine politico, quindi le perturbazioni della divisione internazionale del lavoro, l’inquietudine politica in seguito al primo conflitto mondiale e la sfiducia nel sistema internazionale di credito, a cui si aggiungono fattori di perturbazione economica dovuti allo sviluppo tecnico della produzione agricola. Ma nel metodo di astrazione e considerazione dell’essenziale, sono le trasformazioni strutturali a interessarci maggiormente, in primis la formazioni di grandi imprese in ambito più prettamente industriale cui fa seguito la centralizzazione delle funzioni di commercio e di organizzazione del capitale (bancarie). E l’ineluttabilità delle leggi marxiane è messa in discussione da queste varianti.
La crescita delle unità industriali conferisce all’economia di mercato quel ‘discusso’ carattere di irrigidimento costitutivo in antitesi al declamato ‘libero gioco delle forze’ del laissez-faire: il sostituirsi di grossi monopoli al sistema di concorrenza perfetta e la politica doganale diventano gli strumenti principali della politica dei prezzi. D’altra parte, la concentrazione della produzione in pochi soggetti economici ne aumenta considerevolmente l’importanza al livello nazionale, sì da diventare centro dell’attenzione d’ogni agire politico: il potere statale non può più rinunciare ad essi, corrobora la sua ingerenza in ambito produttivo e limita le libertà imprenditoriali a scopo protettivo. La politica di sconto della banca d’emissione centrale (91) non è più sufficiente.
La tendenza all’isolamento, la fine della divisione internazionale del lavoro e il conseguente restringimento del mercato in seguito alle leggi protezionistiche conosceranno un’ulteriore approfondimento e sviluppo nei saggi del’33.
Difficilmente sarà possibile tornare alla situazione pre-bellica. Contrariamente alle teorie armonizzanti che tendono a ridurre le diverse crisi a elementi di frizione, l’equilibro capitalistico ha sempre conosciuto, sin dal suo esistere, la possibilità di rotture a intervalli rivolte a ristabilire sproporzioni, risolvendole “così come per secoli la lotta contro le epidemie non fu possibile in altro modo che con l’isolamento di malati, che venivano abbandonati al loro destino” (94). Ancora una volta alla base di tutto sussistono i rapporti di produzione: “l’automatismo capitalistico produce un adattamento tendenziale della produzione alla domanda capace di pagare, mentre il vero problema è di rendere possibile una copertura migliore e più adeguata dl fabbisogno effettivo” (Ivi.). Il cerchio si chiude quindi intorno alla teoria del valore e alla possibilità reale che questa legge ha nella sistematizzazione dei rapporti essenzialmente disordinati dei produttori.
L’economia è cambiata, processi di ‘decapitalizzazione’ sono in corso, crollano i prezzi delle materie prime seguiti dai valori dei terreni. Sembrano essere a portata di mano tutti i presupposti per una ripresa, ma manca la ‘messa in moto’ da questa paralisi, e i programmi di intervento dei diversi governi sembrano essere le uniche possibilità d’avvio: molti considerano urgente la sostituzione del sistema economico, ma solamente la razionalizzazione totale, ossia non limitata a interventi parziali, convince l’autore (96).
I contributi teorici citati (Lorwin) richiamano all’analisi terminologica: “intendiamo con il termine economia di piano un sistema economico in cui produzione e distribuzione sono regolate centralmente mediante una pianificazione sociale”: il discorso di Hilferding sulla costituzione di un ‘cartello generale’ che permetta il mantenimento delle strutture essenziali del mercato quali la proprietà privata dei mezzi di produzione accordata con proprietà pubbliche e cooperativistiche –società per azioni-, è alla base di un progetto di un’economia di piano capitalistica, come attuabilità del principio di democrazia economica. Questa tesi verrà fortemente avversa da Pollock, che insisterà sempre di più sulla necessità di eliminare i diversi gruppi di interesse, legati in misura crescente al potere politico: “la mentalità da ingegnere deve essere trasferita dalla singola fabbrica all’economia complessiva”, in modo da aggiungere l’optimum di rendimento (98): ciò che nella fase liberale dell’economia costituiva un punto d’arrivo refrattario alla sopravvivenza stessa del sistema, la fine della libera concorrenza, finisce per essere anello di congiunzione imprescindibile nel passaggio alla fase successiva. Così funzionano l’economia di guerra, l’organizzazione dell’industria elettrica e carbonifera e l’istituzione di strutture (ex: Reconstuction Finance Corporation) creditizie al servizio di interventi regolatori.
Le grandi fabbriche e i mezzi tecnico- amministrativi, che permetterebbero un controllo maggiore del fabbisogno sociale, sono presupposti già dati nelle condizioni attuali dell’economia: gli avversari della pianificazione si raccolgono intorno a tre principali obiezioni, “fino a quando non si sarà arrivati alla verifica della prassi”(101).
I. incalcolabilità dei costi, minore produttività – legata alla distruzione del mercato e delle sue funzioni-, indisposizione agli innovamenti, mantenimento dello status quo.
II. venir meno dell’aspirazione al profitto.
III. mancanza di principi alla base della pianificazione.
Citando diverse fonti, Pollock nega l’impossibilità di conciliare mercato e piano, riconoscendo anzi al secondo il vantaggio di poter determinare a piacimento i prezzi del mercato al fine di determinare i costi , e di poter calcolare meglio questi ultimi con un calcolo ‘economico-naturale’, senza l’utilizzo di prezzi fittizi.
La seconda obiezione viene invece considerata un semplice psicologismo. Anzi, la gestione collegiale e pubblica sottrae ai singoli soggetti e demandata agli organi sociali, occupati alla gestione degli investimenti anche in ambito di ricerca, e considerando che “l’attività inventrice è già oggi largamente razionalizzata negli istituti tecnico-scientifici aziendali e statali, si può parlare quasi di un’ininterrotta produzione di invenzioni” (104). Questo stesso problema è affrontato da Horkheimer nello stesso periodo: in Storia e psicologia (1932), questo considerare l’utile personale come un qualcosa di psicologicamente essenziale ed inalienabile dell’uomo è aspramente criticato dall’autore, per il quale l’egoismo economico è semplicemente, così come ogni altra realtà sociale, un elemento “storicamente condizionato e suscettibile di trasformazione radicale”. Si tratta di uno psicologismo razionalistico, che ha poi determinato l’economia politica liberalistica. È dunque errato, nella discussione sulla possibilità di un ordinamento economico non individualistico, ricorrere ad argomenti pro o contro questo presupposto problematico per la psicologia moderna stessa. Gli individui potrebbero essere soggetti a impulsi di altro tipo, vedi per esempio la solidarietà come principio di accettazione del dolore e della morte – così per l’autoconservazione, gli impulsi sessuali, etc…
Contro l’ultima obiezione, viene messa in luce la principale opposizione tra centralizzazione decisionale e decentralizzazione produttiva: “le nostre obiezioni non si rivolgono alla conservazione dell’organizzazione di mercato in un’economia di transizione, bensì alla concezione per cui, in linea di principio, solo il mercato potrebbe consentire quei calcoli sui quali dovrebbe orientarsi una razionale politica economica”(105). Contro quindi la libera formazione dei prezzi, (Lorwin e Heimann), e il loro conseguente utilizzo come “puri e semplici mezzi di compensazione”( Ivi.).
Le ultime considerazioni si preoccupano solamente di ovviare a problemi in sé complessi, ma ritenuti non rilevanti o pienamente risolti da altri autori, così come il la questione della libertà di consumo e della possibilità di una pianificazione in un solo paese. L’idea di una pianificazione parziale viene osteggiata, così come la proposta di mantenere gli attuali rapporti di proprietà. In quest’ultimo caso, i proprietari sarebbero ridotti a semplici rentiers, per cui il piano non potrebbe essere tollerato da questi: “in nessun ordinamento sociale è stato possibile mantenere per lungo tempo la pura e semplice percezione di rendite a spese della società senza una concreta contropartita” (108). Riparleremo di ciò in seguito.
Autarchia e pianificazione
Se la crisi interna portò alla convinzione di una riorganizzazione razionale della sfera della produzione e distribuzione, la contrazione del mercato internazionale sembrò implicarne una caduta strutturale: il partito degli autarchisti, Sombart e il Tat-kreis ne dedussero la necessità di “annunciare la fine dell’industrialismo e di propugnare un’autarchia agraria”. Uno dei fattori resi noti, consiste nell’espansione territoriale del sistema industriale promossa dal protezionismo, cui seguirebbe la regressione del sistema di divisione internazionale del lavoro tra i paesi fornitori di materie prime e quelli manifatturieri (110). Pollock riprende tre questioni essenziali:
I. Diminuzione della capacità di importazione dei paesi di recente sviluppo capitalistico e ristagno della produttività nei paesi esportatori di materie prime: questi non sono più in grado offrire nessuna contropartita alle importazioni industriali non potendo allo stesso tempo esportare materiali e sviluppare una propria produzione, e cioè “sviluppare su base agraria due sistemi industriali, quello proprio e quello europeo”(111).
II. Tendenza alla regressione demografica, cioè l’inaridimento della fonte dell’esportazione del capitale.
III. Diminuzione dell’esportazione dei prodotti agricoli verso le aree industriali, in riferimento alle tesi di R. Luxemburg e Sternberg.
Il ripiegamento sul mercato interno risulta perciò inevitabile, visto some esito sicuro del crescente interventismo statale: consapevoli però dell’impossibilità della completa autosufficienza, si impone innanzitutto una classificazione delle singole importazioni in base a criteri economici, morali o politici (Diete). Le diverse obiezioni, in riferimento al rischio continuo di crisi (Döblin) e all’inevitabile abbassamento del tenore di vita, vengono eluse a favore della Weltanschauung autartica. Sostituendo perciò una regolamentazione cosciente al posto del decorso meccanico (114), si giungerebbe ad una sorta di ‘pianificazione’ ove la coercizione sostituirebbe la libertà del singolo: così in ambito mondiale si passerebbe ad un “immediato processo di reciproco scambio delle merci…, operante sulla base di contratti a percentuale e di privilegiamenti”(115). Dati questi presupposti teorici, risulta inevitabile instaurare un parallelo tra Autarkie e Planwirtschaft, le cui reciproche implicazioni materiali e pratiche ricondotte al denominatore comune della razionalizzazione e del controllo.
La posizione di Pollock tende al contrario, a tenere separati i due momenti: la lettura della situazione economica attuale in chiave più ottimistica, gli permette di intravedere le condizioni sufficienti alla ripresa. Nelle aree neocapitaliste si riscontra lo sviluppo di apparati industriali nella sfera dei consumi svincolata dalla grande domanda interna di mezzi di produzione, legata alla produzione agricola e mineraria destinata all’esportazione: in seguito anche all’aumento delle importazioni di questi paesi – contro la prognosi basata sulla legge del calo di redditività del suolo (119)-, non sembrano esserci dubbi sulla sicura crescita del mercato mondiale.
É fuori discussione la centralità dello sviluppo industriale e tecnico-agrario nei paesi esportatori di materie prime e lo schiacciante inserimento di questi in alcuni rami di produzione: alla base del ridimensionato assorbimento dei mercati esteri sussiste una crisi industriale e soprattutto agraria, legata allo sviluppo delle tecniche e alla capitalizzazione del settore (120). “Finché i paesi agricoli sono rimasti in una condizione di dipendenza passiva dalla congiunzione economica costituivano, esportando le merci richieste nei paesi più colpiti dalla crisi, la sede naturale cui ricorrere per mitigare e, in parte, superare la depressione”( Ivi.).Il loro coinvolgimento all’interno della crisi, e l’esserne essi stessi la fonte, contribuisce a aumentarne la durata e l’intensità: ne seguirono le diverse misure protezionistiche, la sospensione dei crediti e il conseguente abbandono della parità monetaria da parte dei paesi debitori e la riattivazione della bilancia commerciale (121).
La possibilità di un’economia autarchica sono rilevabili quindi, da un lato nelle zone oltreoceano in fase di costruzione ex novo del capitalismo e nei paesi dittatoriali allo scopo di proteggere le esigue strutture nazionali (Italia, Polonia, Ungheria), dall’altro solo nelle aree europee di coltivazione di frumento (Germania), dove però la diagnosi storica evidenzia la necessità di protezione dei prezzi. Infine, le argomentazioni sulla maggiore resistenza bellica, vengono smentite dalle politiche di Bismark e Caprivi i quali riconobbero l’insufficienza del settore agricolo nei finanziamenti volti ad incrementare le spese militari.
La critica pollockiana, pur mantenendosi a livello astratto, convince sull’autonomia dei due momenti economici: “solo la crisi degli ultimi anni, caratterizzata da una forte fluttuazione dei prezzi sul mercato mondiale, ha reso più volte inservibile la protezione doganale, imponendo l’adozione di una regolamentazione di tipo diretto del commercio con l’estero”(126). Di conseguenza la disciplina della produzione e distribuzione interna, gestita dallo stato e da monopoli, non esente da perturbazioni di breve e di lunga durata (USA). Nel testo, vengono successivamente ripresi e riproposti alcuni temi gia presenti in scritti precedenti: il calo inevitabile della produttività, l’inefficienza di un piano parziale perché nocivo ai rami non ancora regolati, l’adeguamento refrattario alla condizioni di mercato dei settori sovvenzionati e l’utilizzo dei fondi per compensare le perdite a scapito degli investimenti a lunga scadenza, considerando il fatto che là dove i prezzi vengono mantenuti più alti la brama di profitto condurrebbe all’aumento della produzione e al sovraccarico dell’offerta aggregata.
Pollock torna infine a discutere sulla necessità di un ‘Ufficio di pianificazione’, e sull’impossibilità della gestione di un sistema produttivo su base privata. La conclusione del saggio riconsidera i punti essenziali, tra cui la necessità d’un piano totale e non parziale, di un controllo del progresso tecnico [G1]e di una razionalizzazione del capitale senza l’impiego di metodi di politica doganale, ritenuto ormai inadeguato nel caso di un controllo collettivo e sociale del commerci.
Osservazioni sulla crisi economica
Bemerkungen zur Wirtschaftskrise viene pubblicato nello stesso numero della Zeitschrift für Sozialforschung nel 1933: molti temi sono ripresi, ma l’attenzione ruota intorno a fattori di ordine sociale, in sintonia con gli assunti di base. “Questo saggio riporta riflessioni…, che dovrebbero servire a inquadrare alcuni di questi enigmatici fenomeni in un contesto intelligibile. Esso tende a spiegare la struttura fondamentale di queste crisi a partire dal conflitto tra forze produttive e rapporti di produzione, che si esprime nella contraddizione tra le illimitate possibilità tecnico-economiche e il limitato – e tendenzialmente sempre più arduamente realizzabile- scopo della valorizzazione del capitale” (135). Forse le intenzioni superano i mezzi, ma il bisogno di affrontare certi argomenti “fa avvertire il mero carattere probabilistico … come il male minore di fronte all’ignoramus della rassegnazione” (Ivi.).
In primis si tratta di disconoscere la validità delle teorie ‘esogene’, e il metodo adottato impone il riconoscimento delle regolarità delle crisi come di un qualcosa di intrinseco all’oggetto stesso: si tratta ormai del ‘tipico meccanismo’- limitazione produttiva, ristagnamento delle vendite…- di ‘depurazione’ delle ‘disproporzioni’ che avviene mediante la svalutazione o l’annientamento fisico dei prodotti. Le bancarotte entrano in circolo vizioso con le vendite forzate e l’abbassamento dei prezzi, i quali scendono al di sotto del valore al quale la produzione possa essere ancora considerabile redditizia. Pollock rievoca la crisi del 1873 conclusasi solo nel 1879, riconoscendone le affinità con quella attuale, e confuta la ‘teoria delle onde lunghe’ (139). Due cause ‘occasionali’ vengono prese in esame:
I. la guerra innanzitutto, la quale ha aumentato la capacità produttiva dei diversi paesi, distruggendo la divisione internazionale del lavoro, e portando scompiglio nei rapporti internazionali di credito a causa delle riparazioni belliche e ai debiti, rendendo difficile ogni tentativo volto a ristabilire dell’equilibrio (140). Nel clima di insicurezza internazionale, ogni intervento governativo rischia di essere ogni volta un motivo per nuove tensioni politiche. A peggiorare la situazione convengono la scarsa elasticità delle grandi unità industriali e il rituro dei capitali dalla circolazione e la formazione di giacimenti auriferi “del tutto anacronistici”.
II. la crisi agraria, provocata direttamente dal rivoluzionamento delle tecniche agricole d’oltreoceano e le ormai ovvie conseguenze.
Sarebbe però errato considerare questi fattori estranei al sistema; sarebbe probabilmente possibile dimostrare l’ineluttabilità di questi presupposti della crisi a partire dalle condizioni economiche e sociali dell’attuale sistema di produzione.
Una citazione apologetica del sistema di libera concorrenza di A. Salter, consente a Pollock di ritornare sul problema della fine della fase liberale del sistema economico, e dei suoi cambiamenti strutturali. In primo luogo sta l’incapacità delle grandi unità economiche di “resistere entro ampi margini all’anonimo diktat dei prezzi… senza subire gravi perdite. “È noto il ruolo disastroso che i ‘costi fissi’ giocano nelle grandi fabbriche…” (145). Il solo strumento di politica congiunturale di cui il liberismo dispone, la ‘vite di sconto’, risulta impotente di fronte ai grandi capitali. A ciò fa riscontro la politica d’appoggio finanziario da parte dello stato, che impedisce alla crisi di riequilibrare le sproporzioni createsi a causa della sempre maggiore difficoltà degli spostamenti di capitale da un settore all’altro e la messa in circolazione di nuovi crediti. In secondo luogo, allo sviluppo produttivo non ha fatto seguito un’altrettanto ampia evoluzione del mercato e della distribuzione: allo stesso modo crolla il monopolio europeo e statunitense nella produzione e diffusione delle merci industriali – prodotti tessili, orologi …. Appare difficile il ripristino del vecchio modello di mercato.
A quattro anni dall’inizio della crisi sembra possibile intravedere i presupposti di una possibile ripresa. Il ‘risanamento’, prende le mosse dalla “revisione fondamentale del rapporto creditore-debitore” – svalutazione dei debiti mediante inflazione (USA) o cancellazione aperta e parziale senza dichiarazione di bancarotta (Germania)-, ruotando intorno al nodo centrale costituito dal governo forte. Solo se il risanamento interno d’ogni paese è stato portato a termine, può avere luogo una stabilizzazione del corso di cambio, attuabile nell’interesse degli stessi stati.
La sovrabbondanza di capitale monetario attualmente disponibile, con il ripristino della stabilità monetaria e della fiducia negli investimenti, dovrebbe cessare di essere fonte prima della depressione economica e orientarsi verso altre realtà economiche e continenti (Luxemburg). Importanti sono l’allargamento del mercato, e la ‘valorisation des colonies’, con lo Stato a ruolo di garante e con i nuovi paesi pronti ad assorbire i nuovi capitali. Inevitabile sarà anche la razionalizzazione produttiva e la riorganizzazione delle tecniche delle singole economie rurali.
Viene quindi riproposto il tema della ‘accensione iniziale’ non più casuale ma artificiale, che richiama all’ “assegnazione di molti lavori pubblici, aumento dei prezzi con politica monetaria e creditizia per la liberazione dei mercati dalle riserve che li ribassano, l’aumento dei salari e la combinazione con altri provvedimenti”. I punti di riferimento sono ovviamente tutte le riforme politiche dell’epoca, in particolare il New Deal roosveltiano: incoraggiamento delle fusioni, politica creditizia orientata in senso congiunturale e sicura nel controllo degli investimenti. E solo all’interno di questa situazione, Pollock rivaluta l’isolamento e l’autosufficienza economica. Rimane problematica l’efficacia e la durata di tali sistemi.
Pollock concentra ora l’attenzione sulla situazione sociale, dove è evidente una violenza prima d’ora sconosciuta del conflitto fra forze produttive e rapporti di produzione: “qualitativamente nulla di nuovo”, siamo cioè di fronte alla classica incapacità di un sistema economico di mettere al servizio di tutti le proprie potenzialità; è invece quantitativamente che si evidenzia con tutta la sua gravità la tensione sociale. Da un lato dunque, sussiste la possibilità di un aumento della pressione della classe lavoratrice (Groβmann), dall’altro lato invece il processo di adattamento prende avvio attraverso “una riduzione violenta delle forza produttive e con un ampliamento dei confini nei quali esse vengono costrette” , o “piuttosto un conflitto ricorrente, tra la crescita delle capacità tecnico-organizzative da un lato,e le esigenze di dominio e di autovalorizzazione del capitale”. Perciò si svilupperebbero contemporaneamente il ‘metodo di Procuste’, “una lotta spietata contro le forze produttive che tendono a travalicarlo” (Ivi.), e il progressivo adeguamento dei rapporti di produzione alle mutate circostanze.
Pollock è molto attento all’idea dello spreco: il fatto che oggi si considerino le ingenti perdite produttive, ossia la chiusura delle fabbriche e la distruzione di macchine, come semplici ‘frizioni’ di sistema così come il disutilizzo della forza-lavoro sottoforma di operai, è uno dei punti di critica e di forza del principio organizzativo del piano. Anzi, lo sviluppo tecnico potrebbe condurre allo stesso modo alla riduzione del tempo di lavoro – per ora solo ‘tecnicamente possibile’- e all’elevazione culturale degli operai, e creare alcuni presupposti per la riorganizzazione della società: i lavoratori stanno apprendendo la capacità tecnica e d’amministrazione, la disciplina e senso di responsabilità, che potrebbero condurre ad un miglioramento delle sue condizioni. La stessa cosa vale anche per l’istruzione sempre più diffusa. Ma questi sviluppi vengono ostacolati dalla “propaganda del vangelo della vita dura e, screditando … l’educazione scolastica e il diritto all’autogestione e alle organizzazioni autonome”, impediscono l’organizzazione pianificata della vita sociale sulla base di un’economia diretta in modo consapevole.
Il secondo processo invece si sviluppa attraverso forme di proprietà cooperativa o collettiva: le società per azioni, come detto, vagheggiavano quell’ideale di controllo democratico della produzione sperato da Hilferding. Benché poco concorde con questa visione ottimistica dei possibili sviluppi, l’autore considera inizialmente l’azionismo come un freno al rafforzamento smisurato dei proprietari, ma con la scissione tra proprietà e attività dispositiva (imprenditoriale), lo stesso principio si ripropone come centralizzazione del ‘controllo’, senza possibilità di veto da parte dei proprietari sparsi qua e là. Trusts e cartelli, secondo una “possibilità prevalentemente teorica”, possono condurre ad un impiego maggiormente razionale delle attuali forze produttive evitando errori d’investimento, classici dell’ignorare le esigenze del mercato: ma la realtà attuale dei monopoli è ancora lontana da questi risultati. L’antieconomicità della libera concorrenza viene superata nei rami nazionalizzati della produzione – sistema delle comunicazioni e allo stesso tempo viene fortemente limitata la libertà imprenditoriale . A questo consolidamento delle grandi unità mira la politica roosveltiana, e il coordinamento mediante una ‘centrale statale’ ci conduce al punto estremo dello sviluppo degli attuali rapporti di produzione. I contrasti tra gruppi di interesse oppone una forte resistenza ad un possibile accordo tra categorie diverse e si pone la questione, che rimane aperta, sulla garanzia ai due fondamenti presupposti, ossia la proprietà privata e la valorizzazione del capitale. Il dubbio sulla possibilità di conservare della prima è sempre più concreto.
Capitalismo di Stato
A partire dal 1934, il numero degli articoli di analisi economica comparsi sulla Zeitschrift für Sozialforschung tende a decrescere, e prende piede una vera e propria divisione del lavoro tra i diversi autori. In particolare, Kurt Mandelbaum e Gehrard Meyer si occuparono principalmente di rispondere alle critiche mosse partendo da “un’articolata teoria dell’economia di piano” cercando di fornire una rappresentazione ‘positiva’ degli obiettivi socialisti, mentre Pollock preferì continuare lo studio del sistema attuale e delle tendenze che avrebbero condotto al suo concetto di piano. Ciò nonostante si crearono all’interno del gruppo delle divergenze riguardo alla possibilità di uno sviluppo graduale della situazione in grado di prescindere da un forte rivoluzionamento dei rapporti di produzione: i saggi dei primi due autori rimasero comunque in secondo piano, tanto che lo stesso Horkheimer li definì un “lavoro teorico preliminare” che avrebbe dovuto lasciare spazio alla verifica nella realtà e nella prassi.
A ciò si aggiunsero elementi di dissidio personale all’interno della scuola, così per esempio tra il direttore, E.Fromm e Pollock stesso. Quest’ultimo smise anche di pubblicare sulla rivista e fino al 1941 non comparvero che brevi recensioni: Campani spiega questa lunga pausa ricorrendo al ruolo amministrativo che sarebbe diventato fonte di grande apprensione per l’autore e ne avrebbe consumato gran parte delle energie. Probabilmente ci si era convinti del carattere esauriente delle diverse analisi già compiute, ma indipendentemente dalle diverse possibili spiegazioni, comparvero nei primi anni ’40 due saggi che fecero molto discutere.
Nel decimo numero della rivista di teoria critica compare infatti nel 1941 uno degli ultimi contributi pollockiani sull’attuabilità di un’economia di piano, alla fine di uno sviluppo ormai giunto al momento di trarre delle conclusioni: ritengo fondamentale questo testo, non tanto per i punti definitivamente chiariti, cioè sul detto, ma per ciò che in esso non viene detto.
Il discorso prende le mosse dall’inevitabile dissolvimento del libero mercato e dell’iniziativa il più possibile svincolata da regole alcune. Ogni possibile ritorno ad esso è sforzo inutile, e si pone l’urgenza di analizzare quello che può essere l’esito di questo processo – “la forma totalitaria del capitalismo di stato è una minaccia mortale per tutti i valori della civiltà occidentale”– per evitarne la realizzazione.
L’analisi rievoca metodologicamente Weber: se infatti non si può affermare l’esistenza effettiva dell’oggetto in questione, è possibile costruirne un modello (199) rifacendosi alle esperienze europee ed americana e considerandole come momenti di una fase di transizione. Il rapporto fra la situazione attuale e quella descritta non appare necessario, ma questo approccio ne facilita l’indagine. Quattro i punti essenziali definiscono il capitalismo di stato:
I. esso è successore del capitalismo privato,
II. il mercato è spogliato delle sue funzioni di controllo, scompaiono le leggi economiche e la scienza economica stessa,
III. lo stato detiene alcune importanti funzioni, per cui il controllo diretto per regolamentare ed espandere la produzione e per coordinarla ai consumi: primo obiettivo è lo sfruttamento pieno di tutte le risorse,
IV. esso può assurgere a) come strumento di potere nella forma totalitaria di un nuovo gruppo dirigente, nato dal coagulo dei più forti soggetti industriali e finanziari, insieme a burocrati statali, militari o legati al partito vittorioso, oppure b) nella sua democratica, in cui lo stato mantiene la sua funzione di controllo ma deve sottostare a sua volta alla supervisione del popolo.
“Nessun provvedimento, all’infuori della riorganizzazione globale del sistema economico, può salvare le strutture sociali dalla disintegrazione”.Tre sono i gruppi di funzioni essenziali di coordinamento:
I.definizione dei bisogni della società in termini di beni di consumo, strutture e materie prime,
II. organizzazione delle risorse, volta al massimo impiego e la massima soddisfazione
III. coordinamento della produzione orientata all’efficacia
IV. distribuzione
Come già espresso chiaramente – e Pollock non lesina certo nel riprendere termini già chiariti-, l’incapacità del mercato di assolvere il suo ruolo equilibratore di domanda e offerta sta alla base del suo superamento. In questo modo l’attenzione si sposta sul piano politico, e infatti l’autore conclude così: “il vero problema della società pianificata non sta nella sfera dell’economia, bensì in quella politica, nei principi sui quali debba essere costruita una scala di priorità nei confronti dei bisogni da soddisfare, nella decisione sulla quantità di lavoro socialmente necessario e sulla quantità di prodotto da consumare o da reinvestire per l’espansione”,sempre con un occhio di riguardo alle risorse disponibili.
Altri temi vengono brevemente affrontati. Il mercato non scompare del tutto, anzi, viene mantenuto come strumento di misurazione più sensibile e, se così si può dire, svolge un ruolo di maggiore adeguamento delle esigenze effettive alle quote stabilite con i calcoli – apparentemente difficili- da parte di un ufficio apposito: se fino ad oggi “l’amministrazione dei prezzi è più servita alla distruzione dell’automatismo del mercato che alla escogitazione di nuovi sistemi per rilevare le sue funzioni necessarie”, un’integrazione dei due sistemi può servire a individuare meglio le esigenze dei consumatori.
Contemporaneamente alle considerazioni più ‘tecniche’ e spesso in maniera assai cinica,Pollock si pone il problema dell’interesse alla base d’ogni agire: se precedentemente il profitto era il movente non mosso in grado di accendere la più acerrima corsa all’imprenditoria, ora due opinioni tendono escludersi cercando di spiegare la situazione attuale. Una lo afferma come incentivo tutt’oggi ancora valido, l’altra lo disconosce nel suo ruolo essenziale e ne recita il necrologio. Una soluzione rimane la “subordinazione dei singoli interessi al ‘piano generale’”, esprimendo così il significato dell’ideologia classica del nazionalismo secondo la quale il Gemeinnutz geht vor Eigenutz. Si cede dunque il passo al principio della direzione scientifica, e si considera la società come “unità organica paragonabile a uno dei moderni giganti della produzione di acciaio”: questa scientificità sarebbe in grado di imporsi, in modo che “nulla di essenziale vada tralasciato”, e facendo sì che “tutti i problemi economici vengano trattati come problemi politici”.
Non accettando nessuna delle due posizioni antitetiche che assolutizzano o screditano categoricamente il ruolo degli utili lavorativi, è l’analisi della realtà che lo mette in grado di cogliere le peculiarità attuali di questo problema: se infatti il potere è passato al governo, il profitto non può che trasfigurarsi in interesse al potere. “Nel capitalismo di stato, gli uomini – quegli stessi che il feticismo raffigurava liberi ed eguali nello scambio- , si incontrano l’uno con l’altro come comandante o comandato. Il grado di autorità o soggezione dipende in primo luogo dalla posizione nel corpo politico, e solo in via secondaria dalla proprietà”.
Tre sono le forme di disciplina, che Pollock riprende una ad una:
I. controllo della produzione, con i mezzi disponibili hic et nunc all’uomo. Obiettivo sono la piena occupazione ( amministrazione della forza-lavoro) e sviluppo degli impianti al pari con la tecnologia.
Piena fiducia quindi nei “metodi statistici e di valutazione” e gli errori, sempre possibili, non raggiungerebbero comunque la gravità di quelli in corso e verrebbero circoscritti con facilità: tutte le molte organizzazioni private – banche …- assurgono a agenzie governative per il controllo. Ma l’eliminazione dei rischi mette in crisi l’idea del profitto come ricompensa per gli azzardi e le incognite degli investimenti privati; l’investimento coatto del surplus da un lato, e la riduzione dell’ammontare dei rischi nelle diverse operazioni dall’altra, essenzializzano il proprietario a puro rentiers, come accennato, e lo riducono a semplice stipendiato statale in virtù di un possesso ‘originario’. Pollock cita Durbin: “ nel capitale industriale la proprietà ha perduto completamente le funzioni sociali di cui era tradizionalmente investito…, ha cessato di essere un premio…, (ed) è diventata semplicemente il diritto, privo di funzioni, alla riscossione di una parte del prodotto industriale. Questa istituzione è peggio che indifendibile; è proprio inutile”.
Torna quindi il problema dell’incentivo che esclude ovviamente ogni situazione vincolata e strettamente determinata da una specifica necessità ( guerre ): per quanto riguarda “la stragrande maggioranza della popolazione…, al ricatto della disoccupazione viene sostituito il terrore politico e la promessa della ricompensa materiale e ideologica”. E anche per quanto riguarda la classe dirigente il discorso non cambia: ma qua riprende consistenza l’idea della brama di profitto volta a stimolare l’efficienza dell’amministrazione, che dunque può venir interpretata e vissuta non come ritorno di un credito anticipato assumendosi dei rischi, ma come semplice premio di una condotta irreprensibile.
II. controllo della distribuzione: il problema è risolto invertendo i termini classici dello stesso. Infatti non si tratta più della distribuzione allo scopo di ‘smaltire’ le scorte del prodotto a prezzi vantaggiosi per il mercato instabile, ma di precedere inversamente definendo come variabile indipendente il fabbisogno sociale, e adeguando ad esso la produzione. Le falle e gli squilibri possono essere facilmente superati dall’amministrazione: i metodi ormai evidenti all’autore sono l’assegnazione diretta (priorità, quozienti) e l’amministrazione dei prezzi. La distribuzione quindi è riconosciuta come utile all’integrazione dei due momenti distinti e perciò non meno essenziale. E al di là delle diverse opinioni correnti, si pone nella sua centralità l’idea di un sistema di priorità e quote, a garanzia dell’esecuzione del piano nelle sue linee generali.
La ripartizione riguarda però anche le retribuzioni: negare la differenziazione dei salari è impensabile e “anzi, il potere centrale di pianificazione continua ad usar(la), come e più di prima, come incentivazione dell’impegno personale degli operai”. Gli stipendi vengono dunque amministrati ed in caso di penuria Pollock considera possibile anche l’assegnazione diretta dei beni di consumo. Risulta inevitabile, date anche le circostanze soggettive – che l’autore aveva assolutamente allontanato nella critica a Block-, il ridimensionamento della libertà di consumo: risparmi volontari o scelte volontarie dei consumatori altererebbe lo stato di cose, ma verrebbe presto ribilanciato dal meccanismo di mercato che il capitalismo di stato ha rinunciato ad eliminare del tutto.
Una breve analisi dei limiti , trae la conclusione delle considerazioni appena fatte: è più volte ripresa e affrontata la critica sull’incapacità del piano di andar oltre ad una situazione particolare di crisi, quale quella bellica, risultandone drasticamente compromessa l’efficiente produttività, e sul bisogno di investire parte sostanziale del reddito nazionale per far fronte alla disoccupazione: date tutte queste condizioni però, “potremmo perfino arrivare a dire che sotto il capitalismo di stato l’economia come scienza ha perduto il suo oggetto”.
Il nazionalsocialismo
Alla Columbia University, dove si trovava l’ormai Institute of Social Research, ebbe luogo nel 1941 una serie di cinque conferenze riguardo alla situazione tedesca in quegli stessi anni. La conclusione spettò a Pollock il quale, in discussione con i contributi precedenti, portò a confronto il modello ideale precedentemente teorizzato con la situazione reale: il problema della ‘novità’ dell’ordinamento si sviluppa in ambito socioeconomico. L’autore stabilisce quindi cinque caratteristiche che, con occhio di riguardo alla metodologia dell’analisi, risultano essenziali. 1. la classe dirigente 2. l’integrazione della società 3. l’operazione della vita economica 4. il rapporto tra governo e governati e infine 5. il ruolo dell’individuo. Massima attenzione, quindi, al sistema produttivo nella sua incidenza in ambito sociale e ai mutamenti all’interno dei rapporti di produzione, ripensando a quel processo di adattamento e trasformazione già affrontato. La struttura del saggio rispecchia questa ripartizione.
Prima dell’avvio, Pollock si sofferma su due osservazioni metodologiche: da un lato viene affermata la dinamicità di ogni sistema sociale, non in quanto progresso delle istituzioni legali prese in sé, che evidentemente rimangono costanti, quanto piuttosto per la loro funzione sociale – così per esempio la proprietà privata -, dall’altro il problema di quanto i diversi mutamenti siano strutturali, di quando, cioè, “il mutamento quantitativo si trasforma in mutamento qualitativo” (172).
I. l’autore cita la ripartizione in gruppi di potere espressa da F.Neumann – grande impresa, esercito, partito e burocrazia-, per decretare la fine del ruolo che la proprietà privata aveva assunto nella fase liberale, e cioè quella d’esser fonte di potere, d’influenza e di definizione dello status sociale del soggetto: i grandi rivoluzionamenti hanno fatto sì che sia ormai il ruolo all’interno del gruppo a incidere in maniera assoluta. L’interferenza politica nell’economia impone divieti e obblighi alla libera iniziativa e il processo di concentrazione viene accelerato dalla crescente organizzazione sovra-imprenditoriale: la scissione proprietà-gestione esautora poi definitivamente la figura del menager-padrone. Pollock riporta anche un paragrafo tratto dalla relazione di A.R.L.Gurland, mettendo in discussione il potere attribuito da quest’ultimo ai piccoli oligopoli o combines, evidenziando in primo piano la centralità del compromesso tra i diversi sistemi di controllo della produzione: “essi hanno interessi contrastanti se non proprio conflittuali, ma nonostante ciò sono legati e vincolati da mete comuni e dal timore di pericoli comuni” . “Il diritto legale alla proprietà è impotente”, per quanto i discorsi sul ‘finanziamento interno’ sembrano contraddirlo. “Il potere dei monopoli rimane enorme e, oggi come oggi, condizionato dalla buona volontà e dalla cooperazione dei ‘professionisti della violenza”. Il cambiamento qualitativo è dato.
II. Il Fronte del Lavoro ha convogliato in sé capitalisti e lavoro, e li ha “ideologicamente fusi in una comunità popolare”. Distribuisce salari e li organizza snaturando lo scopo di questi, cioè quello di equilibrare la forza lavoro all’interno dei diversi rami, e si costituisce come organizzazione omnicomprensiva che in grado di scardinare il classico rapporto tra proprietà, reddito e potere sociale. Ma ciò che socialmente cambia è l’inabissarsi dello scambio come punto e mezzo d’incontro dei liberi produttori, che invece la propaganda nazionalsocialista tende a sostituire con l’idea di un rapporto di tipo paternalistico tra leader e seguaci; il tutto viene ad essere una macchina burocratica disciplinata gerarchicamente.
III. Pollock distingue l’economia tedesca dall’ideale di piano da lui teorizzato: la prima è più un “ insieme disarmonico e disarticolato di soluzioni provvisorie progettate per far fronte a compiti e agli oneri creati dalla guerra e dalla corsa agli armamenti”. Quindi consiste sostanzialmente in uno sforzo determinato e diretto da una necessità di fondo piuttosto che una scala di valori sulla quale orientare lo sviluppo. Da un lato quindi l’agricoltura si concentra solamente sull’indipendenza e sull’autonomia dal mercato internazionale e dall’industria punta al maximum di produzione di mezzi strumentali e bellici. Il risultato è “un’epoca senza cicli economici”. L’effetto è comunque equivalente, e i metodi usati sono sostanzialmente già stati presi in considerazione precedentemente.
Il problema dei profitti come incentivi riprende essenzialmente ciò che si era già detto di State Capitalism, in cui Pollock aveva spiegato come questi non dovessere più dirigere il flusso dei capitali al fine di equilibrare le diverse branche economiche. La produzione è solamente più destinata all’uso – dove il bisogno nazionale in una situazione pre-bellica non corrisponde ai bisogni di uomini liberi in una società armonica- e non più rivolta al mercato. Venendo anch’essi sottoposti al programma generale, finiscono per svolgere due funzioni essenziali, divenendo “reddito per chi possiede la proprietà…, e premio per l’efficienza imprenditoriale (amministrativa)”.
IV. Il rapporto comandante-comandato si rispecchia in ambito giuridico: sono gli ordinamenti amministrativi a gestire il ruolo e di conseguenza lo status sociale, sostituendosi così alle norme del diritto civile e unificando i due ambiti produttivo e politico: “la duplice razionalità che assoggetta governanti e governati alle stesse formule è stata sostituita da una razionalità tecnicamente unilaterale”.Tutto mira alla precisione e alla velocità del meccanismo, particolarmente preciso e adatto alla calcolabilità tecnica. Al di là dell’apparente mantenimento delle vecchie istituzioni, “ di fatto non è rimasto assolutamente niente dell’ancien regime”.
V. L’ultimo punto risulta originale e estremamente interessante poiché, riprendendo e rielaborando temi classici dell’Istituto, riguarda l’individuo singolo quale particella nucleare della sfera sociale tanto essenziale alla dottrina,. La prima considerazione è il bisogno del nazionalsocialismo di liberare gli istinti più brutali al cui scopo funziona la propaganda, mirata a sviluppare al massimo l’individuo come forza-lavoro per poi sfruttarlo. È l’idea dell’uomo come sorgente d’energia. Egli viene mobilitato a prezzo dell’intrusione della vita sociale nella vita privata e la perdita totale della sua sfera d’indipendenza, ma dovendo successivamente compensare a queste privazioni con un effettivo incremento della libertà, incombeva per il regime il rischio di mettere in pericolo il sistema. Da qui l’idea rafforzare il medesimo abolendo determinati tabù sociali che avrebbero limitato l’individuo alla sua intimità e aprendola all’interferenza dello stato: ciò permise al governo di gestire una politica di popolamento imperialistico del Terzo Reich e orientare gli stessi impulsi divenuti sociali contro capri espiatori del regime. Questa struttura psicofisiologica garantisce e perpetua l’oppressione. Così anche la famiglia si disgrega e l’educazione passa nelle mani del partito.
Dei cambiamenti ci sono, ma che cos’è quest’ordine nuovo? Nella riformulazione del problema, citando uno scrittore nazista (Willi Neuling), Pollock conia il termine economia di comando, antitetico alla classica economia di scambio, per evidenziare la distanza tra il primo modello, il laissez-faire e la forma monopolistica della fase post-liberale. Infatti, per quanto il diverse forme di controllo preesistessero al nazionalsocialismo, “il mercato veniva comunque opportunamente manovrato e manipolato da gruppi antagonistici” e gli interventi avevano un carattere ancora limitato.
Si tratta indubbiamente di un ordine nuovo, ma che cosa lo differenzia da un’economia di piano socialista? Una volta stabiliti i caratteri comuni di ogni mercato organizzato, quali sono le differenze tra i diversi punti di arrivo possibili di questo processo? In quest’ultimo saggio si intrecciano elementi storici semplificati con elementi ipotetici e normativi di un sistema che deve ancora crearsi; non risulta assolutamente chiaro dove finisca il totalitarismo e incominci il socialismo. L’idea della nazionalizzazione dell’apparato produttivo, inizialmente avanzata come condizione sine qua non del piano socialista non è approfondita, ed è probabile che lo stesso Pollock non credesse ormai molto alla sua attuabilità.
Sembra anche venir meno il metodo marxiano e grümberghiano che era già stato in parte abbandonato nei testi precedenti, per cui ogni elemento riconosciuto al nuovo sistema sembra avulso da ogni contesto storico preciso. Si tratta effettivamente di una conferenza che intendeva solo riassumere risultati di ricerche diverse, ma questa mancanza non venne mai colmata nonostante Pollock progettasse un’opera assai più completa. Ciò rese oggetto l’autore di numerose critiche, in particolare da F.Neumann, allora ancora legato all’Istituto, il quale compilò un’opera fondamentale volta allo stesso scopo. Il Behemoth fu pubblicato alla Oxford University di New York nel 1942, e pone le basi per un’interpretazione della realtà tedesca volta a ribadire il ‘primato dell’economia’, sostenuta anche da Gurland e Kirchheimer, antitetica invece a quella pollockiana del ‘primato della politica’ simpatizzata da Horkheimer e Adorno. Bisogna riconoscere che quest’opposizione sfuma nell’originale dei due testi, nel momento in cui le considerazioni e spesso la terminologia concordano. La sezione dedicata all’economia s’avvia con un capitolo ironicamente intitolato “un’economia senza scienza economica?” oramai comprensibile al lettore: due sono i metodi di critica adottati.
Il primo mira a dedurre teoricamente l’impossibilità del ‘capitalismo di stato’: esso risulta essere una contradictio in adiecto, nel momento in cui il monopolio statale dei mezzi di produzione renderebbe impossibile il funzionamento di un’economia di mercato (R.Hilferding). Neumann critica il ‘modello’ come difficilmente giustificabile, volendo questo rispecchiare il punto d’arrivo di un processo ancora in fieri, ricordando che neanche Marx o Smith non avevano osato prefigurare un sistema a loro storicamente posteriore. “La nuova teoria viola il principio secondo il quale il modello o tipo ideale deve essere derivato dalla realtà e non deve trascenderla”. Questa considerazione metodologica non porta a invalidare la teoria, ma certamente ne indebolisce i risultati e la necessità del loro realizzarsi. Va anche ricordato che questo modello si confonde con l’ideale dell’economia socialista; per cui i caratteri attribuitigli, quali la produzione per l’uso, la fine del profitto, la fine dell’antagonismo sociale tra forze produttive e mezzi di produzione…, non potrebbero definirsi in sé né negativi né positivi se non considerando il modo in cui vengono applicati. Per cui tale sistema oscilla tra il peggior totalitarismo e “la realizzazione del sogno dell’umanità”; la politica, separata dall’economia, diventa una semplice tecnica per il dominio delle masse, e di conseguenza ne viene messa in discussione la possibilità. Al di là dunque dell’approccio all’analisi sistematica, molte considerazioni risultano ambigue e sembrano lasciar spazio a dubbi e domande.
Per Franz Neumann il nazionalsocialismo non è considerabile un’economia di piano: l’unico principio valido è la priorità del benessere sociale sull’interesse personale, e il susseguirsi di piani generali mai applicati – il programma dl partito del 1920, ribadito da G.Feder nel 1926- da credito all’uso di criteri pragmatici volti al massimo dell’efficienza. Nessuna teoria coerente si avvicina alla ‘scala di priorità’ idealizzata da Pollock. Anzi, il corporativismo stesso è strumentalizzato dai cartelli per rafforzare il loro potere, e non si tratta di organizzazioni autonome ma di organi dello stato che funzionano dall’alto verso il basso e dove gli industriali svolgono sostanzialmente funzioni amministrative: ma questa situazione non può essere interpretata o letta come fase di transizione, nessun dirigente nazista propone l’espropriazione della proprietà privata o il ‘controllo’ diretto dell’economia. Per Neumann quindi la dittatura della burocrazia manageriale non è certamente un sistema capitalista, non è inevitabile che ciò avvenga, e comunque sia questo non è l’obiettivo esplicito del sistema attuale.
La seconda via alla confutazione invece, mira a descrivere dettagliatamente la struttura e il funzionamento dell’economia tedesca: partendo dalle Spitzverbände industriali e dal Führerprinzip il testo rimane strettamente legato alla realtà storica. Quando il maresciallo del grossdeutsche Reich H.Göring assunse il titolo di delegato generale del piano quadriennale, originariamente (nel 1936) una sorta di istituto per la pianificazione economica, la sua funzione non consistette nella gestione diretta dell’economia, benché legalmente gli fosse concesso questo potere. Si tratta piuttosto di manovre volte alla razionalizzazione dei singoli rami produttivi a al controllo delle posizioni economiche chiave da parte del partito. Nel testo seguono una densissima analisi strutturale dell’apparato produttivo e una presa di coscienza del sistema nel suo versante pratico: ciò porta a concludere che se in teoria il potere dello stato pare illimitato, “la legge, come il linguaggio, non sempre esprime la realtà: spesso anzi la nasconde”.
Molto interessante vedere come uno dei cambiamenti maggiori consista nella rottura dell’integrazione tra proprietà privata e libertà contrattuale, le quali “non sono semplici categorie giuridiche ma svolgono funzioni sociali specifiche”: secondo la concezione classica la seconda non avrebbe dovuto escludere la prima con la creazione di monopoli o cooperazioni che minassero alla base la libera concorrenza, basata sull’efficienza e non sulla distruzione del concorrente, ma sarebbe dovuta essere il mezzo attraverso il quale la società veniva tenta insieme. La contrattazione diviene all’opposto lo strumento primo atto a giustificare i diversi raggruppamenti industriali da un lato, e dall’altro risulta essere anche un incentivo alla formazione di organi sindacali e concorrenziali volti a destabilizzare i monopoli. Si giunge dunque ad un polarismo sociale fondato sul contratto, e questo antagonismo non poteva essere risolto e superato con l’abolizione dell’istituzione legale, in quanto avrebbe privato di fondamento i raggruppamenti economici stessi. Il nazionalismo ha soppresso così ogni libertà garantendo la proprietà con garanzie ausiliarie, in modo autoritario e con atti amministrativi, costringendo la produzione all’interno dei cartelli controllati dagli stessi magnati.
Neumann ripropone analiticamente gli stessi temi e spesso le stesse conclusioni del nostro autore; in particolare la concentrazione coatta, l’arianizzazione – e conseguente espropriazione delle proprietà ebraiche- e la germanizzazione, gli sviluppi tecnologici, il controllo dei prezzi, i finanziamenti e le società per azioni. Non si tratta di dirigenti ma di potenti capitalisti che agiscono in un sistema di concorrenza ancora più spietata, data la scarsità delle materie prime, e la formazione di cartelli “non è la negazione della concorrenza, ma solo un’altra forma di essa”.
Per concludere dunque, tutto ciò volse a rafforzare, anche con l’inserimento di persone legate al partito, i diversi complessi industriali sorti dalla cartellizzazione di interi rami della produzione. L’autore conclude: “l’economia tedesca attuale presenta due caratteristiche vistose e sorprendenti: è un’economia capitalistica, ed è un’economia guidata. È un’economia capitalistica privata, irrigidimentata dallo stato totalitario. Il termine migliore per descriverla è, a nostro avviso, ‘capitalismo monopolistico di stato’”.
Le analisi dei due autori non sono così molto distanti l’una dall’altra. L’essere invece giunti a conclusioni apparentemente opposte, è dato dal fatto che diversi erano alcuni loro presupposti teorici di partenza: molto verosimilmente, Neumann si basa su un concetto di capitalismo strettamente legato all’idea di autonomia e primato delle leggi di mercato e non accetta, insieme ad Adorno, l’idea di un antagonismo capitalista e di una crisi del sistema non fondati su di una libera dinamica economica – e solo partendo dalle contraddizioni di quest’ultima si potrebbe sperare in un crollo del sistema. Così si spiegherebbe anche l’inasprimento graduale del divario tra aspirazioni ideologiche – pseudoegualitarismo sociale, espressione culturale…- e realtà effettivamente irrazionale e distruttiva dell’organizzazione.
Al contrario, Pollock si concentra su una determinata struttura dei rapporti di produzione, per cui la situazione tedesca sarebbe definibile ancora come capitalismo poiché conserva inalterato (o addirittura esaspera) il carattere antagonistico dei rapporti.
Conclusione Ragione e autoconservazione
Nelle ultime battute di State Capitalism vengono alla luce tutti i problemi non facilmente risolvibili con una teoria intrecciata di categorie astratte. Pollock parla di “controllo del livello di vita” e di ostilità sociale nei confronti della classe di rentiers, tracciando le linee essenziali di una società dove la “stragrande maggioranza della popolazione ricade nella categoria dei salariati, soggetti al principio-guida del comando e dell’obbedienza…, e la dominazione politica si regge sul terrore organizzato e sulla propaganda a tappeto”. Non ultima la classica questione politica di “chi controlla il controllore”.
Queste conclusioni pessimistiche si inverano nella prassi dei due grandi sistemi totalitari, tanto che si parla di «congiura del silenzio» attuata dalla scuola e dal suo direttore nei confronti dell’URSS: nello specifico, ciò che colpisce in particolar modo i nostri autori è il fallimento del principio razionale nella sua applicazione alla società nella sua interezza. Con l’esclusione della variante democratica del piano, lo Stato appare come un Behemoth, ossia un non-stato, un caos o meglio un regno di illegalità e anarchia da un lato, e come un sistema razionalmente omnicomprensivo. L’incertezza della conclusione e dell’interpretazione dei risultati storici dividono gli intellettuali.
Nel 1942 Horkheimer stila un resoconto sulla situazione sociale attuale: Ragione e autoconservazione intende ricostruire lo sviluppo della ragione come concetto unitario nelle sue accezioni storiche, per comprendere gli elementi strutturali che hanno portato a questo risultato. La crisi riguarda concetti quali verità, libertà e giustizia, non nella loro datità storica immediata quanto piuttosto nel loro fondamento nell’idea più alta e nobile della società borghese, ossia il concetto di ragione come elemento regolativo nei rapporti fra uomini, e base degli ordinamenti naturali.
“La filosofia borghese è nella sua essenza razionalistica. Ma il razionalismo si volge contro il suo stesso principio e ricade sempre di nuovo nella scepsi”. Il momento di critica insito nell’approccio ‘illuminista’ a ogni verità che non si dimostri tale, è il primo passo verso un lento dissolvimento delle possibilità teoriche dell’uomo e dei suoi risultati: Horkheimer accenna a questo continuo rapporto dialettico tra dottrine filosofiche opposte, quali quelle tra Tommaso d’Aquino e Ruggero Bacone o tra Cartesio e Gassendi, dove insomma a ogni impianto teorico corrispondeva una posizione scettica che lo riconduceva entro limiti ben ristretti. Ma se questa ciclicità costruttiva e distruttiva nella storia delle idee ne costituiva originariamente l’elemento dinamico, ora è proprio questo continuo dubitare ad aver smantellato il concetto stesso di ragione e i suoi feticci concettuali. Tutte le categorie prima utilizzate vengono meno nel loro fondamento; così ad esempio le idee di spirito, volontà e causa finale diventano un fantasma per la scienza moderna, insieme a tutti quei concetti che trascendono la realtà immediatamente data.
Ma la ragione non scompare, e ripropone in tutta la sua radicalità la sua funzione strumentale rivolta all’utile; “freddezza e sobrietà sono le sue virtù”. E se la razionalità oggi si mostra strettamente legata alla prassi e ai suoi risultati, in realtà lo è sempre stata, seppur in forma diversa: Horkheimer ripropone un percorso interpretativo che prende le mosse dalla dottrina socratica dell’identità tra Utile e Bene, e si conclude con la realtà sociale attuale dominata da monopoli privati.
FEDERIGO ENRIQUES

A cura di Moses
Grande studioso di geometria, di algebra e di storia della scienza, Federigo Enriques (1871-1946) si oppose fermamente alle interpretazioni convenzionalistiche e formalistiche della matematica, mirando a una genesi psicologica delle teorie scientifiche. Non sono molti quelli che conoscono Enriques come filosofo, e quei pochi che lo ricordano sono forse gli appassionati di matematica, perché – insieme a Guido Castelnuovo e Francesco Saveri – egli fu uno degli artefici della cosiddetta “scuola geometrica italiana”. Enriques insegnò nelle Università di Bologna e Roma. Negli anni ’30 fu direttore della Sezione Matematica dell’Enciclopedia Italiana, quindi collaborò con Gentile. La sua mancanza di notorietà è strettamente legata al successo straripante dello “storicismo” di Benedetto Croce, dell’“attualismo” di Giovanni Gentile ed alla relativa scomparsa del positivismo dalla scena filosofica nazionale, solo in parte rimpiazzato dal pragmatismo. Il suo torto fu quello di richiamarsi energicamente e chiaramente al positivismo, il grande sconfitto dei tempi, di aver dichiarato che la scienza gli era apparsa “come via maestra della speculazione filosofica” e che “due grandi stelle brillavano nel nostro cielo: Darwin e Spencer. Di questi cercavamo e leggevamo le opere.” (1) Ora, non è facile stabilire se la mancata fortuna di Enriques sia frutto di una miopia degli storici o di una eclissi reale, determinata da una mancanza di audience da parte del mondo intellettuale e della cosiddetta opinione pubblica colta, costituita da lettori di libri e riviste. Molto probabilmente le due spiegazioni vanno intrecciate, considerando che anche durante il regime fascista si continuò a pubblicare una rivista, “Scientia”, che proprio al positivismo si richiamava e che qualche lettore doveva pur annoverare e che questo tipo di lettore non andava necessariamente iscritto tra gli oppositori al regime, costretti in qualche modo a darsi alla macchia.
Enriques dichiarò fin dall’inizio pubblicamente ch’egli rifuggiva la dialettica hegeliana insegnata dal professor Jaja e che essa “ripugnava alle nostre menti”. Se pensiamo che quel professor Jaja altri non era che Donato Jaia, il professore che discusse la tesi di Gentile su Rosmini e Gioberti, abbiamo il quadro preciso della situazione. Ma anche qui, occorre non farsi ingannare dalle contrapposizioni amplificate ed assolutizzate da alcuni storici. In realtà, Gentile ed Enriques dialogarono, e mentre Gentile sembrò apprezzare l’idea di una storia del pensiero scientifico propugnata da Enriques, lo stesso rimproverò a Gentile la mancata attuazione completa della riforma della scuola, nella quale si era previsto l’inserimento della storia della scienza.
Enriques scrisse di suo pugno il programma, pubblicato anonimo, della “Rivista di scienza. Organo internazionale di sintesi scientifica”, che cominciò ad uscire nel 1907 e che nel 1911 divenne semplicemente “Scientia”. In esso si leggeva:
«L’organamento attuale della produzione scientifica trae la propria fisionomia dal fatto che i rapporti reali vengono circoscritti entro discipline diverse, le quali ognora più si disgiungono secondo gli oggetti a secondo i metodi di ricerca. I risultati di codesto sviluppo analitico della scienza furono celebrati fino a ieri come incondizionato progresso, imperocchè la tecnica differenziata e l’approfondita preparazione di coloro che coltivano un ordine di studi ben definito, recano in ogni campo del sapere acquisti importanti e sicuri. Ma a tali vantaggi si contrappongono altre esigenze che il particolarismo scientifico lascia insoddisfatte, ed alle quali si volge con maggiore intensità il pubblico contemporaneo.» (2)
Una simile dichiarazione è già indicativa: per Enriques lo spazio ed il ruolo della filosofia sono delineati come “sintesi” delle conoscenze scientifiche e non come autonoma speculazione, indipendente da ogni acquisizione scientifica. L’idealismo gentiliano contesta alle scienze il loro particolarismo e la loro astrattezza, l’atteggiamento filosofico di Enriques, consapevole tanto dei limiti quanto della forza delle scienze, anziché chiudersi in una condanna aprioristica di tali limiti, si volge decisamente a cercare una riunificazione sintetica dei saperi.
Enriques vide nel convenzionalismo di Duhem e Poincaré il rischio di privare le scienze di uno specifico valore conoscitivo, riducendole ad un puro “gioco”. Il valore e il significato dell’impresa scientifica sono dunque i punti che attraversano tutta la sua riflessione. Già nel 1906 scriveva:
«Il fatto generale che l’esperienza si interpreta per mezzo di conoscenze anteriori, e di ogni fase del progresso scientifico è analogamente sottomessa ad una fase precedente, si accetta oggi […] non più stabilendo una gerarchia assoluta delle scienze, ma riconoscendo il graduale sviluppo di ciascuna […] Pertanto la Geometria, anziché essere ritenuta come necessariamente precedente alla Fisica, viene ad esserne considerata una parte, assorta ad un alto grado di perfezione in virtù della semplicità, della generalità e della relativa indipendenza dei rapporti in essa compresi.» (3)
Enriques non si propone tanto di criticare e contestare l’irrazionalismo e la presunta “bancarotta della scienza” annunciata con rullo di tamburi da Ferdinand Brunetière. Gli interessava rintracciare le premesse stesse dell’irrazionalismo nelle “esagerazioni barocche” della logica formale. La nascita della nuova geometria aveva, per Enriques, condotto all’errata convinzione dell'”arbitrarietà” della costruzione matematica. Egli vide un collegamento tra il pragmatismo matematico e quello filosofico, che Enriques associava al convenzionalismo e al machismo. Le interpretazioni estremistiche del pensiero di Poincaré da parte di Le Roy e quella di Peirce da parte di William James e Ferdinand Schiller avevano ingenerato la falsa convinzione che «il possesso della verità ricercato dalla scienza diviene una pura illusione: i risultati scientifici potranno tutt’al più fornire una tecnica utilitaria, una regola di azione nella vita.» (4)
Ma, lo stesso pragmatismo logico-matematico indica la via per evitare conseguenze simili nel momento in cui contesta il naturalismo matematico, cioé quella dottrina che riconosce l’esistenza di enti matematici indipendentemente dallo spirito umano. Per Enriques si tratta, dunque, di trovare un equilibrio tra l’empirismo radicale delle sensazioni e l’attività costruttiva dello spirito. La loro contrapposizione dà luogo ad una scissione erronea del “concetto pieno del reale”, tra una componente passiva ed una attiva. Secondo Enriques, il dato puro e immediato è un’illusione. Scrive il nostro autore: «non c’è sensazione che non sia in pari tempo una reazione attiva del senziente allo stimolo e non involga quindi in qualche modo la sua attenzione e la sua volontà.» (5) Pertanto la realtà non è mai un dato puro, ma sempre qualcosa di costruito dall’attività razionale. Ciò che chiamiamo realtà è un rapporto invariante (termine estratto dalla matematica e riferito a un dato gruppo di “trasformazioni”). L’invariante era per Enriques una specie di rivelatore che mostrava l’attività della conoscenza al suo livello più elementare. Secondo Enriques, l’uomo è portato naturalmente alla ricerca di qualcosa di invariante nel movimento del reale. Si tratta dell’elemento che rimane costante malgrado le continue modificazioni che avvengono nella realtà ed esso può diventare l’oggetto di un concetto. Enriques allertava i suoi lettori di non confondere l’invariante con l’oggetto empirico rivelato dai sensi. L’invariante è l’oggetto matematico, cioè la costruzione razionale che segue la comprensione del reale proveniente dal senso comune degli individui umani. Ma, bisogna anche evitare di confondere l’invariante coi “noumeni” kantiani, giacché essi non sono ciò che si trova al di là dei fenomeni,dei limiti invalicabili alla conoscenza: gli invarianti giacciono, infatti, “all’interno dei fenomeni stessi”.
È quindi da tale caratterizzazione della realtà e dalla scienza come costruzione che Enriques trova una dimensione storica dell’impresa conoscitiva. La scienza non sarà mai un sistema chiuso di proposizioni definitive sulla realtà, ma un progresso continuo.
«Il concetto costruito dalla scienza – scrive Enriques – rappresenta i fatti in modo approssimato; perciò nella sua determinazione entra – è vero – un elemento arbitrario ed una scelta economica; ma l’arbitrio è contenuto nei limiti dell’approssimazione segnata dalle esperienze e per riguardo al progresso della costruzione scientifica deve essere ritenuto non già convenzione ma ipotesi, cioè disposizione preordinata d’esperienza futura. Così nel rapporto scientifico tra ipotesi ed esperienza si ritrova in forma più ampia il rapporto invariante tra atto volontario e sensazione, che costituisce il significato comune di realtà.» (6)
Per questo, Enriques non ha difficoltà nel riconoscere che i risultati della ricerca scientifica possano essere giudicati “relativi”, ma ciò non deve portare a scetticismo o irrazionalismo: «la scienza è un processo di approssimazioni successive che prolunga indefinitamente le sue radici nelle induzioni inconsce della vita comune, e spinge sempre più in alto i suoi rami, toccando ad un sapere ognora più vasto,più certo e più preciso.» (7) Per questo motivo, Enriques invoca un nuovo razionalismo, che ora definisce come pragmatismo infinito, criticando in particolare W. James e F. Schiller, ma che altrove troviamo presentato come positivismo critico. Il pragmatismo di James e Schiller, infatti, “fissa il significato della verità teorica, scegliendo le conseguenze pratiche, in ordine al [singolo] soggetto”, mentre il pragmatismo criticamente inteso concepisce “la verità [come] funzione di tutti i soggetti possibili e ritrova così il suo valore razionale umano, che è la sua obiettività”.
Enriques rimane, dunque, all’interno di una posizione positivistica, pur ponendosi in una prospettiva critica.
«La filosofia positiva di Auguste Comte – scrive ne Il significato della storia nel pensiero scientifico – ha creduto di poter trovare nella scienza qualcosa di fisso, ritenendo caduche le idee o le teorie costruite secondo le tendenze subiettive, e guardando di là di queste ai fatti che esse contengono. Un fatto, che implichi il riconoscimento di un oggetto o di un rapporto, in un certo ordine di approssimazione, sembra invero sottrarsi al cambiamento delle idee, ritrovandosi sempre lo stesso attraverso le diverse rappresentazioni o spiegazioni tecniche che possiamo darne.
Ma questa dottrina, presa alla lettera, toglierebbe ogni valore alla scienza, riducendola a semplice collezione di ricette. Perché anche quelli che, a buon diritto, chiamiamo “fatti”, ricevono il loro significato proprio dalle idee secondo le quali vengono interpretati. Si parli, per esempio di un fatto astronomico: la scoperta di un pianeta. Che cosa vuol dire, se non che un certo corpo, già forse osservato nei cieli, viene ricollegato al nostro Sole, intorno a cui dovrà muoversi secondo le leggi della gravitazione newtoniana? Si dica invece di un fatto chimico, la scoperta di un elemento. Questa nulla significa per chi non abbia presente la classificazione della materia, cioè la distinzione fra corpi composti ed indecomposti, meglio il sistema periodico di Mendeleieff, in cui gli elementi semplici trovano il loro posto. Così, similmente in ogni campo dello scibile. Un fatto non è mai l’incontro bruto di certi dati sensibili, bensì il collegamento di più dati di un certo ordine, dominato da un’idea: la sua affermazione implica sempre di riconoscere dati obiettivi e subiettivi, separabili fino ad un certo punto, ma non mai in senso assoluto.» (8)
Rispetto al positivismo dell’Ottocento occorre superare l’idea di razionalità da esso canonizzata, e formularne una nuova. Essa può essere conseguita solo proponendo una coraggiosa unione di razionalismo e storicismo, ovvero facendo interagire le strutture formali della razionalità astratta con la dimensione storica del pensiero umano. Ciò pone evidentemente non pochi problemi. A cominciare dal fatto che una razionalità critica non può più essere confinata in un sfera astratta di simboli, sintassi logica e formalizzazioni. Essa può superare gli orizzonti del mondo ipotetico deduttivo costruito da Hilbert e misurarsi con altre idee e diverse prospettive, senza rinunciare alla propria funzione.
D’altra parte, l’apertura allo storicismo non deve in alcun modo costituire una rinuncia a difendere il valore conoscitivo dell’impresa scientifica e le possibilità umane di conoscere orgogliosamente rivendicate e mostrate da Kant. Ma i ricercatori, a loro volta, devono guardarsi dal rinchiudersi in una torre d’avorio, nella ristrettezza che lo stesso Enriques definisce la condizione di “chi sta sull’isola di Laputa”, ben lontana dalle dinamiche sociale e dalle tensioni del mondo.
Scrivere la storia delle scienze può dunque offrire l’opportunità di comprendere i valori conoscitivi insiti nel loro svolgersi, e allo stesso tempo, evidenziare il fatto che le matematiche non sono qualcosa di scheletrico, quindi di “morto” strumento, ma hanno carattere “vivente”, e “Enriques l’aveva inteso con la metafora dell’altalena avanzata nei Problemi della scienza, in quanto evidenzia la formazione e la costante trasformazione dei concetti”.
(9) Tale metafora va vista nel suo contesto, che qui riportiamo per intero:
«Non vi è dubbio che la Scienza miri ad una conoscenza sempre più oggettiva. In ogni momento della sua elaborazione, essa lascia quindi fuori dalle sue esposizioni dogmatiche gli elementi che, nella conoscenza acquisita, appaiono subiettivi. Ma l’eliminazione del subiettivo dovrà essere spinta ancora innanzi in uno studio più avanzato, nel quale la correzione dell’errore che vi attiene, sia proceduta più oltre. E d’altra quegli elementi subiettivi, scartati come residui dall’eliminazione precedente, daranno qualcosa di obiettivo, vagliati con una nuova critica
Così il processo costruttivo della Scienza può paragonarsi al moto di un’altalena, che colui che vi è sopra tenti di spingere avanti il più alto possibile; ad ogni spinta in avanti corrisponde una oscillazione per cui diviene più pronunziato anche il movimento all’indietro, e ciò rende sempre più efficace la spinta. La Scienza riguardata nel suo aspetto genetico non sale soltanto ad una obiettività sempre maggiore, ma per contrasto spinge a vette più eccelse la subiettività delle rappresentazioni, che sono il suo modo di conquista.» (10)
Enriques fu consapevole del rischio di uno psicologismo, con tutto quanto vi è di arbitrario e insidioso in simile approccio, e quindi fu naturalmente condotto a proporre un’immagine della storia del pensiero umano “modellata su un’immagine della fisica” (Paolo Rossi – Federigo Enriques storico della scienza, in -a cura di O. Pompeo Faracovi – Federigo Enriques: approssimazione e verità – Belforte 1982) Ma, a sua volta, la fisica stessa è fondata “sulle esigenze della mente”, e l’epistemologia tende a risolversi in psicologia. Le ‘idee fondamentali’ in quanto ‘contengono il germe di ogni estensione o progresso della conoscenza’ hanno un ‘contenuto più ricco’ di quello che può risultare dalla logica. Per questo, Enriques vide nel neoempirismo logico “lo spettro di una nuova scolastica”. «I congressi parigini del 1935 e del 1937, in cui tra i relatori affiancati ad Enriques figurano pensatori come Carnap, Reichenbach, Schlick, Neurath, Frank, o, tra i francesi, Lautman e Cavaillès, testimoniano dello iato che si è creato tra l’approccio logico-linguistico dei neoempiristi e quello genetico di Enriques.» (11)
Nella relazione presentata all’Accademia dei Lincei del 6 febbraio 1938, Enriques approfondì questo iato sviluppando una ulteriore riflessione sul rapporto tra scienza e storia della scienza. Esso, per essere correttamente impostato, richiede che si debbano verificare due fondamentali concezioni: 1) la scienza non deve essere legata ad un criterio assoluto di verità. 2) la storicità non può che essere intrinseca al processo costitutivo della scienza.
«Ad esse – scrive Sava – va poi aggiunta la tematica dell’errore, che è visto non solo come costitutivo dell’indagine scientifica ma anche come modalità inscindibile dell’esercizio della razionalità. Infatti nella fallibilità si può scorgere che ha perso la connotazione della purezza illuministica perché si è completamente calata nella storia.
Interpretare le conoscenze scientifiche come verità assolute implica una visione antistorica della scienza, tale da rendere possibile esclusivamente una catalogazione di nomi e di date a cui riferire le varie scoperte scientifiche, tralasciando tutta la serie di tentativi e di errori che hanno accompagnato gli sviluppi della ricerca o, al massimo, ritenendoli degni della considerazione dello psicologo più che di quella dello scienziato. Sostenere il carattere approssimativo della scienza e la possibilità dell’estensione e della correzione progressiva dei suoi risultati significa, al contrario, ammettere il carattere relativo ed eminentemente umano del sapere. » (12)
Infatti Enriques scriveva: «Non c’è dunque una verità che si manifesti a noi come qualcosa di compiuto e d’esatto, esente da errori, ma soltanto verità parziali, indissolubilmente connesse all’errore, che costituiscono gradi di approssimazione; e così teorie suscettibili ognora di essere integrate in altre più ampie e precise, senza che possa mai segnarsi un termine al loro perfezionamento.» (13)
Sava mette correttamente in evidenza che in questo tipo di approccio genetico ed umanistico, Enriques rintracciò le fonti della scienza “in settori che a prima vista, sembrerebbero assai lontani, come l’arte o la religione: la ricognizione storica attesta, infatti, che la scienza rinascimentale è nata sulla riflessione e dalla rinnovata religiosità pitagorica dei neoplatonici.” Ciò mette in chiaro la dimensione spirituale dell’impresa scientifica, frutto di un’attività dello spirito, e non come semplice scoperta passiva della realtà esterna. Ecco, in sostanza, dove Enriques e Gentile non paiono così distanti e contrapposti, anche se Enriques tutto sembrava tranne che un nazionalista. Infatti, rileva ancora Sava, sottolineare l’importanza della scienza per la cultura nazionale non vuol dire chiudersi in angusti confini territoriali, ma pensare piuttosto all’ideale di una cultura unitaria attraverso il confronto con tutte le culture.
(1) F. Enriques – I motivi della filosofia di Eugenio Rignano – ora in F.Enriques – Per la scienza. Scritti editi e inediti – a cura di R. Simili / Bibliopolis 2000
(2) Era la Presentazione della “Rivista di scienza. Organo internazionale di sintesi scientifica” La rivista era stata fondata da G. Bruni, A. Dionisi, A.Giardina, E. Rignano e F. Enriques. La direzione della rivista fu condivisa da Enriques e Rignano fino al 1915. Rignano la diresse da solo fino al 1930, anno della morte. Da quel momento la direzione fu assunta dallo stesso Enriques.
(3) F. Enriques – Problemi della scienza – Zanichelli – 2 ediz. 1910
(4) F. Enriques – Scienza e razionalismo – Zanichelli 1912
(5) F. Enriques – ivi
(6) F. Enriques – ivi
(7) F. Enriques – ivi
(8) F. Enriques – Il significato della storia nel pensiero scientifico – Zanichelli 1936
(9) M. Castellana – Federigo Enriques e il metodo storico in filosofia della scienza – saggio contenuto nella ristampa di Il significato della storia nel pensiero scientifico – a cura di Mario Castellana e Arcangelo Rossi – BARBIERI EDITORE 2004
(10) F. Enriques – Problemi della scienza – Zanichelli – 2 ediz. 1910
(11) B. Sassoli – Struttura e dinamica delle teorie scientifiche nell’epistemologia italiana e francese – in Introduzione alla filosofia della scienza – a cura di Giulio Giorello – Bompiani 1994
(12) G. Sava – F. E. “Sintesi scientifica” e storia della scienza – saggio contenuto nella ristampa di Il significato della storia nel pensiero scientifico – a cura di Mario Castellana e Arcangelo Rossi – BARBIERI EDITORE 2004
(13) F. Enriques – Importanza della storia del pensiero scientifico nella cultura nazionale – in “Scientia”, XXXII, vol.LXIII, n. CCCXI-3, 1938
ETIENNE GILSON

A cura di Moses
Etienne Gilson (1884-1978) è stato probabilmente il più insigne studioso di filosofia medioevale fino ad oggi; fu l’autore del più significativo compendio di storia della filosofia medioevale di cui si possa oggi disporre; fu quindi storico della filosofia, più che filosofo in senso ampio o stretto, a seconda di come si guardano le cose. Ed è dallo storico che abbiamo molto da imparare per la serietà, l’impegno, un’erudizione strepitosa ma mai fine a sé stessa, sempre pronta a spiegare, a capire, a carpire da testi obsoleti ed incartapecoriti un certo spirito, una tale tendenza, una forte tensione. Tuttavia, Gilson ebbe una sua filosofia, sostanzialmente una neoscolastica non dogmatica e per nulla chiusa alle istanze della contemporaneità.
Ovviamente, parlando di neoscolastica, si entra di colpo su un terreno delicato e spinoso, quello del rapporto tra fede e scienza, e, all’interno della fede, quello ancor più delicato tra ortodossia cattolica da un lato ed istanze moderniste o spiritualiste dall’altro. Gilson scelse senza esitazione di porsi in una prospettiva neotomistica, non disdegnando di ascoltare altre campane. Fu anche allievo di Bergson al Collège de France nel 1905, l’anno del corso sul “l’effort intellectuel”. «Era il periodo – ricorda Mario Dal Pra – in cui il declino del positivismo apriva la prospettiva di una ripresa spiritualistica di vaste proporzioni, sia attraverso lo sviluppo di temi idealistici o irrazionalistici, sia mediante la ripresa ed il recupero dei contenuti principali della tradizione cattolica. L’età positivistica aveva rappresentato, a livello europeo, un’affermazione organica dello spirito laico e della polemica anti-religiosa. E il momento in cui la grandiosa metafisica scientistico-evoluzionistica del positivismo entrò in crisi fu anche il momento della ripresa della cultura, della filosofia e dell’apologetica di ispirazione cattolica.» (1)
Gilson può essere ricordato per come riuscì a spiegare che Descartes non era nato, come Athena, direttamente dalla testa di Zeus, cioè di Dio, ma formandosi alla scuola della filosofia medioevale, che poi gettò insoddisfatto in un angolo come un ferrovecchio inservibile, considerandola del tutto inadatta a dominare il mondo, a curare le malattie ed allungare la vita all’uomo, rendendola al contempo più comoda e piacevole. Il Commentaire del Discours de la Méthode del 1925 è uno studio rigoroso del pensiero di Descartes, seguito nel 1930 da Ètudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartesien, che indaga a fondo le “fonti” medioevali del sistema cartesiano. Proprio a partire da Descartes, Gilson elabora una concezione della storia della filosofia che predilige la continuità a scapito della rottura e delle rivoluzioni.
Sviluppando questa tesi, Gilson può rivelarsi maestro impareggiabile e guida preziosa per intendere che non solo nulla è inutile nella storia del pensiero umano, e come ben vide Aristotele, “tutti gli uomini” anche i più insignificanti, “concorrono alla verità”. Se ciò è vero persino nella transizione dal medioevo alla modernità, perché non dovrebbe esserlo in generale? Così, studiando Tommaso d’Aquino, Dante Alighieri e Duns Scoto, cui dedicò opere particolari come l’importante Le thomisme: introduction au système de saint Thomas d’Aquin, del 1919 (ma in edizione molto più estesa nel 1942), Gilson venne convincendosi che persino rispetto all’evidente discontinuità della storia politica, si presenta una maggiore continuità nella storia della filosofia e della cultura.
Ciò può stupire chi si sia abituato a vedere quantomeno un profondo mutamento di paradigmi tra filosofie greche ed ellenistiche e la patristica cristiana, tra gli ultimi stoici e Agostino, ma Gilson preferisce insistere sul fatto che il tramonto dell’impero è secondario rispetto alle linee di continuità sviluppate dalla Chiesa nei confronti della cultura latina. Se ne può trovar traccia, ovviamente, soprattutto nelle pagine su Boezio. Ma non meno importante è la messa a fuoco della connessione e della relativa disconnessione tra filosofia e religione, dove entrambe finiscono con il conservare il loro ruolo e la loro autonomia, pur riservandosi, la religione, di poter condannare quelle filosofie decisamente contrarie allo spirito cristiano.
Le pagine su Giustino sono in questo senso illuminanti e genetiche. Mosso da una grande spinta interiore alla ricerca di una luce per la vita, Giustino si trova di fronte una variegata gamma di offerte “filosofiche”. Attraversandole, egli giunge finalmente ad una conclusione ed ad una scelta. «Nella speculazione filosofica stessa – scrive Gilson – le preoccupazioni religiose occupavano allora ampio spazio. Convertirsi al Cristianesimo era spesso un passare da una filosofia animata da uno spirito religioso ad una religione capace di prospettive filosofiche. Per il giovane Giustino, la filosofia era “ciò che ci conduce verso Dio e a lui ci riunisce”. Dapprima egli frequentò gli stoici, ma questi uomini ignoravano Dio e gli dissero anche che non era necessario conoscerlo. Rivoltosi successivamente ai peripatetici, egli cadde sotto un maestro che gli chiese innanzitutto di accordarsi per la retribuzione “affinché le loro relazioni non restassero inutili”: non era dunque un filosofo. Giustino volle allora istruirsi da un pitagorico, ma questo maestro pretendeva che prima si sapesse la matematica, l’astronomia e la geometria, e Giustino non poteva risolversi a dedicare a queste scienze il tempo necessario. Un migliore successo l’attendeva presso i discepoli di Platone. Là egli veramente si istruì su ciò che desiderava apprendere; dice Giustino: “L’intelligenza delle cose incorporee mi conquistava al più alto grado; la contemplazione delle idee dava ali al mio spirito, tanto che, dopo un po’ di tempo, credetti d’essere diventato sapiente; fui anche tanto sciocco da sperare d’essere sul punto di vedere Dio immediatamente; perché questo è il fine della filosofia di Platone.” Ciò che Giustino cercava nella filosofia era una religione naturale: non ci si stupirà dunque, che egli abbia più tardi scambiato il platonismo per un’altra religione. In un luogo isolato dove si era ritirato per meditare, Giustino incontrò un vegliardo che lo interrogò su Dio e sull’anima, e avendo egli risposto esponendo le opinioni di Platone su Dio e la trasmigrazione delle anime, questo vegliardo glie ne mostrò l’incoerenza: se le anime che hanno visto Dio debbono in seguito dimenticarlo, la loro felicità non è che miseria, e se quelle che sono indegne di vederlo restano legate a dei corpi come castigo della loro stessa indegnità, poiché non sanno di essere punite, questa punizione è inutile. A questo punto Giustino abbozzò una giustificazione del Timeo, ma il vegliardo rispose che egli non si preoccupava del Timeo, né della dottrina platonica dell’immortalità dell’anima. Se l’anima vive immortale non è perché è vita, come insegna Platone, ma perché la riceve, come insegnano i Cristiani: l’anima vive perché Dio lo vuole, e tanto a lungo quanto egli lo vuole. Questa risposta ci sembra adesso, di una semplicità che confina con la banalità, ma essa segnava nettamente la linea di demarcazione che divide il Cristianesimo dal platonismo.» (2)
Eppure, nonostante l’evidente differenza tra una situazione nella quale l’uomo cerca di farsi strada faticosamente in un ginepraio di ipotesi discordanti ed una nella quale si offre “una rivelazione”, Gilson sottolinea che la filosofia continua ad essere sé stessa:
«Il Cristianesimo – scrive Gilson – si rivolge all’uomo per sollevarlo dalla sua miseria mostrandogli quale ne è la causa ed offrendogliene il rimedio. E’ una dottrina della salvezza e per questo è una religione. La filosofia è una scienza che si rivolge all’intelligenza e le dice quel che le cose sono, la religione si rivolge all’uomo e gli parla del suo destino, sia perché egli vi si sottometta, come la religione greca, sia perché egli lo costruisca, come la religione cristiana. Per questo, d’altronde, le filosofie greche, influenzate dalla religione greca, sono filosofie della necessità, mentre le filosofie influenzate dalla religione cristiana saranno filosofie della libertà.» (3)
Si tratta, ovviamente, di affermazioni discutibili, perché è evidente che nella scelta di diventare cristiani è implicito l’elemento della libertà di poterlo fare. Ma è anche vero che gli stessi cristiani, a partire dall’assimilazione delle dottrine paoline, diedero grande rilievo alla tematica della “grazia di credere” e che gli stessi Vangeli insistono sul fatto che molti ascoltarono Gesù, e quindi molti ascoltarono i suoi discepoli, ma essi non erano in grado di capire, perché Dio stesso aveva chiuso le loro orecchie ed oscurato la loro vista. Noi preferiremmo osservare, piuttosto, che la filosofia, cioè, i filosofi cristiani, gli stessi Padri della Chiesa, finirono col correggere la credenza religiosa esclusivista e, soprattutto, insistettero sul fatto che non è all’uomo che spetta decidere chi è nella grazia e chi no, chi è predestinato e chi no. Nell’imponente studio di Gilson non ricorre ad esempio il nome di Gotescalco di Orbais, sostenitore della tesi cosiddetta gemina praedestinatio. «Salvezza e condanna sono conseguenza di una scelta assolutamente gratuita da parte del Creatore; portando alle estreme conseguenze gli insegnamenti di Agostino e di Gregorio Magno, il monaco di Orbais rifiuta di identificare la grazia del battesimo, della quale in linea di principio potrebbero beneficiare tutti gli uomini, con la grazia redentrice che deriva solo dalla morte di Cristo.» (3) Risalire alla genesi di queste idee, per esempio in Agostino e Gregorio, potrebbe gettare una luce diversa su tutta la questione.
Non diversamente vanno le cose sul piano del rapporto tra cristianesimo e politica. I primi testi di cui disponiamo, le epistole di san Paolo, invitano esplicitamente gli schiavi ad essere sottomessi ed ubbidienti, quindi ad accettare il loro destino terreno di dannati con l’allegria di chi sa che se le promesse di un imminente ritorno di Cristo non saranno mantenute, sarà una vita infame.
Eppure, nonostante, queste riserve, è giusto ritenere che Gilson sia un passaggio obbligato per chi voglia studiare la vicenda filosofica nel suo insieme e nel suo sviluppo storico. Pur insistendo, ad esempio, sul ruolo decisivo che ebbero le istituzioni ecclesiastiche nella conservazione e nella trasmissione della cultura antica, egli si oppose alla tesi di coloro che consideravano il Medioevo come semplice magazzino dei tesori intellettuali dell’antichità, ed evidenziò il contenuto ed il valore proprii della filosofia del XIII e del XIV secolo. Tesi con la quale è facile concordare. Scendendo nel particolare, possiamo anche convenire con Mario Dal Pra quando evidenziava l’estrema importanza dello studio di Gilson sulla differenze tra la filosofia di Aristotele e quella di san Tommaso. «L’obiettivo principale – scriveva Dal Pra – dell’indagine gilsoniana è quello di deterrminare le distinzioni tra la filosofia di Aristotele e la filosofia di S. Tommaso, che pure hanno in comune il realismo sostanzialistico. Ma al sostanzialismo di Aristotele manca, secondo Gilson, una distinzione che è invece centrale nel pensiero di Tommaso, la distinzione tra l’essenza e l’actus essendi; l’essenza ci rinvia al mondo delle forme; ma mentre per lo Stagirita esso è presente nella sostanza reale in una maniera non determinata e problematica, Tommaso considera il mondo delle forme come potenza, cui solo l’actus essendi conferisce concreta realtà nella sostanze individuali; e mentre in Aristotele la realtà della sostanza individua rinvia solo ad una gerarchia di pure strutture formali, in Tommaso si può risalire dall’actus essendi che realizza le forme nelle sostanze all’intervento creativo di Dio, principio al tempo dell’intelligibilità e dell’essere stesso delle cose. Il Gilson ha ricavato dalla sua riflessione sul tomismo una dottrina filosofica che, anche con elaborazioni più tarde, come L’être et l’essence del 1948, insiste particolarmente sul primato dell’essere nella costituzione metafisica della sostanza, o, se si vuole, sulla metafisica dell’esistenza che ha appunto in Tommaso la base storica più significativa. In tal modo non soltanto egli accentua il distacco del pensiero cristiano dal rilievo ontologico preminente attribuito alle strutture essenzialistiche del platonismo e dalle molteplici correnti platonizzanti (in cui rientra, in parte, anche la pur originale posizione aristotelica), ma accosta, nello stesso tempo, l’interpretazione del pensiero cristiano ai temi dell’individualità e dell’esistenza che hanno particolare rilievo nel pensiero contemporaneo.» (4)
La grande idea di Gilson è condensata in queste parole: «Nulla di più falso che il considerare la filosofia medioevale come un episodio che troverebbe in sé stesso la propria conclusione e che si può passare sotto silenzio quando si espone la storia delle idee. È dal Medioevo che escono direttamente le dottrine filosofiche e scientifiche sotto le quali si pretende di subissarlo; è il Medioevo ad aver criticato le specie intenzionali, le forme specifiche e le altre astrazioni realizzate; è il Medioevo infine ad aver praticato per primo una filosofia libera da ogni autorità, anche umana. Bisogna quindi relegare nell’ambito delle leggende la storia di un Rinascimento del pensiero che succede a dei secoli di sonno, di oscurità e di errore…» (5)
Ovvio, tutto ciò andrebbe preso con minore entusiasmo e molte precauzioni. Rimane innegabile che il Medioevo non fu propriamente una fase di progresso delle scienze e quindi della consapevolezza da parte dell’uomo delle proprie possibilità cognitive e pratiche. Esso si può interpretare, complessivamente, come la storia del tentativo di ricostruire una cultura classica, alla luce della fede cristiana, dopo il crollo dell’impero romano antico e le invasioni barbariche. Questo tentativo fu compiuto da una minoranza infima di preti, monaci e fraticelli, gli unici veri intellettuali dell’epoca, che fecero questo convinti di fare così “la volontà di Dio”. La fine del Medioevo fu segnata dal sorgere di una intellettualità laica ed inquieta, ovviamente insieme al fiorire delle città e delle attività artigianali e mercantili.
note:
1) Mario Dal Pra – Presentazione all’edizione italiana de La philosophie au moyen àge – La Nuova Italia, edizione anastatica, quinta ristampa, novembre 1990
2) Etienne Gilson – La filosofia nel Medioevo – La Nuova Italia, edizione anastatica, quinta ristampa, novembre 1990
3) Mariateresa Fumagalli Beonchio Brocchieri e Massimo Parodi – Storia della filosofia medioevale – Laterza 1989
4) Mario Dal Pra – Presentazione all’edizione italiana de La philosophie au moyen àge – La Nuova Italia, edizione anastatica, quinta ristampa, novembre 1990
5) Etienne Gilson – La filosofia nel Medioevo – La Nuova Italia, edizione anastatica, quinta ristampa, novembre 1990
THOMAS NAGEL

A cura di Alessandro Sangalli
«Il nucleo della filosofia sta in certe questioni che lo spirito riflessivo umano trova naturalmente sconcertanti, e il modo migliore per cominciare lo studio della filosofia è pensarci sopra direttamente».
1. Vita e opere
Thomas Nagel nasce a Belgrado il 4 luglio del 1937, ma ha ottenuto la cittadinanza americana nel 1944. Prima di diventare professore di Filosofia e Diritto alla New York University, ha studiato alle università di Cornell, Oxford e Harvard; in quest’ultima ha conseguito il PhD nel 1963. È conosciuto soprattutto nel campo dell’epistemologia e della filosofia della mente, ma ha pubblicato lavori di rilievo anche in ambito morale (filosofia politica, etica, filosofia del diritto). Le sue opere principali sono: La possibilità dell’altruismo (1970); Questioni mortali (1979) raccolta di saggi e articoli, tra i quali “La bisezione del cervello e l’unità della coscienza” del 1971 e il famoso “Che effetto fa essere un pipistrello?” del 1974; Uno sguardo da nessun luogo (1986); Una brevissima introduzione alla filosofia (1987); I paradossi dell’uguaglianza (1991); L’ultima parola. Contro il relativismo (1997). Tra parentesi è indicata la data dell’edizione originale inglese.
Membro della American Academy of Arts and Sciences e della British Academy, Nagel ha più volte collaborato con la Guggenheim Foundation, la National Science Foundation e la National Endowment for the Humanities.
2. La filosofia della mente
Oramai da alcuni decenni la filosofia della mente sta alimentando un acceso dibattito, vivo in particolar modo nel mondo anglosassone. Autori come Chomsky, Putnam, Davidson, Fodor e Nagel propongono teorie molto differenziate, motivo di continue critiche, rielaborazioni, confronti e discussioni. Queste teorie sono spesso altamente articolate, in quanto coinvolgono a diversi livelli la filosofia, le neuroscienze e la scienza cognitiva, ma in tutte si può individuare come nucleo principale la riflessione sul tema dell’intenzionalità. L’idea di intenzionalità (dal termine scolastico intentio) risale all’opera di quello che forse può essere definito il primo filosofo della mente in senso moderno: l’austriaco Franz Brentano (1838-1917). Con ciò egli voleva significare quella caratteristica fondamentale dei fenomeni psichici, per cui essi si riferiscono necessariamente a un oggetto immanente (non si dà rappresentazione mentale senza un oggetto; o, in altri termini, la coscienza è sempre coscienza di qualche cosa).
I diversi punti di vista su questo complesso fenomeno psichico si dividono solitamente in due grandi gruppi, caratterizzati da un differente approccio di base: si tratta della prospettiva esternista (externalism) e di quella internista (internalism). La prospettiva esternista sostiene una costante correlazione della mente col mondo in cui essa agisce. In tal maniera, viene meno l’idea tradizionale dell’autonomia delle dinamiche cognitive, e viene evidenziata l’essenza oggettiva e sociale del significato. La prospettiva internista afferma invece l’indipendenza dei fatti mentali, difende l’autonomia della mente rispetto al mondo esterno.
Thomas Nagel è uno dei maggiori esponenti della teoria internista, convinto che la coscienza e l’esperienza soggettiva non possano essere ridotti ad un’attività cerebrale basata su impulsi e sensazioni: un punto di vista che si può quindi definire come una forma di antiriduzionismo. Egli sostiene che l’esperienza soggettiva della coscienza non può in nessun modo essere colta attraverso i metodi oggettivi della scienza: la scienza, alla ricerca di una descrizione generale e oggettiva della natura, non potrà mai fare proprio il carattere costituzionalmente soggettivo della mente umana. Di conseguenza, Nagel ritiene che il problema mente-corpo non si ponga nemmeno, o se non altro non si possa porre in modo sensato, poiché sembra improbabile concepire una teoria fisicalistica della mente. Benché molti filosofi e neuroscienziati cognitivisti accettino la fondamentale distinzione tra soggettivo ed oggettivo, tuttavia spesso non accettano le conclusioni alle quali perviene il nostro autore.
Uno degli articoli più famosi di Nagel è certamente quello intitolato “Che effetto fa essere un pipistrello?”, uscito nel 1974 su The Philosophical Review e ristampato nella raccolta Questioni mortali cinque anni più tardi. Si tratta di un punto di riferimento essenziale per chi nutre interessi filosofici e scientifici riguardo al tema della coscienza: questo scritto contiene infatti già buona parte delle argomentazioni che hanno animato il dibattito filosofico recente sulla natura della coscienza. Nagel ha anticipato molte considerazioni che sono state avanzate nei due decenni successivi, condensandole in un articolo breve ed efficace.
L’articolo nasce da una riflessione molto semplice: cosa significa condividere la stessa realtà per esseri con apparati sensoriali così diversi come l’uomo e il pipistrello? Nel testo, Nagel rivendica la necessità di una fenomenologia capace di mostrare i caratteri comuni della condivisione di un mondo da parte di esseri che abbiano sensi e concetti differenti dai nostri: lo fa per risolvere il paradosso per cui, se definiamo le soggettività come monadi incomunicanti e l’oggettività come ciò che può venir compreso dalla fisica, allora un pipistrello e un uomo abiterebbero in due mondi completamente diversi. Egli vuole affermare che la vera sfida per una teoria della mente che intenda confrontarsi anche con il problema dell’io e della soggettività è la coscienza, termine che – secondo la lezione di Brentano, poi ripresa da Husserl – si connette strettamente a quello di intenzionalità, nel senso del riferirsi a o di dirigersi consapevolmente verso qualche cosa, sia esso un oggetto esistente o meno. Tale sfida è stata accolta in particolare da John R. Searle, sul versante filosofico, e da Gerald M. Edelman, sul versante delle neuroscienze: entrambi gli autori hanno elaborato una teoria naturalista della coscienza che, pur facendo riferimento ai dati sperimentali della neurobiologia, non accetta l’idea che la mente sia ridotta al cervello e tanto meno eliminata in favore di un agglomerato di neuroni e sinapsi. L’obiettivo comune di Searle e di Edelman è una teoria non-riduzionista ed evoluzionista della mente che riesca a tenere insieme le attuali conoscenze sull’architettura del nostro cervello, che ci portano a riconoscere la reale esistenza degli stati mentali e degli stati cerebrali.
La nostra domanda – forse banale – potrebbe essere questa: perché Nagel ha scelto proprio il pipistrello? È lui stesso a spiegarci il motivo di tale scelta:
«Ho scelto i pipistrelli invece delle vespe o dei passeri perché se ci si allontana troppo dall’albero filogenetico, gli uomini perdono gradualmente la fiducia sul fatto che vi sia realmente esperienza. I pipistrelli, benché più vicini a noi che le altre specie citate, presentano tuttavia una gamma di attività e un apparato sensorio così differenti dai nostri che il problema che desidero porre è eccezionalmente nitido (sebbene possa certamente essere sollevato anche a proposito di altre specie). Anche senza il beneficio della riflessione filosofica, chi ha passato un po’ di tempo in uno spazio chiuso con un pipistrello agitato sa che cosa vuol dire incontrarsi con una forma di vita fondamentalmente estranea».
3. Filosofia morale e politica: contro il relativismo
In L’ultima parola troviamo ancora una volta ribadita un’idea centrale nel pensiero di Nagel: oggi la filosofia analitica non può più essere considerata nemica della metafisica e dei valori assoluti come lo era ai tempi del neopositivismo; spesso, anzi, ne è una preziosa alleata. In quest’opera, l’autore sviluppa infatti una serie di importanti argomenti contro il relativismo, come recita il sottotitolo aggiunto nella versione italiana.
Schierarsi contro il relativismo significa per Nagel porsi a difesa della ragione, di una ragione intesa come punto di vista universale. Per il nostro «ragionare significa pensare in modi che chiunque dovrebbe poter riconoscere autonomamente come correnti», per cui la ragione è quello stesso logos che per primo Eraclito chiamò comune, universale, quel discorso razionale che permette a tutti di comunicare, di vivere nello stesso mondo, come accade a quanti sono svegli, e non ciascuno in un suo mondo particolare, come accade a coloro che sognano. La negazione di questa ragione, cioè il relativismo – sia teoretico che etico-morale – viene considerata da Nagel come l’espressione della pigrizia intellettuale della cultura contemporanea, come ostacolo insormontabile verso ogni discussione seria, come autocontraddizione e vacuità.
Contro il relativismo, Nagel ripropone come sempre valida, malgrado l’accusa di formalismo rivoltale da Martin Heidegger, la confutazione classica, secondo la quale il relativismo, applicato a se stesso, si autodistrugge. Ma oltre a questo egli porta anche numerosi altri argomenti, tra i quali è particolarmente interessante quello secondo cui il pensiero non può essere compreso dall’esterno e quindi non può essere interamente ricondotto a spiegazioni di tipo psicologico, sociologico o antropologico, perché queste a loro volta sono soggette alle leggi del pensiero, cioè della logica, che sono innegabili.
Oltre alla logica e al linguaggio, di cui mostra il carattere irriducibilmente intenzionale e quindi il necessario collegamento col pensiero, Nagel difende dagli attacchi del relativismo anche la scienza e l’etica. Chiunque faccia un’autentica esperienza di ricerca scientifica – egli osserva – sa che per mezzo di essa non si impone nessun ordine soggettivo al mondo, ma si cerca di scoprire un ordine non fatto da noi. Analogamente, chiunque discuta di etica non si limita ad esprimere semplici desideri, ma cerca delle giustificazioni, delle ragioni universalmente condivisibili. Un altro tema di particolare interesse, nel libro in questione, è la trattazione del naturalismo evoluzionistico, cioè del tentativo di spiegare la logica e l’etica per mezzo dell’evoluzionismo darwiniano. Contro di esso, l’autore fa valere l’argomento sopra esposto, secondo cui il pensiero non può essere spiegato dall’esterno, per cui “l’ultima parola”, in definitiva, spetta all’epistemologia, cioè ad una teoria razionale della conoscenza e della mente. Interessante è soprattutto l’osservazione secondo la quale l’evoluzionismo spesso è accolto per timore che l’unica alternativa ad esso sia la religione, nei cui confronti anche persone intelligenti nutrono una vera e propria paura, una paura tale da sperare, o volere, che Dio non esista. Secondo Nagel, il piano religioso e trascendente non è l’unica alternativa al naturalismo evoluzionistico: ne esistono anche altre, che rimangono sul piano della razionalità.
A riprova di questa sua posizione, nel campo della filosofia politica, Nagel sostiene una forma di liberalismo egualitario in contrasto con quello di stampo liberista: secondo quest’ultimo modello il rapporto tra individui e stato deve partire da una rigida definizione dei diritti di proprietà intesi come diritti naturali inalienabili. Per il nostro, al contrario, anche gli stessi diritti di proprietà esigono di essere definiti entro un quadro più ampio di valori e di ragioni che legittimano la cooperazione sociale e, dunque, un certo tipo di tassazione rispetto ad un’altra. A questi temi ha dedicato un libro scritto a quattro mani con Liam Murphy dal titolo The myth of ownership: taxes and justice (2002).
VLADIMIR JANKÉLÉVITCH

Vladimir Jankélévitch (Bourges 1903 – Parigi 1985) insegnò all’Istituto francese di Praga e all’Università di Tolosa e di Lille. Dal 1951 al 1977 fu titolare della cattedra di Filosofia Morale alla Sorbona.
Oltre che filosofo, era esperto di musica e pianista. Nel 1944 diresse i programmi musicali di Radio-Toulouse Pyrénées. Durante la Seconda guerra mondiale partecipò attivamente alla Resistenza; in seguito si dedicò con passione alla causa di Israele (Jankélévitch era di origini ebraiche) e alla difesa delle minoranze. Nel ’65 sostenne su Le Figaro Littéraire che Heidegger avesse magnificato in un suo discorso l’attacco tedesco alla Russia; contro questa posizione polemizzò François Fédier, professore di filosofia a Neuilly. Francese di lingua e di cultura, nonostante il nome, Jankélévitch è un pensatore di cui si parla poco, anche alla luce del fatto che si tratta di una figura difficilmente inquadrabile in qualsivoglia linea di pensiero. Originale e versatile, egli svolge riflessioni che per lo più assumono la forma della critica musicale. Nella sua riflessione, il problema musicologico è di primaria importanza e costituisce, per così dire, lo sfondo sul quale si possono leggere tutte le sue riflessioni filosofiche, quasi come se il pensiero filosofico del nostro autore germinasse dalla riflessione sulla musica, in una sorta di musicologia dell’essere. Dunque, la riflessione sulla musica è il luogo privilegiato per venire a capo del pensiero di Jankélévitch: ed è proprio sul problema ontologico intorno all’essenza della musica che il nostro autore si misura costantemente con Henri Bergson, uno degli autori che ha maggiormente influito sulla sua formazione. Infatti, la musica – come ha insegnato Bergson – è percezione del tempo, di un tempo despazializzato che permette a Jankélévitch di introdurre il tema dell’intuizione musicale. Del resto, l’influenza bergsoniana è ben presente in tutti i pensatori francesi del Novecento, ancorché in Jankélévitch venga sottoposta a notevoli rielaborazioni. Il punto di vista musicologico del nostro autore si inscrive pienamente nella crisi della metafisica e del sistema tonale: egli ha sempre svolto in parallelo studi musicali e studi filosofici, passando di continuo dal pianoforte alla scrivania. L’evento che sicuramente l’ha più segnato sono state le persecuzioni naziste ai danni degli ebrei, alle quali dedicherà buona parte delle sue riflessioni filosofiche. Tra le sue opere principali ricordiamo Henri Bergson (1931, con prefazione di Bergson stesso), L’ironia, Trattato delle virtù (1949), Debussy e il mistero (1949), Filosofia prima (1954), Il perdono, La musica e l’ineffabile (1961), Il non-so-che e il quasi-niente (1967), L’avventura, la noia, la serietà, Perdonare?, Il paradosso della morale, La coscienza ebraica. Molto apprezzato da Derrida, Jankélévitch elabora una filosofia che si configura come capovolgimento metafisico delle categorie tradizionali, arrivando a rompere i legami con la scienza e coi valori dominanti, i quali, compromessi col potere politico, hanno fatto scaturire le grandi tragedie storiche che hanno costellato il Novecento. Quello di Jankélévitch sembra, a tutta prima, un decostruzionismo sfociante nel nichilismo: eppure il nostro autore non si limita alla pars destrunes, ma anzi cerca di costruire una filosofia fondativa, che addirittura qualifica come “filosofia prima” nella quale senso e non-senso si fondono insieme. Quello di Jankélévitch è allora rifiuto dell’ordine esistente e anelito verso un ordine “altro”, che è pur sempre un ordine. A quest’ordine “altro” egli dà il nome di “ineffabile”, a segnalare che si tratta di una sfera fondante che sfugge alla presa dei concetti e che, a ben vedere, solo la musica sembra cogliere. Accanto alle interessantissime riflessioni sulla musica, Jankélévitch si concentra molto sul tema del perdono, in riferimento alla shoà: soprattutto nei due testi Il perdono e Perdonare. Paradossalmente, si tratta di due testi che approdano a esiti opposti: il primo è un saggio filosofico sul perdono, il secondo è un violento pamphlet contro i crimini di cui si è macchiato il popolo tedesco. Ne Il perdono, Jankélévitch approda a una “etica iperbolica” che ammette il perdono come possibilità estrema: infatti – dice Jankélévitch – il perdono autentico può essere accordato soltanto a un crimine imperdonabile, giacchè non ha alcun senso perdonare il perdonabile. In questa prospettiva, è solo all’imperdonabile che deve rivolgersi il perdono: come ha notato acutamente Derrida, siamo di fronte ad un’aporia, nel senso che tra perdono e impossibilità di perdono viene a crearsi un nesso inestricabile, una tensione dialettica tra possibilità e impossibilità. Il perdono, allora, è un paradosso, proprio perché la possibilità di perdonare si dà soltanto dove c’è l’imperdonabile. A proposito del Nazismo e del popolo tedesco, Jankélévitch è durissimo: “il perdono non è fatto per i porci e per le loro scrofe. Il perdono è morto nei campi della morte” (Perdonare). La shoà è, secondo Jankélévitch, l’inespiabile e, in forza di ciò, non può esserci perdono per essa. L’irrevocabilità, l’incancellabilità, l’inespiabilità della shoà rivelano l’impossibilità di accordare il perdono, l’impossibilità di tornare sul passato e di toccarne la memoria. Il perdono viene a configurarsi come una sorta di eccezione assoluta: già Kant notava che il perdono può essere concesso soltanto da parte della vittima, non da altri; questa convinzione, se applicata alla shoà, diventa assai problematica, nella misura in cui le vittime non ci sono più. In particolare, Jankélévitch attacca quanti vorrebbero cancellare il passato tramite il perdono, facendo ritorno a quel che c’era prima che il misfatto venisse compiuto: accordare un simile perdono sarebbe assolutamente immorale, oltre che assurdo. Un pedonare autentico dev’essere piuttosto inteso come un andare oltre il crimine senza però azzerarne la memoria, ma anzi mantenendola sempre vivissima. Detto altrimenti, il perdono non annulla il male. Alla fine del saggio Il perdono, si parla del “risentimento”, termine che Jankélévitch impiega in senso opposto a quello di Nietzsche: dove non si può fare alcunché, si può almeno ri-sentire inesauribilmente; non è rancore, è piuttosto orrore intramontabile per quanti hanno compiuto il male, per quanti non si sono opposti, per quanti hanno già dimenticato. Nei suoi colloqui col premio Nobel Eli Wiesel, Jankélévitch ha insistito molto sul tema del testimone, che è custode della fiaccola sacra del ricordo, colui che ri-sente le ferite del tempo. Il testimone riattiva la memoria, la quale obbedisce a una logica reiterativa e commemorativa. Dopo la pubblicazione de Il perdono, Jankélévitch – che aveva sostenuto che oggi i Tedeschi dormono bene e hanno del tutto scordato le loro colpe – ha una corrispondenza epistolare con un cittadino tedesco: questi scrive al filosofo che, pur essendo tedesco, non ha ucciso nessuno e non dorme bene la notte, ma anzi si sveglia spesso a pensare con sgomento alla shoà; dice inoltre che se passerà a trovarlo in Germania non gli parlerà di Hegel o di Nietzsche, né gli farà sentire musica tedesca. A questa lettera risponde Jankélévitch, dicendo che erano trentacinque anni che attendeva una simile lettera: dice che è vecchio per andare a trovarlo in Germania ma che se passerà lui da Parigi si potranno mettere a suonare insieme il pianoforte.
JEAN-LUC MARION

A cura del prof. Giovanni Ferretti
A. Il contesto della produzione dell’autore e il contesto filosofico-culturale [1].
Jean-Luc Marion è indubbiamente uno degli autori più brillanti della filosofia francese contemporanea. Nato nel 1946, è stato allievo della prestigiosa École Normale Supérieure di Parigi ed è attualmente professore all’Università di Paris-Sorbonne (Paris IV) e a quella Chicago[2]. Appartiene alla generazione di filosofi che è immediatamente seguita a figure di primo piano come Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, con i quali è ancora in dialogo e di cui porta avanti e discute le posizioni, nate da un serrato ed inventivo confronto con la Scuola fenomenologica di Husserl, la filosofia ermeneutica e l’ontologia di Heidegger, nonché con i problemi posti alla riflessione filosofica dalla fine della metafisica e dal diffondersi del nichilismo. Appartengono alla sua stessa generazione e ne condividono il plesso problematico, autori come Michel Henry, Didier Franck, Jean-Louis Chrétien, Jean Greisch, per limitarci ai nomi più noti di una schiera di filosofi di alta levatura che oggi in Francia hanno ripreso con grande impegno e indubbi risultati il lavoro teoretico propositivo della filosofia.
Per introdurre alla lettura di quest’opera, recentemente tradotta in italiano e non sempre di facile ed immediata comprensione, iniziamo da un’attenta analisi della Prefazione all’edizione italiana del volume, in cui Marion richiama il posto che questo occupa nel contesto della sua produzione, non senza preliminariamente affermare che “si tratta del libro al quale l’autore attribuisce maggior valore” (XII)[3].
Il contesto immediato è quello di un “trittico” in cui esso si colloca al posto centrale. Lo precede il volume, del 1989, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie (Riduzione e donazione. Ricerche su Husserl, Heidegger e la fenomenologia)[4], e lo completa il volume De surcroît. Essais sur les phénomènes saturés (In sovrappiù. Saggi sui fenomeni saturi) del 2001.
Il primo dei volumi citati era un libro di “storia della filosofia applicato alla fenomenologia”, volto cioè ad indagare il metodo fenomenologico seguito da Husserl, il fondatore del movimento fenomenologico, e da Heidegger, il più celebre tra i suoi discepoli ma anche il più originale ed eretico tra i suoi allievi e continuatori. L’intento del libro era di mettere in luce o “liberare” le possibilità ancora aperte a questa scuola di pensiero, impegnandosi in un ripensamento dell’operazione metodica fondamentale o “canonica” della fenomenologia, la cosiddetta “riduzione fenomenologica”. Questa consiste, com’è noto, nella messa tra parentesi, o epoché (sospensione), del giudizio di esistenza circa ogni cosa data per ovvia nel nostro atteggiamento naturale rivolto al mondo, onde ottenere, tramite un’originale ripresa del dubbio metodico cartesiano, di raggiungere il darsi dei fenomeni nella loro assoluta ed indubitabile originarietà e purezza.
Nel volume in questione, Marion cercava di mettere in luce come tale “riduzione” non dovrebbe limitarsi ad assicurarsi del fenomeno come “oggetto”, così avrebbe fatto Husserl, e neppure solo del fenomeno come “ente” o “essere”, così avrebbe fatto Heidegger, bensì “aprire un varco ad una determinazione ancora più originaria del fenomeno, il “dato” (le donné)” (XI)[5]. Questa tesi veniva concentrata nella formula “Autant de réduction, autant de donation”, tradotta in italiano da Rosaria Caldarone con “tanta riduzione, quanta donazione”. Traduzione che noi preferiremmo lasciare nell’indeterminazione del primato tra donazione e riduzione, propria del testo francese, usando la formula italiana “tanta riduzione, altrettanta donazione”. Questo per non pregiudicare il problema del rapporto tra riduzione e donazione, che sarà affrontato da Marion in modo specifico e su cui dovremo ritornare a suo luogo. In ogni caso, sia la tesi del libro, sia la formula in cui è stata concentrata, danno ragione del titolo, Riduzione e donazione, che ne sintetizza bene il tema di fondo se non la tesi.
Come Marion ci ricorda, il libro suscitò inaspettatamente in Francia un’appassionata discussione, cui parteciparono autori di grande notorietà, come P. Ricoeur, J. Derrida, D. Franck, M. Henry, D. Janicaud, J. Greisch, J. Grondin e altri. Marion li cita sia in questa Prefazione sia, più ampiamente e con più precisione, cioè con l’indicazione bibliografica dei loro interventi, nelle “Risposte preliminari” premesse all’edizione di Dato che (cfr. pp. XXXVII-XLIII). Le tesi sostenute nel libro si inserivano infatti in modo originale e provocatorio in un ambiente filosofico-culturale che stava ripensando e riprendendo l’eredità della scuola fenomenologica come prospettiva da valorizzare teoreticamente per “continuare a pensare” dopo il tramonto non solo del metodo dialettico idealistico e marxistico, ma anche del metodo strutturalista. E inoltre, sia pur riprendendone l’eredità, alla presenza della sempre più evidente crisi della metafisica, che ha fatto seguito a tali tramonti, con il conseguente diffondersi del nichilismo; crisi della metafisica e nichilismo testimoniati in particolare da autori come Nietzsche e Heidegger, variamente ripresi nel novecento. Tra i compiti del “pensare” che la filosofia francese avvertiva ed avverte, in primo luogo quello di ripensare la stessa ontologia, giustamente rilanciata da Heidegger, e con essa la questione della verità e di come essa possa darsi nel fenomeno quale sua manifestazione originaria.
La discussione suscitata dalle tesi proposte nel libro Riduzione e donatione, di indole soprattutto storiografica, fecero sentire a Marion la necessità di “passare da un’inchiesta fattuale e storica a una ricerca concettuale ed organica”, che l’impegnò in “dieci anni di duro lavoro” (XI-XII). L’esito di tale lavoro è appunto il volume Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione, del 1997-98, di cui nella “Prefazione”, come poi nella “Risposte preliminari”, Marion ricorda sinteticamente il contenuto dei cinque capitoli, che fin d’ora segnaliamo con i loro rispettivi titoli:
1) La donazione. Il fenomeno è interpretato come “dato”, cioè “donato” secondo la “donazione”.
2) Il dono. Si studia il fenomeno “dono”, che viene anch’esso ricondotto alla “donazione”.
3) Il dato. I: Determinazioni. Si analizzano le “determinazioni” del dato che permettono di tradurre la fenomenalità in termini di donazione puramente immanente.
4) Il dato. II: Gradi. I vari gradi dei fenomeni vengono individuati secondo il quantum di donazione che in essi si ritrova, fino a giungere all’analisi dei cosiddetti “fenomeni saturi”, in cui si ha il massimo di donazione possibile e quindi anche il paradigma di ogni fenomenalità.
5) L’adonato. Si procede alla caratterizzazione del “soggetto” che accoglie la donazione, il cosiddetto “adonato”, quale “figura della soggettività accordata a e attraverso la donazione” (XII).
Dovremo ritornare sulla struttura di quest’opera, ad iniziare dal suo titolo francese e dalla difficoltà di tradurlo in italiano. Seguendo per ora la “Prefazione” di Marion, ricordiamo il terzo volume del trittico, il già menzionato De surcroît. Essais sur les phénomènes saturés, con cui egli ha ritenuto necessario completare Dato che, approfondendone il quarto capitolo, ancora troppo astratto e formale, con una descrizione più analitica dei “fenomeni saturi”, tra cui, in particolare, il fenomeno di “Rivelazione”, specificamente il Cristo.
In complesso il trittico, al cui centro si situa Dato che, ha nell’intenzione di Marion una ben precisa mira teoretica, sintetizzata dall’autore stesso nella “Prefazione” come segue:
Questo insieme mira a rendere possibile una ripresa della fenomenologia, liberandola dai due orizzonti i cui limiti ci sono divenuti evidenti (l’oggettualità, l’essere), senza perdere la radicalità di un metodo la cui fecondità ha attraversato il secolo che si è appena compiuto. Fecondità che resta uno dei punti di riferimento per una filosofia che intende pensare dopo e grazie alla fine della metafisica. Speriamo che altri andranno più lontano in questa direzione (XII).
Dunque l’intento dell’opera è liberare la fenomenologia dal suo situarsi nei due orizzonti ontologici di senso, quello dell’oggetto (come si avrebbe in Husserl) e quello dell’essere (quale si avrebbe in Heidegger), che sono ritenuti da Marion inadeguati in ordine alla sua fecondità teoretica. Ci potremmo chiedere: di quale fecondità si tratta? La risposta, che in questa “Prefazione” Marion ci dà solo implicitamente, va individuata, a nostro avviso, nell’impegno teoretico di fondo che sembra reggere tutta la ricerca di Marion: ripensare l’ontologia dopo la crisi della metafisica; o meglio ancora, situandosi sulla scia di Levinas – tentare di aprirsi ad un livello fenomenologico più originario di quello dello stesso “essere”, almeno come pensato dalla tradizione filosofica occidentale fino ad Heidegger. E ciò per ripensare radicalmente non solo il rapporto tra teologia e metafisica (pregiudicato dalla crisi della metafisica) ma anche quello tra teologia e ontologia (considerato inadeguato anche nei termini proposti da Heidegger).
Questo intento emerge con nettezza se, continuando la lettura della Prefazione, vediamo come Marion ci ricordi che Dato che riprende alcune questioni lasciate in sospeso da un suo libro anteriore, Dieu sans l’être, del 1982[6]. In quest’opera, Marion si poneva esplicitamente sulla scia della tematica inaugurata da Levinas. Questi aveva per primo posto con estremo vigore l’esigenza di tentare di “intendere un Dio non contaminato dall’essere”[7], cioè non solo oltre l’orizzonte degli enti, come richiesto da Heidegger per andare oltre l’interpretazione di Dio in termini metafisici, ma anche oltre l’orizzonte stesso dell’essere coestensivo con il pensiero, orizzonte considerato inadeguato a salvaguardare la trascendenza assoluta del Dio biblico. Come Marion ci dice, “si trattava di sottrarre la questione di Dio non solo alla metafisica (e alla sorte della “morte di Dio”), ma a ciò che rendeva possibile l’interrogazione, divenuta tanto ossessiva quanto imprecisa, sull’“esistenza di Dio”, e cioè l’orizzonte ininterrogato dell’essere come unico quadro supposto per la sua presenza” (XII).
L’opera procedeva, nella sua pars destruens, alla critica di ogni concezione idolatrica di Dio; ove per idolo Marion intende ogni comprensione di Dio tramite concetti umani, ossia ogni idea di Dio elaborata a partire da e tramite concetti umani. In tale contesto, Marion chiama idoli non solo i concetti chiaramente antropomorfi propri degli dei pagani, ma anche i concetti propri della metafisica: quello dell’ente, che ci porta a pensare Dio come l’ente sommo, causa trascendente di ogni altro essere; quello del comando etico, che porta a considerare Dio come il fondamento della morale (il “Dio morale” alla Kant, criticato da Nietzsche con la nota tesi della “morte di Dio”); quello della “volontà di potenza”, elaborato da Nietzsche per superare la visione metafisica di Dio, ma che ha aperto un nuovo orizzonte idolatrico del divino, che si ritrova, appunto, nella volontà di potenza come valore assoluto del nostro tempo pervaso di nichilismo.
Ma la comprensione idolatrica di Dio non è superabile, secondo Marion, neppure pensando Dio nello sfondo dell’”essere nella sua differenza dall’ente”, come proposto da Heidegger per risolvere il problema dei rapporti tra filosofia e teologia. Anche in questo caso, infatti, Dio sarebbe pensato a partire da un’istanza che lo precede, cioè da una pre-comprensione umana, sia pur la più ampia, come quella dell’essere, sfociando inevitabilmente in una nuova concezione idolatrica di Dio. “Al di là dell’idolatria propria della metafisica, anche in questo caso è dunque all’opera un’altra idolatria, propria del pensiero dell’Essere in quanto tale”[8].
A questa pars destruens, in Dio sensa essere Marion faceva seguire una pars costruens, in cui si proponeva di pensare Dio con il termine di “amore” (agape). Ove il termine amore, agape, veniva tratto dalla rivelazione biblica, in particolare dal celebre testo della Prima lettera di San Giovanni, “Dio (è) agape” (1 Gv 4,8), per poi essere elaborato concettualmente in termini di “dono” e di “donazione”. I due tratti decisivi dell’amore-agape erano infatti individuati, già in tale opera, 1) “nel fatto che esso si dona…. senza condizioni (previe)”[9], e 2) che esso “non pretende di comprendere, dato che non ha la minima intenzione di prendere”[10]. Amando, infatti, il donatore si abbandona completamente alla donazione fino a “coincidere rigorosamente con questo dono”, senza in alcun modo distanziarsene con la com-prensione o ri-presa concettuale del proprio dono[11].
L’amore esclude quindi l’idolo, o meglio lo sovverte, perché nel movimento del dono il soggetto non investe l’altro con la sua concettualità ma si abbandona totalmente a lui, fino a lasciar determinare se stesso da questa donazione. Un “pensiero del dono” riuscirebbe così a pensare Dio senza reintrodurre il meccanismo della sua trasformazione in un idolo concettuale; esso infatti non lo pensa a partire da un nostro concetto ma a partire dal suo stesso donarsi. Ben esprimono questa posizione le seguenti citazioni, in cui si ha chiara testimonianza di come Dato che riprenda temi già affrontati in Dio senza essere.
La prima citazione riguarda in particolare i tratti di fondo della fenomenologia dell’amore in termini di dono-donazione.
“L’amore non si dona se non abbandonandosi, trasgredendo continuamente i limiti del proprio dono, sino a trapiantarsi fuori di sé. La conseguenza è che questo trasferimento dell’amore fuori di se stesso, trasferimento senza fini né limiti, impedisce immediatamente che ci si lasci prendere in una risposta, in una rappresentazione, in un idolo. È tipica dell’essenza dell’amore – diffusivum sui – la capacità di sommergere, così come un’ondata sommerge i muraglioni di una diga foranea, ogni limitazione, rappresentativa o esistenziale, del proprio flusso; l’amore esclude l’idolo o, meglio, lo include sovvertendolo. Può anche essere definito come il movimento di una donazione che, per avanzare senza condizioni, s’impone un’autocritica permanente e senza riserve. L’amore, infatti, non si riserva nulla per sé, né se stesso, né la propria rappresentazione. La trascendenza dell’amore significa innanzitutto che esso si autotrascende in un movimento critico nel quale nulla – neppure il Niente/Nulla – può contenere l’eccesso di una donazione assoluta – assoluta: liberata da tutto ciò che non si esplica in questo abbandono stesso”[12].
La seconda citazione, che immediatamente segue nel testo, riguarda i risvolti teologici di tale fenomenologia, ma anche, per un procedimento circolare, la sua stessa derivazione teologica.
“Dio non può darsi da pensare senza idolatria se non a partire esclusivamente da se stesso, darsi da pensare come amore e quindi come dono; darsi da pensare come un pensiero del dono. O meglio, come un dono per il pensiero, come un dono che si dà da pensare. Ma un dono, che si dona per sempre, non può essere pensato se non da un pensiero che si dona al dono da pensare. Solo un pensiero che si dona (se donne) può consacrarsi (s’adonner) ad un dono per il pensiero. Ma cosa significa, per il pensiero, donarsi se non amare?”[13].
Avendo così richiamato, sia pur per sommi capi, il tema e l’impostazione di Dio senza essere, possiamo meglio comprendere l’annotazione che Marion fa, nella Prefazione di Dato che, circa la diversità metodologica di quest’opera rispetto alla prima. In quella prima opera, mentre il versante critico, ossia la pars destruens, si manteneva strettamente nel campo della filosofia, il versante costruttivo, la pars construens dell’accesso alla “carità” come senso del divino oltre l’orizzonte dell’essere, veniva direttamente desunto dalla teologia. La difficoltà metodologica di tale immediato ricorso alla teologia da parte della filosofia, viene invece superata in Dato che. In quest’opera, infatti, Marion ritiene di essere giunto a dare uno schizzo del fenomeno stesso della “carità”, ossia della donazione fino all’abbandono totale di sé, senza far ricorso diretto alla teologia, bensì tramite un rigoroso uso del metodo fenomenologico. Ciò in particolare nella descrizione fenomenologica dei “fenomeni saturi”, culminanti in quel fenomeno saturo per eccellenza che è appunto la Rivelazione cristologica.
La distinzione tra filosofia e teologia viene così mantenuta, perché con il metodo filosofico-fenomenologico si giunge solo alla delineazione del senso o della “possibilità” dello straordinario fenomeno della “rivelazione” di Dio come amore-donazione assoluta, lasciando alla teologia, che riflette a partire dalla fede, l’accertamento della “realtà effettiva” di tale rivelazione. Non diversamente da ciò che avviene per l’analisi fenomenologica del fenomeno del “dono” in generale, che è in grado di studiare il senso e la possibilità del fenomeno “dono” pur prescindendo dal problema della constatazione storico-empirica del darsi in concreto di “doni/donazioni” autentici.
La distinzione tra filosofia-fenomenologica e teologia, così delineata da Marion, non toglie però – osserviamo noi – che fra le due discipline si dia un mutuo influsso di carattere circolare. Per un verso, infatti, è solo a partire dall’esperienza del darsi di doni effettivi, fino all’incontro storicamente datato con la rivelazione cristiana della “donazione assoluta” di Dio in Cristo, che nasce l’esigenza filosofica di fare una fenomenologia del dono, fino alla fenomenologia del dono-amore assoluto. Per altro verso, la teologia non riuscirebbe a riflettere adeguatamente sulla natura della rivelazione di Dio in Cristo, senza l’aiuto di una corretta fenomenologia del dono come “donazione assoluta” di sé fino all’abbandono[14]. Prova ne sia che la teologia cristiana, senza una tale fenomenologia, è spesso caduta in una concezione metafisica o ontologica di Dio, la quale, invece di pensare correttamente il novum assoluto della rivelazione cristiana di Dio, ne ha dato una versione fortemente impregnata di idolatria concettuale.
Sui rapporti tra fenomenologia e teologia secondo Marion, dovremo ancora ritornare. Per ora ci basti ricordare che tra le prime opere di Marion v’è un’altra opera filosofica di argomento teologico, cioè L’idole et la distance, del 1977[15]. In essa già si affrontava il problema della salvaguardia della trascendenza assoluta di Dio da ogni comprensione idolatrica, quale si ha inevitabilmente ogni qualvolta si cerca di pensare Dio a partire da pre-comprensioni concettuali proprie della coscienza umana. Celebre, in tale opera, oltre la rigorosa fenomenologia dell’idolo, quella dell’icona, entrambi considerati come “due modi di apprensione del divino nella visibilità” [16]. Tuttavia, i due modi sono profondamente differenti. La caratteristica fondamentale dell’idolo è, infatti, che esso si presenta all’interno di un mio sguardo, ossia di una mia visione sensibile o concettuale, di cui compie l’intenzione previa che lo ha di mira. Esso non può quindi uscire dall’orizzonte della pre-comprensione dello sguardo o della concettualità umana. L’icona, invece, capovolgendo i tratti essenziali dell’idolo, mi si presenta come l’apparire di un volto che mi guarda. Nel visibile di ciò che si dà al mio sguardo, io mi avverto quindi come lo specchio di una realtà invisibile, che sfugge ad ogni mia presa o com-prensione, mantenendosi nella sua assoluta “distanza”.
“In questo caso, il nostro sguardo diventa lo specchio di ciò che guarda solo nella misura in cui si trova ad esserne più radicalmente guardato: diventiamo specchio visibile di uno sguardo invisibile che ci sovverte commisurandoci alla propria gloria…… Al contrario dell’idolo, che misurava la magra della nostra mira, l’icona sposta i limiti della nostra visibilità commisurandola a quella che le è propria, cioè alla sua gloria. Essa ci trasforma nella sua gloria, facendola risplendere sul nostro viso che le fa da specchio; ma uno specchio bruciato da questa stessa gloria, che si trasfigura di invisibile e che, a forza di essere saturata al di là di se stesso da questa gloria, ne diventa, esattamente anche se imperfettamente, l’icona: visibilità dell’invisibile come tale”[17].
La tematica teologica, centrale nella due opere sopra ricordate, resterà senza dubbio sullo sfondo degli interessi di Dato che anche se ora Marion è impegnato a svolgerla in termini rigorosamente filosofici. Come già nelle opere precedenti, anche in quest’opera, secondo quanto sopra accennato, essa s’intreccia sempre più strettamente con la problematica metafisica ed ontologica. Problematiche a cui Marion aveva peraltro dato notevoli contributi storiografici in opere di notevole impegno. Oltre quella sopra ricordata dedicata a Husserl e a Heidegger, vanno menzionati gli studi su Cartesio. Per completare il quadro del contesto delle opere di Marion in cui si situa Dato che, ne citiamo i principali: Sur l’ontologie grise de Descartes, Vrin, Paris 1975 (2 ed. completata 1981), Sur la théologie blanche de Descartes, Puf, Paris 1891 (2 ed. completata 1991), Sur le prisme métaphysique de Descartes, Puf, Paris 1986. Cui si aggiungono i commenti e gli indici alle Regulae ad directionem ingenii e alle Meditazioni metafisiche, rispettivamente del 1976-77 e del 1996, nonché i due volumi di Questions cartésiennes, del 1991 e del 1996.
B. Il titolo dell’opera e il problema della sua traduzione.
Il titolo dell’opera ed anche il modo con cui è stato tradotto in italiano hanno bisogno di una spiegazione, che dopo quanto abbiamo detto nel primo paragrafo può ora risultare di più agevole comprensione. Marion stesso ci offre tale spiegazione, per il titolo francese, nelle “Risposte preliminari” che introducono all’opera (XXXVII-XLIII); mentre Rosaria Calderone ce la offre, per la traduzione italiana, nella “Nota del traduttore” (XXXII-XXXV).
La formula “Étant donné” (alla lettera: “Ente dato/donato” oppure anche “Essendo dato”) non va interpretata, ci avverte Marion, come se un articolo precedesse la prima parola, e quindi intendendola come equivalente di “l’ente dato”. In tal caso, infatti, la si penserebbe in riferimento all’ente come un sostantivo (l’ens latino o l’étant francese, secondo una parola ormai caduta in disuso in tale lingua), di cui essa direbbe soltanto che “si dà”, nel senso che semplicemente “è”. Ove l’espressione “l’ente (è) dato” non farebbe che affermare una tautologia, cioè che “l’ente – ciò che è – è”. Cosa che la filosofia ha ripetuto fedelmente fin da Parmenide, nel cui Poema si trova la celebre espressione: “è necessario dire e pensare che l’ente è”[18].
In questo caso, proprio di una lettura che Marion dice “comune”, ma anche “sapiente e spontanea allo stesso tempo”, la formula ci porterebbe in pieno clima metafisico, non facendo altro che enunciarne uno dei principi di fondo, cioè che “c’è l’ente piuttosto che il nulla”. Ma questa lettura, oltre che essere scorretta sul piano grammaticale – perché aggiunge un articolo che non c’è nel testo – non solo sfocia in una semplice tautologia, ma trascura del tutto il ricorso che nel titolo si fa al termine “dato”, che risulterebbe del tutto inutile e superfluo.“In sintesi – conclude Marion – la lettura spontanea e sapiente di “ente dato” moltiplica “ente” e dimentica interamente “dato”” (XXXVIII).
Rinunciando quindi ad aggiungervi un articolo, la formula va letta intendendo “étant” come verbo ausiliare, che mette in opera un altro verbo; nel caso dell’ausiliare al gerundio, il verbo messo in atto, ossia il verbo “dare”, ne risulta irrevocabilmente compiuto. Così come nelle formule “essendo fatto”, o “essendo detto”, il fare e il dire si trovano del tutto compiuti: “quel che è fatto è fatto”, “quel che è detto è detto”, qui ciò che risulta compiuto è il “dato”: “quel che è dato è dato”. Nella formula “essendo dato”, l’ausiliare si risolve quindi tutto nella funzione di stabilire l’irrevocabile compiutezza del dato.
“Divenendone l’ausiliare, “essendo”, a titolo di verbo, precipita e sparisce nel “dato”, perché non mira che a rafforzarlo; “essendo” pone il fatto del “dato” e vi si deposita per intero” (XXXVIII).
Dandosi di fatto, il “dato” attesta quindi la sua “donazione” e lungi dall’irrigidirsi in un “ente” o nell’“essere”, sottomette anche l’essere (del verbo) alla sua donazione. Donde la pregnante ed illuminante affermazione conclusiva sul senso del titolo dell’opera.
“Tramite lo stesso gesto, il dato conquista la sua donazione e l’“essere” (l’“essendo” verbale) vi scompare, compiendosi. Qui, infatti, il dato dispiega (déplie) verbalmente in sé la sua donazione – cosa che chiameremo “piega (pli) del dato” -, e l’essere ausiliare si dispone (se range) alla donazione che serve. “Étant donné (essendo dato) dice il dato in quanto donato (donné)”[19].
In base a questa spiegazione del significato del titolo francese dell’opera, è più facile comprendere le motivazioni che la traduttrice adduce per la scelta di tradurre Étant donné con Dato che. La motivazione è presentata come una sorta di “imperativo pittorico”, che chiama in causa l’arte di mettere in rapporto il visibile con l’invisibile. In questo caso si tratta di portare a termine quello scomparire o rendersi invisibile dell’essere nel dato, che Marion – come abbiamo visto – intendeva con la formula francese “Étant donné “ (essendo dato). Secondo la traduttrice, la lingua italiana ci offre tale possibilità, poiché può sintetizzare “essendo dato che” nel più semplice “dato che”, in cui il verbo essere scompare, risultando così invisibile, anche se grammaticalmente continua a sostenerne il senso.
“Nel Dato che, dunque, ciò che viene esposto è il “dato” affrancato dall’istanza dell’essere che materialmente non viene più mostrato” (XXXI).
Come già per il titolo francese, anche la formula italiana presenta una certa ambiguità, in quanto si presta ad una lettura “metafisica” che deve essere evitata. Questa lettura si avrebbe se “dato che” venisse inteso come seguito da puntini di sospensione, “dato che….”, sottintendendo il rimando ad una “connessione causa-effetto”: “dato che…, allora…”. Ma ciò contrasterebbe profondamente con il pensiero di Marion, ove il dato è interpretato come equivalente al dono, e quindi va pensato, al di fuori di ogni connessione causale necessitante, come assolutamente libero e gratuito; si pensi all’imporsi del volto dell’altro, del suo amore, ove non ha senso interrogarsi sulla sua causa o sulla sua origine; esso infatti va accolto con ri-conoscenza come ciò che ci rinnova quali soggetti disponibili all’accoglienza. Emblematiche, in tal senso, le espressioni Eccoti! Eccomi!; la prima, dello stupore di fronte all’imprevedibile gratuità del dato/dono, la seconda, della disponibilità alla sua accoglienza, senza previ imbrigliamenti del dato/dono nelle nostre categorie metafisiche di causa-effetto o simili.
Questa concezione del “dato” impedisce quindi di sottintendere a “dato che” dei puntini di sospensione, limitando il senso dell’espressione, che la traduttrice non esita a riconoscere come “aspra ed enigmatica”, alla enfatizzazione del semplice “darsi del dato”, inteso come “l’atto di ciò che precede la coscienza e la costituisce a partire dall’attitudine di ricevere e di rispondere” (XXXII).
Con questa spiegazione, però, l’enigmaticità della traduzione del titolo con Dato che, non è del tutto superata. Rimane infatti in essa come occultata l’ambivalenza del termine francese donné, cui in italiano corrispondono due termini che se ne ripartiscono il campo semantico: dato e donato. Il che farà sorgere un difficile problema di traduzione che si ripropone lungo tutto il corso dell’opera e non solo a proposito del titolo.
La difficoltà non si limita al problema d’interpretare, in base al contesto, quando, nei singoli luoghi, donné significa “dato” e quando significa “donato”, come avverrebbe nella traduzione di un testo francese “normale”. Il “cuore del problema” nasce infatti dalla scelta operata da Marion di tradurre il termine husserliano tedesco Gegebenheit, che i traduttori italiani hanno normalmente tradotto con “datità”, con il termine “donation”.
Una scelta resa possibile dal significato del verbo tedesco “geben” (da cui il participio passato gegeben e l’astratto Gegebenheit) che contiene in sé il significato sia di dare che di donare (da cui il sostantivo Gabe che significa dono). Donde la difficoltà dei traduttori francesi che non avendo l’astratto donneité (a cui pur qualcuno è ricorso)[20], si sono divisi da una parte traducendo con donné, o donnée-en-personne, sottolineando così l’aspetto oggettuale di “esser dato”, e le traduzioni di présence-en-personne o donation, che ne sottolineano, invece, l’aspetto attivo del processo che porta al dato, la “donazione”, appunto.
L’originalità della scelta di Marion non si limita però ad una semplice disambiguazione del doppio senso del tedesco Gegebenheit, che ritorna peraltro nel francese donné (dato/donato), ma nel mettere in evidenza che alla base del “dato” vi è sempre una “donazione”, ed è per questo che il “dato” va inteso come “dono”, ovvero come ciò che nella visibilità del dato contiene un rimando alla donazione che pur rimane, come tale, invisibile.
Quello che a prima vista nel donné francese appare come una ambiguità tra dato e donato, e che l’italiano può sciogliere, nel discorso di Marion – osserva pertinentemente la traduttrice (XXXIII) – si mostra così come il sintomo di una complessità e di una ricchezza: il dato si presenta con la struttura di una “piega”, di un risvolto (le pli du donné, la “piega del dato”), perché contiene al suo interno il rimando alla donazione. “Che cosa nasconde il dato nella sua piega? – si chiede la traduttrice – E cioè, che cosa non mostra il dato, mostrandosi? Il suo carattere proveniente dal dono, dalla donazione, ossia il suo carattere di donato” (XXXIII).
Per questo motivo, non solo filologico ma strettamente teoretico, la traduttrice ha scelto di tradurre “donné” con “dato” e non con “donato”, non solo nel titolo ma normalmente in tutto il corso dell’opera, tranne i casi in cui il contesto non lo esiga perentoriamente. Tradurre “donné” con “donato”, significherebbe infatti trascinare l’invisibile “donazione”, che è serbata nella piega del “dato”, nel regno della luce, della visibilità, contravvenendo all’imperativo pittorico sopra accennato, di “non far vedere ciò che per definizione non è fatto per essere mostrato” (XXXIV).
Con questa spiegazione del senso del titolo dell’opera, sia nell’edizione francese originale che nella traduzione italiana, ci siamo così già introdotti nell’orizzonte dei problemi centrali che saranno affrontati nell’opera. Marion ce li richiamo sinteticamente anche nelle “Risposte preliminari” che introducono l’opera e che noi abbiamo già incontrato prendendo in esame la prefazione all’edizione italiana.
Li possiamo sintetizzare nell’esigenza, che Marion intende far valere, di sviluppare una rigorosa “fenomenologia della donazione” – come recita il sottotitolo dell’opera – al fine di arrivare alle “cose stesse”, ossia ai fenomeni ricercati dalla fenomenologia.
Ma forse è il caso di ricordare ancora alcune questioni cui egli accenna al termine di tali “Risposte preliminari” (XLI-XLIII).
Anzitutto la questione del rapporto tra questa fenomenologia della donazione e la metafisica. Nonostante si sia spesso sostenuto che la fenomenologia si tiri fuori dalla metafisica (se non addirittura che ne contesti la legittimità), per Marion la fenomenologia non “oltrepassa” la metafisica, ma la lascia come una possibilità al suo interno. Una possibilità che andrà esplorata dopo che la via fenomenologica sarà stata ben sgombrata. Ora essa resta solo nello “spazio di una speranza”.
In secondo luogo la questione del rapporto – cui già si è accennato – tra questa fenomenologia e la teologia; soprattutto quando essa affronta la descrizione dei fenomeni saturi, spingendosi fino al fenomeno della Rivelazione, specificatamente il Cristo. Si tratta di una “svolta teologica”, come è stato scritto?[21]. Secondo Marion – che qui si rifà anche al giudizio di Ricoeur – no, in quanto, come già si è detto, egli non intende in quest’opera affrontare la Rivelazione nella sua pretesa di verità effettiva, ma solo nel suo concetto, come possibilità, di fatto come la possibilità ultima, del paradosso dei paradossi della fenomenalità, quale si ha nei cosiddetti fenomeni saturi.
Infine la denuncia preventiva di alcuni possibili malintesi, in cui di fatto alcuni sono incorsi ma che un’attenta lettura del testo dovrebbe permettere di evitare. Vale la pena di tenerli presenti fin d’ora, nelle parole stesse di Marion.
“Quando diciamo che la donazione ridotta non chiede alcun donatore per il suo donato, non stiamo insinuando che essa reclami un donatore trascendente; quando diciamo che la fenomenologia della donazione oltrepassa per definizione la metafisica, non sottintendiamo che questa fenomenologia restauri la metafisica; e quando infine opponiamo alla soggettività trascendentale la figura dell’adonato, non suggeriamo che il soggetto rinasca dalla donazione” (XLII).
Ma per cogliere il senso dei problemi insiti in questi possibili malintesi, e perché Marion li denunci come stravolgimento del suo pensiero, dobbiamo procedere all’esame diretto dell’opera, cui ormai siamo sufficientemente introdotti.
1. Libro I: la donazione.
Il primo libro dell’opera, dal titolo “la donazione”, affronta di fatto l’intera problematica del metodo fenomenologico, intendendo ripensarlo in radice sia per quanto riguarda l’impianto metodico della riduzione sia per quanto riguarda il suo risultato, cioè l’essenza del fenomeno che tende a cogliere.
1. 1. Nel suo primo paragrafo, intitolato “L’ultimo principio”, Marion si propone anzitutto di studiare la natura del “principio” che regge il metodo fenomenologico, esaminandone le varie formulazioni che ne sono state date. Al tema Marion s’introduce parlando della svolta metodologica radicale operata dal metodo fenomenologico, fino a farlo apparire come una sorta di “contro-metodo”.
1. 1. 1. Un contro-metodo, ovvero la “svolta” fenomenologica.
In fenomenologia, egli osserva, si tratta di passare dall’intento di “dimostrare”, proprio delle scienze e della metafisica, a quello di “mostrare”. “Dimostrare” significa infatti ricondurre l’apparenza al suo fondamento, per conoscerla in modo certo, mentre “mostrare” significa far sì che l’apparenza appaia come tale, ossia divenga percepibile in persona. Ma nella fenomenologia, più propriamente ancora, si deve tendere a “mostrare” non tanto privilegiando uno dei sensi, come ad esempio il “vedere”, per cui mostrare significherebbe “far vedere”. Tutti i sensi, da questo punto di vista, vanno infatti considerati alla pari, il vedere come l’udire, il tastare, il percepire ecc. Ciò a cui la fenomenologia deve tendere è piuttosto l’apparire stesso della cosa in seno alla sua apparenza, privilegiando quindi la manifestazione delle cose in sé stesse rispetto ad ogni nostra attività percettiva soggettiva.
Se così stanno le cose, in fenomenologia non basta passare dal “dimostrare” (metafisico) al “mostrare”; un procedimento in cui il soggetto manterebbe pur sempre l’iniziativa.
“Questo primo passaggio deve completarsi con un secondo: passare, cioè, dal mostrare al lasciar mostrarsi, dalla manifestazione alla manifestazione di sé a partire da sé di ciò che, allora, si mostra” (5).
La cosa però non è semplice, dato che la conoscenza proviene normalmente da me, ossia è frutto di una mia attività. Donde quello che Marion chiama il “paradosso iniziale e finale della fenomenologia”, cioè il paradosso di un metodo che consiste precisamente nel “prendere l’iniziativa di perdere l’iniziativa”, presentandosi così non tanto come un “metodo” di cui siamo gli attori, quanto come una specie di “contro-metodo”, in cui i veri attori divengono i fenomeni che si mostrano, e a cui è lasciata l’ultima parola.
Sulla base di queste prime considerazioni, Marion può fin d’ora anticipare in che senso egli intenderà la natura del metodo fenomenologico della “riduzione” e lo stesso famoso e controverso concetto husserliano della “costituzione” come “Sinngebung” (donazione di senso). Costituire – egli afferma – “non equivale a costruire né a sintetizzare, ma a dare un senso, o più esattamente a riconoscere il senso nel fatto che il fenomeno si dà da se stesso” (6). E l’operazione metodica della riduzione consiste esclusivamente nel togliere gli ostacoli che impediscono alla manifestazione di manifestarsi. La riduzione – leggiamo – “sospende le “teorie assurde”, le false realtà dell’attitudine naturale, il mondo oggettivo, per lasciare che i vissuti facciano apparire, per quanto possibile, ciò che si manifesta come e attraverso di essi; la sua funzione culmina, dunque, in una eliminazione di ostacoli alla manifestazione” (6).
Di qui la conclusione sulla natura della “svolta” che il metodo fenomenologico comporta, presentandosi come vero e proprio contro-metodo.
“Il metodo fenomenologico pretende dunque di configurare una svolta, che va non solo dal dimostrare al mostrare, ma dal mostrare, nel senso che si ha quando un ego mette in evidenza un oggetto, a lasciare che un’apparizione si mostri in un’apparenza: metodo di svolta che si rivolge contro se stesso e consiste in questo rivolgimento stesso – contro-metodo” (7, con nostre correzioni alla trad. it.).
1. 1. 2. Esame di tre formulazioni inadeguate del “principio” della fenomenologia e proposta di un quarto principio: “tanta riduzione, altrettanta donazione”.
La svolta metodica della fenomenologia, che sembrerebbe presentarsi in tutta semplicità, a guardarla più da vicino mostra invece tutta la sua difficoltà. Essa emerge in particolare nel tentativo, che è stato fatto a partire da Husserl, di formulare il “primo principio” della fenomenologia, che dovrebbe costituirne come l’indicatore di base del suo procedimento metodico.
Già la ricerca di un principio primo che guidi il procedimento di contro-metodo, che intende “prendere l’iniziativa di disfarsi dell’iniziativa”, si presenta problematica, perché sembra contraddire l’intento stesso del contro-metodo così delineato; invece di lasciare che l’apparizione si mostri come tale, la s’imbriglierebbe in un nostro apriori, il principio primo, che la precede. Più che di un “principio primo” dovrebbe quindi se mai trattarsi di un “principio ultimo”, cioè scoperto alla fine. Ma in questo caso si tratta ancora di un “principio”?
L’aporia del principio, così delineata in generale, ritorna nel vaglio cui Marion sottopone le tre formulazioni classiche del principio della fenomenologia, individuate ed elencate da Michel Henry nel suo saggio sull’opera Réduction et donation di Marion (cit. p. XXXIX, n. 5). Ad esse egli contrapporrà una quarta formulazione, la sua, che ritiene sia l’unica in grado di superare le aporie in cui incorrono le altre (cfr. 14).
1. La prima formulazione suona: “Tanto apparire, tanto essere”. La formula, risalente a J. F. Herbart e ripresa da Husserl e da Heidegger, tende a dare dignità ontologica all’apparire, al fenomeno. Ma in un modo che non solo sembra consacrare l’opposizione, già platonica, tra apparire ed essere, ma lascia del tutto indeterminato il senso dell’apparire. Essa rimane quindi in un contesto metafisico e non dà alcun apporto alla svolta, sopra prospettata come il proprium della fenomenologia, dall’apparire alla manifestazione.
2. La seconda formulazione suona: “Dritto alle cose”. Anch’essa di derivazione husserliana (celebre l’espressione husserliana: Zurück su den Sachen!), enuncia bene la questione in oggetto, ma in modo da ordinarla subito alle “cose”, già presupposte al loro posto prima dell’apparire, riducendo così l’apparire al rango “metafisico” di semplice via d’accesso ad esse. Anche questa formulazione non dà quindi alcun apporto alla comprensione della “svolta fenomenologica”.
3. La terza formulazione, indubbiamente più importante perché Husserl stesso l’ha presentata come il “principio di tutti i principi”, è ad un tempo più complessa e più pertinente. Essa suona, nelle Idee di Husserl, come segue:
“Ogni intuizione donatrice originaria è una sorgente legittima per la conoscenza; tutto ciò che ci si offre originariamente all’intuizione (nella sua effettività, per così dire, in carne ed ossa) deve essere semplicemente ricevuto per il fatto che esso si dà, ma senza oltrepassare i limiti nei quali si dà” (10, con i riferimenti al testo delle Idee).
Marion sottolinea i vantaggi di questa formulazione, che affranca la fenomenologia da ogni rimando metafisico ad un fondamento dell’apparire e da ogni apriori concettuale di tipo kantiano; “nessun altro titolo se non l’intuizione è ormai richiesto ad un fenomeno perché esso appaia” (10).
Ma anche questa formulazione si presta a delle riserve. Nonostante metta giustamente in luce l’importanza dell’intuizione di ciò che si dà effettivamente “in carne ed ossa”, essa finisce per limitare l’ambito della fenomenalità al solo campo dell’intuizione. Ora l’intuizione – così possiamo sintetizzare le cinque particolari riserve che Marion muove a questo primato fenomenologico dell’intuizione – sembra avere in Husserl solo la funzione di riempire una mira o una intenzionalità d’oggetto, riferendosi quindi sempre ad una “trascendenza” verso cui la coscienza estaticamente si muove. Di conseguenza, limitare la manifestazione fenomenale al solo campo dell’intuizione di un oggetto trascendente, risulta essere un’indebita restrizione del campo della fenomenalità, che invece dovrebbe poter comprendere, senza riserve, tutto ciò che si mostra[22].
Senza contare, come Marion osserva nella quinta delle riserve formulate, la e), la formulazione di questo “principio di tutti i principi” interviene prima e senza previa messa in atto della “riduzione”, che invece dovrebbe essere il gesto inaugurale della fenomenologia.
Per superare le aporie di queste tre formulazioni, Marion ne propone un’altra, già introdotta in conclusione di Riduzione e donazione.
4. Questa quarta formulazione suona: “tanta riduzione altrettanta donazione”[23].
Marion la giustifica a) con il ricorso ai testi husserliani, ove il legame di principio tra riduzione e donazione è letteralmente riscontrabile, anche se non vi si ritrova la formulazione alla lettera; b) con delle considerazioni concettuali.
a)I testi husserliani ricordati sono tratti dall’opera, frutto di un corso di lezioni, L’idea della fenomenologia, del 1907. Un’opera che, com’è noto, inaugura la tematizzazione della “riduzione” fenomenologica come via d’ingresso nella fenomenologia ed anticipa quindi quell’impostazione che nelle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, del 1913, sposterà la fenomenologia di Husserl su posizioni di tipo nettamente idealistico. L’idea della fenomenologia si trova quindi sul crinale del passaggio da un’impostazione incentrata sul tema dell’intenzionalità, con cui la coscienza si aprirebbe ad oggetti da essa distinti, che caratterizza la prima grande opera fenomenologica di Husserl, Ricerche logiche, del 1900-1901, ad un’impostazione in cui i fenomeni saranno fatti rientrare nell’ambito di ciò che è immanente alla coscienza, ovvero di ciò che – come osserverà Ricoeur – è nella coscienza non solo perché è per (für) la coscienza ma anche perché è dalla (aus) coscienza.
Tra le quattro citazioni tratte da quest’opera, che Marion riporta, ne segnaliamo in particolare una, la terza, di cui correggiamo in parte la traduzione italiana per renderla più precisa e comprensibile. In essa leggiamo:
“Solo attraverso una riduzione (Reduktion), che adesso vorremmo chiamare riduzione fenomenologica (phänomenologische Reduktion), conquistiamo una donazione assoluta (absolute Gegebenheit), non dovendo più nulla alla trascendenza” (14).
Il collegamento tra “riduzione” e “donazione” è quindi ben attestato nei testi di Husserl. Ove per “riduzione” s’intende la messa tra parentesi del giudizio di esistenza circa la cosa in oggetto, e, più in generale, la messa tra parentesi o la sospensione di tutto ciò che in qualsiasi modo trascende il darsi effettivo dei fenomeni; tanto che Marion può parlare anche di “riduzione all’immanenza” (14). E per “donazione” deve intendersi il darsi/manifestarsi di per sé dei fenomeni, fino a quella donazione assoluta in cui non rimane nulla, in essi, di trascendente, ossia di non dato. Marion però indubbiamente accentua ed al tempo stesso interpreta il collegamento in questione con la sua scelta di tradurre – come già abbiamo sopra osservato – il tedesco Gegebenheit con “donazione”, e non con un equivalente francese di “datità”, con cui viene di solito tradotto in italiano.
b) La giustificazione della formula con considerazioni concettuali si basa sui concetti di riduzione e di donazione che or ora abbiamo chiarito. La “riduzione”, come sopra definita, non è infatti altro che una “riduzione alla donazione”, cioè a ciò che si dona in se stesso e di per se stesso alla coscienza, escludendo tutto ciò che non appare (non si dà) in persona. Essa, si può anche dire, non fa quindi altro che “misurare il grado di donazione contenuto in ogni apparenza, in modo da stabilirne il diritto ad apparire o no” (15). Donde la conclusione che ben commenta il principio: “non c’è donazione alcuna che non sia filtrata da una riduzione, così come non c’è riduzione che non lavori per una donazione” (15). Ove, come Marion sottolinea, le due operazioni di riconduzione all’Io della coscienza e di ritorno alle cose, non sono altro che i due versanti “dell’unico ordinamento (ordonancement) della riduzione alla donazione” (15)[24].
Il principio della fenomenologia, così formulato, permette, ad avviso di Marion, di superare le aporie che inerivano alle tre precedenti formulazioni (15-18).
L’apparire infatti non equivale all’essere (1° principio) se non nella misura in cui questo apparire si riduce a se stesso, ossia si compie in una donazione; e così si toglie ogni ambigua configurazione dell’essere delle cose come altro dall’apparire stesso.
Il “ritorno alle cose” (2° principio) non implica più nessun realismo precritico, bensì la riduzione del trascendente ai vissuti tali quali si danno alla coscienza.
E si supera anche l’ambiguità del primato dell’intuizione d’oggetto (3° principio). Se questa merita un privilegio è infatti solo in quanto “intuizione donatrice”, ovvero perché mette in atto una donazione. La donazione si misura quindi con il suo proprio canone e non con il canone dell’intuizione.
La donazione quale principio della fenomenologia, infine, supera l’aporia che sembrava inerire alla stessa ricerca di un principio metodologico per la fenomenologia, in quanto non fa altro che fissare “il fatto che la donazione si compie attraverso la riduzione” (18). In altri termini, la donazione fissa, per principio, “che niente precede il fenomeno, se non la sua propria apparizione a partire da sé; e ciò ripropone il fatto che il fenomeno accade senza altro principio al di là di se stesso” (Ivi). Per questo essa può essere considerata il “principio ultimo” della fenomenologia.
In conclusione del paragrafo, Marion osserva che chi si scandalizza del primato della donazione, rifiutandola per pregiudizio, non fa altro che chiudersi alla fenomenalità del fenomeno. Ma la donazione non deve a sua volta essere concepita come una sorta di “parola magica”, che traduce semplicemente lo stupore di fronte alla fenomenalità. “Fra magia e scandalo si apre un’altra via – e cioè che la donazione articola razionalmente i concetti che descrivono il fenomeno come ciò che si manifesta” (20).
Ed è questa terza via che Marion si propone di percorrere nel seguito del suo lavoro.
1. 2. Il secondo paragrafo del primo libro, “L’essenza del fenomeno” (20 ss. cerca di mettere in luce, a partire dal primato della donazione, come debba intendersi il “fenomeno”. O, se si vuole, come il primato della donazione si confermi nello studio dell’essenza del fenomeno.
1. 2. 1. La trattazione inizia da alcune considerazioni sul rilancio del tema dell’evidenza operato da Husserl fin dalle Ricerche logiche. Un tema che sembrava obsoleto, è stato da Husserl rilanciato tramite due significativi ampliamenti, che ne hanno decisamente esteso la portata oltre l’ambito dell’evidenza scientifica che il positivismo aveva privegiato considerandola paradigmatica.
Il primo ampliamento si è avuto con l’estenzione dell’evidenza dall’intuizione sensibile all’intuizione categoriale. Per Husserl, infatti, diversamente da Kant, anche le categorie (quantità, qualità, causalità ecc. ) possono essere oggetto d’intuizione evidente, ovvero si possono presentare come fenomeni che si danno in se stessi. Il secondo ampliamento, per Marion il più decisivo, consiste invece nel passaggio dalla evidenza come stato o vissuto di coscienza, semplice impressione soggettiva (come in Cartesio), all’evidenza come donazione di qualcosa d’altro dalla coscienza, qualcosa di non-cosciente, non-vissuto, non-pensato. Qualcosa, quindi, che rispetto all’evidenza come certezza soggettiva vissuta, può essere detto “inevidente”[25]. L’evidenza vissuta deve quindi essere considerata solo come il “luogo” dell’autodonazione (Selbstgebung) del fenomeno “inevidente”, che non solo si dà in carne ed ossa, “dà se stesso”, ma si dà “da sé stesso e a partire da se stesso”. Solo la donazione dà quindi vita all’evidenza fenomenologica autentica, come già alla riduzione.
1.2.2. Chiarito il significato fenomenologico dell’evidenza a partire dalla donazione, Marion può passare a precisare in che senso la correlazione tra riduzione e donazione venga a determinare l”essenza del fenomeno”. Con l’ausilio di preziose citazioni da Husserl, l’essenza del fenomeno viene vista nella “correlazione essenziale” – che in esso si realizza – tra l’”apparire” e “ciò che appare”. Come dice Husserl nell’Idea della fenomanologia, “la parola ‘fenomeno’ ha un doppio senso (doppelsinning), in virtù della correlazione essenziale fra l’apparire (Erscheinen) e ciò che appare (Erscheinenden)” (22).
Perché vi sia ‘fenomeno’, cioè, non basta vi sia un apparire soggettivo, un vissuto dell’apparire, bisogna che a questo versante soggettivo del fenomeno sia essenzialmente correlato il versante in qualche modo oggettivo di ciò che appare. Ma questa correlazione – osserva Marion – si ha solo in virtù della donazione, cui compete il compito di tenere unito sia il versante dell’apparire che quello di ciò che appare, senza che vi sia alcuna scissione tra la donazione dell’apparire e la donazione di ciò che appare.
Marion ricorda (24) lo stupore dichiarato da Husserl in L’idea della fenomenologia, di fronte alla constatazione di questa correlazione, che di colpo ci porta oltre la necessità di scegliere tra l’oggetto (come fa il “realismo”) e l’apparire (come fa il “fenomenismo”), perché l’uno e l’altro si collegano indissolubilmente nell’unica donazione.
Per riuscire però a “pensare” questa stupefacente correlazione, che sta al cuore del fenomeno stesso della conoscenza, Husserl compie, secondo Marion, un ulteriore decisivo passo: quello di distinguere due tipi di immanenza. L’“immanenza reale”, propria di ciò che materialmente inerisce alla coscienza, e l’“immanenza intenzionale”, che caratterizza ciò che si dà alla coscienza, cioè non sta al di là, non trascende il darsi alla coscienza. Come Husserl si esprime: “A guardarci più da vicino, l’immanenza reale si distingue pertanto dall’immanenza nel senso della donazione in persona (Selbstgebenheit) costituentesi nell’evidenza” (26)[26].
Decisivo, su questo punto, l’operazione con cui Husserl ha legato l’immanenza all’intenzionalità, superando così il pregiudizio psicologistico di considerare l’immanenza solo come immanenza reale, finendo così per ricondurre l’oggetto della conoscenza (le idee, i pensieri pensati), ad elementi reali della psiche.
“Non si tratta soltanto – sono ancora parole di Husserl – di ciò che è materialmente immanente, ma anche dell’immanente in senso intenzionale (das im intentionalem Sinn Immanente). I vissuti conoscitivi – che appartengono all’essenza della coscienza – hanno una intentio, essi mirano (meinen) qualche cosa, essi si riferiscono, in un modo o in un altro ad una oggettualità” (26, con corr. nostre).
In base a questa fondamentale distinzione, Husserl potrà parlare dell’intenzionalità come di una “trascendenza nell’immanenza”, in quanto con essa la coscienza va oltre l’ambito di ciò che le è realmente immanente anche se non oltre l’ambito di ciò che le è immanente in senso intenzionale, ovvero le si dona con evidenza[27].
Con questa acquisizione, anche la “riduzione” fenomenologica può essere meglio colta nella sua vera natura. La sospenzione del giudizio di esistenza non ha di mira l’esclusione di ogni trascendenza, ad esempio l’esclusione di tutto ciò che non è riconducibie ad un fatto di coscienza, ma solo l’esclusione della trascendenza rispetto all’ambito dell’immanenza intenzionale, cioè l’esclusione di tutto ciò che non è riconducibile ad una “donazione” di sé alla coscienza intenzionale. “Così la trascendenza – osserverà Marion – non si trova fuori circuito come tale (a prova di ciò essa resta ammessa come intenzionale), ma nella stretta misura in cui essa non soddisfa la donazione; così anche l’esistenza, ogni volta che non si percepisce, ma non quando perviene alla donazione” (28, con corr. n.).
In conclusione, secondo Marion la “donazione” determina tutte le tappe della fenomenalità: la riduzione, la correlazione delle due facce del fenomeno, l’immanenza intenzionale, ed infine l’essere stesso delle cose, che sono solo nella misura della loro donazione: “apparire in carne ed ossa equivale dunque finalmente ad essere, ma essere presuppone esser dato” (28).
Il paragrafo si chiude con una domanda: perché Husserl, che ha dato un posto così rilevante alla donazione, non ne dà mai una definizione? La risposta che Marion tenta è la seguente: a) perché è con essa che si definiscono tutti gli atti fenomenologici; b) perché essa stessa è un atto che si compie, non un oggetto; un atto che è come il rovescio della riduzione, sotto cui, quindi, resta nascosta; c) perché Husserl pensa a partire dalla donazione, ma lascia la donazione impensata. Pensare la donazione resta quindi il compito che Marion si prefigge con il suo lavoro (30).
1. 3. Il terzo paragrafo del capitolo primo porta avanti tale compito con un confronto critico con la concezione fenomenologica di Husserl ed Heidegger, di fondamentale importanza nell’economia del lavoro. I due elementi del titolo del paragrafo: “L’oggettualità e l’entità”, rimandano di fatto alle critiche che Marion rivolgerà ai due autori: il primo avrebbe finito per restringere l’ambito della donazione all’oggettualità (Objectité, Gegenständlichkeit), mentre il secondo l’avrebbe ristretta all’entità (étantité) o all’essere. Ma procediamo per gradi, seguendo il testo di Marion.
1.3.1. Critica ad Husserl. Una volta stabilito che la donazione apre il campo della fenomenalità, l’autore affronta il problema posto dalla seguente difficoltà: se ogni fenomeno si dà, la donazione non si disperde all’infinito nei molteplici modi con cui i fenomeni si danno? Il principio husserliano della donazione non resta, a questo punto, talmente indeterminato da scadere a semplice metafora? Sarà mai possibile individuare lo statuto comune dei differenti modi di donazione, che Husserl enumera già nel testo del 1907, ricomprendendovi, ad esempio, la cogitatio, il suo ricordo recente, il flusso della durata della coscienza, la cosa che si dà nella percezione esterna, ma anche ciò che viene immaginato, le varie figure della logica, fino al darsi del non-senso, del nulla?
Una prima risposta a questa difficoltà si trova invero già in Husserl, il quale osserva che non tutte le donazioni sono delle donazioni autentiche. Le donazioni autentiche, ovvero le “donazioni assolute”, cui corrisponde l’effettiva evidenza, dovranno quindi essere considerate come il metro di riferimento per vagliare i vari gradi di donazione ed eventualmente escludere ciò che vera donazione non è. Trasformando il noto effato spinoziano, veritas index sui et falsi est, Marion dirà: la donazione è index sui et non dati, cioè è criterio di se stessa come anche del non dato.
Ma una volta preso atto che si danno vari gradi di donazione, si ripropone la domanda circa ciò che precisamente la donazione accorda, quanto a statuto, figura e realtà ai fenomeni. “Che cosa mette in gioco il darsi?” (33).
La risposta che si trova in Husserl viene scandita da Marion come in due tappe successive.
a) Sebbene con una certa ambiguità e talora in modo solo implicito, Husserl avrebbe chiaramente ricondotto i vari modi della donazione a vari modi d’essere. Ciò che la donazione dà ai fenomeni sarebbe il loro statuto di enti: tra ente, apparire, dato vi sarebbe quindi un’equivalenza. Anzi, in Husserl si sarebbe giunti anche all’affermazione dell’equivalenza dell’essere stesso con l’esser-dato, riconoscendo così una chiara “portata ontico-ontologica alla donazione” (34). Per Marion tale portata ontologica, chiaramente testimoniata nelle lezioni del 1907, si estenderebbe anche all’altra operazione determinante della fenomenologia husserliana, la “costituzione”, che fin dal 1907, e poi definitivamente con il 1913, si definisce come “donazione di senso” (Sinngebung). Diventare un ente dipenderebbe infatti sempre – in Husserl – da un senso assegnato dal gioco dell’intenzione e dell’intuizione.
b) Ma la tesi che la donazione determini bene il senso fenomenologico che Husserl mantiene ad “essere” e ad “ente”, non toglie la difficoltà che nasce dalla doppia imprecisione nella quale Husserl lascia questa determinazione (v. pp. 35-37).
La prima imprecisione, riguarda l’equivalenza che Husserl pone tra l’essere/ente e l’”oggetto” (Gegenstand). Oltre non presentire la differenza ontologica di essere e ente, cosa giustifica questa supposizione che ente/essere non dica nient’altro che “oggetto”? Nonostante le precisazioni che si possono addurre, non sembra in alcun modo giustificato che il fenomeno che si dà venga alla fin fine sottoposto all’orizzonte dell’oggettualità che come tale non si darebbe.
La seconda imprecisione, derivata dalla prima, consisterebbe nel confondere la “donazione” stessa con l’oggettualità (Gegenständlichkeit). Certo l’oggetto può anch’esso darsi. Ma ciò non significa – osserva Marion – che il dato debba sempre o inizialmente oggettivarsi per potersi dare. Diversamente da Husserl, non l’oggettualità, ma la donazione offre quindi la norma ultima della fenomenalità[28]. La “fenomenalità della donazione” permette infatti al fenomeno di mostrarsi in sé e attraverso sé, mentre la “fenomenalità dell’oggettualità” finisce per ricondurre il fenomeno ad una costituzione a partire dall’ego di una coscienza che lo prende in considerazione con il suo noema. Questa sembra infatti essere la natura dell’oggettualità, come si è dispiegata dai medioevali fino a Kant e oltre[29].
1.3.2. Critica a Heidegger. Secondo Marion, Heidegger avrebbe ripreso il disegno incompiuto husserliano di pensare l’essere secondo la donazione; ma sarebbe infine indietreggiato di fronte all’originalità della donazione, lasciando così anche lui incompiuto tale disegno.
L’impegno a pensare l’essere secondo la donazione è testimoniato dal fatto che Heidegger ha posto e mantenuto la questione dell’essere nella figura originale dell’es gibt (si dà). Una espressione tedesca di cui Marion contesta l’abituale traduzione francese con il y a (c’è), che occulta tutta la semantica della donazione, per tradurre con la formula francese, inusuale ma a suo avviso più esatta, cela donne.
Nell’interpretazione di Marion, supportata dal riferimento ad alcuni ben precisi testi (38-40), già in Essere e tempo, del 1927, Heidegger avrebbe non solo delineato la differenza ontologica tra essere e ente, ma avrebbe pensato il dispiegarsi dell’essere stesso secondo la donazione. L’analisi del Dasein metterebbe infatti in luce che questo è l’orizzonte concreto (la condizione ontica) in cui l’essere (e non solo e non tanto l’ente) può dispiegarsi in quanto “si dà” (es gibt).
Nella conferenza Tempo ed essere, del 1962, cui è seguito, nello stesso anno; il seminario attestato dal Protocollo di un seminario sulla conferenza “Tempo ed essere”[30], Heidegger conferma e radicalizza ciò che già era presente in Essere e tempo, cioè che la fenomenalità ontologica si lega al “si dà” originario. Ciò avviene soprattutto con l’osservazione che l’essere, nella sua differenza dall’ente, si dà solo secondo la logica della donazione, cioè “ritraendosi” dal dato/donato. L’essere infatti non si dà al modo dell’ente, sul piano dell’essere che si presenta, ma solo ritraendosi da ciò che offre in dono dopo averlo consegnato, “inviato”. Al donare, infatti, è essenziale il donarsi, ritraendosi dal donato, “… in favore del donato (zugunsten der Gabe)” (41). Solo la donazione scoprirebbe quindi l’ente “nel (e senza il) suo essere” (43), aprendo così la via al nichilismo.
Vi sarebbe quindi in Heidegger una stretta correlazione tra “differenza ontologica”, “ritrarsi dell’essere dall’ente”, “donazione” e quel “nichilismo” che è il destino dell’oblio dell’essere che caratterizza l’occidente.
Nonostante questa chiara riconduzione dell’essere alla donazione, Heidegger avrebbe lasciato incompiuto il disegno di Husserl in quanto avrebbe inteso la donazione solo come un punto di passaggio dall’essere all’Ereignis (l’evento/avvento)[31]. Riflettendo sulla natura del “si” (es) che di ritrova nell’espressione “si dà (es gibt), Heidegger ne avrebbe bensì sottolineato la natura enigmatica, del tutto indeterminata e anonima, escludendo che esso possa interpretarsi in chiave metafisica o tanto meno teologica. Ma poi ne avrebbe offuscato l’enigmaticità anonima attribuendogli il nome di Ereignis; anzi, interpretandolo come Ereignis[32] . Ma in questo modo non solo l’essere ma anche la donazione scompare nell’evento/avvento. Heidegger avrebbe quindi meritevolmente messo in luce alcune proprietà fondamentali della donazione ma poi si sarebbe ritratto dal riconoscerle la funzione fenomenologica di principio, concependola solo come un tramite tra l’essere e l’Ereignis.
In conclusione, tanto Husserl quanto Heidegger avrebbero esitato a riconoscere nella donazione la funzione di principio fenomenologico, che può definirsi solo in sé stesso e a partire da sé stesso, subordinandola l’uno all’oggettività e l’altro all’entità propria dell’Ereignis. E avrebbero fatto ciò perché non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo nel processo di “riduzione”, che l’uno ferma davanti all’oggettività e l’altro di fronte all’entità. La questione di una donazione fenomenologica radicale può essere risolta solo portando fino in fondo la riduzione, secondo il principio: “tanta riduzione, altrettanta donazione”. Solo questo principio ci permette infatti di “definire la donazione in sé stessa e a partire da se stessa”, come Marion si propone di fare a partire dal paragrafo seguente.
1. 4. Il quarto paragrafo, intitolato “la riduzione al dato”(donné), intende passare dalla pars destruens alla pars construens, cercando di mettere “positivamente” in luce la donazione come tale. Cosa non facile, poiché, come sopra si è accennato, “la donazione non può mai apparire se non indirettamente, nella piega del dato” (47). Bisognerà quindi partire da un fenomeno dato per scoprire in esso una donazione irriducibile all’oggettualità o all’entità. Il fenomeno che Marion sceglie per avviare questa “analisi fenomenologica” è quello, del tutto comune ed indiscutibilmente visibile, del “quadro” (le tableau), ritenendo che già in esso si abbia “il caso di un fenomeno che per apparire pretende ostinatamente di sottrarsi a questi due paradigmi, che tende di mostrarsi benché sfugga sia all’oggettualità che all’entità; o meglio: perché e nella misura in cui si sottrae ad essi” (47).
Accenniamo alle linee di fondo dell’analisi, semplice da seguire nelle pagine di Marion ad essa dedicate. Si prenda un quadro qualunque (una casa di paese, un paniere di fiori….) e ci si domandi: quale fenomeno mi è così dato? O meglio: in che cosa, ciò che mi appare risente della donazione? Tre possibili risposte vengono esaminate e criticate come insoddisfacenti(48-57).
a) Il quadro è un “oggetto sussistente”, presente in quanto a portata di mano (vonhanden). Si osserva: la sussistenza di oggetto non è il proprium del quadro, che rimane anche se si cambiano tutti gli elementi materiali che lo compongono. Anzi, come nel caso del ready-made, lungi dal confondersi con gli oggetti che “mette in scena” (il bidet, il porta-bottiglia, ecc.) ci svia da essi, offrendone una nuova visibilità. Il quadro, infatti, non è una cosa da constatare, come un qualsiasi oggetto sussistente, ma la pura apparizione di se stesso, che si tratta di “contemplare”. Esso è quindi “ciò che non sussiste”.
b) Il quadro è un “oggetto maneggevole” e utilizzabile (zuhanden). Si osserva: anche se è vero che può essere “utilizzato” per produrre un piacere estetico nello spettatore, per una valutazione in moneta da parte di un mercante, di un giudizio estetico da parte di un critico, il quadro sfugge allo statuto dell’utilizzabile in quanto non si esaurisce in nessuna di tali forme di utilizzabilità; esso si compie, infatti, solo in quanto si rende manifesto, e lo fa a partire da se stesso. Ne sono conferma: 1) il fatto che, come il bello che Kant definisce, non ha di per sé alcuna finalità estrinseca; 2) come ben ha messo in evidenza Heidegger, l’utilizzabile appare solo scomparendo (se funziona bene, un attrezzo non viene percepito o avvertito come tale); 3) la cornice in cui lo si pone, separa effettivamente il quadro dallo spazio degli oggetti utilizzabili, dandogli uno “spazio di extraterritorialità”. Si ricordi il celebre quadro di Magritte, raffigurante una pipa, sotto il quale il pittore scrive: “Questa non è una pipa”. Il quadro è quindi “ciò che non serve”.
c) Il fenomeno del quadro si riduce, allora, alla sua “entità”, al suo carattere di “ente”(ens, Seiendes). Come dice Heidegger, che avrebbe perseguito fino in fondo tale via, l’essenza dell’”arte” consisterebbe “nel porsi in opera della verità dell’ente” (das sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seiendes” (cit. 53, n.96).
L’obiezione che Marion fa a questa posizione, non consiste nel mettere in discussione che anche l’arte metta in opera la verità dell’ente (spesso, nell’arte, vediamo infatti le cose meglio che nella realtà!), ma che questa messa in opera ne definisca l’essenza. A suo avviso la fenomenalità della bellezza, in cui va vista l’essenza dell’arte, non si riduce a semplice modalità della fenomenalità della verità, quasi che l’arte fosse un semplice strumento per la manifestazione dell’ente, ma possiede una fenomenalità sua propria, tramite cui è forse possibile accedere “ad una fenomenalità non ancora conquistata – e senza dubbio più radicale, quella del dato” (54).
Nel caso del quadro ci troviamo infatti di fronte ad una fenomenalità che sembra affrancarsi dalla sua fenomenalità come cosa che è, quanto più esso appare come bello. Ne sono indizi, ad esempio, 1) il fatto che esso è talmente indifferente al suo carattere di cosa, da rimanere tale anche quando il suo supporto cosale sparisce (perché del tutto sostituito nel restauro) o si moltiplica (come nel caso della sua riproduzione); 2) il fatto che “il quadro non appare perché è, ma perché si espone” (56), cioè a condizione che alla sua visibilità come ente si aggiunga, o si sostituisca, la sua “sovravisibilità” estetica, l’evento della sua apparizione in persona (Selbsgegebenheit), il suo “sorgere” come quadro; 3) donde quella che viene chiamata la “liturgia della re-visione”, che mi fa ritornare indefinite volte a rivedere il quadro. Ulteriore indizio che esso non consiste nel suo essere (in tal caso basterebbe vederlo una volta sola) ma nel suo modo di apparire (che può ripetersi ogni volta in modo nuovo) (57). In conclusione: “esso non è”.
Criticate queste tre risposte alla domanda circa la “fenomenalità” del quadro (sussistenza, utilizzabilità, entità) ci si trova di fronte ad un paradosso di difficile spiegazione: una fenomenalità che tanto più appare quanto meno si rapporta ad un oggetto sussistente, ad un utilizzabile, ad un ente. A questo punto Marion ricorre alla testimonianza di artisti come Baudelaire, Cézanne, Kandinsky, per cercare di mettere in evidenza la necessità, perché si dia un bel quadro, che esso abbia la capacità di farsi visibile, di sorgere o salire al visibile con il suo senso; in altre parole, che esso produca un “effetto”, consistente nello choc emotivo, o incanto, che provoca in colui che lo guarda. “Ciò che appare del quadro in quanto quadro si chiama, dunque, effetto” (59).
Non si tratta però solo dell’effetto “fisico” che esso suscita facendo sorgere in noi la percezione del quadro o una emozione nel mio corpo; si potrebbe dire, piuttosto, che si tratta di un effetto “spirituale”, da intendersi, in termini cartesiani, come una “passione dell’anima”. Questa ne risulta infatti scossa con delle vibrazioni che non possono essere descritte né come oggetti, né come enti visibili, e tuttavia mi dicono della fenomenalità del quadro che si mostra in sé e a partire da sé[33]. Si pensi al celebre quadro di Kandisky, che Marion ricorda, in cui tramite l’inclinazione ocra e rossa della luce al tramonto, che occupa tutta la scena, colpisce il visitatore nella misura in cui produce in lui la “passione” di un’anima “affetta dalla profonda serenità del mondo salvato e protetto dall’ultimo rosseggiare del sole”(61).
Questo effetto, che non si produce sul modello dell’oggetto e dell’ente, tuttavia si dà. Nella sua fenomenalità ultima, il quadro quindi appare in quanto si dà nell’effetto che suscita. O meglio: il quadro, come tale invisibile (nel gesto del suo sorgere, nell’avanzare del suo darsi) si dà nell’effetto visibile che ci dona.
“Il quadro (e attraverso di esso ogni altro fenomeno a gradi ogni volta differenti), si riduce alla sua fenomenalità ultima in quanto dà il suo effetto. Esso appare in quanto dato nell’effetto che viene donato (que cela donne). Così si definisce l’essenziale invisibilità del quadro. /…/ Il quadro non è visibile, esso rende visibile; rende visibile in un gesto che resta per definizione invisibile – l’effetto, il sorgere, l’avanzata del darsi. Darsi esige un ridursi – ricondurre – a questo effetto invisibile che rende, esso solo, visibile. L’effetto risulta così nient’altro che il fenomeno ridotto al dato” (62)[34].
Per cogliere il pensiero di Marion su questo punto fondamentale, è importante ricordare che la riduzione fenomenologica, che egli intende mettere in atto, consiste in nient’altro che nella messa tra parentesi di tutto ciò che, trascendente, non appartiene alla fenomenalità pura, cioè l’oggettualità e l’entità, guidati dal fenomeno stesso della donazione.
L’esempio del quadro, il cui fenomeno abbiamo visto darsi di per se stesso, non è che un esempio, molto elementare. Esso non deve però far dimenticare fenomeni più complessi, che si danno egualmente senza oggettualità (dare il tempo, dare la vita, dare la propria parola) o senza entità (dare la morte, la pace, il senso ecc.), senza necessità di speciali riduzioni. In essi, infatti, la loro stessa designazione indica già la riduzione spontanea di tutto ciò che potrebbe offuscare il loro puro darsi, oggetto o ente che sia.
La considerazione di questi fenomeni, oltre a quello del quadro, potrebbe confermare la scoperta, cui si mirava, di una nuova classe di fenomeni ridotti all’effetto di “pura donazione”, a partire esclusivamente da se stessi.
1. 5. Il quinto paragrafo, intitolato “privilegio di donazione”, affronta il problema della “universalità” e della “primarietà” della donazione, ossia se essa possa effettivamente ricomprendere in sé tutti i tipi di fenomeni e se sia veramente impossibile ricondurla ad un orizzonte più ampio o diverso da essa. In tali universalità e primarietà incondizionate, consiste infatti il “privilegio” che s’intende riconoscere alla donazione come principio ultimo della fenomenologia.
Il tema, affrontato a partire dalle obiezioni che si possono avanzare rispetto alla tesi sostenuta, si concentra nell’esame di due fenomeni, il “niente” e la “morte”, che più di ogni altro sembrerebbero sfuggire alla donazione, ovvero non offrirsi come dati.
1.5.1. Quanto al niente (63 ss.), analizzato sotto vari aspetti: il nulla, la possibilità, l’oscurità, il vuoto, il non senso, Marion sostiene che con esso non si ha una sospensione della donazione quanto piuttosto una “donazione per denegazione”, ossia per il darsi di un’assenza[35]. Ciò può aversi in vari modi: ad esempio come angoscia del nulla (Heidegger), come intuizione della possibilità in quanto non-contradditorietà di una cosa (Leibniz), come eccesso positivo dell’infinito nel caso dell’incomprensibilità dell’infinito (Pseudo Dionigi, Cartesio) ecc. L’esame dei vari modi, sia pur paradossali, del darsi del “niente” si conclude con l’affermazione:
“Ogni negazione ed ogni denegazione, ogni negativo, ogni niente e ogni contraddizione logica presuppongono, infatti, una donazione che ci autorizzi a riconoscerli e così a dare accesso alle loro particolarità; in sintesi un dato che ci permette, non fosse che questo, di discuterli” (65-66).
Da questa considerazione segue un’importante presa di posizione nei confronti della concezione di Derrida, secondo cui la “differenza” (différence) e la relativa “decostruzione” esulerebbero dal campo della fenomenalità e quindi dalla donazione (66-68). Osserva Marion: se, come giustamente sostiene Husserl, anche il non-essere, il contro-senso (Widersinn), la contraddizione (Widerspruch) derivano anch’essi dalla donazione, e lo stesso potrebbe dirsi del non-senso, allora “ogni senso” resta nel campo della donazione; anche se non convalidato da alcuna presenza, anche se continuamente “differisce” dall’intuizione. E resta nel campo della donazione anche la famosa “decostruzione” del senso, che dovrebbe mostrare come ogni senso, che si suppone presente nell’intuizione, ad un’attenta analisi si risolve in altro da sé, non riuscendo a mantenersi come fenomeno dato.
L’errore di Derrida, secondo Marion, consiste nel far coincidere la donazione con l’intuizione, con la conseguenza di espungere dalla donazione, e quindi dalla fenomenalità, ciò che sfugge ad ogni tipo di intuizione. Seguendo alcune suggestioni di Husserl, bisogna invece, se mai, distinguere tra donazione intuitiva e donazione non intuitiva, ma mai parlare di non-donazione o di donazione negativa. Nel caso della decostruzione, si potrebbe ad esempio parlare di “donazione differita” (67). In sintesi:
“La donazione, index sui et non dati, fissa, dunque, l’orizzonte del non-dato quanto quello del dato, perché, precisamente, uno stesso orizzonte ha la funzione di circondare il dato da un circuito di non-dato” (68).
1. 5. 2. Alla donazione non sfugge neppure la morte (68 ss.). Si potrebbe pensare che essa la sospende in quanto annullando il destinatario della donazione rende addirittura impossibile la donazione. Ma a ben vedere le cose sono più complesse, come risulta anche dal linguaggio che parla di “dare” e “ricevere” la morte. Queste pagine dedicate alla morte sono particolarmente interessanti, soprattutto se lette alla luce di un affascinante saggio recente di Derrida intitolato Donné la mort[36].
L’analisi prende il suo avvio dalla definizione heideggeriana della morte come “possibilità dell’impossibilità”, propria del Dasein. Se vale questa definizione, la morte, che si presenta quindi come ben differente da un ente o da un nulla, lungi dal sopprime il destinatario della donazione ne caratterizza profondamente l’essere, come quella possibilità radicale che precede in lui tutte le altre possibilità. Obiettando al paradosso epicureo (la morte non è niente per noi perchè se noi ci siamo essa non c’è e se essa c’è noi non ci siamo più), si può quindi dire che la morte “appare ben prima che io scompaia”. Essa caratterizza il Dasein aprendolo al mondo come orizzonte di ogni intenzionalità, e così lo rende atto ad ogni possibile donazione.
Si potrebbe obiettare che in quanto “possibilità dell’impossibilità” la morte finisce per sospendere ogni altra possibilità, e quindi anche quella della donazione. Ma a ciò si può rispondere che essa dona, appunto, l’impossibilità, cioè “dona di sperimentare la finitezza come una determinazione esistenziale insuperabile del Dasein” (70). Un’esperienza che mi dà il senso della morte, della mia morte, molto più che non la “morte altrui”, che a prima vista sembrerebbe testimoniarmi l’effettività della morte. In conclusione:
“Alla morte niente sfugge, ma essa stessa non sfugge alla donazione: non solo perché si può “dare la morte” ma soprattutto perché essa si dà da se stessa. Di conseguenza, la morte non sottrae alla donazione ciò (o colui) che potrebbe riceverla per sempre nell’orizzonte dell’unica donazione” (71).
1. 5. 3. L’ultimo sottoparagrafo, intitolato “l’altro inconcussum” (71 ss.), porta a termine la difesa del “privilegio della donazione” mostrando che essa non solo è universale perché ricomprende in sé ogni tipo di fenomeno (l’intuizione, il concetto, l’essere, finanche il nulla e la morte….), ma che non è possibile negarla in alcun modo, ovvero sorpassarla con qualcosa di più originale che la ricomprenda in sé. Infatti qualsiasi cosa la voglia negare o contestare non farebbe che riaffermarla, dovendosi pur sempre presentare come un dato nell’orizzonte della donazione. La negazione della donazione risulta quindi autocontradditoria; donde l’assoluta “indubitabilità” della donazione.
A questo proposito Marion rileva una profonda analogia tra l’indubitabilità del cogito e quella della donazione. Come l’ego cogito si attesta come indubitabile ogni volta che pensa, sia pur nel dubitare, così la donazione si attesta ogni volta che dona, sia pur quando dona ciò che non è o rinnega il minimo dato. La donazione condivide quindi con l’ego il privilegio dell’indubitabilità assoluta.
Ma l’analogia tra cogito e donazione implica anche una radicale differenza. Mentre il cogito perviene all’indubitabilità del possesso di sé, o alla propria certezza d’essere, la donazione, donando, si conferma non perché si autopossiede ma perché si disfa di sé attraverso il donarsi nel dato, perché si abbandona producendo un altro da sé in cui scomparire.
“(La donazione) si assicura di se stessa, spossessandosene, producendo un altro da sé in cui poter scomparire, il dato. Così la donazione resta come ritirata, trattenuta nello sfondo, dissimulata dal suo dato; essa non appare, così, mai come tale, mai dunque al modo di un ente, una sostanza o un soggetto; in breve, mai come un inconcussum quid. Inconcussum forse, ma mai quid” (72).
Il paragrafo termina affermando che l’indubitabilità della donazione non è l’indubitabilità di un ente, sia pur l’ente ego ma, se mai, quella di un atto. Un “atto universale”, da non confondere con un principio trascendentale, comunque inteso, o con un “atto puro” che preceda e apra lo spettacolo del mondo; la donazione è indubitabile solo nel senso di quell’“atto fenomenologico”, di cui la riduzione è l’altra inseparabile faccia.
1. 6. Il sesto paragrafo, “darsi, mostrarsi”, conchiude il capitolo sulla donazione insistendo sullo stretto nesso tra il “dato” e la “donazione” da cui sorge, ed anche tra il “darsi” del dato tramite la donazione e il “mostrarsi” ad una coscienza. Darsi equivale dunque a mostrarsi, ma non v’è mostrarsi che non si origini da un darsi. Il nesso in questione è espresso con la metafora della “piega del dato”, in cui dato e donazione, darsi e mostrarsi sono strettamente intrecciati. Nella piega del dato vi è quindi sempre contenuta, sia pur in modo invisibile, la donazione.
La trattazione prende l’avvio da un’obiezione effettivamente mossa a Marion da Janicaud e citata in nota a p. 75. Tutta la trattazione non farebbe che giocare sull’ambiguità del termine francese “donation” e, più a monte, del termine tedesco “Gegebenheit”, unificando nello stesso termine generico significati differenti, come “dato” e “donato”, ma anche l’atto del “donare” con il suo risultato, il “dono”, la modalità del dato compiuto (il suo carattere di donato) e il rimando al donatore ecc. L’enfasi sulla donazione sarebbe quindi il frutto di un semplice effetto di linguaggio, che condurrebbe ad una “confusa illusione” senza alcun valore filosofico.
Marion risponde all’obiezione con due argomenti: a) non si tratta di sfruttare un’ambiguità, ma di riconoscerla; b) questa ambiguità s’impone senza scampo, per cui vale la pena di interrogarla esplicitamente al fine di articolare il concetto di donazione.
Tale interrogazione, cui Marion procede nel seguito del discorso, prende l’avvio dall’esame dell’uso francese del termine (75-80), per poi passare al problema della traduzione del termine tedesco (80-83).
1. 6. 1. Nell’uso francese donation comporta indubbiamente la dualità tra “dono-fatto” o “dono-donato” e l’atto di donazione da cui esso trae origine. Ora, questo atto di donazione, per un verso persiste nel dono come “dono donato”, ma per altro verso vi sparisce, lasciando essere il “dato” (datum) come puro e semplice dato. Stante questa situazione linguistica, è possibile, come riterrebbe l’obiezione, limitarsi al “dono donato” come semplice “dato”, scevro di ogni traccia di origine, evitando così l’ambiguità del termine donazione?
La cosa, secondo Marion, non è possibile, perché ogni dato, per quanto pensato come puro fatto bruto, porta sempre con sé “la costitutiva ambiguità della donazione”. L’esempio su cui Marion si sofferma, è quello, all’apparenza più neutro e minimale, dei “dati di un problema” scientifico, matematico o fisico. Anche in questo caso non ci troviamo di fronte dei dati senza alcun rinvio alla donazione, perché essi sono pur sempre dei dati offerti a qualcuno in vista di una soluzione e solo se intesi come dei “dati donati” è possibile affrontarli sullo sfondo di un modello coerente in cui ricercare con fiducia la soluzione. Così anche il “dato matematico” offre un esempio privilegiato del “donato”, ovvero di un “fatto” che non si è fatto da solo. Altri esempi potrebbero essere tratti (77, n. 124) dal “dare le carte” all’inizio di una partita, dai “dati genetici” di ogni individuo, dei “doni” artistici propri di una persona. Sempre, conchiude Marion, non è possibile separare, nel dono, la sua effettività dalla sua origine. “Dato e donazione non si identificano di certo, ma un dato senza la donazione non si può pensare né può apparire” (77-78).
Per esprimere questo rimando essenziale di ogni dato alla donazione, Marion ritorna a parlare di “piega del dato” (pli du donné), in cui i due versanti del dato e della donazione sono strettamente congiunti, anche se la donazione non si presenta con la stessa visibilità del dato in quanto rimane ad un tempo nascosta o ritratta nel dato e in esso dispiegata.
L’ambiguità della “donazione” non va quindi sciolta, sciegliendo tra “dato” e “donato”, tra “dato” e “donazione”, ma va mantenuta nella suo fecondità di “piega del dato”. La difficoltà iniziale quindi s’inverte: “non si tratta più di sapere se si può e si deve pensare il fanomeno a partire dalla donazione, ma se lo si può ancora pensare senza di essa” (80).
1. 6. 2. Dopo quanto detto, il problema della difficoltà della traduzione in francese del termine tedesco Gegebenheit (e potremmo dire lo stesso per l’italiano) si precisa come segue. Il termine, come Husserl stesso rileva, contiene in sé due possibili significati: il risultato della donazione (il dato) e la donazione come processo (il donare). Conviene usare per i due sensi due parole diverse, onde togliere l’ambiguità, oppure è meglio usare un termine solo, che mantenga i due sensi, per salvaguardare la “piega del dato”?[37]
Marion è decisamente per la seconda alternativa, quella da lui seguita scegliendo di tradurre con donation. A coloro che si ostinano a voler tradurre l’unico termine tedesco con due termini, egli rinfaccia – oltre l’
PIERRE KLOSSOWSKI

A cura di Fabrizio Cerroni
LA VITA E LE OPERE
Pierre Klossowski è stato romanziere, filosofo, disegnatore, saggista, pittore, e cineasta.
Nasce Parigi nel 1905 da genitori polacchi. Fratello del pittore Balthus (il cui vero nome era Balthazar Klossowski) durante l’infanzia, il suo mentore fu Rainer Maria Rilke (compagno della madre di Klossowski dopo la separazione di questa dal padre). Dal 1920, lo stesso ruolo fu svolto da André Gide, per il quale Klossowski lavorò come segretario e curatore de I Falsari. Nella sua opera, Klossowski cercò sempre di unire queste due profonde influenze.
A partire dagli anni ’30 il Marchese de Sade, insieme a Nietzsche, divenne il suo maître à penser, affinità condivisa con surrealisti come Robert Desnos, Paul Eluard, e Georges Bataille; ma mutata d’accento, giacché, a differenza di questi, Klossowski è sempre stato interessato alle implicazioni filosofiche della pornografia sadiana, piuttosto che alle violenze ed agli eccessi da cui questa è caratterizzata.
In questo periodo inizia la propria attività di traduttore che continuerà negli anni successive. Tradurrà opere di Hölderlin (poema della follia, 1928), Hamann (meditazioni bibliche, 1948), Virgilio (Eneide, 1964), Svetonio (La vita dei dodici Cesari, 1959), Tertulliano, Virgilio, Nietzsche (La gaia scienza, 1954, ed i frammenti dell’ultimo periodo), Heidegger (Nietzsche, 1971), Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus, 1961).
Negli stessi anni Klossowski è vicino al Fronte Popolare, e pertanto interessato alla possibilità di utilizzo dell’arte per propaganda politica. Quest’impegno insieme al fascino per il ruolo delle nuove tecnologie nell’arte, lo portarono a stringere amicizia con Walter Benjamin, ed a tradurre in francese un saggio di quest’ultimo sul ruolo dell’arte negli anni della riproduzione meccanica.
Nel 1935, dopo aver frequentato la Scuola Psicoanalitica di Parigi, la cui rivista pubblica i suoi primi saggi su Sade, incontra Georges Bataille con il quale nasce una forte amicizia. È Sotto lo stimolo di Bataille che Klossowski prende contatti con André Breton e Maurice Heine, nel gruppo di Contre-Attaque, e che più tardi parteciperà alla rivista Acéphale.
Nel 1939, un crescente interesse per la teologia, unito ad una montante avversione per la politica, lo portarono ad unirsi all’ordine dominicano di La Lesse. Durante l’occupazione, intraprende degli studi di scolastica e teologia alla facoltà domenicana di Saint-Maximin, successivamente a Lione, ed infine all’Istituto cattolico di Parigi. Svolge inoltre attività di recensore e di critico, pubblicando lavori su Gide, Kafka, Nietzsche, Kirkegaard, Bataille, Blanchot, Barbey d’Aurevilly. Nel frattempo lavora come cappellano nel campo di internamento per prigionieri politici di Vichy, ed entra in contatto con la Resistenza. Nel 1944 formò, insieme ad altri intellettuali, il gruppo Dieu vivant, per riflettere sulle questioni morali poste dall’occupazione.
Nel 1947 ritornato laico, si sposa e pubblica Sade prossimo mio ( Sade mon prochain). In questo periodo partecipa al movimento esistenzialista pubblicando alcuni articoli nella rivista diretta da Sartre, Les Temps Modernes.
La sua attività di romanziere comincia nel 1950 con il romanzo La vocazione sospesa (La Vocation suspendue), trasposizione letteraria della sua crisi religiosa. Ma le sue opere più importanti sono quelle successive, a cominciare da Roberta questa sera (Roberte ce soir), del 1953, il cui personaggio principale, Roberte, alter ego della moglie Denise, comparirà come segno unico in molti altri romanzi. La novella racconta la storia di Octave, che concede la moglie ai propri ospiti, appositamente invitati, per trarne piacere voyeuristico, e conoscere i lati nascosti della propria consorte. Si tratta, dunque, di un romanzo erotico, al limite tra l’invenzione narrativa e la speculazione filosofica. Carattere limitare che sarà mantenuto in tutte le novelle successive.
Tale novella sarà molto apprezzata dalla critica, come mostrano gli esempi di Blanchot e Gilles Deleuze, con il quale nascerà una profonda amicizia. Essa sarà completata da altre due novelle, che ne condividono personaggi e situazioni: La revoca dell’editto di Nantes (La révocation de l’édit de Nantes) del 1959, ed Il suggeritore (Le souffler) del 1960. Queste tre opere furono riunite nel 1965 in un unico volume dal titolo: Le leggi dell’ospitalità (Les lois de l’hospitalité); nel quale, su richiesta dell’autore, lo scritto, che in ordine cronologico è il secondo, venne inserito per primo.
L’altro frutto di quest’attività di narratore fu Il Bafometto (Le Baphomet) del 1965 che trasforma in mito la leggenda dei Templari e la trasferisce in un turbinoso regno di spiriti.
A partire dal 1975 Klossowski abbandona la sua attività di scrittore per dedicarsi esclusivamente alle arti visive: pittura e fotografia. Se già in passato aveva elaborato dei disegni per contornare le sue opere letterarie, ed aveva esposto alcuni quadri, si verifica ora il completo passaggio dalla parola all’immagine, «dallo speculativo allo speculare» per utilizzare la sua espressione. Ciò coerentemente con la sua opera filosofica, nella quale denuncia la falsificazione che «il codice dei segni quotidiani» opera dell’esperienza, attraverso la sua funzione di mediazione; e ad essa oppone la rassomiglianza rispetto alla realtà dell’immagine immediata.
Quanto alla fotografia Klossowski inizia collaborando con Pierre Zucca lavorando ad una versione illustrata de La moneta vivente, successivamente nella realizzazione cinematografica delle sue novelle, operata inizialmente dallo stesso Zucca e successivamente da Raoul Ruiz.
Quanto alla pittura, il cui carattere erotico non è meno pronunciato che nei romanzi, si è dapprima accompagnata ad i suoi romanzi, fornendo dei tableaux-vivants delle scene più importanti; successivamente (come detto dal 1975), è stata per più di vent’anni attività esclusiva di Klossowski. Dopo la prima esposizione privata nel 1956, a partire dal 1967 le sue opere saranno esposte, oltre che a Parigi, in tutto il mondo: Genova, Roma, Milano, Torino, Anversa, Messico, ecc. ottenendo un successo ed un riconoscimento della critica crescenti.
Il suo pensiero filosofico ha trovato espressione: nel già ricordato Sade prossimo mio; nel saggio il Bagno di Diana (La Bain de Diane) del 1956, analisi del mito di Diana e Atteone; Un così funesto desiderio (Un si funeste désir) del 1963, nel quale sono raccolti alcuni acuti saggi su Gide, Nietzsche, Barbey d’Aurevilly, ecc.; La moneta vivente (La mannaie vivante) del 1970. Ma la sua opera filosofica più importante è Nietzsche e il circolo vizioso (Nietzsche et le cercle vicieux) del 1969, nella quale non solo Klossowski dà un’interpretazione originale del pensiero di Nietzsche, ma, inoltre, attraverso di esso fornisce una lettura critica della cultura occidentale.
Grazie a queste opere è introdotto nel dibattito filosofico il concetto di simulacro, con un significato sfuggente a qualsiasi codificazione, destinato ad avere grande seguito nel pensiero francese degli anni sessanta e settanta; in particolare nel pensiero di Deleuze e Baudrillard.
Klossowski muore a Parigi il 12 Agosto del 2001, all’età di ottantasei anni, pochi mesi dopo la morte del fratello Balthus.
BREVE SINTESI DEL PENSIERO
Pierre Klossowski si definiva monomane ed inventore di simulacri. Nel suo pensiero la prospettiva ateologica della morte di dio si lega alla filosofia della differenza. Giacché dio è il garante dell’io, la fine della trascendenza fa venir meno anche il principio di identità.
Tuttavia l’identità è ancora resa possibile dal codice dei segni quotidiani, ossia il linguaggio. La filosofia della differenza di Klossowski si esprime allora in una critica del linguaggio istituzionale, il quale consente l’annullamento dell’alterità attraverso la dialettica speculativa. La priorità data al logos nella cultura occidentale, consente la supremazia della parola sull’esperienza, attraverso la quale la parola si costituisce come stereotipo.
Il linguaggio si costituisce come verità, occultando l’indicibile, ossia il fondo impulsionale, in cui si esprimono le forze pulsionali che abitano l’individuo, e che sono prive di senso, scopo ed intenzione. Il linguaggio falsifica la realtà imponendo un’identità fittizia che dissimula la differenza ontologica dell’individuo. Si configura una ragione contro la quale l’arma migliore è la parodia.
Per queste ragioni è necessario un passaggio dallo speculativo allo speculare, ossia all’immaginario. L’immagine crea un rapporto di rassomiglianza con il reale, che lascia sussistere l’indicibile, rinviando ad esso attraverso il segno unico.
Prima che l’impulso sia deformato dall’interpretazione dell’intelletto (mezzo dell’identità), esso si esprime nel fantasma. Anche il fantasma però è sottoposto ad interpretazione, e quindi deformato dall’intelletto. Si configura quindi il problema dei rapporti tra fantasma ed ambiente istituzionale, problema centrale nel pensiero di Klossowski. Questione che egli affronta attraverso il concetto di simulacro, destinato ad un largo seguito nel pensiero francese. Il simulacro è il corrispettivo del fantasma: «Il simulacro non è il prodotto del fantasma, bensì la sua ingegnosa riproduzione» (Klossowski, Nietzsche e il Circolo Vizioso).
Nel mondo contemporaneo il simulacro sostituisce il principio di realtà con il dominio della simulazione, cosicché l’individuo non incontra mai un’esperienza autentica, ma riproduzioni di una realtà assente. Tante copie senza originale. Tutto è falsificato, l’umanità abbandona il tempo storico per entrare nel tempo del mito.
DALLO SPECULATIVO ALLO SPECULARE
Il pensiero filosofico di Klossowski si caratterizza per una radicale critica del linguaggio istituito. La sua funzione di mediazione è alla base della dialettica speculativa che, da Platone ad Hegel, annulla la differenza. Nella sua attività di artista questa sfiducia è alla base della decisione di abbandonare le “opere di linguaggio” per dedicarsi esclusivamente alla pittura.
Si delinea così una critica del pensiero occidentale, incentrato sul primato del logos sull’esistenza che porta ad «una svalorizzazione dell’esistenza mediante una parola che, separata dall’esistenza, prende il posto dell’esistenza» (Klossowski, Le Langage, Le Silence et Le Communisme). La parola, separata dall’esperienza, diventa stereotipo.
Attraverso la mediazione linguistica si costituisce l’identità, falsificazione della realtà psichica abitata da una pluralità di forze differenti, irriducibili all’unità. Questo fondo impulsionale è inscambiabile, pertanto non si può esprimere a parole, ma nell’immediatezza dell’emozione derivante dalla visione ossessionante.
In tale visione si esprime l’immaginario o speculare. La relazione dell’immaginario con il reale è quella della rassomiglianza, al fondo della quale sussiste un dato irrappresentabile. L’immaginario si contrappone alla contraffazione del linguaggio. «L’immagine era per me un condensato di esperienza incomunicata. Nessun contenuto di esperienza si può comunicare se non in virtù dei solchi concettuali scavati dal codice dei segni quotidiani. E, inversamente, questo codice dei segni quotidiani censura ogni contenuto di esperienza» (Klossowski, Je Me Fait Sous La Dictée de L’Image).
L’immagine è concepita come alternativa rispetto alla violenza dell’interpretazione imposta dal linguaggio. Allo speculare è collegata l’emozione che nella coscienza si distingue dalla parola. Nell’ambito dello speculare il segno si configura come segno unico, ossia come immagine che rinvia all’incomunicabile mediante la sua rassomiglianza con esso.
Il linguaggio occulta la pluralità delle forze impulsionali che abitano la psiche, rispetto alle quali Klossowski concepisce una nuova coerenza, basata sempre sul codice dei segni quotidiani, ma che invece di porre questo come verità negando l’incomunicabile, rimanda costantemente alle ineffabili forze impulsionali che lo determinano. L’identità diventa così incoerenza nei confronti delle forze impulsionali la cui intensità configura il supporto (l’io), il quale le occulta per difendere la sua coerenza con l’intelletto, che rispetto a tali forze costituisce la forza repressiva.
Il venir meno dell’identità permette all’individuo di costituirsi nella discontinuità, intesa come discorso che non giunge a compimento, impedendo al pensiero di costituirsi come strumento di dominio, il quale è invece consentito dalla continuità del codice dei segni quotidiani. Questo processo porta al passaggio dalla coscienza dell’identità alla coscienza della forza, nella quale la soggettività non viene meno, ma insieme ad essa trova espressione l’energia delle forze impulsionali. Questa espressione si realizza attraverso il gesto muto, il quale costituisce un termine medio tra linguaggio istituzionale ed idioma corporale, poiché è capace sia di essere ricondotto nella designazione, sia di esprimere l’indicibile che ad essa sfugge. Il gesto muto si trova in stretto rapporto con lo speculare, rapporto reso possibile dall’esistenza di un quadro preliminare, nel quale le forze impulsionali si articolano in una visione, in un’immediatezza originaria rispetto alla concettualità. Questo quadro concettuale è anche alla base della rassomiglianza.
Klossowski propone, dunque, un passaggio “dallo speculativo allo speculare”, in cui il tradizionale primato della parola sull’esperienza viene invertito in favore di un realismo nell’ambito del quale si possa accedere all’indicibile dell’emozione. In questo modo diventa possibile per l’individuo porsi di fronte all’alterità, la quale è invece negata dalla dialettica speculativa che costituisce il tratto distintivo della filosofia occidentale. Questo riconoscimento dell’alterità è resa possibile dal simulacro che imita la differenza, sostituendo la rassomiglianza all’imitazione. Si realizza così il riconoscimento della differenza, ossia l’etica.
KIERKEGAARD CON NIETZSCHE
Lo scritto principale di Klossowski dedicato a Kierkegaard è il “Don Juan Selon Kierkegaard” .
Tale scritto è dedicato in particolare all’analisi di un’opera del filosofo danese: “Gli Stadi Erotici Immediati ovvero Il Musicale Erotico”, pubblicata in Enten-Eller tomo I. Testo basato sull’idea che l’immediato erotico o «genialità sensuale» essendo «forza, respiro, insofferenza, passione» non possa trovare espressione nel linguaggio, medium della riflessione, ma si manifesti solo nella musica.
L’immediato erotico è il desiderio forte ed infinito, impersonificato, secondo Kierkegaard, dal Don Giovanni di Mozart.
Il suo carattere immediato deriva dal suo essere senza scopo, essendo centrato esclusivamente su stesso.
Da qui l’irrequietezza della genialità sensuale, e la sua irriducibilità al linguaggio, per il quale rappresenterà sempre l’ineffabile e l’inintelligibile. Gli stadi erotici immediati, annullando la riflessione, lasciano la coscienza indeterminata e disindividualizzata.
Kierkegaard pone, dunque, una contrapposizione tra immediato erotico e riflessione, intendendo quest’ultima come la mediazione della coscienza. Dicotomia dalla quale deriva quella tra musica e linguaggio, modalità di espressione rispettivamente dell’immediato e della riflessione.
Questa spaccatura, sempre secondo Kierkegaard, è stata introdotta dal cristianesimo con la sua esaltazione della parola e dello spirito e la contemporanea denigrazione della musica e della sensualità. Questa trae quindi dall’esclusione del cristianesimo non le sue peculiarità, ma la sua qualità di interdetto, giacché l’escluso deve esistere prima dell’esclusione, ma è solo dopo quest’ultima che diventa tale.
L’immediato erotico è così costretto a confluire nel dominio dello spirito, che lo conserva a prezzo però della sua falsificazione. La sensualità è osteggiata perché essendo senza scopo impedisce la prospettiva teologica.
Klossowski condivide pienamente le tesi di questo saggio. In particolare, la dicotomia tra immediatezza e riflessione cui si collega quella tra musica e linguaggio; nonché la tesi per la quale il cristianesimo attraverso la mediazione riconduce a sé l’immediato e l’indeterminato, occultandone la natura.
Ciò gli permette di porre un legame tra Kierkegaard e Nietzsche. Anche questi, infatti, è convinto che la musica dia espressione agli impulsi ineffabili, come mostra questo frammento tradotto dallo stesso Klossowski: «la musica è un linguaggio semiotico di affetti» (Nietzsche citato in Klossowski 1969). L’immediato kierkegaardiano è così ricondotto al dionisiaco di Nietzsche. Secondo Klossowski infatti Don Giovanni è «l’incarnazione del dionisiaco» (Don Juan Selon Kierkegaard).
Il processo descritto da Kierkegaard rappresenta perciò la dissimulazione del dionisiaco effettuata dal cristianesimo, e denunciata da Nietzsche. Si spiega così la teoria della morte di dio, volta ad impedire che l’uomo si fissi in un’identità che dà luogo alla riflessione ed alla coscienza, giacché dio è il fondamento dell’io.
Proseguendo nel confronto, Klossowski afferma che Nietzsche e Kierkegaard rappresentano le due coscienze che «formano la testa di Giano della coscienza moderna» (Don Juan Selon Kierkegaard). Il primo si caratterizza per la teoria del fato, il secondo per quella della colpa.
Distinzione in linea con quella postulata da Kierkegaard tra il tragico antico e moderno: mentre l’eroe moderno vive nell’angoscia della colpa, quello antico vede la propria responsabilità limitata dalla credenza nel destino, e da gruppi sociali che ne riducono la libertà di scelta.
Secondo Klossowski, Don Giovanni rappresenta entrambe le coscienze, giacché è un eroe moderno ma è anche espressione dell’eroe antico nella sottomissione agli impulsi, la cui necessità è ineliminabile sia per gli uomini che per gli dei.
Per questo, l’attrazione che Kierkegaard prova per il Don Giovanni mozartiano, ne testimonia i dubbi sull’esistenza di un al di là rispetto alla divinità, costituito appunto dal fondo impulsionale (il dionisiaco). «Don Giovanni fu per lui la forza elementare ed informe che, arrestata fortuitamente nel suo movimento e sul punto di incontrarsi con l’oggetto, ricade nella sua prima informità per riprendere il suo ritmo infinito» (Don Juan Selon Kierkegaard).
Tali dubbi sono controllati e dissimulati attraverso l’angoscia della colpa. Don Giovanni «è la melodia infinita del possibile che l’anima di Kierkrgaard intendeva con una nostalgia angosciata dal sentimento di colpevolezza» (Don Juan Selon Kierkegaard).
Se tale al di là esistesse veramente, sarebbe necessariamente intaccata anche la coscienza, nonché l’etica cristiana.
Questo è il fondamento della critica radicale di questa etica che Klossowski porta avanti in altri scritti. Nel momento in cui essa diventa una convenzione, possono essere giustificate tutte le azioni compiute in nome degli stereotipi che veicola. L’istituzione trasforma la convenzione in convinzione, permettendo a qualsiasi idea morale di imporsi divenendo il codice sulla cui base giustificare comportamenti divenuti totalmente irresponsabili.
Ciò che Klossowski contesta è l’idea della divinità onnisciente il cui disegno consente agli uomini di agire senza responsabilità per i propri atti. È l’idea del dio che permette all’individuo di agire secondo i propri obiettivi di dominio, sicuro della moralità dei propri atti in quanto conformi all’imperativo codificato.
Klossowski denuncia quindi il dio divenuto il fondamento di sopraffazione e violenza.
Il cristianesimo, i suoi valori ed i suoi concetti (bene, male, colpa, peccato, ecc,), raggiungono il risultato paradossale per cui imponendosi come base per la moralità, diventano il presupposto dell’irresponsabilità. È questa la ragione per la quale Klossowski condivide la critica radicale che di questi valori fa Nietzsche.
L’idea centrale, che accompagnerà Klossowski in tutta la sua opera, è che ogni linguaggio istituzionale comporta sempre una falsificazione. La morale cristiana è un mero simulacro.
Il valore serve a nascondere l’assenza di scopo della volontà umana, attraverso una parvenza di giustizia ottenuta attraverso la conformità agli imperativi trascendenti.
È necessario un cambiamento per il quale, come afferma Nietzsche, si passi dal “tu devi”, imperativo codificato dal gregge che falsifica l’esperienza, all’”io voglio” in cui si esprime il fondo impulsionale che fa dell’individuo un singolo.
In conclusione Klossoswki lungi dall’opporre Kierkegaard a Nietzsche, ne mostra l’affinità. Il filosofo che teorizzava la colpevolezza dell’uomo, e quello che enfatizza Dioniso, “l’innocenza del divenire”, e la critica i valori occidentali, s’incontrano nella constatazione che Kierkegaard avverte, attraverso il Don Giovanni di Mozart, il dionisiaco ma lo rimuove attraverso la colpa.
Il risultato di questo legame non è la fine della colpa, quanto l’impossibilità della sua codificazione dovuta alla deformazione che il linguaggio comporta; a cui contrapporre un pensiero corporante in cui trovi espressione il fondo impulsionale, l’eterno dionisiaco la cui scoperta accomuna Kierkegaard a Nietzsche.
SADE PROSSIMO MIO
Sade Mon Prochaine inaugura un periodo di studi e rivalutazioni dell’opera sadiana, fino a quel momento considerata scandalosa, al quale parteciperanno filosofi come Sartre, Bataille, De Beauvoir, Deleuze; è questo uno dei maggiori meriti dell’opera.
Il saggio ha avuto una prima edizione nel 1947, una seconda nel 1967 con l’aggiunta, in apertura, dello scritto “Il Filosofo Scellerato” (Le philosophe scélérat) che corregge l’impostazione eccessivamente teologica ed hegeliana del primo.
La riflessione di Klossowski su Sade è continuata nel 1970 con il saggio “La Moneta Vivente” (La mannaie vivante) e nel 1974 con “Gli Ultimi Lavori di Gulliver seguito da Sade e Fourier” (Les derniers travaux de Gulliver suivi de Sade et Fourier).
Il saggio del 1947 si apre con l’analisi della posizione di Sade dinanzi alla Rivoluzione Francese.
Tale analisi è una spiegazione della tesi sadiana in base alla quale la Rivoluzione, essendo rovesciamento del crimine monarchico si possa mantenere solo restando nel crimine.
In Sade, secondo Klossowski, agiva la cattiva coscienza del libertino, il quale si aspettava dalla Rivoluzione «un rifacimento totale della struttura dell’uomo» (Klossowski 1947). Essa avrebbe dovuto portare ad una società in cui il silenzio delle leggi avrebbe finalmente permesso il discorso dell’uomo.
Tale posizione evidenzia un latente atteggiamento teocratico nei confronti del re. Infatti, per i teorici laici della Rivoluzione, l’uccisione del re è resa necessaria dal suo alto tradimento nei confronti dello stato; per i cattolici controrivuzionari, al contrario, il re è l’unto di dio, pertanto il suo assassinio è l’uccisione del rappresentante temporale della divinità. Sade, nel suo pensiero più profondo, condivide quest’ultima impostazione, ma, considerando dio malvagia fonte di tutti i mali, ne trae un giudizio di segno opposto. Per Sade, e per Klossowski, l’uccisione del re è il simulacro dell’uccisione di dio, al crimine inaugurale ed inespiabile, potrà seguire solo una società che si fonda essa stessa sul crimine. La Rivoluzione deve essere permanente, perpetuandosi attraverso un progressivo annientamento dell’idea di dio nella vita familiare e sociale.
Riprendendo il sillogismo di Ivan Karamazov, dalla morte di dio tutto è permesso, per cui la repubblica che ne nasce non dovrà essere basata sulla fraternità ma dovrà essere cainica. «Probabilmente Sade voleva sostituire alla fraternità dell’uomo naturale (passata alla storia come uno dei tre valori rivoluzionari-repubblicani) la solidarietà del parricidio (che sarebbe stata la logica conseguenza della messa a morte di Luigi XVI) parricidio eseguito come volontà popolare» (Klossowski 1947). La società nata dal parricidio non può che essere, per Sade, una società di criminali.
L’uccisione del re è la rivoluzione politica, logica conseguenza della rivoluzione morale dei libertini che ha portato alla morte di dio. Su queste basi Klossowski critica la Rivoluzione. Il suo errore è stato quello di voler fornire una legittimazione politico-giuridica all’uccisione del re. Per questo Robespierre è stato il rivoluzionario più coerente: il re non può essere giudicato, giacché ciò significherebbe riconoscerlo innocente fino a prova contraria, e quindi mettere in discussione la Rivoluzione. «Luigi XVI deve morire affinché la patria possa vivere» (Klossowski 1947).
Il crimine non deve essere giustificato ma portato fino alle sue estreme conseguenze. Klossowski propone qui un’interpretazione hegeliana (la dialettica hegeliana sarà il leit motiv di tutto il saggio) della Rivoluzione, nei termini della dialettica del Servo e del Padrone (nella versione di Kojéve). Divenuti atei Padroni e Schiavi, vengono meno tutte le giustificazioni del rapporto di signoria, e non può che nascerne un conflitto con cui gli Schiavi cercano di rovesciare i rapporti di forza. Gli Schiavi si ribellano così contro i Padroni e li processano.
Questo movimento dialettico ha come motore il privilegio del crimine. Per rovesciare lo status quo lo Schiavo deve assumere su di sé il carattere criminale del potere del Padrone, mantenendone il carattere autoreferenziale. «L’unico esito del processo è l’assunzione da parte degli Schiavi delle prerogative dei Padroni» (Klossowski 1947).
Klossowski oppone dunque l’autoreferenzialità del crimine alla ricerca di una giustificazione, che non può che essere un simulacro, ed individua in questa ricerca l’errore dei rivoluzionari che ha impedito loro di portare a termine il processo iniziato con l’uccisione di dio.
Nella sezione successiva, intitolata Esquisse du Sistéme Sade, Klossowski analizza più dettagliatamente il Sade libertino, mostrando come esso sia portato alla filosofia della natura.
Lo scenario rimane quello della morte di dio, con il conseguente venir meno dell’identità personale e della nozione di prossimo.
La ricerca di una libertà originaria assume la forma di un’utopia del male, nella quale l’uomo lascia libero sfogo alle forze impulsionali costrittive nell’immaginazione di crimini privi di razionalità.
L’ateismo è per Sade solo una maschera, sotto la quale persiste la considerazione per la nozione di prossimo. Per Sade dopo la morte di dio il crimine trionfa, paradossalmente, per la ricerca di fini virtuosi. Pertanto, l’unico modo per conservare il prossimo è quello di costituirlo come oggetto della pratica criminale.
Per il libertino, dunque, dio ed il prossimo sono fondamentali per rimanere nel vizio, pervertendo i valori tradizionali per raggiungere i propri fini. «Il suo [di Sade] ateismo non è che una forma di sacrilegio» (Klossowski 1947).
Il mondo venuto meno con la morte di dio è ricreato attraverso le forze impulsionali, chiuse nell’immaginazione, dalla quale emergono crimini mostruosi ed il loro oggetto: il prossimo.
Secondo Sade tutto è vizio e distruzione, ad imitazione di dio, padre di tutti i crimini. L’altro è ricostruito attraverso la sua distruzione.
Per effetto di questo movimento il sadico si differenzia sempre più dal libertino. Quest’ultimo,
infatti, ritiene il prossimo fondamentale per la perversione, giacché in essa si costituisce un rapporto di odio-amore in forza del quale l’affermazione di sé passa attraverso la costruzione dell’altro.
Per il sadico, al contrario, il prossimo dilegua sempre più nella distruzione permanente di cui è oggetto, divenendo un puro nulla sul quale far valere la coscienza di sé. La coscienza sadica cade così in contraddizione tra la necessità della distruzione e quella della conservazione. Riducendosi a nulla il prossimo, anche l’io sprofonda. «Se l’altro non è più nulla per me, non solamente io non sono più nulla per lui, ma nulla anche a riguardo della mia propria coscienza, quando è necessario che la coscienza sia ancora mia» (Klossowski 1947).
Questa contraddizione porta la coscienza sadiana dalla figura del libertino a quella del filosofo della natura. Giacché è necessario che il prossimo si ricomponga dopo la sua distruzione, Sade sceglie a modello del proprio movimento quello della natura, nella quale distruzione e creazione convivono in vista di un fine predeterminato.
In altri termini, giacché l’essere nulla del prossimo porta al dileguamento dell’io, è necessaria per la continuazione del movimento l’esistenza di due soggetti. La soluzione è immaginata da Sade, ad imitazione della natura, nella «reiterazione senza fine degli atti» (Klossowski 1947).
In questo modo, la dialettica del movimento sadico è ricondotta ad una più alta legge di natura, per la quale il vizio, il male, la morte non sono che un momento della sua metamorfosi perenne.
Giacché la distruzione è frutto di una legge di natura, la reazione del soggetto sadico, di fronte ad i propri atti, non può che essere l’apatia. Sentimento che emerge dall’individuazione nel movimento della distruzione e ricomposizione della natura la spiegazione della propria perversione. Nel riconoscere il suo prossimo, il sadico lo distrugge per poi ricomporlo di nuovo.
In questo modo la morale viene meno, per essere però reintrodotta, invertita di segno, ossia orientata verso la prossimità più lontana ed irraggiungibile: la vergine.
Al fondo di questo movimento corporale, l’anima (intesa da Klossowski come “spazio puramente psichico” nel quale agiscono “forze oscure”) scopre la noia e «la durata nel tempo insopportabilmente lungo e vuoto, come l’incatenamento alla sua propria condizione» (Klossowski 1947). Venuto meno il prossimo, l’anima si considera caduta nella maledizione del vuoto, condannata alla solitudine. Diventa allora necessario negare la distruzione attraverso «l’ossessione della verginità; esperienza di base del temperamento di Sade» (Klossowski 1947). Nel “crimine puro” «distruzione e purezza si confondono e divengono una sola esigenza assoluta» (Klossowski 1947).
In quanto irraggiungibile il copro della vergine è disincarnato, per esistere solo nell’immaginazione del sadico, il quale sostituisce alla ferocia del carnefice l’attesa destinata a restare frustata. Questa situazione è definita da Klossowski delectatio morosa. Con questa espressione Klossowski intende un attacco meramente immaginario portato dal perverso alla purezza verginale, con cui egli ricerca di ricostituire il peccato, con il quale superare la noia nella quale la sua anima è sprofondata. «La delectatio morosa consiste in questo movimento dell’anima, attraverso il quale [il sadico] si porta volontariamente verso le immagini di atti criminali e spirituali proibiti, per attardarsi nella loro contemplazione» (Klossowski 1947).
Nell’immaginario la coscienza cerca di ricostituire la propria colpevolezza, attaccando la vergine che nella realtà è irraggiungibile. Gli oggetti scomparsi vengono ricostituiti nell’immaginazione ma solo per essere distrutti di nuovo. Anche nell’immaginazione si attua il movimento distruttore che ha annientato gli oggetti reali portando alla scomparsa anche di quelli immaginari. «La delectatio morosa è sterile, non serve alla necessità per cui il pensiero la pratica, in quanto incatena alla noia perpetua, piuttosto che liberare. È attesa distruttrice del presente» (Klossowski 1947).
Anche nell’immaginario si rinnova la contraddizione tra il desiderio di distruggere e quello di conservare gli oggetti, e l’esito è lo stesso: la noia.
Riassumendo: la rabbia di Sade contro il re e dio, è la ribellione contro le istituzioni che schiacciano le forze impulsionali nelle convenzioni e nei divieti. Nel suo movimento distruttore, però, Sade annienta il prossimo, e per sfuggire alla solitudine che ne deriva, lo ricostituisce nell’immaginario. In esso il prossimo assume la forma della vergine, quale simbolo di purezza inaccessibile.
La criminalità pura è dunque abitata dalla speranza di raggiungere la purezza attraverso la colpa.
Questa analisi dell’opera sadiana è fortemente influenzata dalla dialettica hegeliana, tanto che, nel suo commento, Bataille vede in essa la chiave interpretativa utilizzata dal suo amico Klossowski nella lettura degli scritti del marchese.
Negli Ecrits d’un Monomane Essais 1933-1939, serie di saggi di Klossowski dedicati a Sade, Nietzsche e Kierkegaard, pubblicati nel 2001, emerge come Klossowski considerasse la figura del libertino e quella del filosofo della natura come due metafore del dominio. La prima mostra come il potere si accerti di sé nella negazione ripetuta dell’altro, nella sua distruzione infinita. Nella seconda prevale invece la fredda autonomia di un ordine meccanico, in cui l’altro non esiste più, lo si può uccidere senza più provare né piacere, né dolore, nell’ apatia dell’adesione totale alla grande macchina.
Vent’anni dopo il suo primo saggio su Sade, Klossowski torna ad occuparsi dell’argomento nello scritto Il Filosofo Scellerato. In questo testo, successivamente posto in apertura di Sade Prossimo Mio, Klossowski prende le distanze dal suo primo lavoro, ravvisandovi un certo «romanticismo quasi wagneriano» (Klossowski 1967).
L’opera sadiana si caratterizza per la contrapposizione tra la generalità istituita, e la singolarità anomala del perverso. Questi si caratterizza per la sua coerenza con il fondo impulsionale del corpo, che si manifesta nel pensiero corporante. Da qui la giustificazione e l’approvazione per i crimini dei suoi personaggi, vista l’impossibilità di mantenersi nella purezza.
Sade sente la necessità di divulgare questa singolarità, e per farlo utilizza, paradossalmente, l’organo più importante della generalità: il linguaggio istituzionale. In questo modo, Sade incrina la coerenza del linguaggio, facendolo entrare in crisi, poiché lo costringe ad ospitare i fantasmi del perverso. Quest’espressione inevitabilmente falsificherà il fantasma, poiché il fondo impulsionale è indicibile, e pertanto non può essere espresso dal linguaggio.
L’opera di Sade è allora un simulacro di scrittura. La mostruosità di Sade non è più considerata la sua volontà di distruggere tutto, ma quella di servirsi del linguaggio istituzionale per invertirne il senso, rendendolo autocontraddittorio. Conservare la morale e la nozione di prossimo è dunque necessario per fornire al perverso gli oggetti con cui affermare la propria singolarità.
Il fine perseguito da Sade attraverso la perversione del linguaggio istituzionale è la distruzione della ragione normativa, il fondamento dell’identità e dell’io. Solo attraverso la distruzione del concetto di identità potranno emergere nella coscienza le forze impulsionali che abitano il corpo.
Corollario della critica della ragione normativa è quella del monoteismo. Per liberarsi dell’io, infatti, è necessario anche liberarsi del dio monoteista, che è alla base dell’identità personale.
Dunque la critica del monoteismo è necessaria per quella della ragione normativa, ma l’inverso è altrettanto vero. Da qui la critica dell’ateismo razionale che è solo «un monoteismo rovesciato» (Klossowski 1967), nel quale sono mantenute tutte le garanzie di stabilità dell’io e dell’identità. È necessario, quindi, un ateismo integrale, che oltre a dio elimini tutti le altre maschere del monoteismo.
Secondo Klossowski, la questione fondamentale posta da Sade è quella relativa al modo in cui piegare il linguaggio, strumento della razionalità, per asservirlo alle anomalie.
Sono due gli strumenti attraverso i quali Sade fa emergere la singolarità nel tessuto istituzionale.
In primo luogo la sodomia, che Klossowski considera la parodia sadiana della sessualità convenzionale. Essa è il simulacro della procreazione, la trasgressione nei confronti della generalità, della regola istituzionale.
Il secondo strumento è il linguaggio corporale, ossia la comunicazione silenziosa tra i corpi. «Gli atti obbediscono al silenzio, le parole non sono dette che per nascondere questa obbedienza» (Klossowski 1967).
Tale linguaggio corporale è in realtà un simulacro di comunicazione, giacché le parole valgono per ciò che è scambiabile, l’inscambiabile si manifesta nella contraffazione. Esso è dunque la parodia della parola.
Questo non-linguaggio è ostacolato dalla coscienza. Tale conflitto è legato alla duplice funzione svolta dalle forze impulsionali, consistente nella creazione di «un organo di intimidazione sotto la pressione del mondo istituzionale, come di un organo di sovversione sotto la pressione interna di quelle forze» (Klossowski 1967). L’apatia è il sentimento che risulta da questo movimento, poiché in esso non si dà priorità a nessuna delle due forze, ma vengono espresse insieme, in quella che Klossowski definisce simultaneità contraddittoria. Da una parte, affinché i corpi s’incontrino devono essere affetti dall’impulsionalità esplosiva, uscire dal proprio io per essere possedibili; dall’altra per alienare il proprio corpo occorre possederlo ed esercitare su di esso un controllo attraverso l’impulsionalità implosiva. Pertanto la trasgressione necessita delle interdizioni sociali.
Sade delinea così il circolo vizioso della trasgressione, che Klossowski considera una grande intuizione poiché anticipa la nozione di “innocenza del divenire” elaborata da Nietzsche.
Riassumendo, le norme istituzionali (in particolare il linguaggio) formano la coscienza e l’identità basandosi sull’istinto gregario. Il perverso, invece, realizza la propria pratica singolare attraverso l’oblio del concetto di io. Il perverso sente il corpo altrui come proprio, ed il proprio corpo come estraneo, giacché ha dissolto nell’apatia i limiti tra le persone. La parola è sostituita dal linguaggio corporale, ossia dal gesto in cui si esprime la simultaneità contraddittoria; ed il razionale dall’immaginario.
Questa esperienza disindividualizzante è espressa da Sade nella scrittura, ossia attraverso il codice dei segni quotidiani. Giacché è sempre necessario utilizzare le convenzioni esistente, anche per modificarne l’uso. In questo modo il linguaggio viene contaminato dal fondo impulsionale, che esso non può esprimere poiché è indicibile. Questo ineffabile non può che essere falsificato dal linguaggio. Da questa distorsione si configura la scrittura simulacro, che ha i caratteri della coerenza razionale, ma comporta un residuo rivelato ed insieme occultato dal simulacro stesso.
Proprio perché il filosofo deve rivelare il fondo impulsionale, egli deve essere un filosofo scellerato.
LO SCAMBIO DEI CORPI: SADE O FOURIER?
Nel 1970 Klossowski pubblica La Moneta Vivente, opera nella quale torna ad occuparsi di Sade.
Se con Il Filosofo Scellerato Klossowski aveva liberato Sade dalla dialettica hegeliana di Sade Prossimo Mio, considerando la opera sadiana come perversione del linguaggio istituzionale; con il suo nuovo saggio si ha un allargamento dell’analisi che considera ora la perversione alle prese con la società industriale.
Klossowski continua, dunque, a considerare il rapporto tra fantasma ed istituzioni, ma ora la sua analisi cambia di oggetto: dal linguaggio alla produzione seriale di beni di consumo. Come il linguaggio, anche le nozioni dell’economia di mercato sono pervertite dal loro senso abituale, per entrare in nuovo luogo in cui il godimento è l’oggetto di scambio. In questo modo il fondo impulsionale entra nel meccanismo economico e configura un’economia impulsionale.
Klossowski postula una equivalenza tra economia impulsionale ed economia di mercato. Il termine medio è il simulacro. Infatti, questa eguaglianza diventa possibile nel caso in cui «un oggetto sia di uso necessario proprio in quanto simulacro» (Klossowski 1970). Con l’industrializzazione e l’economia di mercato l’utensile assume il carattere del simulacro. «Un utensile può essere un utensile solo se è un simulacro» (Klossowski 1970).
Giacché in questo tipo di economia il valore rivelante non è quello d’uso, ma quello di scambio. Affinché il bene sia scambiabile, l’operatore dovrà produrre il simulacro del valore d’uso inutilizzabile, ossia dovrà rendere produttivo il fondo del bene in sé sterile. La società industriale imita il perverso.
Il bene è acquistato in quanto simulacro del fantasma del perverso. Ma questo non è scambiabile, pertanto non ha prezzo. Entrando nella sfera della produzione invece viene fissato un prezzo, che è tanto maggiore quanto più comporta il dissolvimento dell’identità dell’individuo. Il commercio di beni di godimento risiede, dunque, nella conservazione e nella trasgressione dell’io.
Nel momento in cui la perversione del sistema industriale è realizzata, sarà possibile far entrare nel commercio le stesse persone. Per l’individuo che possiede il proprio corpo, l’oggetto di scambio sarà la rinuncia di tale possesso, l’alienazione di se stesso. «Il fantasma perverso si forma in quanto oggetto d’uso dell’emozione voluttuosa» (Klossowski 1970). Ma tale fantasma potrà entrare nel mercato solo come oggetto di scambio, ossia come simulacro, il cui prezzo dipenderà dalla sua utilità, la quale a sua volta dipende dal livello della domanda di voluttà.
Ma se il perverso rinuncia volontariamente al proprio io, per l’operatore economico una simile rinuncia non è possibile. Pertanto l’operatore potrà accettare questa logica perversa solo se esiste un equivalente «uno che valga per qualcosa tanto nella sfera del fantasma elaborato a spese dell’unità individuale, quanto a livello dell’individuo, nella sfera esterna dell’oggetto fabbricato» (Klossowski 1970). Il denaro diventa così un mezzo convenzionale della perversione. «Mentre rappresenta ciò che esiste il denaro diventa ancora di più il segno di ciò che non esiste, ossia del fantasma» (Klossowski 1970).
Lo scambio dei corpi diviene simile allo scambio economico, ed il denaro, strumento istituzionale che consente al perverso di realizzare i propri fantasmi, diventa moneta vivente. La moneta vivente è il corpo che nello scambio è l’oggetto dato in cambio del denaro. Pagando, l’individuo adotta la mediazione istituzionale per rapportarsi all’altro, oggetto della propria voluttà. Il mezzo principale dell’economia utilizzato come mezzo di perversione: ecco la perversione della società industriale. Il corpo pagato diventa il simulacro del fondo impulsionale privo di prezzo.
In Gli Ultimi Lavori di Gulliver seguito da Sade e Fourier, Klossowski confronta le posizioni di Sade e Fourier dinanzi a questo sistema industriale.
Anche per Fourier, come per Sade, la creazione del simulacro è necessaria, ma, al contrario di questi, Fourier è molto critico nei confronti del sistema industriale. «Per Fourier il fantasma in sé incomunicabile, come per Sade, esige la creazione di un simulacro; ma il senso del simulacro dal punto di vista dello scambio, Fourier lo sviluppa in una direzione totalmente opposta» (Klossowski 1970).
Per Fourier lo scambio dei beni oggetto della volontà deve avvenire su basi gratuite, il valore viene quindi annullato. Per Sade, invece, la moneta, e quindi il valore, è uno strumento di mediazione per ottenere il corpo alienato, divenuto merce.
NIETZSCHE E LA SEMIOTICA IMPULSIONALE
Nietzsche e Il Circolo Vizioso è l’opera filosofica più importante di Klossowski. Essa partecipa alla Nietzsche-renaissance, fornendole un contributo originale e profondo. Questa rinascita degli studi sul filosofo tedesco, basata sull’interpretazione che di esso fece Bataille negli anni venti, inizia subito dopo la fine della guerra e raggiunge il suo culmine negli anni sessanta e settanta. Comincia Blanchot con il suo saggio Dalla Parte di Nietzsche del ’49, un altro contributo importante è l’opera L’Avant Dernière Pensée de Nietzsche di Jean Wahl del 1961. Ma il saggio che spicca maggiormente è quello di Gilles Deleuze Nietzsche e La Filosofia del 1962.
Klossowski trova in Nietzsche piuttosto che un maestro un complice, il cui pensiero rappresenta uno strumento senza pari per la critica dei valori occidentali. L’adesione pressoché totale al pensiero del filosofo tedesco non si trasforma in Klossowski in un dogma, proprio perché si riferisce ad una “teoria” profondamente antidogmatica.
L’interpretazione di Nietzsche proposta da Klossowski, è legata alla filosofia della differenza teorizzata da Deleuze, al quale, significativamente, Nietzsche e Il Circolo Vizioso è dedicato. Questa visione si oppone sia alla distorsione nazista, sia all’esegesi proposta da alcuni marxisti, i quali non considerano «il fatto che questo pensiero ruota intorno al delirio come al proprio asse» (Klossowski 1969).
Klossowski analizza non solo gli scritti dell’ultimo Nietzsche (1880-1888), da lui stesso tradotti, ma anche la sua biografia, con le patologie che l’attraversano e la follia in cui culmina. Sia la vita che il pensiero sono letti come un complotto delle forze impulsionali che abitano il corpo contro il principio di identità (ossia la coscienza), e ciò che lo fa sorgere: l’autorità istituzionale (ossia il linguaggio definito codice dei segni quotidiani); complotto culminante nella valorizzazione del delirio, nel quale è abolito il principio di identità personale. Delirio la cui estrema lucidità è occultata dalla coscienza. Complotto, delirio e lucidità sono i tre i cardini del pensiero nietzscheano.
Questo conflitto avviene tra due potenze: «quella livellatrice del pensiero gregario e quella erettiva del caso particolare» (Klossowski 1969). Il pensiero gregario è espresso dalla coscienza nella sua sottomissione al codice dei segni quotidiani che le permette di costituirsi come io. La personalità erettiva è invece la singolarità che si eleva al di sopra del gregge poiché sprofonda volutamente nel proprio organismo, inventando la semiotica impulsionale ossia la strategia comunicativa adottata dalle forze impulsionali.
Il venire alla luce del fondo impulsionale comporta la supremazia dell’immaginario, il quale deve però trovare espressione anche nella dimensione istituzionale. Affinché ciò avvenga è necessario che la semiotica della coscienza sia invertita nella semiotica impulsionale, in un pensiero corporante in cui si esprime la coerenza tra l’individuo e le sue pulsioni.
Gli stati valetudinari di Nietzsche sono, dunque, il risultato della reazione della coscienza agli assalti delle forze impulsionali. «L’emicrania torturante di cui soffre periodicamente come di un’aggressione che sospende il pensiero, non è un’aggressione dall’esterno; la radice del male è in lui, nel suo organismo: è il suo io fisico che attacca per difendersi dallo sfacelo» (Klossowski 1969). Questo sfacelo è però considerato tale solo dal cervello. «Nel corpo la situazione è molto diversa: vi sono delle forze attive che, essendo funzioni organiche, e dunque non libere, vogliono spezzare la loro schiavitù; ciò può avvenire soltanto se questa volontà passa per il cervello: il quale d’altro canto sente questa volontà come propria soggezione alle forze dello sfacelo: l’impossibilità di pensare è la sua minaccia» (Klossowski 1969).
C’è, dunque, in Nietzsche un conflitto tra corpo e cervello, dove con corpo si intende «il risultato del caso fortuito: è solo il luogo d’incontro di un insieme di impulsi individuati nell’intervallo costituito da una vita umana, impulsi che aspirano solo a disindividualizzarsi» (Klossowski 1969). Il corpo dunque è la sede della forza degli impulsi.
Negli stati valetudinari questi impulsi cercano di trovare espressione. «Se il corpo soffre a tal punto, se dal cervello non vengono che segnali angosciosi, ciò vuol dire che in tutto questo c’è un linguaggio che cerca di farsi intendere a dispetto della ragione» (Klossowski 1969). Più Nietzsche intende questa semiotica impulsionale «più diffida dalla persona che ha il corpo come supporto» (Klossowski 1969). La conseguenza per Nietzsche è «un sospetto, un odio, una rabbia nei confronti della propria persona cosciente e ragionevole. Non è questa persona – formatasi secondo i condizionamenti di un’epoca, in un clima familiare sempre più aborrito – che Nietzsche vuole conservare; anzi vuole distruggerla per amore di quel sistema nervoso che sa di possedere e da cui trae vanto» (Klossowski 1969).
Esistono due codici radicalmente contrapposti: la semiotica impulsionale espressione delle forze che abitano il corpo, ed il codice dei segni quotidiani, forniti dall’esterno e dai quali sorge la coscienza. Questa contrapposizione deriva dal fatto che il linguaggio istituzionale inverte i messaggi del fondo impulsionale. «Il corpo vuole farsi capire per mezzo di un linguaggio di segni che la coscienza decifra in modo errato: essa costituisce un codice di segni che inverte, falsifica, filtra tutto ciò che si esprime attraverso il corpo. La coscienza stessa non è altro che il cifrario dei messaggi trasmessi dagli impulsi, e la decifrazione è proprio quella inversione del messaggio che l’individuo si attribuisce» (Klossowski 1969).
Il segno è originariamente la traccia lasciata da una fluttuazione di intensità tornata su se stessa. «Com’è allora che [l’intensità] acquista un senso […]? Tornando appunto su se stessa, anche in una nuova fluttuazione! Così ripetendosi e quasi imitandosi essa diventa un senso» (Klossowski 1969). Tuttavia il segno così costituito non può nascondere il Caos che l’ha generato. «nonostante il segno in cui culmina la fluttuazione di intensità, il significato, costituendosi solo nell’afflusso, non emerge mai completamente dagli ondeggianti abissi che cerca di nascondere. Ogni significato rimane funzione del Caos generatore di senso» (Klossowski 1969). Affinché da questa traccia ancora rivelatrice della propria origine, si passi al codice dei segni quotidiani, è necessario che l’intensità subisca un processo di abbreviazione e deformazione da cui scaturisce la parola, la quale determina la sensazione di continuità. Quando un nuovo impulso si prospetta alla coscienza, essa lo conosce attraverso la traccia lasciata da una precedente intensità, che questo nuovo impulso intensifica, per questa ragione il nuovo è considerato già noto. Questo processo dà alla coscienza l’impressione che l’esterno sia diventato un suo possesso, e pertanto annulla l’alterità.
La coscienza è solo un prodotto del codice dei segni quotidiani, per questo in essa trova espressione l’istinto gregario. «In che misura si dirà che è “cosciente” […]? Nella misura in cui si produce in esso lo scambio più o meno disuguale tra la pulsione e il segno del codice quotidiano» (Klossowski 1969). Questo scambio è anche alla base dell’occultamento delle forze impulsionali. «Ma allora non è forze inconsapevole di quello che vogliono tali impulsi per sé?» (Klossowski 1969). La coscienza rovescia i segnali che le provengono, ricostituendoli con il codice dei segni quotidiani. Ne deriva la differenza tra la semiotica cosciente ed il fondo impulsionale. «dove vige un sistema di designazione diverso e per il quale non esiste né fuori né dentro. Ne segue che noi siamo presi, abbandonati, ripresi e sorpresi, ora dal sistema di designazione pulsionale, ora da quello dei segni quotidiani» (Klossowski 1969).
Il linguaggio è, come affermava Mallarmé, una moneta consumata che gli individui si scambiano, in silenzio. Giacché più gli individui parlano, più utilizzano il codice dei segni quotidiani, più cresce la differenza tra il linguaggio istituzionale ormai completamente automizzato, e il reale dell’esperienza, che esso dovrebbe designare, ma che in realtà occulta. La parola diventa uno stereotipo. La costituzione fortuita della coscienza e dell’io deriva dall’imposizione da parte del linguaggio istituzionale, di, utilizzando l’epressione di Deuleze-Guattari, una “surcodificazione dispotica” al fondo impulsionale incomunicabile. Ma questo è incomunicabile, muto. Solo se il fuori s’incontra con tale mutismo, questo potrà diventare parola. Ma, proprio attraverso tale processo l’individuo apprende ad essere questo fuori a parlare, l’esterno si sostituisce all’ineffabile, distorcendone il contenuto. L’idioma della coscienza, originariamente interpretazione del fondo impulsionale, ne dissimula ora il contenuto, uniformandosi al codice istituzionale. La coscienza è l’esterno di un interno. «Nella misura in cui l’esteriorità, attraverso il codice dei segni quotidiani, penetra nel supporto, questo dichiara o dichiara a se stesso, pensa, non può pensare, tace, non può tacere se non in funzione di quel codice. Esso stesso in quanto pensante ne è il prodotto. […] Anche l’intimità, anche la cosiddetta vita interiore, sono ancora il residuo dei segni istituiti all’esterno con il pretesto di significarci in maniera “oggettiva”, “imparziale”: residuo che indubbiamente prende la configurazione del modo pulsionale proprio di ciascuno, perciò adattando i contorni dei nostri modi di reagire a quell’invasione che non siamo stati noi ad inventare. Ecco la nostra “coscienza”» (Klossowski 1969). L’atto del pensiero è dunque una passività fondata sulla fissità dei segni del linguaggio.
Benché i punti di contatto siano numerosi, emerge qui la differenza tra Klossowski e Freud (è, infatti, da una simile concezione del pensiero nietzscheano che Freud prese le mosse, come mostra la lettera a Fliess, 1.2.1900: «spero di trovare in lui [in Nietzsche] le parole per tutto quanto resta muto in me»). Mentre per Freud la distinzione è all’interno della psiche tra inconscio e conscio, per Klossowski la differenza è tra corpo e coscienza, l’inconscio non essendo nulla di reale. «Dunque i termini coscienza e incoscienza non corrispondono a nulla di reale: se Nietzsche li usa è per convenzione “psicologica”» (Klossowski 1969).
Riassumendo, il linguaggio è una falsificazione dell’esperienza che consente all’individuo di costituirsi nell’illusione dell’identità. In realtà, l’individuo (per usare l’espressione di Groddeck, anch’egli influenzato da Nietzsche) è vissuto da una serie di forze impulsionali che sfuggono al suo controllo. L’io si costituisce solo attraverso l’oblio e l’occultamento di tali forze, grazie al codice dei segni quotidiani, che gli dà l’illusione del controllo e dell’autonomia. «la persona può credere di ridere, tremare, soffrire, godere per un’evocazione di motivi che sono invece soltanto un’interpretazione di sensazioni corporali. La coscienza che rivendica per sé tali sintomi può farlo solo prima o dopo la loro comparsa. […] Nell’intensità del dolore o del piacere, e in special modo nella voluttà, la “persona” scompare per un attimo, e allora quel che resta della coscienza si limita così strettamente al sintomo corporale che la struttura stessa si inverte: l’incoscienza è qui solo un’immagine dell’oblio» (Klossowski 1969). È solo «il mutismo del corpo» che ci consente «di restare quello stesso che crediamo di essere» (Klossowski 1969). Ma il vero sé si trova nel corpo, mentre l’io è solo una finzione. «La sofferenza che si manifesta negli stati valetudinari è una conseguenza di questa imposizione di un’identità fittizia. «tutte le sofferenze risultano da questo conflitto tra la pluralità del corpo con le sue mille velleità pulsionali, e l’ostinazione interpretativa del senso cerebrale; è dal corpo, è dal sé che scaturiscono le forze creatrici, le valutazioni; è dalla loro inversione cerebrale che nascono gli spiriti mentali, a cominciare da un io volontario» (Klossowski 1969).
Ma questo sé non è altro che «un’estremità prolungata del caos» (Klossowski 1969) pertanto esso è inscambiabile, non significa nulla. Dall’incapacità dell’uomo di affrontare quest’assurdo deriva la sua costituzione identitaria. «E, appunto perché, dietro a tutto, sussiste questa inscambiabilità, noi ci ripariamo con quello schermo che chiamiamo coscienza, cultura, morale e che è tutto basato sul codice dei segni quotidiani. Dietro lo schermo c’è il nulla, il fondo o il caos» (Klossowski 1969). Per difendere questa finzione di senso e scopo, che in realtà è solo un simulacro, è necessario assicurare la coerenza tra il supporto (l’io) e il suo intelletto. L’intelletto è un impulso che costituisce l’inverso degli altri impulsi, verso i quali agisce come forza repressiva ogni volta che si stabilisce una coerenza tra di essi ed il supporto, coerenza che è in totale discordanza con quella tra supporto ed intelletto. Si configura così il pensiero come repulsione dell’impulso, attraverso la quale esso è escluso dalla coerenza con il supporto. L’intelletto è il mezzo dell’identità. Al punto limite in cui l’impulso diviene pensiero si produce il fantasma, ultimo stadio al quale è possibile articolare la coerenza tra supporto ed impulso. Quando il fantasma si converte in parola, attraverso il codice dei segni quotidiani, subisce un’interpretazione che ne distorce il senso e gli impone un volere. Al fantasma non rimane che un mezzo per esprimersi: «sotto la sua coercizione noi simuliamo ciò che esso “vuol dire” con la nostra dichiarazione: ecco il simulacro» (Klossowski 1969). In questo modo il linguaggio diventa contemporaneamente il simulacro della resistenza dell’ambiente istituzionale, ma anche il simulacro della singolarità del fantasma.
Per questo, la soluzione prospettata da Klossowski non è l’uscita dal codice dei segni quotidiani, ma la rinuncia all’identità ed all’intenzione, a favore di un pensiero corporante in cui si esprima la coerenza tra il supporto e gli impulsi da cui è vissuto, in un linguaggio che non occulti ma dia espressione al Caos da cui è abitato.
L’ETERNO RITORNO COME SIMULACRO DI DOTTRINA
Gli stati valetudinari mostrano a Nietzsche la falsità del concetto di identità. La filosofia della differenza che ne deriva è espressa da Nietzsche, secondo Klossowski, attraverso due teorie: l’Eterno Ritorno (che Klossowski denomina Circolo Vizioso) e la morte di dio. «Il punto da rivelare è la perdita dell’identità data. La “morte di dio” (del dio garante dell’identità dell’io responsabile) dischiude all’anima tutte le sue possibili identità» (Klossowski 1969).
Klossowski insiste spesso sulla necessità di considerare l’Eterno Ritorno come una liquidazione del principio di identità, a favore di una filosofia per la quale non esistano né origine, né fine, né identità date, ma solo serie di individualità differenti. «Quando abbraccio con lo sguardo la necessità del ritorno come legge universale, disattualizzo il mio io attuale nel volermi in tutti gli altri io di cui devo ripercorrere la serie. […] Nel momento della rivelazione dell’Eterno Ritorno, io cesso di essere io hic et nunc e sono suscettibile di diventare infiniti altri. […] Un corollario della dottrina è la necessità di rivivere in una serie di individualità diverse. Dunque la ricchezza del Ritorno consiste nel voler essere altro da quello che si è per diventare quello che si è» (Klossowski 1969).
La dottrina dell’Eterno Ritorno è, secondo Klossowski, solo una maschera della filosofia della differenza, essa dunque è un principio apparente, falso. L’Eterno Ritorno è un simulacro di dottrina, è solo una parodia. «Il segreto del Circolo Vizioso può benissimo passare per un simulacro inventato secondo un fantasma di Nietzsche» (Klossowski 1969).
Appare qui un aspetto paradossale del pensiero di Nietzsche: egli demistifica il principio di identità, ma non per sostituirlo con la “verità”, bensì con un’altra mistificazione. Sembra che egli demistifichi solo per mistificare meglio. Le forze del negativo sono transvalutate nell’affermazione dell’Eterno Ritorno, ossia una nuova mistificazione.
Per Klossowski questo paradosso ruota intorno a tre concetti: mistificazione, demistificazione e simulacro. La sua riflessione parte da una frase di Nietszche: “A noi i bei simulacri! Dobbiamo essere gli impostori che abbelliscono l’umanità! Questo è essere filosofi”. Questa affermazione nasconde un giudizio negativo sulla realtà.
Nietszsche è preoccupato dal nichilismo negativo e riconosce la necessità che la filosofia non si limiti alla critica, ma crei nuovi valori. Per questo il filosofo deve essere un filosofo impostore.
L’Eterno Ritorno è necessariamente un simulacro poiché è la parte comunicabile di un’esperienza non comunicabile, un fantasma, quindi una contraffazione. Pertanto, la divulgazione del fantasma non è possibile fino a quando la sua falsità è intesa come contraffazione positiva. Il fondo impulsionale, con i suoi fantasmi, costituisce la critica del codice istituzionale, ma questa negatività viene transvalutata attraverso l’invenzione di simulacri creativi.
Il simulacro è, dunque, il corrispettivo del fantasma. «Non esiste nulla all’infuori degli impulsi essenzialmente generatori di fantasmi. Il simulacro non è il prodotto del fantasma, bensì la sua ingegnosa riproduzione, ed è in esso che l’uomo trova la capacità di prodursi da sé, nella forza dell’impulso esorcizzate e dominate. Il Turgbild – il simulacro – diventa nelle mani del filosofo “impostore”, la riproduzione voluta di fantasmi non voluti, nati dalla vita impulsionale. Perché il simulacro eserciti la sua coercizione è necessario che risponda alle necessità del fantasma» (Klossowski 1969).
Attraverso il simulacro, il fondo impulsionale non nega la realtà istituzionale, ma afferma valori positivi. Il simulacro deve raggiungere un compromesso con la realtà, l’arte ne è l’esempio maggiore. Per questo è possibile affermare che «il simulacro è in rapporto all’intelletto, la licenza da questo concessa all’arte: una sospensione ludica del principio di realtà» (Klossowski 1969). Il simulacro si sostituisce al principio di realtà, questo è il senso del famoso enunciato di Nietzsche, contenuto nel Crepuscolo Degli Idoli, secondo il quale il mondo reale si è convertito in una favola. Nel mondo contemporaneo tutto è elevato al massimo grado di falsificazione. «Non vi è realtà che quella perfettamente arbitraria espressa dai simulacri istituiti» (Klossowski 1969).
Secondo Klossowski il simulacro dell’Eterno Ritorno è pensato da Nietzsche come complotto contro il pensiero gregario. Anche l’otreuomo, è solo un simulacro di scopo, giacché il Circolo Vizioso in sé non ha fine. L’obiettivo di questo complotto non è la negazione del livello istituzionale, ma la transvalutazione dei suoi valori in falsità affermativa riconsegnata al fondo impulsionale privo di fini.
CHAÏM PERELMAN

A cura di Fabrizio Cerroni
“Solo l’esistenza di un processo argomentativo che non sia né cogente né arbitrario, dà un senso alla libertà umana, condizione per l’esercizio di una scelta ragionevole” (Trattato dell’Argomentazione).
LA VITA E LE OPERE
Chaïm Perelman nasce a Varsavia il 20 Maggio 1912 da una famiglia ebraica.
Nel 1925 si trasferisce in Belgio dove compie i propri studi, ottenendo una prima laurea in legge nel 1934, e poi, dopo una dissertazione sul filosofo e matematico Gottlob Frege, una seconda laurea in filosofia nel 1938, entrambe all’Université Libre di Bruxelles. Della stessa diventerà professore l’anno successivo, e vi insegnerà fino al 1978.
Inizialmente Perelman si è occupato di logica matematica, argomento al quale ha dedicato due saggi: Les Paradoxes de la Logique del 1936, e Une Solution des Paradoxes de la Logique et ses Consequence pour la Conception de l’Infini del 1937.
Successivamente si è occupato della teoria del diritto e della giustizia nel cui ambito si è interessato specialmente al problema dei giudizi di valore. Frutto di questo studio è il saggio De la Justice pubblicato nel 1945.
Nel 1948 inizia la sua collaborazione con la specialista di psicologia sociale Lucie Olbrechts-Tyteca, che frutterà due opere: Retorica e Filosofia (1952), la quale costituisce una sorta di introduzione al più completo ed importante Trattato dell’Argomentazione. La Nuova Retorica (1958). In questi saggi, che testimoniano l’allargamento delle ricerche di Perelman, dalla filosofia del diritto all’intero ambito delle scienze umane e dei problemi della comunicazione sociale, viene elaborata la teoria dell’argomentazione.
Alla luce della nuova retorica, Perelman torna ad occuparsi di diritto, innanzi tutto ripubblicando nel 1963 il trattato De la Justice, integrato con altri saggi nel frattempo pubblicati sulla giustizia e la ragion pratica. Ma soprattutto attraverso l’elaborazione di nuove opere: Diritto, Morale, Filosofia (1968) in cui approfondisce la natura del ragionamento giuridico ed i suoi legami con la filosofia; Campo dell’Argomentazione. Nuova Retorica e Scienze Umane (1970); Logica Giuridica e Nuova Retorica (1976); Il Dominio Retorico (1977); Introduzione Storica alla Filosofia Morale (1980).
Perelman è stato nominato membro dell’Accademia Reale del Belgio, dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Accademia delle Scienze di Heidelberg, nonché socio dell’Accademia delle Scienze Morali e Politiche dell’Institut de France. Inoltre è stato nominato dottore honoris causa delle Università di Firenze, di Gerusalemme e della McGill di Montreal. Infine, ha fondato la Société Belge de Logique et de Philosophie des Sciences; il Centre National belge de Recherche et de Logique, nonché una scuola di filosofia del diritto.
Perelman è morto a Bruxelles per un attacco di cuore il 22 gennaio1984.
IL PENSIERO
Perelman è stato uno dei più importanti e conosciuti filosofi belgi. Allievo di Dupréel, ne riprende la critica del positivismo e la riflessione sui valori. La sua ricerca ruota intorno a due assi: la nuova retorica ed il ragionamento giuridico. In entrambi, Perelman ha analizzato il problema dei giudizi di valore, giungendo alla conclusione che la logica che li muove non possa essere compresa nell’ambito della filosofia occidentale post-cartesiana a causa della sua ristretta concezione della razionalità.
Difatti, tale concezione, nata con Descartes e sviluppata in seguito dai logici e dai matematici, considera razionale solo ciò che, per il suo carattere necessario ed apodittico, si impone a tutti con la forza dell’evidenza. Questa certezza è considerata il corollario di una dimostrazione astratta od empirica e produce il proprio effetto di verità esprimendosi in idee chiare e distinte.
In questo modo, ciò che è soltanto probabile, verosimile, incerto o confuso, è posto intrinsecamente fuori dall’ambito della ragione. Però, sostiene Perelman, è solo in questo campo del preferibile che avviene il confronto etico sui valori, sulla cui base vengono prese le scelte che portano all’azione. L’effetto della limitazione cartesiana è, dunque, che questo vastissimo campo nel quale si dispiega la libertà umana, sprofonda nel dominio della suggestione, della violenza, del fondamentalismo, del dogmatismo, ossia dell’irrazionale.
È per opporsi a questa deriva che Perelman, con la collaborazione di Lucie Olbrechts-Tyteca, elabora la nuova retorica (o teoria dell’argomentazione). Tale teoria, che, come afferma Norberto Bobbio, è una delle tesi più feconde degli ultimi anni, è esposta in forma compiuta nel Trattato dell’Argomentazione. Il suo oggetto è «lo studio delle tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l’adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso» (Trattato dell’Argomentazione): la finalità della nuova retorica è, dunque, quella di recuperare le argomentazioni usate nel discorso persuasivo nella sfera della razionalità, attraverso l’estensione di quest’ultima espressa dalla nozione di ragionevolezza, la quale comprende tutte le idee sostenute dagli uomini indipendentemente dal grado di adesione dagli stessi manifestato. La ragionevolezza pertanto non riguarda solo le conoscenze evidenti e necessarie, ma tutte quelle semplicemente verosimili, per le quali, non esistendo certezza oggettiva, l’adesione può essere ottenuta solo attraverso l’argomentazione (la quale si oppone così alla dimostrazione).
Questa teoria è debitrice delle teorie di Aristotele, il quale postulava una “logica in situazione”, capace di tener conto del rapporto tra oratore ed uditorio. Ed è proprio quest’ultimo aspetto, ossia che ogni argomentazione è determinata dalla necessità di stabilire un contatto mentale con l’uditorio al quale si rivolge, che, per Perelman, si basa il legame tra vecchia e nuova retorica. Ogni argomentazione è predisposta e sviluppata dall’oratore tenendo conto (consciamente o inconsciamente) dei mezzi più adatti per persuadere il particolare uditorio cui si rivolge. Per questo è possibile affermare che è l’uditorio a determinare la qualità dell’argomentazione.
Il concetto di uditorio è dunque centrale per la nuova retorica. Esso implica che ogni argomentazione abbia un carattere relativo. Tale relatività è alla base della distinzione proposta da Perelman tra le filosofie prime che pongono princìpi ritenuti assolutamente veri, cosicché la loro messa in questione comporta la perdita di validità di tutta la filosofia; e filosofie regressive, le quali, al contrario, considerano i propri assiomi come risultati di una situazione particolare e determinata: se questa si modifica, anche i princìpi andranno rivisti.
Poiché il “campo del preferibile” è quello proprio delle controversie sui valori, ne segue che la nuova retorica ha immediate implicazioni pratiche. Giacché questo è il campo della scelta fra soluzioni alternative, situazione intermedia tra la violenza che interrompe ogni argomentazione e la dimostrazione che impone una conclusione univoca al ragionamento. Per cui la nuova retorica investe i settori dell’etica, del diritto, della politica, della filosofia e delle scienze umane. La nuova retorica consente di recuperare questi settori ad una razionalità persuasiva, che non si imponga in modo assoluto ma lasci la libertà del dubbio, indispensabile per creare un clima di discussione aperto e democratico, estraneo sia al dogmatismo che allo scetticismo, i quali altro non sono che due facce della stessa medaglia; ma estraneo anche ai mezzi persuasivi irrazionali come la violenza del fondamentalismo, o la suggestione della pubblicità e della propaganda.
Sono importanti le implicazioni per la filosofia del diritto, la quale per Perleman si basa sul principio: “la logica giuridica non è la logica formale”; principio che gli è valso la definizione di antiformalista. Il ragionamento giuridico dovrà basarsi anch’esso sull’argomentazione, di modo che il giudice, sempre nel rispetto della legge, tenga conto anche dei valori esistenti nella società, in modo di arrivare a decisioni condivise da tutte gli uditorii, e che rappresentino una sintesi tra diritto ed equità.
La nuova retorica apre la strada a una scelta responsabile ed impegnata, unica possibile manifestazione sociale della libertà, che sia contraria ad ogni autoritarismo, nel riconoscimento che non esistono verità assolute, e si sviluppi nelle istituzioni democratiche.
«Solo l’esistenza di un processo argomentativo che non sia né cogente né arbitrario, dà un senso alla libertà umana, condizione per l’esercizio di una scelta ragionevole» (Trattato dell’Argomentazione).
TRATTATO DELL’ARGOMENTAZIONE
«La pubblicazione di un’opera dedicata all’argomentazione e la ripresa in esso di un’antica tradizione, quella della retorica e della dialettica greche, costituiscono una rottura rispetto ad una concezione della ragione e del ragionamento nata con Descartes, che ha improntato di sé la filosofia occidentale degli ultimi tre secoli» (Trattato dell’Argomentazione). Con queste parole si apre l’introduzione al Trattato. Esse mostrano il progetto della teoria dell’argomentazione: l’ampliamento del concetto di ragione, limitato dalla filosofia post-cartesiana al razionale puro (enunciati evidenti o necessari), per includervi l’ambito del ragionevole.
Perelman critica la concezione nata con Cartesio e fatta propria dai positivisti per i quali il probabile equivale al falso, e la conoscenza scientifica può derivare esclusivamente dall’esistenza di concetti chiari, distinti ed inoppugnabili. Infatti, fu Descartes «per cui l’evidenza era il marchio della ragione a non voler tenere per razionale che le dimostrazioni capaci di estendere, a partire da idee chiare e distinte, e mediante prove apodittiche, l’evidenza degli assiomi a tutti i teoremi. Il ragionamento more geometrico fu dunque il modello proposto ai filosofi desiderosi di costruire un sistema di pensiero che potesse avere dignità di scienza» (ibid.). Secondo questa concezione, la scienza razionale deve basarsi sul modello della dimostrazione, la quale porta necessariamente a un consenso unanime. La scienza razionale, secondo questa impostazione, deve dunque configurarsi come «un sistema di proposizioni necessarie che s’imponga a tutti gli esseri ragionevoli, e sulle quali l’accordo sia inevitabile. Ne risulterà che il disaccordo è segno d’errore» (ibid.). Nata con Cartesio, «questa tendenza s’è ulteriormente accentuata da quando, sotto l’influenza dei logici-matematici, la logica è stata limitata alla logica formale, cioè allo studio dei mezzi di prova utilizzati nelle scienze matematiche. Ne risulta che i ragionamenti estranei al campo puramente formale sfuggono alla logica e, per conseguenza, alla ragione stessa» (ibid.).
Questa tendenza ha la colpa di confinare nell’ambito dell’irrazionale, territorio della suggestione o della violenza, tutto ciò che esorbita dagli stretti limiti del razionale puro. «A noi sembra, invece, che si tratti di una limitazione indebita e del tutto ingiustificata del campo in cui interviene la nostra facoltà di ragionare e di provare. […] La concezione post-cartesiana della ragione ci obbliga a far intervenire degli elementi irrazionali ogni volta che l’oggetto della conoscenza non sia evidente» (ibid.). Tale concezione si basa su di una visione dicotomica dell’uomo al quale vengono attribuiti «passioni ed interessi capaci di opporsi alla ragione» (ibid.). Ma tale distinzione «è fondata su un errore e conduce ad un vicolo cieco. L’errore sta nel concepire l’uomo come costituito di facoltà completamente separate; il vicolo cieco consiste nel togliere all’azione fondata sulla scelta ogni giustificazione razionale, rendendo così assurdo l’esercizio della libertà umana» (ibid.).
Al contrario, la teoria dell’argomentazione nasce dalla consapevolezza che, accanto alle dimostrazioni analitiche, esistono le prove dialettiche concernenti il verosimile, il quale si caratterizza così per l’assenza di prove certe ed inoppugnabili. «Il campo dell’argomentazione è quello del verosimile, del probabile, nella misura in cui quest’ultimo sfugge alle certezze del calcolo» (ibid.). È questo il campo del discorso retorico attraverso il quale l’oratore cerca di persuadere l’uditorio all’accettazione di una tesi determinata.
L’oggetto della teoria dell’argomentazione è, dunque, «lo studio delle tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l’adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso» (ibid.), studio non limitato, come quello cartesiano ai casi in cui tale consenso è caratterizzato dall’evidenza. Si tratta di un campo molto ampio comprendente le argomentazioni dei filosofi, politici, avvocati, giornalisti.
L’adesione alla retorica che caratterizza la teoria dell’argomentazione «mira a sottolineare il fatto che ogni argomentazione si sviluppa in funzione di un uditorio» (ibid.). A fronte di quest’analogia con la retorica antica, ci sono anche importanti differenze. Infatti, mentre questa era soprattutto l’arte di fare discorsi pronunciati di fronte a un pubblico, la nuova retorica si occupa, invece, della struttura dell’argomentazione, studiando i mezzi discorsivi per ottenere il consenso.
Il Trattato si divide in tre parti:
I. QUADRI DELL’ARGOMENTAZIONE. Specifica gli elementi della teoria dell’argomentazione.
II. BASE DELL’ARGOMENTAZIONE. Si occupa delle formalità e degli elementi utilizzati per predisporre ed argomentare il discorso.
III. TECNICHE ARGOMENTATIVE. È la parte più ampia che illustra alcuni argomenti che possono essere utilizzati nei discorsi persuasivi sulla base di una ricchissima documentazione raccolta dagli autori.
La prima parte si apre con la distinzione tra dimostrazione ed argomentazione. Mentre la prima si caratterizza per il suo carattere necessario, la seconda lascia all’uditore la possibilità del dubbio. «Quando occorre dimostrare una proposizione, è sufficiente indicare in base a quali procedimenti essa possa essere ottenuta come ultima espressione di un seguito di deduzioni, i cui primi elementi sono forniti da chi ha costruito il sistema assiomatico all’interno del quale la dimostrazione viene effettuata. Da dove provengano questi elementi, se siano verità impersonali, pensieri divini, risultati dell’esperienza o postulati dell’autore, è questione che il logico formalista considera come estranea alla sua disciplina. Quando invece si tratta di argomentare, di influire cioè per mezzo del discorso sull’intensità dell’adesione di un uditorio a determinate tesi, non è più possibile trascurare completamente, considerandole irrilevanti, le condizioni psichiche e sociali in mancanza delle quali l’argomentazione rimarrebbe senza oggetto o senza risultato. Ogni argomentazione mira infatti all’adesione delle menti e presuppone perciò l’esistenza di un contatto intellettuale» (ibid.). Per questa ragione, nell’ambito dell’argomentazione gioca un ruolo fondamentale il rapporto con l’uditorio, e questa prima parte dell’opera è quasi interamente dedicata alla sua analisi.
Fase preliminare a qualsiasi argomentazione è dunque la ricerca di una comunanza spirituale con l’uditorio al quale ci si rivolge, contatto delle menti, come lo chiamano gli autori, il quale non è affatto spontaneo.
L’uditorio è definito come «l’insieme di coloro sui quali l’oratore vuole influire per mezzo della sua argomentazione» (ibid.). L’oratore deve sempre avere presente l’uditorio al quale si rivolge, non solo nella predisposizione, ma anche nello svolgimento del discorso, se vuole raggiungere il proprio fine persuasivo. «La conoscenza dell’uditorio che ci si propone di convincere è dunque condizione preliminare di ogni argomentazione efficace» (ibid.).
Tale conoscenza implica, per poter essere efficace, anche quella dei mezzi più idonei per agire sull’uditorio stesso in modo da persuaderlo. Questa azione è definita condizionamento. «Conoscere l’uditorio significa pure sapere, e come il suo condizionamento possa essere assicurato e quale sia, in ogni singolo istante del discorso, il condizionamento attuato» (ibid.).
Le principali forme di condizionamento sono non-linguistiche, tuttavia ve ne è anche una discorsiva che consiste nel «continuo adattamento dell’oratore al proprio uditorio» (ibid.). Ciò implica che è l’uditorio a determinare la qualità dell’argomentazione. «L’importante nell’argomentazione non è sapere che cosa l’oratore consideri vero o probante, ma quale sia l’opinione di coloro ai quali si rivolge. […] Spetta in realtà soprattutto all’uditorio il compito di determinare la qualità dell’argomentazione e il comportamento dell’oratore» (ibid.).
Il convincimento ed il condizionamento potrà riuscire nei confronti di un uditorio particolare od universale. In questa prospettiva, gli autori elaborano la distinzione tra persuasione e convincimento. «Ci proponiamo qui di chiamare persuasiva l’argomentazione che pretende di valere soltanto per un uditorio particolare, e di chiamare invece convincente quella che si ritiene possa ottenere l’adesione di qualunque essere ragionevole» (ibid.). A differenza della concezione tradizionale (propria ad esempio di Blaise Pascal e Immanuel Kant) che vuole basare questa distinzione su basi oggettive e nette, Perelman mostra come questa distinzione dipenda in realtà dall’uditorio, e pertanto deve rimanere imprecisa.
Gli autori distinguono tre diversi tipi di uditorii: l’uditorio universale costituito da tutta l’umanità; l’interlocutore nel caso del dialogo; lo stesso soggetto nel caso del monologo.
L’uditorio universale non ha esistenza oggettiva ma è una costruzione propria di ogni individuo e di ogni cultura. Esso può essere considerato tale quando «chi non ne fa parte potrà, per ragioni legittime, non essere preso in considerazione» (ibid.). L’uditorio universale fornisce all’oratore una importante soluzione nel caso in cui non riesca a suscitare un consenso unanime. «Se l’argomentazione rivolta all’uditorio universale e considerata atta a convincere non convince tutti resta sempre la possibilità di squalificare il recalcitrante, considerandolo stupido o anormale» (ibid.). L’uditorio universale è tale solo per chi gli riconosce il ruolo di modello, per gli altri resterà un uditorio particolare.
Anche la riflessione personale è ricondotta da Perelman all’argomentazione. «Noi siamo del parere che sia preferibile il considerare la deliberazione intima come una specie particolare di argomentazione […] Spesso d’altronde la discussione con altri non è che un mezzo per chiarire meglio a noi stessi le nostre idee. L’accordo con se stessi è un caso particolare dell’accordo con altri» (ibid.).
Nella seconda parte del Trattato, gli autori analizzano le premesse del discorso, necessarie affinché esso riesca a convincere l’uditorio. Le premesse vengono analizzate da tre punti di vista: accordo, scelta, presentazione.
Le premesse oggetto dell’accordo sono raggruppate in due categorie: il reale, comprendente fatti, verità e presunzioni; e il preferibile riguardante i valori, le gerarchie tra valori ed i luoghi comuni (definiti luoghi del preferibile).
Un evento può essere considerato un fatto solo se non è controverso. «Dal punto di vista argomentativo siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso un accordo universale, non controverso» (ibid.). Tuttavia «non esiste enunciato che possa godere, in forma definitiva, di tale condizione, perché l’accordo può sempre essere rimesso in questione e una delle parti può sempre rifiutare la qualità di fatto a ciò che l’avversario afferma» (ibid.). Vi sono, dunque, due modi per squalificare un fatto: quando vi sono dei dubbi nell’uditorio, e quando si dimostra che l’uditorio che ammette il fatto è un uditorio particolare.
Il ragionamento concernente i fatti può essere esteso anche alle verità. Queste si differenziano dai primi poiché rispetto ad essi sono «sistemi più complessi, relativi a legami fra i fatti» (ibid.). Dunque, sia le verità sia i fatti non sono delle realtà oggettive, assolute ed inconfutabili, al contrario possono sempre essere contestate, ed in questo caso l’oratore non può più utilizzarli come premesse.
Le presunzioni «godono ugualmente dell’accordo universale, tuttavia l’adesione alle presunzioni non è massima, ci si aspetta che l’adesione sia rafforzata ad un dato momento da altri elementi» (ibid.). Le presunzioni sono legate a ciò che è considerato dall’uditorio normale e verosimile. Pertanto l’accordo fondato su di esse ha, per l’uditorio, la stessa validità di quello fondato sui fatti e sulle verità.
I valori costituiscono un oggetto d’accordo fondamentale e irrinunciabile, essi però valgono solo per un uditorio particolare, giacché non esistono valori universali (e, anche se esistessero, sarebbero tali solo nella forma: non appena si considera il contenuto, tornano le differenze particolari). «L’accordo a proposito di un valore consiste nell’ammettere che un oggetto, essere concreto o ideale, deve esercitare sull’azione e sulle disposizioni all’azione una determinata influenza, della quale si può fare uso in un’argomentazione, senza per questo ritenere che il corrispondente punto di vista si imponga a tutti» (ibid.). Se in una discussione si desidera contestare un valore occorre necessariamente promuovere altri valori. Come aveva già affermato Dupréel (esplicitamente citato dagli autori), i valori universali sono valori di persuasione. «Il loro compito è dunque quello di giustificare delle scelte sulle quali non esiste un accordo unanime» (ibid.). I valori si distinguono in astratti e concreti, i primi sono utilizzati soprattutto dai rivoluzionari, i secondi (che attribuiscono un valore ad un essere determinato, sia esso un individuo od un gruppo) sono, invece, utilizzati dai conservatori.
Poiché i valori sono conflittuali, e poiché in un’argomentazione possono essere utilizzati più valori, l’oratore deve sempre considerare la gerarchia di valori esistente nell’uditorio. È questa la ragione per la quale «le gerarchie di valori sono più importanti dei valori stessi» (ibid.).
I luoghi comuni «costituiscono un arsenale indispensabile al quale chi vuole persuadere altri dovrà per forza attingere. […] Chiameremo luoghi solo le premesse di ordine generale che permettono di dare un fondamento ai valori e alle gerarchie, e che Aristotele studia fra i luoghi dell’accidente. Questi luoghi costituiscono le premesse più generali, spesso sottintese, che intervengono a giustificare le nostre scelte» (ibid.). I luoghi sono classificabili in sei categorie. Innanzitutto, i luoghi della quantità, i quali attribuiscono ad una cosa un valore maggiore rispetto ad un’altra per ragioni quantitative. Appartengono a questa categoria anche i luoghi comuni basati sul probabile, sull’evidente, sull’abituale. «Ciò che si presenta più spesso, l’abituale, il normale, è oggetto di uno dei luoghi più frequentemente utilizzati, a tal punto che il passaggio tra ciò che si fa a ciò che si deve fare, dal normale alla norma, sembra per molti spontaneo» (ibid.).
In secondo luogo, i luoghi della qualità, i quali costituiscono l’opposto rispetto ai precedenti, giacché valorizzano l’unico, in tutte le sue possibili forme, come ad esempio l’originale, il precario, l’irrimediabile, la norma unica rispetto alla molteplicità del reale.
Le altre categorie sono: i luoghi dell’ordine, i quali affermano la superiorità dell’anteriore sul posteriore; i luoghi dell’esistente, i quali affermano la superiorità del reale sull’eventuale; i luoghi dell’essente, i quali valorizzano gli individui che meglio rappresentano l’essenza; ed, infine, i luoghi della persona, legati alla sua dignità, al suo merito, ed alla sua autonomia.
Costituiscono, infine, oggetti d’accordo valevoli per determinati uditorii: il senso comune, il linguaggio tecnico, le presunzioni legali, gli argomenti ad hominem, e l’inerzia sociale.
La fase successiva all’accordo è la selezione. Poiché i potenziali oggetti d’accordo sono molteplici, l’oratore deve pensare accuratamente a quali scegliere. Tale scelta è un momento fondamentale giacché «riconosce agli elementi una presenza che è un fattore essenziale dell’argomentazione […]. Così una delle preoccupazioni dell’oratore sarà quella di rendere presente, solo grazie alle magie delle sue parole, ciò che è assente […] oppure di valorizzare, rendendoli più presenti, alcuni degli elementi che sono effettivamente offerti alla coscienza» (ibid.). Il fenomeno opposto, consistente nel deliberato occultamento della presenza, è un fenomeno altrettanto degno di nota.
Oltre al riconoscimento della presenza, ci sono anche altri importanti corollari della selezione. I dati, infatti, non vanno solo selezionati, ma occorre anche attribuire loro un senso, ossia vanno interpretati. Poiché le interpretazioni possibili sono molto numerose, l’interpretazione proposta va sempre tenuta distinta dai dati, e può essere loro contrapposta. Sono molto rari (forse inesistenti) i dati aventi un senso univoco, di regola, ogni discorso, ed ogni fatto, può acquisire più significati e pertanto necessita di un’interpretazione, che nel primo caso è definita dagli autori interpretazione dei segni, nel secondo interpretazione degli indizi.
I dati non vanno solo interpretati, ma l’oratore dovrà anche scegliere le qualità degli stessi da mettere in rilievo. Questa funzione è svolta dall’epiteto. Un altro aspetto, all’apparenza neutrale, che consente di raggiungere lo stesso scopo è la classificazione dei dati, mediante la quale si attribuisce loro una particolare qualifica con la quale li si designa.
Un altro mezzo fondamentale, ed all’apparenza ancora più neutrale, rispetto all’epiteto ed alla classificazione è la scelta delle nozioni. «L’utilizzo delle nozioni di una lingua viva si presenta così molto spesso non più come semplice scelta di dati applicabili ad altri dati, ma come costruzione di teorie e interpretazioni del reale, grazie alle nozioni che esse permettono di elaborare. C’è di più, il linguaggio non è solo mezzo di comunicazione: esso è anche strumento di azione sugli spiriti, mezzo di persuasione» (ibid.). Per questa ragione, uno dei mezzi di persuasione utilizzato dagli oratori consiste nell’agire sulle nozioni, ad esempio attribuendo una maggiore fluidità alle proprie, e maggiore rigidità a quelle dell’avversario, ovvero allargando o restringendo il campo di una nozione, per svalutare o valutare idee o situazioni. Tutte queste operazioni influenzano profondamente sul significato di una nozione.
Riassumendo, la fase della selezione comporta il riconoscimento della presenza, l’interpretazione, la scelta di alcuni aspetti dei dati attraverso l’epiteto, la classificazione e l’utilizzo delle nozioni.
Dopo l’accordo e la selezione, la fase successiva nell’elaborazione delle premesse consiste nella presentazione. Essa comprende innanzitutto tutti gli strumenti utilizzati per dare l’impressione della presenza, come ad esempio la ripetizione, l’accumulazione, la descrizione dei particolari, la specificazione (difatti, di regola, anche se non sempre, più un termine è concreto maggiore sarà il suo impatto emotivo).
Inoltre, momento centrale della presentazione è quello della scelta dei termini, e della loro posizione nel contesto. Tale scelta non è mai neutrale, ed anche quando si sceglie uno stile neutrale lo si fa per un fine argomentativo preciso, quello «di suggerire una trasposizione del generale consenso accordato al linguaggio, al consenso delle norme espresse. Non bisogna dimenticare infatti che il linguaggio è, fra gli elementi di accordo, uno dei primi» (ibid.).
Anche la scelta dei tempi verbali ha precisi intenti persuasivi nell’ambito della presentazione. Il passato dà l’idea di un fatto avvenuto e indiscutibile, l’imperfetto di un fatto transitorio, il presente, invece, esprime l’universale, la legge, la norma. La stessa funzione è svolta dalla scelta dei pronomi: il pronome impersonale “si” esprime la norma; la scelta della terza persona o del “si” al posto della prima riduce la responsabilità personale; l’operazione contraria dà un sentimento di presenza; la scelta di un nome singolare per designare un plurale (ad esempio: l’Ebreo), infine, ha un duplice effetto: quello di dare il senso della presenza, e quello di unificazione del punto di vista attraverso una sineddoche (la pars pro toto).
La scelta della forma è un altro momento importante, giacché può essere utilizzata per esprimere comunione con l’uditorio. Funzione argomentativa possono avere anche le figure retoriche. «Consideriamo argomentativa una figura se, comportando un mutamento di prospettiva, il suo uso appare normale in rapporto alla nuova situazione suggerita» (ibid.). Altrimenti si tratterà di una figura di stile. In relazione alla loro funzione argomentativa, le figure retoriche possono essere classificate in tre categorie: figure di scelta (esempi: definizione retorica, perifrasi, antonomasia, correzione, ripresa); figure di presenza, le quali rendono attuale l’oggetto alla coscienza (esempi: ripetizione, conduplicatio, amplificazione, sinonimia, enallage del verbo); figure di comunione (esempi: allusione, citazione, apostrofe, interrogazione retorica, enallage del nome).
Infine, nella presentazione altre astuzie possono essere utilizzate per persuadere l’uditorio. Ad esempio, i sentimenti personali possono essere espressi come giudizi di valore, i giudizi di valore come giudizi di fatto, la conclusione di un’argomentazione come un fatto di esperienza.
«Uno degli effetti più importanti della presentazione dei dati è la modifica dello statuto degli elementi del discorso» (ibid.).
Nella terza parte del Trattato, gli autori offrono un’ampia tassonomia relativa all’uso pratico dell’argomentazione. I diversi schemi discorsivi caratterizzanti la struttura argomentativa sono ricondotti a due forme generali: i procedimenti di associazione e i procedimenti di dissociazione. «Intendiamo per procedimenti di associazione degli schemi che avvicinano degli elementi distinti e permettono di stabilire tra loro una solidarietà mirante sia a strutturarli sia a valorizzarli positivamente o negativamente l’uno per mezzo dell’altro. Intendiamo per procedimenti di dissociazione, delle tecniche di rottura aventi lo scopo di dissociare, di separare, di infrangere la solidarietà di elementi considerati come costituenti un tutto o per lo meno una unità solidale in seno a uno stesso sistema di pensiero: la dissociazione avrà l’effetto di modificare il sistema, modificando alcune delle nozioni che ne costituiscono i pilastri» (ibid.). Queste tecniche sono complementari, giacché ogni associazione implica una dissociazione e viceversa; tuttavia, l’argomentazione può mettere l’accento su uno dei due processi, occultando l’altro. Alla categoria dei procedimenti associativi appartengono le argomentazioni quasi-logiche, quelle basate sulla struttura del reale, e le prove tratte da esempi ed analogie, tutte miranti a stabilire una connessione od una generalizzazione. Alla categoria dei procedimenti dissociativi appartengono le argomentazioni basate su coppie oppositive, le quali tendono a modificare o dileguare i sistemi utilizzati per comprendere il reale.
In conclusione, oltre che per l’ampia tassonomia di esempi, l’accurata analisi dei mezzi discorsivi di persuasione, la nuova retorica di Perelman, assume rilevanza per la sua critica del razionalismo dogmatico, in favore della valorizzazione del ragionevole, luogo dell’argomentazione, della retorica e quindi del dialogo. Unica base possibile su cui fondare una società libera, plurale, tollerante.
«Noi combattiamo le opposizioni filosofiche, nette e irriducibili, che ci vengono presentate dagli assolutismi di ogni specie. […] Noi non crediamo a rivelazioni definitive e immutabili, quale che sia la loro natura o la loro origine […] non faremo nostra l’esorbitante pretesa di erigere in dati definitivamente chiari, intoccabili certi elementi della conoscenza. […] Pretendendo che ciò che non è obiettivamente e indiscutibilmente valido dipenda dal soggettivo e dall’arbitrario, si scaverebbe un insuperabile abisso tra la conoscenza teorica, considerata la sola razionale, e l’azione le cui motivazioni sarebbero del tutto irrazionali. […] Se la libertà fosse solo adesione necessaria a un ordine naturale dato precedentemente, esso escluderebbe ogni possibilità di scelta: se l’esercizio della libertà non fosse fondato su delle ragioni, ogni scelta sarebbe irrazionale e si ridurrebbe a una decisione arbitraria che agirebbe in un vuoto intellettuale. Grazie alla possibilità di un’argomentazione che fornisce delle ragioni, ma non delle ragioni cogenti, è possibile sfuggire al dilemma: aderire a una verità obiettivamente e universalmente valida, o ricorso alla suggestione e alla violenza per far accettare le proprie opinioni e decisioni» (ibid.).
IL RAGIONAMENTO GIURIDICO
La riflessione di Perelman sul diritto e sulla giustizia precede cronologicamente quella sull’argomentazione, ma quest’ultima le fornirà importanti contributi.
La prima opera di Perelman dedicata al diritto è La Giustizia; in essa si cerca di esplicitare la razionalità dell’atto conforme alla giustizia.
Quando un atto è giusto? Secondo Perelman tale conformità si realizza solo quando l’atto corrisponde all’applicazione di una norma. Tuttavia, affinché la norma possa fondare la giustizia, non basta che essa esista: deve anche non essere arbitraria. Ciò si verifica quando essa può essere dedotta dai princìpi generali dell’apparato giuridico di cui fa parte, ossia dai suoi valori. Un atto è giusto nella misura in cui si conforma ad una norma, la quale, a sua volta, è giusta nella misura in cui si conforma al valore. «Siamo condotti a distinguere tre elementi nella giustizia: il valore su cui è fondata, la norma che l’enuncia, l’atto che la realizza» (Perelman, La Giustizia).
Esiste una profonda differenza tra le norme e gli atti da una parte, e il valore dall’altra. Giacché, mentre le norme e gli atti possono essere fondati razionalmente, proprio in relazione alla loro conformità al valore, quest’ultimo, al contrario, «non lo si può sottoporre ad alcun criterio razionale, esso è perfettamente arbitrario e logicamente indeterminato» (ibid.).
Il valore è totalmente arbitrario quindi non-razionale. I princìpi di un ordinamento giuridico rinviano a valori, non solo arbitrari, ma anche conflittuali.
La fondazione razionale di tale ordinamento deve pertanto arrestarsi di fronte ai valori che lo fondano, del tutto sottratti alla logica formale. Questa è, dunque, inadeguata a rendere la logica dei valori. È da questa riflessione che iniziano le perplessità di Perelman sulla concezione filosofica della razionalità che troveranno piena espressione nella teoria dell’argomentazione. Quest’ultima consente a Perelman di fondare il proprio ragionamento sul diritto su basi diverse.
Il motto di questa impostazione sarà: “la logica giuridica non è la logica formale”. Per questo, questa concezione è definita “antiformalista”. Giacché la logica dei valori esula completamente dalla razionalità pura, il ragionamento giuridico potrà trovare attuazione solo nell’ambito dell’argomentazione, nella quale si scontrano dialetticamente visioni diverse. Tale conflitto attinente ai valori mostra come la logica giuridica sia legata alla controversia. «Di fatto il conflitto tra i giudizi di valore è al centro di tutti i problemi di metodo posti dall’interpretazione e dell’applicazione del diritto. Per questo la logica giuridica è una logica della controversia» (La Logica Giuridica).
Di fronte a tale disaccordo, spetterà al giudice scegliere. Poiché anche tale decisione deve essere argomentata, il giudice dovrà giustificarla, come in ogni buona argomentazione, adattandosi all’uditorio. «Il giudice […] deve conoscere i valori dominanti nella società, le sue tradizioni, la sua storia, la metodologia giuridica, le teorie che vi sono accettate, le conseguenze sociali ed economiche di questa o quella presa di posizione, i meriti rispettivi della certezza del diritto e dell’equità in una data situazione. Una grande sensibilità ai valori, per come essi vivono in una determinata società, è condizione del buon funzionamento della giustizia, per lo meno di una giustizia che miri al consenso, condizione della pace giudiziaria» (ibid.). Naturalmente, in tale adattamento il giudice dovrà sempre rispettare «i limiti posti dal suo sistema di diritto» (ibid.).
L’argomentazione del giudice, quindi, dovrà conciliare le esigenze dell’equità e del diritto, prendendo decisioni giuste e ragionevoli. «Il diritto si sviluppa attraverso l’equilibrio di una duplice esigenza: l’una di ordine sistematico, l’elaborazione di un ordine giuridico coerente; l’altra di ordine pragmatico, la ricerca di soluzioni accettabili da parte dell’ambiente sociale, in quanto conformi a ciò che appare giusto e ragionevole» (ibid.).
Quest’attività fa del giudice qualcosa in più del mero esecutore di leggi: infatti oggi «la legge non rappresenta più tutto il diritto, è solo il principale strumento di orientamento per il giudice nell’adempimento del compito di risolvere i casi concreti» (ibid.). Il giudice diventa così complemento indispensabile del legislatore, non solo nei sistemi di common law ma anche in quelli di civil law.
Mediante l’argomentazione, il giudice ottiene il consenso dei diversi uditorii interessati alle sue decisioni esprimenti una sintesi tra equità e diritto. Per cercare la pace giudiziaria, il giudice dovrà persuadere i destinatari delle sue decisioni della conformità di queste ai valori giuridici e sociali.
È questa ricerca del consenso mediante l’argomentazione finalizzata alla risoluzione delle controversie dialettiche, che fornisce al ragionamento giuridico (a tutti i livelli istituzionali in cui si attua) il suo carattere precipuo. In questo modo, in esso trova espressione la logica dei valori, configgenti ed arbitrari, irriducibile alla logica formale.
GUSTAVO GUTIERREZ

A cura di Marco Apolloni
(Sito personale: http://noiperborei.blogspot.com
Contatto personale: escobar17@hotmail.it )
Traduzione dall’inglese di Silvia Del Beccaro
Gutierrez è un marxista? Forse, se consideriamo la sua “teologia della storia” come qualcosa che cerca di trasformare la società. Ma, in effetti, questa ipotesi non regge completamente. Gutierrez ha un differente approccio, più spiccatamente idealista, rispetto alla ben più realista filosofia marxiana.
Tuttavia, preferiamo non esprimerci subito su questi due diversi aspetti e intendiamo pertanto procedere per gradi, elaborando entrambe le ipotesi…
Prima ipotesi: Gutierrez è un marxista?
Gutierrez scrive:
Questo libro è un tentativo di riflessione, basata sul vangelo e sulle esperienze di uomini e donne impegnati nel processo di liberazione della terra, oppressa e sfruttata, dell’America Latina. È una riflessione teologica, nata dall’esperienza di sforzi comuni per abolire l’ingiusta situazione corrente e per costruire una società diversa, più libera e più umana.
Per comprendere meglio quanto appena affermato da Gutierrez, occorre analizzare un aspetto nascosto della Chiesa latino-americana, ovvero la sua corruzione e la povertà intrinseca, esaminando anche lo sporco e oscuro potere dei suoi governi nazionali.
La situazione di povertà nell’America Latina è veramente drammatica. Lo schema che segue mostra con chiarezza il livello di disuguaglianza che vige nella suddetta società: élite 5%; ceto medio 10%; ceto povero 85 %. A fronte di questi dati, risulta chiaro ammettere che, prima di una totale trasformazione della società, la popolazione latino-americana necessita più che altro di una trasformazione radicale della sua chiesa, corrotta.
Al riguardo, la cinematografia internazionale offre un bellissimo film diretto dal regista brasiliano Walter Salles e intitolato “I diari della motocicletta”. La pellicola racconta la vera storia del noto rivoluzionario argentino, Ernesto “Che” Guevara, prima che diventasse l’uomo-simbolo della rivoluzione cubana condotta da Fidel Castro. Nello specifico, la suddetta opera cinematografica è estremamente interessante perché narra il viaggio mistico del “Che” attraverso l’America Latina, in cui egli vide il grado di eccezionale povertà in cui versava tale popolazione. Ma più di tutto, intravide la fiamma lucente della rivoluzione ardere dentro le pupille scintillanti di questa gente. Non a caso, l’esclamazione finale che Ernesto rivolge ad Alberto Granado, suo fedele amico nonché compagno di quel memorabile viaggio avventuroso, fu: «C’è troppa ingiustizia a questo mondo».
A tal proposito, si può riprendere la seguente osservazione di Gutierrez:
In un continente come l’America Latina non si ha a che fare con dei non-credenti, bensì con delle non-persone. […] Perciò la questione non sarà come parlare di Dio in un mondo adulto, bensì come annunciarlo, in quanto Padre, in un mondo non-umano.
Un’altra tesi indiretta, che ci porta a definire Gutierrez un marxista, è legata al fatto che nel pensiero moderno non possiamo parlare di una dottrina specifica senza tenere conto del fenomeno culturale marxista.
Già altri pensatori, infatti, su tutti lo spiritualista Henri Bergson (teorico della “evoluzione creatrice”), possono venire collocati in quest’orbita marxista. Non a caso il grande pensatore italiano Antonio Gramsci concepì l’evoluzione creatrice bergsoniana come qualcosa di inscindibile dall’anello storico mancante del marxismo.
Esiste anche un illuminante poema, nel quale l’anima viene unita alla materia. Stiamo parlando di “Foglie d’Erba”, scritto dal famoso autore americano Walt Whitman, influenzato dalla lettura delle Sacre Scritture:
Farò i poemi della materia, poiché credo che siano i più spirituali poemi, e farò i poemi del mio corpo e della mortalità, poiché credo che così otterrò i poemi dell’immortalità e dell’anima.
Di conseguenza, se per Whitman è possibile unire questi due estremi opposti, perchè considerarlo inammissibile nel caso di Gutierrez? Il teologo peruviano, infatti, traspone il messaggio evangelico nella quotidiana situazione di oppressione dei popoli latino-americani. Quindi le sue argomentazioni riescono nel difficile intento – troppo spesso mancato dalla Chiesa ufficiale romana – di portare esempi concreti per combattere la povertà dilagante nello sfruttato continente sudamericano.
Come già espresso, la nostra intenzione è quella di indagare le invisibili connessioni fra la Moderna Teologia e il Marxismo, perché ciascuno è basilare per la sussistenza dell’altro. Infatti, mentre la prima intende studiare e possibilmente capire lo spirito assoluto, la seconda invece cerca di approfondire la materia assoluta. Questa è la loro principale ed essenziale distinzione.
Per usare le stesse parole di Gutierrez:
La teologia contemporanea in effetti si trova nel confronto diretto e fruttuoso con il marxismo e ciò è in larga misura dovuto all’influenza marxiana, secondo la quale il pensiero teologico, che cerca le proprie fonti, ha cominciato a riflettere sul significato della trasformazione di questo mondo e dell’azione umana nella storia.
Se leggiamo con attenzione il pensiero sopra citato, possiamo riconoscere che Gutierrez per molti aspetti viaggia sulla stessa lunghezza d’onda della weltanschuung marxista.
In un mondo moderno dove molti valori sono stati dimenticati, dunque, la metafora più appropriata corrisponde all’immagine evocata dal poeta Thomas Sterns Eliot nel suo capolavoro “La terra desolata”, che descrive un mondo privato dell’essenziale senso del sacro e in cui ogni cosa sembra ammessa.
In quest’opera vengono riscoperti molti preziosi valori religiosi che, anche per un ateo pensatore umanista, possono rappresentare un elemento indiscutibilmente prezioso. Parliamo anche di non-credenti perché pensiamo che chiunque creda, se non in Dio, almeno in una vita religiosa. Del resto, che cos’è la vita se non un misterioso dono, datoci dall’invisibile potere che governa le nostre esistenze, quale il Fato per gli antichi Greci o Dio per la teologia cristiana? A differenza delle filosofie neo-positiviste, noi crediamo nel progresso scientifico, indispensabile per uno corretto sviluppo del genere umano; ma non crediamo altresì in una scienza senza etica, necessaria per vivere in pienezza e in tranquillità le nostre responsabilità, in quanto uomini. Per questo motivo è importante credere in un’etica, cristiana o marxista che sia, per avere comunque qualche fondamento spirituale che guidi le nostre esistenze. Per quel che può valere, noi crediamo che un certo materialismo sia niente meno che uno spiritualismo sotterraneo. Ne è un esempio il sopra citato Walt Whitman.
Per capire meglio, ora, i collegamenti esistenti fra la filosofia di Marx e la teologia di Gutierrez, occorre però indagare anche il concetto marxiano di “escatologia”, che prevede una visione finalistica della storia, derivante dagli sviluppi della lotta di classe. È possibile paragonare infatti la redenzione cristiana del genere umano, nella storia, al sopra citato concetto escatologico.
Secondo la concezione messianica benjaminiana, vi è un Messia che infrange il continuum della storia, oltrepassando così le barriere dell’eterno ritorno dell’uguale nietzschiano ma prima di tutto cristiano. Basti pensare all’anomala filosofia di Basilide d’Alessandria, pensatore gnostico sconosciuto ai più. Il Messia, secondo la visione di Benjamin, è la figura catalizzatrice della lotta di classe; infatti, è proprio colui il quale permetterà l’insperata redenzione degli oppressi sugli oppressori. Le rivoluzioni per questo sono il “balzo di tigre” nonché il “freno d’emergenza” azionato per arrestare il cammino verso lo sfacelo della locomotiva umana. L’attimo in cui viene infranto il continuum della storia corrisponde al momento di avveramento della prassi marxiana, che da mera teoria si tramuta in pura azione.
Crediamo, quindi, che sia necessario costruire daccapo le fondamenta dell’intero apparato sociale, a fronte di un fattore basilare: se sei povero, assetato e affamato, puoi rubare e uccidere soltanto per un pezzo di pane o di carne. Infatti la povertà, in un certo senso, implica necessariamente la criminalità, e viceversa.
Sempre in merito al concetto di prassi, per dirlo con Gramsci, non conta tanto la sua definizione quanto il suo processo. Per capirci meglio, occorre comprendere il complesso e reversibile meccanismo della storia umana. Infatti, non dimentichiamoci che Marx è stato il degno continuatore del pensiero di Hegel ed ha ereditato da lui alcune importanti idee, tra cui il ruolo della storia sull’agire umano.
Lo storicismo hegeliano, però, con lui è diventato materialismo storico: in questo Marx fu ispirato dall’altro suo maestro, Feuerbach, autore controverso de “L’essenza del Cristianesimo”, un libro che mise a nudo un certo cristianesimo snaturato.
Nell’articolo “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel”, Marx sostiene:
L’uomo crea la religione, non la religione l’uomo.
Qui e in altri scritti lui si distacca dalle tenui argomentazioni contro la religione cristiana adoperate da Feuerbach, accusato di non aver risolto la questione religiosa e – addirittura – di aver fatto sfociare la sua filosofia nella religione stessa. Il materialismo di Feuerbach viene amplificato all’ennesima potenza da Marx, la cui filosofia si propone di cambiare la società, con la discesa in campo dei filosofi nelle questioni concrete riguardanti il genere umano.
A conferma di quanto appena detto, nell’Undicesima Tesi su Feuerbach, Marx recita: «I filosofi hanno soltanto provato a capire il mondo; ora, però, occorre cambiarlo». Attraverso un messaggio “subliminale”, l’autore vuole comunicarci che è giunto il tempo dei cambiamenti: un tempo in cui tutto può diventare possibile; un tempo in cui i filosofi devono prendere parte al gioco e non solo osservarlo impassibili, magari cercando anche di lottare per raggiungere la vittoria.
Ritornando alla visione messianica, esiste l’ulteriore rischio di incorrere in terribili episodi sanguinari, quale fu il nazismo hitleriano che causò l’immane sciagura dell’Olocausto, in cui morirono milioni di persone: non solo ebrei, ma anche altre minoranze, come zingari, oppositori politici, handicappati e omosessuali.
Fra la concezione marxista della storia e quella esposta da Gutierrez esistono altri evidenti parallelismi, come in questo caso:
Riflettere (teologicamente) sulle basi della prassi storica della liberazione […] significa riflettere guardando all’azione che trasforma il presente. Ma non significa fare questo da una poltrona; piuttosto significa ricercare le radici in cui pulsa il battito della storia e illuminare la storia con le parole del Signore della Storia, che irreversibilmente è impegnato per condurre l’umanità verso il proprio adempimento.
E di nuovo Gutierrez:
Il Peccato compare, quindi, come l’alienazione fondamentale, la radice della situazione dell’ingiustizia e dello sfruttamento.
Il “peccato” è un impedimento per ottenere la vita eterna. Ma che cos’è esattamente la vita presente, se non un tipo di qualificazione ulteriore per la vita futura?
La Salvezza comincia proprio con la Creazione – sinonimo curioso con cui Gutierrez chiama la prassi marxiana –, ovvero la ri-costruzione di un mondo nuovo e possibilmente migliore. Ciò giustifica il collegamento intrinseco che esiste per Gutierrez fra il concetto di Salvezza e quello di Creazione, o meglio di Ri-Creazione; ma per ri-creare qualcosa occorre un’azione immediata, che attui il concetto cruciale di prassi.
A tal proposito, Gutierrez sostiene:
La salvezza non è qualcosa di sopramondano, rispetto a cui la vita attuale è soltanto una prova. La salvezza – la comunione degli esseri umani con Dio e con se stessi – è qualcosa che abbraccia tutta la realtà umana, la trasforma e la conduce alla relativa pienezza in Cristo.
La cosiddetta “teologia dell’evento” – o degli “atti della liberazione” – di Gutierrez è basata su questi due fondamentali presupposti teologici: il primo consiste nella singola vocazione alla Salvezza, secondo cui tutta la vita umana ha dei valori religiosi; il secondo consiste nella Salvezza stessa, che incorre direttamente nella Storia.
La priorità della prassi è un’idea cruciale nella filosofia di Marx così come nella teologia di Gutierrez. In questo senso l’irruzione dei poveri nella storia, predetta in tempi non sospetti dal filosofo tedesco, è stata una sorta di teologia dei “segni dei tempi” – così definita da Giovani XXIII e dal Consiglio Vaticano II –, significante la richiesta indispensabile della gente per soddisfare i propri bisogni basilari. La prassi della liberazione per Gutierrez significa: scuole, acqua pulita, sindacati, riforme agrarie, eccetera… Poiché, infatti, la trasformazione radicale della società implica che dobbiamo concretizzare le nostre vite a immagine e somiglianza dei nostri sogni.
Infatti, come disse il poeta beat Delmore Schwartz: «Nei sogni cominciano le responsabilità». Se combattiamo uniti per i nostri sogni, forse abbiamo qualche possibilità di creare e, allo stesso tempo, di salvare il nostro oppresso mondo, troppo spesso sottovalutato e trascurato.
Esiste anche un fantastico libro del filosofo tedesco Hans Jonas, intitolato “Il principio della responsabilità”, che tratta questo delicato argomento ed è un ottimo spunto per l’acquisizione della coscienza individuale, fondamentale per la vita quotidiana del singolo.
In merito alla liberazione, poi, Gutierrez afferma:
[…] La liberazione umana e lo sviluppo del regno sono entrambi orientati verso la completa comunione degli esseri umani, con Dio e con se stessi. Essi hanno lo stesso obiettivo, ma non seguono strade parallele e neppure convergenti. Lo sviluppo del regno è un processo che si presenta storicamente nella liberazione, nella misura in cui liberazione significa un adempimento umano più grande. Inoltre, possiamo dire che l’evento storico e politico della liberazione segna lo sviluppo del regno, non di tutta la salvezza.
Non sappiamo se nel suo lavoro Gutierrez sia colpevole o meno di far confluire il Regno di Dio in quello dell’azione umana. Ma la vera questione è riuscire a capire se la lotta per questo mondo prepari o no il terreno per il superiore messianico avvento del Regno dei Cieli. Teologicamente è giusto combattere: prima per guadagnarsi un posto nel mondo, poi per conquistare la propria salvezza celeste. In questo senso, se la teologia e la filosofia cominciassero a combattere unite per rendere migliore questo mondo, ciò sarebbe un buon segno per l’intero genere umano. O se non altro, esse potrebbero collaborare alla costruzione della “società perfetta” marxiana: più giusta, equanime e dignitosa per tutte le persone.
Perciò pensiamo che non sia così importante se alcuni pensatori marxisti, diversamente dalla teologia, non credono in un altro mondo metafisico. Purché però, nel frattempo, essi combattano tenacemente per questo mondo fisico, contro le differenze e contro le ingiustizie sociali. Ma la cosa più importante è che questi pensatori siano convinti delle infinite possibilità di miglioramento della propria perfettibile società.
Redenzione o lotta di classe: dunque, qual è la differenza? Noi non riusciamo a intravedere alcuna discrepanza effettiva, poiché infatti i loro scopi sono pressoché identici.
Seconda ipotesi: Gutierrez non è un marxista?
È impensabile non tener conto del fatto che Marx è essenzialmente un pensatore ateo, realista. Di conseguenza, nella sua visione, la natura divina è assolutamente assente, poiché per lui la dottrina religiosa si fonda tutta nella natura umana: per questo motivo, quando parliamo di dottrina marxista potremmo benissimo definirla una sorta di nuovo umanesimo.
In una famosa affermazione, Karl Barth dichiara: «L’uomo è la misura di tutte le cose, dacché Dio si è fatto uomo». Secondo la filosofia marxiana ciò è del tutto insussistente, perché la resurrezione di Gesù Cristo non è un processo che può essere storicamente dimostrato.
Credere o non credere a Cristo come un’entità ultraterrena è solamente “un atto di fede”. Infatti chi era Gesù se non un profeta, un uomo, con grandi ideali e un combattente per la nobile causa dell’umanità, morto per questo sulla croce?
A differenza del realismo marxiano, Gutierrez invece difende la sua posizione ecclesiastica e crede fermamente in Cristo in quanto divinità.
Oltre a ciò, esiste un secondo motivo per definire Gutierrez un pensatore non-marxista.
Ne “L’ideologia tedesca”, Marx scrive:
Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza.
Non crediamo che Gutierrez possa acconsentire completamente a tale presupposto: ovvero, che il cervello sia il vero luogo in cui risiede l’anima e che entrambi, allora, corrispondano allo stesso materiale organico umano. Per il teologo, infatti, la vita partecipa al rafforzamento della coscienza.
Quanto affermiamo è abbastanza intuitivo, leggendo il seguente passaggio tratto da “Teologia della liberazione”:
La liberazione dell’Egitto, collegata e coincidente con la creazione, aggiunge un elemento di importanza capitale: il bisogno ed il posto di partecipazione attiva umana nella costruzione della società assume il suo destino nella storia, e così il genere umano forgia se stesso.
In seguito, il teologo peruviano si sofferma sul fatto che l’uomo non è solo ma è compartecipe della natura divina nella sua propria creazione. Diversamente per Marx, l’uomo è il solo e unico artefice di se stesso.
Oltre a ciò, però, c’è un altro motivo che ci impedisce di definire Gutierrez un “marxista ortodosso”. L’idealismo di un teologo, qual è lui, è lontano anni luce dal realismo pragmatico della filosofia di Marx, il quale si è più volte espresso con toni sprezzanti sull’idealismo.
Perciò, a ben guardare, se consideriamo questa loro indiscutibile diversità di fondo, non potremmo definire Gutierrez un marxista. Tuttavia la forte portata innovatrice della sua “teologia della liberazione” – tralasciando alcuni dettagli meramente dottrinari – è indubbiamente influenzata dal pensiero di Marx e ripropone infatti, seppur in chiave teologica, delle importanti acquisizioni filosofiche marxiane. Perciò, ammettendo il paragone tra un’idealista-teologo e un realista-filosofo, allora sì potremmo dire che Gutierrez sia il massimo paladino di una certa, per così dire, “teologia marxista”…
(Questo scritto è stato originariamente compilato in lingua inglese, dunque, qui si è voluto opportunamente evitare d’infarcire il testo, con inesatte indicazioni bibliografiche e altrettanto inesatti riferimenti a piè pagina).
GUY DEBORD

A cura di Fabrizio Cerroni
«Lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine» (La Società dello Spettacolo).
LA VITA
Guy Debord nasce a Parigi nel 1931. All’età di quattro anni rimane orfano di padre. Compie tutti i suoi studi a Cannes.
A diciotto anni ritorna a Parigi. Qui scopre il surrealismo e avviene l’incontro con il poeta Isidore Isou ed i suoi amici lettristi. Dopo un’iniziale adesione, si allontana sia dal surrealismo, sia da Isou, e nel 1952 insieme all’ala radicale del lettrismo dà vita all’Internazionale Lettrista, in aperto contrasto con il fondatore del movimento.
Nel luglio del 1957 a Cosio d’Arroscia, paesino ligure, fonda l’Internazionale Situazionista. Costituzione alla quale, oltre a Debord, prendono parte Gianfranco Sanguinetti, il pittore Pinot-Gallizio, Milanotte, artisti del movimento COBRA (Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam), il comitato psico-geografico di Londra, ed il Movimento per una Bauhaus Imaginista. L’Internazionale Situazionista si attesta su una critica totale dell’ordine esistente, sotto l’aspetto politico, economico (consumismo) e urbanistico. Il testo costitutivo fu scritto dallo stesso Debord con il titolo: Rapporto sulla costruzione di situazioni e sulle condizioni dell’organizzazione e dell’azione della tendenza situazionista internazionale.
Dal 1958 l’Internazionale Situazionista inizia a pubblicare una rivista semestrale omonima della quale Debord sarà direttore fino al 1969, anno dello scioglimento del gruppo, e nella quale pubblicherà numerosi articoli.
Visita molto spesso l’Italia, in particolare durante gli “anni di piombo”, fino al 1977 quando il governo Andreotti, con Cossiga Ministro dell’Interno, decreta la sua espulsione con l’accusa di fomentare il clima insurrezionale del paese.
Nel 1959 esce Memoire, libro scritto da Debord in collaborazione con il pittore Asger Jorn.
Nel 1967 scrive il suo capolavoro, La Società dello Spettacolo, destinato ad avere una vasta eco mondiale soprattutto dopo il Maggio ‘68. In quest’opera Debord afferma che i paesi capitalisti si stanno evolvendo verso una società in cui gli individui sono meri spettatori passivi di un flusso di immagini scelte dal potere, giustificatrici dell’assetto istituito, che si sostituiscono completamente alla realtà. Circa vent’anni dopo, nel 1988, pubblica i Commentari sulla Società dello Spettacolo, in cui afferma che il processo descritto nell’opera precedente aveva subito negli ultimi anni un’ulteriore accelerazione verso quello che definisce lo “spettacolarismo integrato”.
In occasione dell’assassinio del suo amico ed editore Gerard Lebovici, avvenuto nel 1984, pubblica Considerazioni sull’Omicidio di Gerard Lebovici (1985).
Nonostante sia stato una persona molto schiva, non concedeva interviste, non aveva il telefono, non si lasciava fotografare (se non in rare occasioni), tanto da essere considerato l’intellettuale più misterioso degli ultimi anni; Debord ha realizzato due autobiografie: Panegirico (1989) e Questa Cattiva Reputazione (1993).
Tra il 1952 ed il 1978 dirige tre lungometraggi e tre cortometraggi. I film sono: Hurlements en Faveur de Sade (1952); La Société du Spectacle (1977); e In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni (1978). I cortometraggi sono: Sur le Passage de Quelques Personnes à travers une Assez Courte Unité de Temps (1959); Critique de la Séparation (1961); e Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film «La Société du spectacle» (1975).
Lo scarso successo ottenuto da questi film induce Debord a pubblicarne i dialoghi nel volume Opere Cinematografiche Complete 1952-1978. Altra opera dedicata al cinema è Contro il Cinema, pubblicata nel 1968.
Il 30 Novembre del 1994 nella sua casa di Champot, paesino dell’Alta Loira, muore suicida con un colpo di pistola.
IL PENSIERO
Debord è stato uno dei critici più importanti delle società occidentali avanzati.
Tale critica è basata sui testi del giovane Hegel e di Marx, dei quali Debord opererà spesso un détournament, ossia una riscrittura creativa.
Esempio di tale processo è l’incipit della Società dello Spettacolo che riprende quello del Capitale di Marx: «tutta la vita delle società moderne in cui predominano le condizioni attuali di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di merci».
L’incipit dell’opus magnum di Debord è: «tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli» (La Società dello Spettacolo).
Questo détournament esprime bene quella che, per Debord, è la caratteristica principale del capitalismo moderno. L’accumulazione del capitale e l’espansione delle tecnologie della comunicazione hanno permesso di spingere il “feticismo delle merci” ad un grado prima impensabile.
La società dello spettacolo è il risultato di questa espansione. Lo spettacolo, concetto centrale della critica di Debord all’ordine capitalistico, non era inteso da questi meramente come espressione della tirannia dei mass-media. Quest’aspetto dello spettacolo è sicuramente «la sua manifestazione sociale più opprimente» (ibid.) ma non né l’unica, né la più importante. Lungi dall’esserne causa, la televisione è solo l’espressione della struttura delle società spettacolari.
Lo spettacolo è, piuttosto, il tipo di relazioni interpersonali costruite dalle immagini di una società spettacolarizzata.
«Lo spettacolo non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini» (ibid.).
Per questo motivo, esso non è qualcosa di esterno alla società, ma, al contrario, è la sua struttura profonda.
«La società che riposa sull’industria moderna non è fortuitamente o superficialmente spettacolare, è fondamentalmente spettacolista» (ibid.).
Tuttavia lo spettacolo è, allo stesso tempo, solo un settore della società separato dagli altri, e lo strumento attraverso cui questa parte domina il tutto. Questa contraddizione fa sì che esso sia necessariamente falso ed ingannevole, giacché struttura le immagini secondo gli interessi di una parte della società.
«Lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa, come una parte della società, e come strumento di unificazione. […] Per il fatto stesso che questo settore è separato, è il luogo dell’inganno dello sguardo e il centro della falsa coscienza» (ibid.).
Questo settore che domina sul resto della società non è altro che l’economia. Lo spettacolo è così il prodotto della mercificazione della vita moderna, il progresso del capitalismo consumistico verso il feticismo e la reificazione. L’economia è ormai completamente autonomizzata.
Pertanto lo spettacolo può essere definito come «il regno autoritario dell’economia mercantile elevato a uno statuto di sovranità irresponsabile, e l’insieme delle nuove tecniche di governo che accompagnano tale regno» (Commentari sulla Società dello Spettacolo).
Lo spettacolo, dunque, è il risultato della frammentazione sociale, derivante dal fatto che un settore domina sugli altri, e la ricomposizione dell’unità perduta nella realtà sul piano delle immagini, le quali mostrano tutto ciò che manca nella vita degli individui. Si realizza così una nuova alienazione. Mentre nel capitalismo classico, descritto da Marx, l’alienazione è il risultato del passaggio dall’essere all’avere, nel capitalismo spettacolare essa deriva dal passaggio dall’avere all’apparire.
«La prima fase del dominio dell’economia sulla vita sociale aveva determinato nella definizione di ogni realizzazione umana un’evidente degradazione dell’essere in avere. La fase presente dell’occupazione totale della vita sociale da parte dei risultati accumulati dell’economia conduce a uno slittamento generalizzato dell’avere nell’apparire, da cui ogni “avere” effettivo deve trarre il suo prestigio immediato e la sua funzione ultima» (La Società dello Spettacolo).
Gli individui separati ritrovano la loro unità nello spettacolo, ma solo in quanto separati. Giacché la comunicazione è unilaterale; è il Potere che giustifica se stesso e il sistema che l’ha prodotto in un incessante discorso elogiativo del capitalismo e delle merci da esso prodotte.
«Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo. È l’autoritratto del potere all’epoca della gestione totalitaria delle condizioni di esistenza» (ibid.).
Lo spettacolo presuppone, quindi, l’assenza di dialogo, poiché è solo il potere a parlare. Condizione per raggiungere tale risultato è la totale separazione di individui sempre più isolati nella folla atomizzata. È da questo stato che lo spettacolo deriva, ed è esso che cerca costantemente di riprodurre, come mostrano i prodotti che realizza: televisione, automobile, ecc.
«Il sistema economico fondato sull’isolamento è una produzione circolare di isolamento» (ibid.).
Ridotto al silenzio, al consumatore non resta altro che ammirare le immagini che altri hanno scelto per lui. L’altra faccia dello spettacolo è l’assoluta passività del consumatore, il quale ha esclusivamente il ruolo, e l’atteggiamento, del pubblico, ossia di chi sta a guardare, e non interviene. Lo spettacolo è «il sole che non tramonta mai sull’impero della passività moderna» (ibid.).
In questo modo lo spettatore è completamente dominato dal flusso delle immagini, che si è ormai sostituito alla realtà, creando un mondo virtuale nel quale la distinzione tra vero e falso ha perso ogni significato. È vero ciò che lo spettacolo ha interesse a mostrare. Tutto ciò che non rientra nel flusso delle immagini selezionato dal potere, è falso, o non esiste.
«Quando l’immagine costruita e scelta da qualcun altro è diventata il rapporto principale dell’individuo col mondo, che egli prima guardava da sé da ogni luogo in cui poteva andare, evidentemente non si ignora che l’immagine reggerà tutto. […] Il flusso delle immagini travolge tutto, e analogamente è qualcun altro a dirigere a suo piacimento questa sintesi semplificata del mondo sensibile» (Commentari sulla Società dello Spettacolo).
Come l’immagine si sostituisce alla realtà, la visione dello spettacolo si sostituisce alla vita. I consumatori piuttosto che fare esperienze dirette, si accontentano di osservare nello spettacolo tutto ciò che a loro manca. Per questo lo spettacolo è il contrario della vita. Debord descrive in questi termini tale alienazione del consumatore: «più egli contempla, meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la sua propria esistenza e il suo proprio desiderio» (La Società dello Spettacolo).
L’individuo, quindi, deve rinunciare alla propria personalità se vuole essere accettato dalla società, poiché questa richiede «una fedeltà sempre mutevole, una serie di adesioni continuamente deludenti a prodotti fasulli» (Commentari sulla Società dello Spettacolo); e ciò gli impedirà di conoscere i suoi veri bisogni e desideri.
È così che, secondo Debord, la società moderna, fondata sull’ideale dell’individualismo, produce la più mortale e sterile passività che la storia abbia mai conosciuto.
Non si deve credere, però, che lo spettacolo sia un’invenzione del capitalismo moderno. Esso si produce ogniqualvolta vi sia nella società una separazione gerarchica creata dall’esistenza di un potere istituzionalizzato. In questo senso la religione può essere considerata l’antecedente dello spettacolo. In questo senso si può dire che «il più moderno è qui anche il più antico» (La Società dello Spettacolo).
Tuttavia, solo nell’epoca moderna il Potere ha accumulato i mezzi sufficienti, non solo per dominare la società, ma anche per plasmarla secondo i propri interessi, attraverso una produzione volta alla diffusione dell’isolamento.
Rientra nello spettacolo anche la creazione di un antagonismo tra sistemi sociali che sono in realtà solidali tra loro. È stato questo il caso della guerra fredda, definita da Debord come «divisione dei compiti spettacolari» (ibid.).
Anche i paesi comunisti (o capitalisti) di Stato erano considerati da Debord sistemi spettacolari. Essi erano basati su uno spettacolo concentrato nel quale, a causa del minore sviluppo dell’economia, le merci erano sostituite dall’ideologia e dall’identificazione con il capo supremo. Ad essi si contrappone lo spettacolo diffuso delle società capitalistiche basate sul consumo delle merci. Tuttavia questa contrapposizione è in realtà fittizia, giacché vuole convincere gli individui che esistono solo quei due modelli di società, i quali in realtà hanno più affinità che differenze, essendo entrambi basati sulla logica capitalistica e sul dominio gerarchico di una classe: la borghesia nello spettacolo diffuso, la burocrazia nello spettacolo concentrato.
In questa pseudolotta il sistema vincente si è rivelato quello dello spettacolo diffuso, poiché questo permette la scelta tra un numero indefinito di merci, ed il dominio dell’economia sulla società equivale al dominio della merce sull’uomo.
«Lo spettacolo è il momento in cui la merce è pervenuta all’occupazione totale della vita sociale» (ibid.).
In una società mercificata, sostiene Debord, non può che essere la merce ad avere un ruolo centrale. Ogni merce promette il soddisfacimento dei bisogni, e quando arriva l’inevitabile delusione, dovuta al fatto che tali bisogni sono fittizi e manipolati, subentra una nuova merce pronta a mantenere la promessa disillusa dall’altra. Si crea così una concorrenza tra le merci, rispetto alla quale il consumatore frustrato è un mero spettatore.
Debord afferma che questo modello impregna di sé, ormai, tutta la vita sociale, divenendo il prototipo di ogni competizione, compresa quella politica. Questa si riduce alla competizione tra leader che vendono la propria immagine come una merce, e fanno promesse che non manterranno mai. Il tutto nell’assoluta passività e apatia dei “cittadini”.
Quando nel 1988 nei Commentari Debord tornerà ad analizzare lo spettacolo, affermerà che i processi descritti negli scritti precedenti avevano avuto un’ancora più rapida evoluzione.
Questa era dovuta al fatto che agli spettacoli concentrato e diffuso si era aggiunto un nuovo tipo: lo spettacolare integrato. Esso è al tempo stesso concentrato e diffuso e riesce così a combinare i vantaggi di entrambi. Il risultato è una società completamente spettacolarizzata.
«Il senso dello spettacolare integrato è che si è integrato nella realtà stessa man mano che ne parlava; e che la ricostruiva come ne parlava. […] Lo spettacolo si è mischiato ad ogni realtà irradiandola» (Commentari sulla Società dello Spettacolo).
Lo spettacolare integrato ha cinque caratteristiche principali:
«il continuo rinnovamento tecnologico; la fusione economico-statale; il segreto generalizzato; il falso indiscutibile; un eterno presente» (ibid.).
In questo modo tutti gli effetti dello spettacolo si amplificano in misura esponenziale. La società è completamente dominata dalle immagini falsificate che si sostituiscono alla realtà, facendo scomparire qualsiasi possibilità di attingere la verità al di là della falsificazione continua che la ricopre.
Ciò determina la scomparsa del concetto di storia, e quindi anche della democrazia.
«Credevamo di sapere che la storia era apparsa in Grecia con la democrazia. Adesso possiamo verificare che la prima sta scomparendo dal mondo come la seconda» (ibid.).
La finzione di democrazia è mantenuta in vita solo attraverso la costruzione di un nemico comune, il quale consente una falsa unità che ricopre la realtà della separazione gerarchica tra dirigenti ed esecutori. È questo il ruolo del terrorismo.
«Questa democrazia così perfetta fabbrica da sé il suo inconciliabile nemico, il terrorismo. Vuole infatti essere giudicata in base ai suoi nemici piuttosto che in base ai suoi risultati. La storia del terrorismo è scritta dallo Stato; quindi è educativa. Naturalmente le popolazioni spettatrici non possono sapere tutto del terrorismo, ma possono sempre saperne abbastanza da essere convinte che, rispetto al terrorismo, tutto il resto dovrà sembrare loro abbastanza accettabile, e comunque più razionale e democratico» (ibid.).
In questo contesto ogni critica diventa impossibile. Lo spettacolare integrato non vuole essere criticato, e, d’altronde, gli individui vengono educati sin dalla nascita per evitare che questo accada. Infatti, essendo inondati da un flusso inarrestabile di immagini che non lascia loro il tempo per comprendere e riflettere, questi individui fanno costantemente l’esperienza concreta della sottomissione permanente.
Questa formazione a quello che Debord chiama pensiero spettacolare è ciò che indurrà gli individui a mettersi sin da subito al servizio dell’ordine costituito. Ed anche se una persona riuscisse a superare questa formazione resterebbe comunque attaccata al linguaggio dello spettacolo, giacché è l’unico che conosce, essendo l’unico che gli è stato insegnato.
«Magari vorrà mostrarsi nemico della sua retorica; ma userà la sua sintassi. È uno dei punti più importanti ottenuti dal successo raggiunto dal dominio spettacolare» (ibid.).
La mondializzazione dell’economia è l’apogeo di questo processo che si distingue da ciò che l’ha preceduta per un solo elemento, ma di importanza decisiva.
«Il fatto nuovo è che l’economia abbia cominciato a fare apertamente guerra agli umani; non più soltanto alle possibilità della loro vita, ma anche a quelle della loro sopravvivenza» (ibid.).
Si può quindi affermare che «l’economia onnipotente è diventata folle, e i tempi spettacolari non sono altro che questo» (ibid.).
Il risultato è quel villaggio globale di cui parla McLuhan, ma del quale Debord dà una valutazione opposta rispetto al sociologo canadese.
«I villaggi, contrariamente alle città, sono sempre stati dominati dal conformismo, dall’isolamento, dalla sorveglianza meschina, dalla noia, dalle chiacchiere ripetute all’infinito sulle stesse famiglie» (ibid.).
A questo stato di cose, prodotto dalla tendenza al feticismo delle merci ed alla reificazione dell’economia autonomizzata, Debord contrappone il concetto di totalità. Se la costituzione del potere produce una separazione gerarchica della società, l’unica soluzione è quella di ricostruire realmente l’unità della stessa.
Questa totalità è intesa da Debord come comunità umana che, egli considera la vera natura umana. Tale comunità è possibile solo se ognuno può accedere direttamente ai fatti, e se tutti hanno i mezzi intellettuali e materiali necessari per decidere.
Nella comunità la comunicazione prende la forma del dialogo e della discussione ai quali ciascuno può partecipare, condizione necessaria per prendere decisioni in comune. Questa comunicazione diretta è l’opposto di quella unilaterale dello spettacolo, nel quale una parte separatasi dalla totalità pretende di essere l’unica a parlare impartendo ordini che il resto della società deve limitarsi ad eseguire. Questa concezione consente a Debord di affermare che «là dove c’è comunicazione non c’è lo Stato» (L’Internationale Situationniste).
Al di là delle concezioni pessimistiche sullo stato della critica sociale nello spettacolo, Debord è rimasto sempre ottimisticamente convinto della necessità di una simile ricomposizione dell’unità. Si esprime qui una concezione deterministica della storia, che Debord condivide con Marx, e che considera necessaria sia la frammentazione dell’unità originaria, sia la sua ricomposizione ad un livello più alto, raggiunto grazie allo sviluppo dell’economia, considerato il vero motore della storia.
Questo risultato può essere ottenuto poiché anche nella società dello spettacolo rimane la lotta di classe. Il soggetto rivoluzionario è sempre il proletariato del quale Debord amplia la definizione, fino ad includervi tutti coloro che hanno perso il controllo sulla propria esistenza.
«È l’immensa maggioranza dei lavoratori, che hanno perduto ogni potere sull’impiego della loro vita, e che dal momento in cui lo sanno, si ridefiniscono come proletariato, il negativo all’opera in questa società» (La Società dello Spettacolo).
Affinché questa classe sia rivoluzionaria è necessario che prenda coscienza del tempo storico. Debord considera l’evoluzione di questa presa di coscienza strettamente legata al progresso tecnico. Originariamente, quando l’agricoltura era l’unica attività produttiva, la concezione del tempo era da questa determinata. Tale rappresentazione era pertanto quella del tempo ciclico dell’eterno ritorno. Il tempo diventa sociale quando si formano le classi al potere, le quali, non lavorando la terra, iniziano ad avere coscienza del tempo storico, e della sua irreversibilità. Per il vertice della società la storia inizia ad avere un senso, e quest’idea entra in contrasto con quella della base della società, per la quale vale l’opposto. La religione monoteista è il risultato di questa contraddizione.
La diffusione del tempo storico ha luogo con la borghesia, giacché con il capitalismo il lavoro cessa di essere regolare e ciclico, ma subisce anch’esso una continua trasformazione. Tuttavia nel momento in cui la concezione del tempo potrebbe diffondersi anche alla base, esso perde la sua storicità per tutta la società, divenendo il tempo «della produzione in serie degli oggetti» (ibid.).
«Il tempo delle cose» (ibid.) si sostituisce a quello delle persone. Ne risulta una perdita totale dell’aspetto qualitativo del tempo, il quale viene ridotto esclusivamente al suo lato quantitativo. In quest’ambito i momenti si distinguono solo per aspetti quantitativi, si attua, quindi, per il tempo, lo stesso processo descritto da Marx per la merce, con il passaggio dal valore d’uso al valore di scambio. Anche il tempo è mercificato.
Per essere rivoluzionario, dunque, il proletariato deve riprendere coscienza del tempo storico, ossia del fatto che l’economia è il vero motore della storia. Questo avviene grazie al progresso economico attraverso il quale l’economia non rimane la base incosciente della storia, ma, nel momento in cui dirige la vita, si rivela creazione dell’uomo; ed in tal modo questi ne prende coscienza. A questa presa di coscienza si oppone lo spettacolo che cerca di perpetuarsi diffondendo la finzione di un eterno presente che pretende di aver posto fine alla storia.
Il proletariato può arrivare alla coscienza della storia, del suo carattere di processo e lotta, dopo essere passato per uno sviluppo «complesso e terribile» (ibid.). Debord analizza questo sviluppo del movimento operaio, considerandolo come un’evoluzione verso la presa di coscienza.
Tale movimento è cominciato con la Prima Internazionale, nella quale il problema principale era l’autoritarismo, che Marx e Bakunin condividevano, e dovuto all’ideologia, vera e propria degenerazione della teoria rivoluzionaria. L’anarchismo individualista è considerato da Debord «risibile» (ibid.), e l’anarchia in generale poco efficace poiché ha posto attenzione più sull’obiettivo che sui mezzi, e si basa sulla concezione ideologica di una «libertà pura» (ibid.), idealista ed astorica. La socialdemocrazia, invece, commette l’errore di rafforzare la distinzione tra il proletariato ed i dirigenti del partito, in questo è precorritrice del bolscevismo. L’Unione Sovietica, e successivamente la Cina, non sono considerati da Debord paesi comunisti, ma capitalisti di Stato, con la burocrazia che si sostituisce alla borghesia come classe sfruttatrice. Anche Trotzkij, infine, ha condiviso l’autoritarismo bolscevico e non ha visto nella burocrazia una nuova classe, ma solamente un ceto parassitario.
«In questo sviluppo complesso e terribile che ha condotto l’epoca delle lotte di classe verso nuove condizioni, il proletariato dei paesi industriali ha completamente perduto l’affermazione della sua prospettiva autonoma, e, in ultima analisi, le sue illusioni, ma non il suo essere. Esso non è stato soppresso» (ibid.).
La forma nella quale tale essere può venire recuperato è quella del consiglio operaio. Esso «è il luogo in cui le condizioni oggettive della coscienza storica sono riunite; la realizzazione della comunicazione diretta attiva, in cui finiscono la specializzazione, la gerarchia e la separazione, in cui le condizioni esistenti sono state trasformate in condizioni dell’unione».
La costituzione dell’Internazionale Situazionista ha lo scopo di favorire questa presa di coscienza. Tale obiettivo è stato perseguito in modo diverso in tempi diversi. Innanzi tutto attraverso un’attività di avanguardia culturale ed artistica. Tale avanguardia è resa necessaria dal fatto che la sovrastruttura culturale è rimasta indietro rispetto allo sviluppo della struttura; ed è questo il motivo per cui la borghesia è contraria ai movimenti avanguardisti.
La cultura, però, non deve più essere un’attività separata, ma deve inserirsi nella vita quotidiana, la quale rimane l’unico campo in cui può compiersi la rivoluzione. In questo contesto l’arte deve portare nuovi valori e nuove passioni, mirando alla propria distruzione come sfera separata.
«Ci collochiamo dall’altro lato della cultura. Non prima di essa ma dopo. Noi diciamo che bisogna realizzarla, superandola in quanto sfera separata» (L’Internationale Situationniste).
L’attività dell’Internazionale Situazionista in questa fase è diretta a portare alla luce i «desideri dimenticati», creando situazioni (da qui il nome del gruppo) in cui gli individui potessero divenire partecipanti gioiosi della vita e non osservatori passivi dello spettacolo. Lo scopo è la soddisfazione del desiderio, concretamente e senza sublimarsi nell’arte.
Successivamente Debord ha posto maggiormente attenzione alle nuove forme di ribellione sociale. Gli esempi che considera sono gli scioperi selvaggi, il vandalismo delle bande giovanili, il saccheggio, la rivolta nel quartiere nero di Los Angeles. Debord vi vede un rifiuto del consumo imposto e della merce. Debord definisce questi eventi «il secondo assalto proletario contro la società di classe» (La Società dello Spettacolo).
Questo assalto non è dovuto, come il primo, alla miseria, ma al contrario è diretto contro l’abbondanza. E proprio come il movimento operaio è stato preceduto dal luddismo, questo nuovo assalto assume inizialmente forme criminali, dirette alla «distruzione delle macchine del consumo permesso» (ibid.).
Debord continua, comunque, ad attribuire all’avanguardia un ruolo estremamente positivo. Per questo l’Internazionale Situazionista rimane un gruppo piccolo, elitario, molto chiuso. L’avanguardia è però concepita in modo diverso rispetto a Lenin. Secondo Debord essa ha un ruolo esclusivamente prerivoluzionario, volto a favorire l’insurrezione attraverso una critica radicale delle società capitalistiche moderne, nei loro aspetti politici, economici, urbanistici.
«Noi organizziamo solo il detonatore: l’esplosione libera dovrà scapparci per sempre, e scappare a qualsiasi altro controllo» (L’Internationale Situationniste).
KAZIMIERZ TWARDOWSKI

A cura di Fabrizio Cerroni
LA VITA
Kazimierz Twardowski nasce a Vienna il 20 ottobre del 1866.
Frequenta l’Università di Vienna nella quale studia, oltre alla filosofia, filologia classica, matematica e fisica. È allievo dal 1885 al 1889 di Franz Brentano e successivamente, fino al 1892, di Robert Zimmermann.
Brentano influenza notevolmente il pensiero di Twardowski il quale accetta alcuni dei postulati fondamentali del filosofo tedesco, come la separazione tra rappresentazione e giudizio, quella tra l’aspetto genetico e l’aspetto descrittivo della psicologia, nonché la teoria del carattere fondante dei giudizi riguardanti l’esperienza interna.
Questa influenza si evidenzia nella tesi con la quale Twardowski ottiene il dottorato nel 1892 (con Zimmermann relatore): Idee und Perception. Eine erkenntnis-theoretische Untersuchung aus Descartes (“Idea e percezione. Una ricerca teorico conoscitiva su Descartes”); nonché nella sua tesi di abilitazione del 1894: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen (“Sulla dottrina del contenuto e dell’oggetto delle rappresentazioni”).
Nelle opere successive, in particolare dal 1898 con il saggio Raffigurazione e concetto, Twardowski si allontanerà gradualmente dallo psicologismo di Brentano, avvicinandosi a Husserl e Meinong.
Dal 1894 insegna filosofia, prima a Vienna, successivamente a Leopoli (all’epoca ancora in territorio austriaco), dove terrà una delle due cattedre di filosofia dal 1895 fino al 1930.
A Leopoli Twardowski è il fondatore della prima e più importante scuola di filosofia polacca: la Scuola di Leopoli-Varsavia. Ciò dà alla filosofia polacca un impulso fondamentale, al quale Twardowski contribuisce in maniera basilare, sia sotto il profilo istituzionale (riforma delle istituzioni culturali esistenti, creazione della Società Filosofica Polacca, e della Società polacca di psicologia sperimentale), sia attraverso la sua attività di insegnamento.
Alla scuola di Twardowski si formano i più importanti filosofi polacchi nel campo della logica, della matematica e della semantica filosofica: Jan Lukasievicz, Stanislaw Leśniewski, Alfred Tarski, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden.
La scuola di Leopoli-Varsavia si caratterizza per un forte pluralismo, quindi per l’assenza di princípi dogmatici la cui accettazione è imposta a tutti i membri. Ciò porta ad un’eterogeneità dei contenuti, attenuata però dall’unitarietà del metodo e dello stile. Questi sono incentrati su un realismo scolastico-aristotelico, su di una concezione corrispondentistica della verità, e su un interesse sempre crescente per la linguistica.
Twardowski influenza notevolmente questo stile per la sua critica dell’irrazionalismo e la valorizzazione del discorso logico-razionalista, la quale porta alla ricerca di un’argomentazione chiara e lineare che renda immediatamente comprensibili le tesi sostenuti.
I numerosi saggi scritti da Twardowski in questi anni sono raggruppati in due raccolte: Scritti filosofici (1927); e Saggi (1938).
Twardowski muore il 2 febbraio 1938 a Leopoli.
IL PENSIERO
L’importanza di Twardowski per la storia della filosofia è legata non solo alla sua attività didattica capace di formare logici del calibro di Alfred Tarsi, ma anche per la sua ricerca filosofica.
Infatti il suo pensiero può essere considerato come un “anello di congiunzione” tra lo psicologismo di Brentano da una parte, e la fenomenologia di Husserl dall’altra.
Allievo del primo, Twardowski ne prenderà progressivamente le distanze, arrivando ad anticipare alcuni temi della filosofia di Husserl, come ad esempio un’analisi della psicologia basata sul concetto di intenzionalità.
Nel suo primo testo filosofico, la tesi di dottorato del 1892, Twardowski studia il ruolo della percezione e della rappresentazione nel giudizio, al fine di individuare i criteri che permettano di considerare quest’ultimo vero. Twardowski polemizza con coloro i quali riducono la percezione alla rappresentazione, ma, afferma, essa non può neanche essere fatta coincidere con il giudizio nella sua interezza.
Il ruolo della percezione e della rappresentazione viene chiarito da Twardowski sulla base di una distinzione tra forma e materia: la rappresentazione è l’elemento materiale del giudizio, mentre la percezione ne costituisce l’aspetto formale.
In base a questo suo ruolo, la percezione è ciò che consente di motivare la decisione sull’esistenza o meno dell’oggetto, ossia il giudizio.
La percezione costituisce dunque la base della verità del giudizio.
Il criterio che permette di stabilire la verità di un giudizio è così ricondotto alla percezione chiara e distinta, identificata con la percezione intellettuale, interna ed evidente. Twardowski condivide, quindi, l’assunto di Cartesio in base al quale questa percezione è necessariamente vera.
Twardowski considera inoltre la valenza che i criteri di chiarezza e distinzione hanno per la percezione e per la rappresentazione.
Da questo punto di vista i due criteri si differenziano, giacché mentre la distinzione assume lo stesso significato per entrambi gli elementi del giudizio, lo stesso non vale per la chiarezza. Per l’idea la chiarezza costituisce il suo elemento caratteristico; mentre per la percezione, un ruolo fondamentale è svolto dall’attenzione, che le consente di cogliere l’oggetto «in modo completo ed in tutte le sue parti» (Contenuto e oggetto). Quindi, mentre nella rappresentazione il criterio della chiarezza è sempre soddisfatto, per la percezione è necessario l’intervento dell’attenzione.
Nel testo del 1898, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, Twardowski introduce la distinzione tra atto, oggetto e contenuto nella rappresentazione, considerato il più importante apporto teorico del filosofo.
Ogni rappresentazione è un atto intenzionale rivolto ad un oggetto. Tuttavia essa non è in grado di attingerlo direttamente, ma necessita di una mediazione. È questo il ruolo svolto dal contenuto.
L’oggetto trascendente rimane irraggiungibile per il soggetto conoscente, il quale può averne informazioni solo attraverso il contenuto.
Per questo è necessario distinguere il contenuto dall’oggetto. Il rapporto della rappresentazione con l’oggetto è quindi modificativo, in quanto essa gli attribuisce proprietà che non gli appartengono. Modificazione necessaria, giacché la rappresentazione non può avere una conoscenza immediata dell’oggetto. Al contrario, il rapporto della rappresentazione con il contenuto è attributivo. Dunque, mentre il contenuto è una costruzione mentale che dipende dall’atto rappresentativo, l’oggetto è esogeno rispetto a tale atto.
Twardowski chiarisce questa differenza servendosi di «un’analogia tra i fenomeni psichici e le forme linguistiche che li designano» (ibid.). In particolare, Twardowski utilizza come strumento di questo paragone il nome.
«Ai tre aspetti della rappresentazione – l’atto, il contenuto e l’oggetto – corrisponde un triplice compito che ogni nome deve soddisfare» (ibid.).
Infatti ogni nome svolge tre funzioni:
«primo, il render noto un atto di rappresentazione che ha luogo in colui che parla; secondo, il destare un contenuto psichico, il significato di un nome, in colui al quale ci si rivolge; terzo il designare un oggetto che è rappresentato mediante la rappresentazione significata dal nome» (ibid.).
Un nome, quindi, designa un oggetto per mezzo di un contenuto psichico da esso significato. Allo stesso modo l’atto di rappresentazione designa l’oggetto per mezzo del contenuto.
Un’altra analogia usata da Twardowski per chiarire questa distinzione è quella del dipingere. Poiché è possibile affermare sia che si dipinge un quadro, intendendo con ciò il risultato dell’atto, sia che si dipinge un paesaggio, intendendo l’oggetto che si intende raffigurare. Il quadro coincide con il contenuto, il paesaggio con l’oggetto.
Questa concezione permette di considerare il problema delle rappresentazioni il cui oggetto non esiste nella realtà. Un esempio è fornito dalla rappresentazione dell’assenza.
Twardowski critica la tesi secondo la quale queste sarebbero rappresentazioni senza oggetto. Giacché dove c’è rappresentazione c’è anche l’oggetto, è impossibile che un’idea sia priva di questo suo elemento fondamentale. L’errore di queste concezioni sorge da una confusione tra l’oggetto ed il contenuto. Benché nella realtà un determinato oggetto possa non esistere, nella rappresentazione esso è sempre presente come oggetto rappresentato, ossia come contenuto.
«L’oggetto rappresentato […] è il contenuto della rappresentazione. […] Il contenuto della rappresentazione e l’oggetto della rappresentazione sono la stessa cosa. […] La confusione dovuta ai sostenitori della rappresentazione senza oggetto consiste nel fatto che essi ritengono che la non esistenza di un oggetto sia identica al suo non essere rappresentato» (ibid.).
Occorre dunque distinguere tra realtà ed esistenza dell’oggetto della rappresentazione. Mentre può anche non esistere, l’oggetto è necessariamente presente nella rappresentazione, come suo contenuto.
La tripartizione della rappresentazione vale anche per il giudizio, giacché questi due atti psichici hanno la stessa struttura.
«Appare evidente l’assunto che i giudizi in rapporto alla distinzione tra contenuto e oggetto si mostreranno del tutto simili alla rappresentazione» (ibid.).
Al di là di questa comunanza strutturale, ciò che distingue la rappresentazione dal giudizio è il tipo di riferimento intenzionale all’oggetto.
«È infatti evidente a tutti che si tratta di un rapporto diverso se qualcuno si rappresenta semplicemente qualcosa, o se invece lo afferma o lo nega» (ibid.).
Compito del giudizio è appunto stabilire se un oggetto rappresentato esista o meno. Questa differenza di riferimento si riflette in una diversità di contenuto. Nella rappresentazione il contenuto è un segno dell’oggetto; nel giudizio, invece, il contenuto è costituito dall’esistenza dell’oggetto. L’esistenza dell’oggetto del giudizio non è preesistente all’atto, ma viene posta con lo stesso.
«Con il contenuto del giudizio si deve intendere, quindi, l’esistenza di un oggetto della quale si tratta in ogni giudizio» (ibid.).
Benché assuma forme diverse, anche nell’atto del giudizio esiste una differenza tra oggetto e contenuto. Essa è dimostrata dai giudizi negativi.
La verità di questo tipo di giudizi, infatti, richiede che l’oggetto giudicato non esista. Tuttavia ciò non toglie che l’oggetto debba esistere nella rappresentazione attraverso un contenuto. L’oggetto inesistente può essere giudicato solo attraverso un contenuto che esiste: ciò dimostra che anche nel giudizio esiste un’alterità tra oggetto e contenuto.
Il giudizio è dunque un atto di conformità ad un contenuto. Il giudizio negativo mostra che l’oggetto può essere rappresentato anche se non esiste. In questo caso l’oggetto si identifica con l’insieme delle proprietà che gli vengono attribuite, e che per il loro carattere contraddittorio ne determinano la non esistenza.
Ciò consente a Twardowski di affermare che l’oggetto della rappresentazione non coincide con l’esistente. La sua caratteristica fondamentale è l’oggettualità, ossia la possibilità di essere rappresentato. L’oggetto coincide con il rappresentabile.
In Raffigurazione e concetto del 1898 Twardowski ribadisce la differenza tra contenuto ed oggetto sia per la prima che per il secondo. Giacché, per la raffigurazione l’oggetto è rappresentato attraverso un unico atto e non attraverso la composizione di più impressioni; quanto al concetto, esso è l’attribuzione ad un oggetto di una proprietà a seguito di un giudizio, pertanto tale proprietà non è presente nell’oggetto stesso, ma è il risultato di un’attività psichica.
Twardowski, dunque, considera la rappresentazione come un Tutto che solo a posteriori può essere scomposto in parti. Il concetto sorge dove non è più possibile la raffigurazione, per questo non è rappresentabile in immagini visive.
Questa teoria porta Twardowski a sottolineare la creatività del pensiero nell’elaborazione dei concetti. Tale visione positiva della funzione della creatività nella scienza lo porterà ad accogliere favorevolmente la filosofia del “come se” di Vaihinger.
Da questo scritto inizierà l’allontanamento di Twardowski dallo psicologismo, che diventerà definitivo dopo la conoscenza della fenomenologia di Husserl, della quale lo stesso Twardowski aveva anticipato alcuni temi. Ciò lo porta ad una visione della psicologia che la riduce a scienza ausiliaria rispetto alle altre.
Questo viraggio conduce ad una modifica negli interessi di Twardowski e della sua scuola. Acquistano un’importanza sempre maggiore la logica, la matematica, la teoria della conoscenza e la filosofia del linguaggio. L’importanza crescente attribuita a quest’ultima, lo conduce ad uno stile sempre più improntato al formalismo, e ad una concezione che vede nella comprensibilità e nella chiarezza degli enunciati una condizione necessaria della scientificità del testo.
Questa esigenza esprime la ricerca di una filosofia scientifica contrapposta alla metafisica. Opposizione non definitiva, giacché anche nel pensiero metafisico possono essere espresse delle verità, ed anch’esso può assurgere alla scientificità.
La sua concezione del linguaggio e del giudizio lo porterà ad una valutazione negativa della possibilità di distinguere tra giudizi relativamente e assolutamente veri. La vera distinzione è, secondo Twardowski, quella tra il giudizio e l’enunciato che lo esprime. La possibilità di una verità determinata dalle circostanze è corretta solo per l’enunciato, poiché la parola è un polisenso predestinato, ed il significato di una frase viene così a dipendere dal contesto. Ma il giudizio, in quanto atto psichico distinto dall’enunciato che lo trasmette, è o assolutamente vero, o assolutamente falso.
In conclusione, l’importanza di Twardowski come didatta è legata non alla trasmissione di un pensiero dogmatico, ma all’affermazione di un’attitudine minimalista. L’esigenza di uno stile logico-formale, la difesa del realismo, l’analisi del linguaggio, la critica della metafisica; tutti questi aspetti della filosofia di Twardowski, attraverso i quali si esprime una concezione della filosofia come scienza, saranno fatti propri dai suoi allievi.
L’importanza di Twardowski come filosofo è legata alla distinzione tra atto, contenuto ed oggetto, ad una visione del concetto che ne riconosce il carattere di costruzione rispetto ad una realtà che non si può mai cogliere direttamente, ed al riconoscimento del ruolo della creatività nel pensiero.
ZYGMUNT BAUMAN

A cura di Alberto Rossignoli
Cenni biografici
Nato da genitori ebrei non praticanti a Poznan (Polonia), nel 1925, fuggì successivamente nella zona di occupazione sovietica nel 1939, a seguito dell’invasione nazista della Polonia e si mise a servizio di un’unità militare sovietica, per la precisione il KBW, un’unità sorta con lo scopo di combattere l’anticomunismo.
Dopo la guerra, iniziò a studiare sociologia all’ università di Varsavia, ove rimase almeno fino al 1968.
Collaborò con diverse riviste specializzate, tra cui “Sociologia na co dzien” (“sociologia di tutti i giorni”), che raggiungeva un pubblico relativamente vasto.
Inizialmente fu fedele al Marxismo ma successivamente si avvicinò al pensiero di Gramsci e Simmel.
Nel marzo 1968, una epurazione antisemita in Polonia spinse molti degli ebrei polacchi superstiti a cercare rifugio all’estero: il ministro populista Mieczyslaw Moczar scatenò una dura campagna antisemita, culminata in una purga, che non consentì a Bauman di candidarsi a leader del Partito polacco dei Lavoratori Uniti e fece perdere al contempo la sua cattedra all’Università di Varsavia.
Durante un temporaneo soggiorno in Gran Bretagna, presso la “London School of Economics”, pubblicò uno studio sul socialismo inglese, sotto la supervisione di Robert McKenzie(1959). Questa fu la sua prima opera maggiore e venne tradotta in inglese nel 1972.
Bauman, colpito dall’epurazione, riparò in Israele e insegnò all’università di Tel Aviv; in seguito ottenne una cattedra all’università di Leeds.
La fuga in Israele non fu indolore per Bauman:ebbe difatti dei dissapori con il padre, del quale non comprendeva il fervente sionismo; a causa di questo progetto, il filosofo ebbe a scontrarsi con i suoi superiori del KBW.
Dal 1990 circa, il filosofo polacco esercitò una considerevole influenza sul movimento Anti-Globalizzazione.
Bauman è attualmente sposato con la scrittrice Janina Bauman e ha tre figli, di cui una è la pittrice Lydia Bauman.
Opere
1957: Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina [Questions of Democratic Centralism in Lenin’s Works]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1959: Socjalizm brytyjski: Źródła, filozofia, doktryna polityczna [British Socialism: Sources, Philosophy, Political Doctrine]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1960: Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego [Class, Movement, Elite: A Sociological Study on the History of the British Labour Movement]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1960: Z dziejów demokratycznego ideału [From the History of the Democratic Ideal]. Warszawa: Iskry.
1960: Kariera: cztery szkice socjologiczne [Career: Four Sociological Sketches]. Warszawa: Iskry.
1961: Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej [Questions of Modern American Sociology]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1962 (with Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz): Systemy partyjne współczesnego kapitalizmu [The Party Systems of Modern Capitalism]. Warsaw: Książka i Wiedza.
1962: Spoleczeństwo, w ktorym żyjemy [The Society We Live In]. Warsaw: Książka i Wiedza.
1962: Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia [Outline of Sociology. Questions and Concepts]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1964: Zarys marksistowskiej teorii spoleczeństwa [Outline of the Marxist Theory of Society]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1964: Socjologia na co dzień [Sociology for Everyday Life]. Warszawa: Iskry.
1965: Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii [Visions of a Human World: Studies on the social genesis and the function of sociology]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1966: Kultura i społeczeństwo. Preliminaria [Culture and Society, Preliminaries]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1972: Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study. Manchester: Manchester University Press ISBN 0-7190-0502-7 (Polish original 1960)
1973: Culture as Praxis. London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7619-5989-0
1976: Socialism: The Active Utopia. New York: Holmes and Meier Publishers. ISBN 0-8419-0240-2
1976: Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation. London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7100-8306-8
1978: Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Hutchinson. ISBN 0-09-132531-5
1982: Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class. London/Boston: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7100-9196-6
c1985 Stalin and the peasant revolution: a case study in the dialectics of master and slave. Leeds: University of Leeds Department of Sociology. ISBN 0-907427-18-9
1987: Legislators and interpreters – On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2104-7
1988: Freedom. Philadelphia: Open University Press. ISBN 0-335-15592-8
1989: Modernity and The Holocaust. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1989. ISBN 0-8014-2397-X
1990: Paradoxes of Assimilation. New Brunswick: Transaction Publishers.
1990: Thinking Sociologically. An introduction for Everyone. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell. ISBN 0-631-16361-1
1991: Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2603-0
1992: Intimations of Postmodernity. London, New York: Routhledge. ISBN 0-415-06750-2
1992: Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-1016-1
1993: Postmodern Ethics. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ISBN 0-631-18693-X
1995: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ISBN 0-631-19267-0
1996: Alone Again – Ethics After Certainty. London: Demos. ISBN 1-898309-40-X
1997: Postmodernity and its discontents. New York: New York University Press. ISBN 0-7456-1791-3
1998: Work, consumerism and the new poor. Philadelphia: Open University Press. ISBN 0-335-20155-5
1998: Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press. ISBN 0-7456-2012-4
1999: In Search of Politics. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2172-4
2000: Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press ISBN 0-7456-2409-X
(2000 [ed. by Peter Beilharz]: The Bauman Reader. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-21492-5)
2001: Community. Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2634-3
2001: The Individualized Society. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2506-1
2001 (with Keith Tester): Conversations with Zygmunt Bauman. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2664-5
2001 (with Tim May): Thinking Sociologically, 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-21929-3
2002: Society Under Siege. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2984-9
2003: Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-2489-8
2003: City of fears, city of hopes. London: Goldsmith’s College. ISBN 1-904158-37-4
2004: Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3164-9
2004: Europe: An Unfinished Adventure. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3403-6
2004: Identity: Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3308-0
2005: Liquid Life. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3514-8
2006: Liquid Fear. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3680-2 (due September 28, 2006)
2006: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press. ISBN 0-7456-3987-9 (due October 31, 2006)
Pensiero
Acuto e impegnato analista della società, al centro del suo lavoro vi è sempre la dimensione etica e la dignità della persona umana .
In particolar modo, egli concentra la sua riflessione sul tema della globalizzazione: scrive di un mondo divenuto oramai irrimediabilmente “liquido”…ma che significa questo?
Significa che, mentre nell’età moderna tutto era dato come una solida costruzione, ai nostri giorni, invece ogni aspetto della vita può venir rimodellato artificialmente.
Dunque nulla ha contorni nitidi, definiti e fissati una volta per tutte. Ciò non può che influire sulle relazioni umane, divenute ormai precarie in quanto non ci si vuole sentire ingabbiati; le influenze non mancano anche nel mondo politico:difatti ora non si cerca più di costruire il “mondo perfetto”, seguendo un rigido e predeterminato sistema politico, forte di una consolidata ideologia, come era nel passato…
A quanto sembra, Bauman condivide la tesi di Lyotard circa la caduta delle metanarrazioni, anzi la utilizza in certo qual modo come nucleo del suo sistema, in quanto è proprio a causa della scomparsa delle “grandi narrazioni metafisiche” che ora si ha la “liquidità” come essenza stessa dell’attuale. Tuttavia è importante rilevare che Bauman, a differenza di altri autori, rifiuta il termine “postmoderno” a favore di “modernità liquida”, proprio per indicare la labilità di qualsiasi costruzione in questa nostra epoca…
Infatti, alla prima fase della modernità, vale a dire quella solida”, apparteneva il tentativo di circoscrivere la posizione dell’individuo all’interno di leggi definenti la razionalità umana e inglobarle conseguentemente nel corpo dello Stato. Parallelamente, in questa fase, si assiste al tentativo di ripartire il Tutto entro un ordine misurabile…come dimenticare Galileo?
Attualmente, tuttavia, si assiste ad una progressiva crescita del processo di individualizzazione (punto cardine della fase “liquida”) che si pone in un rapporto dialettico con le strutture e la visione del mondo caratteristiche della fase “solida”…individualizzazione che si ricollega al processo di globalizzazione, di cui si parlerà tra poco.
Se, però, la modernità è “liquida”, esiste comunque, per il filosofo, qualcosa che rimane stabile, vale a dire il socialismo, che non sarebbe un modello alternativo di società, bensì “un coltello affilato premuto contro le eclatanti ingiustizie della società, una voce della coscienza finalizzata a indebolire la presunzione e l’autoadorazione dei dominanti”, come Bauman dirà in un’intervista di Serena Zoli per il Corriere della Sera del 13 ottobre 2002.
A proposito di “globalizzazione”, la tesi di Bauman ò che essa genera sostanzialmente delle differenze, esaspera quelle già esistenti col risultato di polarizzare ulteriormente la natura umana.
Il filosofo muove da un’indagine del legame tra la natura dello spazio-tempo e le organizzazioni sociali, per giungere all’analisi degli effetti che la compressione spazio-temporale produce sulla società contemporanea e sulle persone.
Non esiste più lo spazio, bensì il luogo, che è lo spazio capace di dare significato all’esperienza, definendo in particolare ambiti e dimensioni locali;quando lo spazio cessa di essere significante cessa conseguentemente di essere luogo, non definisce più, dunque, né ambiti né dimensioni locali, diventando mero spazio.
Come dice Bauman, la globalizzazione mina alla base la coesione sociale su scala locale, portando alla creazione di una “èlite della mobilità” in grado di annullare lo spazio, di dare significati allo spazio, e capaci soprattutto di rendere lo spazio significante per se stessi…quasi che parte dell’umanità potesse attraversare il mondo e l’altra parte se lo vedesse passare davanti.
La coesistenza di questi due mondi, di queste due modalità di essere (delineate da Bauman nelle figure del “turista” e del “vagabondo”) trasforma il territorio urbano in una sorta di campo di battaglia per lo spazio.
Questa situazione è definita da Bauman “guerre spaziali”, le quali rischiano di diventare foriere di pericolose conseguenze a causa della disintegrazione delle reti protettive.
In particolare, nell’opera “Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone” (2001), il filosofo sviluppa la dialettica “globale/locale” che si è venuta ormai a creare attualmente…i “globali” fissano le regole del gioco.
Nel processo in atto, infatti, se la finanza e l’informazione da un lato uniformano il globo, dall’altro lato promuovono la differenziazione delle condizioni di vita di intere popolazioni; la globalizzazione, dunque come un “Giano bifronte”, che nel, momento stesso in cui unisce, divide e localizza, annullando le possibilità di azione di ampi strati sociali. Nel saggio, inoltre, il pensatore polacco identifica nella mobilità come il valore più grande della post-modernità…mobilità che, come detto poc’anzi, diviene anche un fattore di prestigio sociale.
Riguardo alla sfera politica, è da rilevare il fatto che essa continua a muoversi entro gli schemi delineati nella prima fase della modernità, vale a dire entro idee di dominio e controllo dello spazio fisico, di uno spazio ben definito e delineato, mentre l’economia, la “new economy” è in grado di spostarsi con velocità nettamente superiori grazie all’ausilio delle reti telematiche…il suo terreno è il cyberspazio.
Qual è il risultato? Mentre nella prima modernità vi era un rapporto di dipendenza reciproca tra capitale e lavoro, oggi invece il capitale è sempre meno legato ad un territorio.
L’azienda della fase “liquido-moderna”, a differenza della fabbrica fordista, proprio a causa della natura del capitale nell’era attuale, perde qualsiasi interesse nella tutela dei dipendenti, non avendo bisogno di uno spazio fisico ma essendo anzi svincolata da esso in special modo per quanto riguarda gli investimenti: può investire difatti ove si presentino le condizioni migliori, anche se a farne le spese, è necessario e doveroso sottolinearlo, sono i lavoratori stessi!
Nell’attuale mondo “liquido” vi è un ingresso ma nessuna via d’uscita, nel senso che chi è escluso lo resterà per sempre, e sarà condannato a vivere una realtà dove sono sospesi lo stato di diritto e tutto il complesso delle procedure previste dal welfare state.
Ancora, ricollegandoci a quanto si diceva circa l’orientamento politico attuale, c’è da rilevare come logica conseguenza, che lo stato-nazione ha aumentato le sue risorse al fine di garantire la sicurezza dei pochi privilegiati ammessi alla tavola dello sviluppo economico.
In conseguenza di ciò, si rileva tutta una serie di interventi militari fatti dalle potenze egemoni( o sarebbe forse meglio dire LA potenza egemone..?) allo scopo di respingere “oltre frontiera” le migrazioni dalle aree povere verso quelle più ricche…gli stati-nazione privilegiati si danno attualmente molto da fare non solo nell’ambito della “produzione di rifiuti”, bensì anche per quel che concerne il loro “smaltimento”…quali rifiuti?
Quelli prodotti dalla globalizzazione! Difatti per Bauman la distinzione tra politica interna e politica internazionale è una mera convenzione volta a legittimare (o mascherare?) le scelte dei governi locali e delle organizzazioni internazionali per smaltire questi rifiuti…non è un caso, come osserva argutamente il filosofo, che gli interventi militari nei Paesi esteri hanno alquanto il carattere di azioni di polizia, cosa confermabile appieno anche nella più recente attualità, del resto.
E dunque, per Bauman, il quale fa riferimento alle riflessioni di Agamben, tutta la massa dei diseredati, dei rifugiati, degli immigrati, dei “rifiuti” forma uno stato d’eccezione che in certo qual modo riempie il vuoto creato dalla crisi della prima modernità così bene descritta da Foucault come “società disciplinare”, volta cioè al totale controllo delle masse.
Che fare dunque? Per il pensatore polacco, la soluzione al problema non può che essere un ripensamento della politica del welfare-state, orientata su scala globale…però è doveroso tener conto che, se si vuole intervenire in questo “stato d’eccezione” si deve dare la parola, prima di tutto, a coloro che sono stati etichettati come “scarti umani”, cosa quanto mai lesiva nei confronti della dignità umana che ricorda troppo da vicino quanto fatto dai nazisti con gli ebrei.
In particolar modo, le nuove funzioni riguardano la gestione dei “campi di permanenza temporanei” (luoghi pensati per far fronte all’emergenza immigrazione) ma anche l’amministrazione del mercato del lavoro in base al principio della flessibilità o, per meglio dire, della precarietà.
Unitamente a ciò, lo Stato si occupa di creare specifiche politiche di pervasivo controllo sociale.
Ad ogni modo, Bauman, nei suoi testi, non fornisce ricette: si limita soltanto ad analizzare la situazione lucidamente e criticamente, mosso principalmente dalla speranza di informare. Anzi, formula un suo vivo desiderio, ossia quello che si costruisca una “comunità” di individui mossi da un’etica comune e, soprattutto, responsabilizzata
Impresa tuttavia molto difficile, visto l’attuale stato di cose…
La società dell’incertezza di Z. Bauman
“Il disagio della postmodernità nasce da un genere di libertà nella ricerca del piacere che assegna uno spazio troppo limitato alla sicurezza individuale”….
Con queste parole esordisce, nell’introduzione al testo, Bauman con il palese intento di farci comprendere sin dall’inizio che il sentimento principale che affligge l’uomo postmoderno è un sentimento di DISAGIO, richiamando, seppur opportunamente adattata al contesto attuale, la dialettica “principio di piacere-principio di realtà” già enunciata da Freud nella sua opera “Il disagio della civiltà”.
Ma da cosa ha origine questo disagio?
Da diversi fattori, primo dei quali è dato dal problema dell’identità…nel postmoderno infatti, a differenza dell’epoca moderna, in cui la questione principale era quella di costruire un’identità e stabilizzarla, si rende necessario evitare qualsiasi tipo di fissazione:non a caso, la parola d’ordine postmoderna circa la questione dell’identità è “riciclare” .
Nello specifico, l’autore utilizza figure come quella del “pellegrino”, del “turista” e del”vagabondo” per aiutarci a comprendere la questione…
Quella del pellegrino, figura simbolo dell’età moderna, è il ritratto dell’uomo che sta costruendo la sua vita, il suo futuro, la sua identità….conscio e sicuro che domani ci sarà un futuro…un uomo che agisce per il domani, sicuro che ci sarà un domani….
Tuttavia ora non c’è più posto per il pellegrino:troppo flessibile è divenuta la realtà perché si possa costruire un qualcosa di stabile e duraturo nel tempo….ed ecco apparire altre figure rimpiazzo come quella del “flaneur” ma, soprattutto, quella del “vagabondo”.
Autentico flagello dell’età moderna, nel postmoderno la figura del “vagabondo” è rivalutata proprio grazie alla sua mancanza di radici e di stabilità, esattamente come si presenta il mondo in cui ora si trova a vivere.
Altra figura interessante è quella del”turista”: egli, a differenza del “vagabondo” ha una casa…ma si sposta temporaneamente alla continua e febbrile ricerca di sensazioni e piaceri però sempre “cosciente e sistematico”, come avverte Bauman.
Poi viene il “giocatore”:votato perennemente ed incessantemente al gioco, per lui il tempo altro non è se non una successione di partite…..
Altra questione importante è quella dello “straniero”:sottoposto a restrizioni nell’età moderna, nel postmoderno, lo “straniero” rimane tra noi come una presenza costante, condividendo l’incertezza di questa nostra era, e anzi è fatto oggetto di “eterofilia” da parte dei benestanti cercatori di sensazioni nuove.
Illuminante è quanto dice l’autore a proposito di emancipazione:”Tuttavia c’è una vera opportunità di emancipazione nella postmodernità: la possibilità di deporre le armi, di sospendere gli scontri di frontiera ingaggiati per tenere lontani gli stranieri, di mettere da parte i piccoli muri di Berlino eretti quotidianamente per mantenere le distanze e le separazioni”.
Due sono le strategie adottabili con lo “straniero”:
1) limitare il più possibile l’imprevedibilità dello “straniero”;
2) allontanare il più possibile i movimenti degli estranei.
In verità la questione è duplice e dialettica:se da un lato vi è comunque il desiderio, per mantenere se non altro una parvenza di tranquillità e sicurezza, di circoscrivere i movimenti e gli spazi dello “straniero”, dall’altro lato entra in gioco un certo “piacere per la promiscuità” (come spiega Bauman), derivato dal carattere misterioso e attraente che è proprio dello”straniero”, foriero di esperienze piacevoli.
Sappiamo bene (anche perché ognuno di noi lo avrà sperimentato) che l’incertezza genera altresì un senso di paura…
Da quali fattori è causata la paura postmoderna? Vediamoli assieme a Bauman….
Anzitutto, il progresso tecnologico ha attualmente “reso sempre più inutile il lavoro di massa in relazione al volume della produzione”, unitamente ad una progressiva deistituzionalizzazione dei processi produttivi, nel senso che lo Stato non fornisce più i servizi per vincere l’incertezza dell’uomo…Ora l’uomo postmoderno “diventa il sorvegliante e l’insegnante di se stesso” e, mentre nell’età moderna fungeva da approvigionatore di beni, ora la sua principale funzione è quella di cercatore di piaceri e sensazioni.
Una fonte di inquietudine postmoderna è proprio il corpo, coerentemente visto come recettore di sensazioni…e affinché possa assolvere al suo compiti principale, è necessario che sia in buona salute:ed ecco entrare nella vita dell’uomo postmoderno il concetto di “fitness”, legato ad una maniacale attenzione per le pratiche salutistiche, tra l’altro ottima fonte di guadagno per gli addetti al settore!
Altra interessante questione è quella relativa all’Altro…chi è l’Altro?
Essenzialmente, può essere una “possibilità di agire” per l’approvigionatore di beni dell’era moderna, mentre, per il cercatore di piaceri (possibilmente con il minor numero possibile di complicazioni) è una figura attraente in quanto promette potenzialmente di stimolare sensazioni…
Ma c’è dell’altro:questa febbrile e intensa cura per il proprio corpo si è, in certo qual modo, estesa, anzi ri-collettivizzata…condensandosi proprio nell’attività politica, la quale “oggi non è altro che una estensione della mania per il corpo”.
Nello specifico, come nell’età moderna, noi stiamo attualmente inseguendo il sogno della razionalità…tuttavia ora si parla più che altro di “microrazionalità” , le quali non ne vogliono sapere di unificarsi…anche questo genera un profondo senso di insicurezza e inadeguatezza.
In conclusione, vale la pena soffermarsi sull’avvertimento di Bauman:”La dissoluzione dell’ordine socio-politico che ha permesso alle bio-tecno-scienze di assumere la loro ben nota e sinistra tendenza genocida, ha cancellato alcuni pericoli dall’ordine del giorno, o almeno ha reso improbabile la loro replica nell’epoca della postmodernità. Ma i nuovi tempi e i nuovi assetti socio-politici, hanno procurato nuovi rischi -per ora solo intuiti e inesplorati…Il problema di come impedire loro di trasformarsi in realtà, configurerà probabilmente il contenuto dell’agenda politica del futuro. Altrimenti potrebbe non esserci più un futuro da forgiare:o, piuttosto, non ci saranno esseri umani in grado di forgiarlo”.
CARL GUSTAV HEMPEL

A cura di Sebastiano Pirotta
Vita.
Carl Gustav Hempel nasce l’otto gennaio del 1905 ad Oranienburg (Germania). Studia fisica, matematica e filosofia a Gottinga, Heidelberg e Vienna; nel 1934 ottiene il dottorato a Berlino con una tesi sui fondamenti logici della probabilità, sotto l’egida di H. Reichenbach.
Dopo i contatti avuti con il Circolo di Vienna e il Circolo di Berlino, nel 1937 è costretto ad emigrare in USA a causa del nazismo. In seguito ad un soggiorno in Belgio conosce tra gli altri O. Neurath e K. Popper. Dal 1938 si trasferisce nuovamente in USA per iniziare la carriera accademica; dopo il 1955 insegna a Pittsburgh e a Princeton, dove muore nel 1997.
Opere.
– La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica (1952).
– La logica dell’analisi funzionale(1959).
– Spiegazione scientifica e spiegazione storica (1962).
– Aspetti della spiegazione scientifica(1965).
– Filosofia delle scienze naturali(1966).
Pensiero.
Epistemologo ed importante esponente del neopositivismo, Hempel si è affermato sulla scena internazionale durante la seconda metà degli anni ’90, dopo essersi distinto grazie alla sua critica rivolta al criterio verificazionista, ma soprattutto per la scoperta del “paradosso dei corvi” e l’invenzione del noto “modello a leggi di copertura”.
Per quanto riguarda il cosiddetto “paradosso dei corvi”, Hempel intende mettere in luce i limiti del procedimento logico induttivo. Secondo il procedimento induttivo “l’acquisizione di un nuovo riscontro empirico di una teoria, aumenta la probabilità che questa teoria sia vera”.
Se poniamo come esempio la teoria: tutti i corvi sono neri e consideriamo un milione di corvi presenti in natura, appare evidente dopo ogni osservazione che ognuno di essi è nero. Il fatto di riscontrare una quantità sempre maggiore di corvi neri in natura dunque aumenta la probabilità che la nostra teoria sia vera.
Tuttavia se l’enunciato 1. tutti i corvi sono neri è vero, esso è logicamente equivalente all’enunciato 2. tutte le cose che non sono nere, non sono corvi.
Dato questo secondo enunciato (equivalente a 1.), secondo la teoria della confermabilità, l’osservazione di un oggetto non nero che non sia un corvo (per esempio una sedia marrone) conferma 2. ma anche 1.
Dunque, l’osservazione di una sedia marrone (ovvero un oggetto che non è nero e non è un corvo) conferma anche la teoria 1. tutti i corvi sono neri e ne aumenta la probabilità di essere vera.
Il modello a leggi di copertura.
Hempel ritiene che la scienza nasca dalla necessità di soddisfare il bisogno fondamentale dell’uomo di trovare la sua collocazione all’interno del mondo. Per poter comprendere la realtà circostante la storia dell’umanità ha partorito le spiegazioni scientifiche, le quali secondo l’opinione del filosofo hanno tutte la stessa forma, quella del “modello nomologico-deduttivo”(D-N).
Questo modello viene così denominato perché ha la forma di un argomento deduttivo in cui l’evento da spiegare, detto explanandum (E), viene dedotto dalle premesse (chiamate explanans). Le premesse sono composte dalle circostanze antecedenti (circostanze particolari che caratterizzano l’accadere degli eventi) e dalle leggi generali (universali o statistiche) sotto cui i fenomeni vengono sussunti. Il termine nomologico si riferisce alla presenza delle leggi. Per essere spiegate le leggi vengono fatte derivare a loro volta da altre leggi generali di portata più ampia.
Un esempio di spiegazione D-N potrebbe essere questo:
– la lancetta del barometro segna che la pressione atmosferica si è abbassata (circostanza antecedente C);
– ogni volta che la pressione atmosferica si abbassa si verifica un temporale (legge L);
dunque segue deduttivamente:
– si è verificato un temporale (explanandum E).
Il modello può rappresentare anche una spiegazione di tipo causale, ma non è necessario che tutte le spiegazioni siano di questo tipo. Inoltre Hempel sostiene la simmetria tra previsione e spiegazione, esse infatti vengono a coincidere nel modello D-N, la loro differenza è solo di carattere pragmatico.
Esiste anche un modello I-S (statistico-induttivo) formulato da Hempel, in esso le leggi non hanno validità universale, ma si limitano a conferire agli eventi un’alta probabilità induttiva.
GERSHOM SCHOLEM

Gershom Scholem, nacque a Berlino nel 1897 da una famiglia della borghesia ebraica originaria della Slesia, una di quelle famiglie, la maggioranza allora in Germania, che avevano scelto la strada della completa assimilazione nella società tedesca. Era il più piccolo di quattro fratelli, ognuno dei quali ha una scelta autonoma e indipendente rispetto alla propria condizione di ebreo: Gershom prese la via della ricerca delle proprie radici e del sionismo. “Nei primi anni del Novecento”, spiega lo stesso Scholem, “solo una minoranza della gioventù ebraica aderì a movimento sionista, la grande maggioranza era assimilazionista e scelse l’autoinganno — cioè: la totale germanizzazione degli ebrei. Un’altra esigua minoranza – che includeva mio fratello Werner – si unì al campo rivoluzionario.” (Consigli in Rassegna mensile d’Israel, 1982:193). Il fratello maggiore divenne un nazionalista di destra, un altro condusse la propria vita al di fuori di qualsiasi coinvolgimento politico, mentre il terzo, Werner, optò per la rivoluzione. La vita di Scholem è permeata da una continua ricerca di se stesso, della propria identità ebraica. Egli cominciò dal primo interesse per la storia che avvenne quando aveva tredici anni, in prossimità della maggiorità religiosa, quello fu il primo impulso all’ebraismo, paradossalmente non ricevuto dalla religione o dalla scuola ebraica. L’insegnante Moses Barol, bibliotecario nell’Istituto per la scienza dell’ebraismo, fu il primo a mostrargli i tre grossi tomi dell’edizione popolare della storia degli ebrei di Heinrich Graetz, incontestabilmente una delle principali opere della storiografia ebraica dalla cui lettura crebbe in lui il desiderio di imparare l’ebraico e, contemporaneamente alla lettura di testi ebraici antichi cominciò nel 1911 a leggere letteratura sionistica tra cui Teodor herzl, Max Nordau e Nathan Birnbaum. Fra il 1912 e il 1917, Scholem aderì al circolo “Jung Juda”, in cui confluivano, all’insegna della presa di coscienza sempre più approfondita del proprio ebraismo, sia i rampolli delle famiglie assimilate, sia i giovani originari dell’Europa orientale, discendenti di quei famosi Ost Juden che tanta importanza ebbero nella definizione dell’identità ebraica dell’epoca. Essi erano depositari di un ebraismo rimasto integro, in cui l’identità etnica e quella ebraica erano ancora fuse insieme, come era stato nell’Europa occidentale, sin dai tempi dell’illuminismo ebraico che aveva aperto la via all’assimilazione e al cambiamento dell’identità ebraica, che, da appartenenza a una nazione, con lingua, cultura e tradizioni proprie, era diventata semplice adesione a una confessione. Le sedute erano rivolte a parlare di libri di interesse ebraico, oppure alla lettura di poesie dei grandi narratori ebrei orientali, nell’originale jiddisch o in traduzione tedesca, e spesso si svolgevano in un caffè della stazione, dove Scholem incontrò per la prima volta il personaggio che divenne in seguito il suo migliore amico, Walter Benjamin. Egli fu uno dei fondamentali punti di riferimento nella vita di Scholem; i due si confrontavano in quel mondo in crisi, che gli ha sempre più uniti nella loro intesa spirituale che è rimasta scritta nella storia. Sholem è autore di una biografia di Benjamin, pubblicata nel 1975, Walter Benjamin, Storia di un’amicizia, che vuole essere l’intervento di un testimone fedele e riesce ad essere, anche nonostante le zone volutamente trascurate del Benjamin, che Scholem comprendeva di meno, un’opera di alto valore letterario. Scholem diventò allora, nonostante il contrasto con la famiglia, uno dei membri più attivi dei movimenti giovanili sionisti ma contemporaneamente scelse la via dell’approfondimento del proprio ebraismo: nel 1913 frequentò lezioni di Talmud, nonostante che prima della prima guerra mondiale la ricca comunità ebraica di Berlino si rifiutasse di permetterne l’insegnamento. L’emozione più grande nella vita di Scholem come ricorda lui stesso fu quando imparò a leggere la prima pagina del Talmud nell’originale e, più tardi, sentì la spiegazione dei primi versetti della Genesi data da Rashi, il più grande di tutti i talmudisti ebrei. Alla fine del 1913 egli si aggregò ad una nuova associazione giovanile, “Agudath Israel”; fondata nel 1911, essa era un’organizzazione dell’ortodossia in concorrenza con il sionismo, la quale tuttavia allora non aveva preso ancora la direzione rigorosamente clericale e antisionistica in cui si sarebbe avviata in seguito. La tesi del suo programma – “assolvere ai compiti di tutta la comunità ebraica nello spirito della Torah” – fu un’intimazione ortodossa del “Programma di Basilea” del sionismo formulato nel 1897, per la soluzione della questione ebraica – identificandola con la questione della creazione, in Palestina, di una dimora assicurata dal diritto pubblico. Comunque tale adesione era stimolante perché permetteva a Scholem di seguire un vivace programma di corsi intensivi di studio delle fonti ebraiche, periodo dopo il quale si dissociò. Non è un caso che la generazione postassimilatoria sionista, per rispondere alle annacquature dell’ebraismo tedesco assimilazionista, recuperi e metta in primo piano la Kabbalà e il chassidismo attraverso – tanto per citare due grossi nomi -Martin Buber che diffuse con la sua rivista Der Jude migliaia di sostenitori, e attraverso il filosofo Franz Rosenzweig che con la sua Stella della redenzione diede una singolare ed interessante visione della teologia ebraica e entusiasmò i giovani sionisti dell’epoca. In Scholem si alternavano all’adesione sionistica lo studio delle origini ebraiche, una complementarità tra i due interessi che risiedeva in un’unica passione, la ricerca della propria identità ebraica. Sion era il suo simbolo, che collegava la sua origine e il suo scopo utopico in un senso piuttosto religioso che geografico e Scholem non si orientò verso il sionismo perché la creazione di uno Stato israeliano, principale scopo del movimento sembrasse un fine urgente e del tutto evidente, per molte persone che aderivano al movimento non era determinante il suo aspetto puramente politico, con i relativi argomenti di diritto internazionale. Invece avevano una forte influenza tendenze volte alla riflessione degli ebrei su di sé, sulla loro storia e una possibile rinascita di natura spirituale e culturale, ma anche e soprattutto sociale. Se esisteva una qualche prospettiva di un rinnovamento essenziale in cui l’ebraismo realizzasse il suo intrinseco potenziale, ciò sarebbe potuto accadere solo là dove l’ebreo avesse incontrato se stesso, il suo popolo e le sue radici. Interveniva l’atteggiamento relativo alla tradizione religiosa con una funzione spiccatamente dialettica, perché il conflitto tra lo sforzo di assicurare la continuazione, la rinascita della forma tradizionale dell’ebraismo da un lato, e dall’altro la ribellione cosciente proprio a questa tradizione, ingenerava preliminarmente una dialettica centrale, ineludibile per il sionismo: “C’era qualcosa di atmosferico, che penetrava nell’ambiente; qualcosa di cosciente, in cui si intrecciavano dialetticamente il desiderio di rinunciare a se stessi e al tempo stesso quello della dignità umana e fedeltà a se stessi, c’era qualcosa di una rottura cosciente con la tradizione ebraica di cui erano ancora sparsi in giro, i pezzi più diversi e spesso singolari” (Scholem, 1988:25). In quel periodo Martin Buber con la sua storia della religione come esperienza Erlebnis e amplificazione dell’interiorità, con le sue disquisizioni sullo spirito dell’Oriente, il suo pensiero dialogico dell’Io-Tu, con il sionismo appassionato e romanticheggiante, affascinava l’intera gioventù sionista riscuotendo una vastissima eco da Berlino anche in Francia e in Italia. Buber avvicinò Scholem alla “casa del popolo ebraico” creata da giovani berlinesi che nutrivano un forte interesse ebraico e sociale; essi erano sionisti che – sotto l’influsso delle idee dei populisti russi convinti della necessità di “andare al popolo” – volevano intraprendere il loro lavoro, da cui si ripromettevano reciproco aiuto e alimento. Quell’adesione non durò a lungo, per Scholem, a causa di contrasti con il leader Siegfried Lehmann, che si compiaceva di interpretare le interpretazioni buberiane del chassidismo senza sapere nulla della storia dell’ebraismo. Buber in un primo momento impressionò profondamente Scholem, che in seguito ne rimase deluso in parecchie occasioni. I contrasti, infatti, con Martin Buber lo hanno visto contro per certi aspetti già nel 1915, quando uscì sulla “Judische Rundschau” un articolo intitolato Noi e la guerra, che sosteneva un perfetto “buberismo” e culminava con la frase: “Avvenne così che noi partissimo per la guerra, non già sebbene noi fossimo ebrei, ma perché eravamo sionisti” (Scholem, 1988:80). Scholem rispose protestando violentemente contro la rivista che esaltava la guerra, che i sionisti per lui non dovevano incitare. Nonostante le critiche, Sholem descrive Buber come il primo pensatore ebreo che abbia visto nel misticismo una forza basilare dell’ebraismo e una tendenza in esso al rinnovamento. Contemporaneamente allo studio della Torà viveva in Scholem un grande interesse per la matematica specialmente per la teoria dei numeri, l’algebra e la teoria delle funzioni e questo, come disse lui, creò un conflitto tra le sue due anime, quella matematica e quella ebraica. Ma la direzione della sua vita era già determinata inequivocabilmente, poiché “mi ero proposto di, legare la mia esistenza alla costruzione di una nuova esistenza ebraica nel paese d’Israele” (Scholem, 1988:66). Il sionismo si incarnava nel suo interesse per la Kabbalà, il misticismo ebraico, che aveva le radici nella sua anima, nel grande bisogno di comprendere il mistero della storia ebraica, attraverso la lettura di Graetz sulla “Storia degli ebrei”, la lotta del popolo ebraico rivolta a mantenere viva, pur tra le avversità, la purezza della fede monoteista e il suo slancio etico che l’autore presentò in termini vivi e drammatici. Riferendosi allo Zohar, il testo fondamentale della Kabbalà, Scholem spiega che Graetz lo considerò il “libro delle menzogne” e lo stesso, nei confronti dei cabalisti usò una serie di epiteti dispregiativi, in consonanza con il suo temperamento polemico, mentre proprio in quest’opera Scholem aveva trovato, sin dalle prime fasi del suo precoce interesse per le fonti ebraiche, qualcosa di nascosto che lo attirava. La Kabbalà rappresentava per Scholem l’elemento vivificante dell’ebraismo, il quid che gli aveva consentito di sopravvivere spiritualmente nonostante le condizioni artificiose della vita diasporica, dando una propria risposta ai problemi via via posti dalla storia, sulla scia delle istanze di adeguamento ai parametri tedeschi, che nella sostanza più intima rispondevano ad uno spirito protestante, che doveva “depurare” l’ebraismo da tutte le sue espressioni peculiari. Da qui prendeva origine l’idea del “monoteismo etico” (Scholem, 1998:12) come caratteristica essenziale per la definizione della religione ebraica, una volta che le aspirazioni alla dimensione nazionale si erano rilevate illusorie o piuttosto, come avrebbe notato Scholem, erano state censurate in nome dell’adeguamento al concetto germanico di nazionalità, secondo il quale era impossibile ammettere nello stato tedesco gli appartenenti a una nazione autonoma, come era stata quella ebraica prima dell’emancipazione. Il sionismo così diventò il principale ostacolo all’integrazione in seno al mondo tedesco e, come tale dovette essere combattuto tenacemente dalla borghesia ebraica. Da qui la polemica contro la Wissenschaft des Judentums, di cui Scholem faceva parte, che dal canto suo aveva contribuito in misura notevole sia al formarsi della nuova identità ebraico-tedesca, sia alla sua fossilizzazione anacronistica, che Scholem ha più volte messo in luce con accenti fortemente polemici. Riconsiderare le origini dell’ebraismo attraverso i documenti letterari e storici di tutta la diaspora adattandoli in una chiave moderna, ai problemi dell’assimilazione, come tentativo illusorio di adeguarsi ai parametri culturali, che comunque, non erano adatti a comprendere la specificità ebraica, era una vera e propria “miopia culturale” (Scholem, 1998:11). Scholem descriveva questo fenomeno brutale come “Autoinganno”; l’incapacità di giudicare tutto ciò che concernesse se stessi, che caratterizzava la maggior parte degli ebrei, fu uno degli aspetti più importanti e tristi dei rapporti fra i tedeschi e gli ebrei. Scholem viveva questo conflitto culturale emerso dalle due realtà, quella ebraica e quella tedesca spesso in contrasto, come un “dramma” (Turner, 1986:49). La sovrapposizione, l’inter-referenzialità tra le due culture generava un conflitto determinato dalla volontà di allontanare un mondo per recuperarne un altro. Scholem riuscì a superare la rottura emersa dal rifiuto di porre le proprie armi simboliche, in mani tedesche tra cui, sistemi rituali, sempre più invasive della vita ebraica, perché egli intravedeva proprio in questo “dramma” l’origine di una trasformazione generata dal potere della comunicazione mediante simboli recuperati attraverso lo studio della Kabbalà. Quello che i padri fondatori della Wissenschaft consideravano irrilevante, rispetto alla concezione dell’ebraismo che si proponevano di valorizzare, diventa centrale per Scholem: egli si poneva all’opera con maggiore consapevolezza della complessità implicita nel concetto di obiettività scientifica che non è possibile isolare artificiosamente dall’elemento ideologico, sotteso a ogni operazione culturale del tipo di quella messa in atto in qualsiasi rilettura dell’ebraismo. La conoscenza di una verità non era quella dei suoi predecessori che vedevano nell’ebraismo un avvicinamento a una “decorosa sepoltura”, come disse Getthold Weil ad una conferenza tenuta all’istituto Leo Baeck di Londra, Scholem, seppure fedele alla Wissenschaft ma per certi aspetti critico, era animato da uno spirito di ricerca che prendeva le mosse dal significato che assumeva per lui la dialettica, come dinamica vitale che si rileva all’occhio attento a cogliere il valore dei particolari, attraverso “la Kabbalà come corpus simbolicum che si traduce in forme temporali che celano attraverso apparenze nebulose e transeunti un nucleo di verità” (Consigli in Rassegna mensile d’Israel, 1982:2069). Egli aveva cominciato a scandagliare le fonti del patrimonio ebraico, giungendo alla mistica, l’esame spassionato delle fonti condotto con il massimo rigore filologico, l’ideale di ricerca che ha perseguito in tutta la sua lunga carriera da studioso, lo muoveva la convinzione che, riportare i fatti alla luce nella loro obbiettività fosse il primo passo per giungere alla verità. L’ansia che emerge dalla rottura del passato si fa continua con la prospettiva del futuro. Non a caso ricercare un significato profondo nelle parole della Torà, servendosi della numerologia, racchiude il simbolo espresso da un “ponte di passaggio” tra passato e futuro, per arrivare alla conoscenza e chiarezza di un futuro che diventa identità. Scholem, in un documento estremamente significativo del suo iter intellettuale in una lettera del 1937 a Zalman Schockenche, oltre a rilevare le vere intenzioni che lo avevano spinto allo studio della Kabbalà, fa intravedere anche la ragione profonda della sua adesione alla forma della Wissenschaft in nome di una sostanza del tutto diversa. Scrivendo infatti della Kabbalà come del quid in cui si era realizzata nell’ebraismo l’Aufhebung del mito e del panteismo (elementi misconosciuti dai razionalisti ebrei di tutti i tempi e dai contemporanei e in particolare, “in nome del monoteismo puro”), Scholem parla simbolicamente della “chiave” per entrare nella sfera della mistica. Questa chiave forse perduta o forse trascurata è, secondo Scholem, lo strumento per penetrare nella vita nascosta dei simboli, forzando la muraglia della storia che li circonda. “Il corpus delle cose – dice Scholem – non ha alcun bisogno di una chiave; bisogna solo penetrare (forare) il muro di nebbia della storia che lo circonda” (Scholem in Consigli, 1982:193). La storia è “nebbia” che verosimilmente si rivela nella sua essenza, ma è anche il rivestimento che necessariamente prende la sostanza per emergere dalla vita segreta al mondo fenomenico. La Kabbalà è il metodo basato sull’interpretazione perpetuamente orientata al rinnovamento di una parola divina in sé inafferrabile per l’uomo, è una sorta di noumeno, che pur essendo differente dal rivestimento fenomenico, non ne può prescindere e pertanto si rivela proprio attraverso il nascondimento e grazie ad esso. L’esplicita attività politica forte nella sua convinzione lo ha reso più sensibile di fronte all’obbiettivo della sua vita, quello finalmente di giungere in Israele, realizzato nel 1923, dove trovò a Gerusalemme un posto di lavoro come professore di matematica all’Istituto di formazione degli insegnanti. Diventò un forte sostenitore del movimento di sinistra dei pionieri halutzim e fece parte del Brit Shalom, l’organizzazione che si batté fin dagli anni venti per il dialogo tra arabi ed ebrei. All’inizio di quegli anni, Israele rappresentava un culmine del movimento sionistico, lì vivevano meno di centomila ebrei eppure c’era una grande spinta, uno slancio di questa gioventù che si era data alla causa del sionismo, possedendo una coscienza storica nella quale era concentrata la dialettica di continuità e di rivolta. Scholem spiega che nessuno avrebbe potuto rinnegare la storia del popolo d’Israele, ma la patria era una realtà concreta per fissare le proprie radici. Quelle di Scholem si basavano sulla realizzazione di un progetto per la fondazione dell’università per gli Studi ebraici che ebbe luogo alla fine del 1924, con a seguito l’apertura nel 1925 dell’università ebraica. Si cercavano scienziati che potessero adornare una facoltà intesa all’indagine di tutti gli aspetti dell’ebraismo e della sua storia: Scholem fu proprio uno di quelli ad essere scelti per insegnare la Kabbalà. Da qui escono i primi studi dell’autore: Bibliliographia Kabbalistica nel 1927 e Capitoli nella storia della letteratura cabbalistica nel 1930. Dopo la guerra appare nel 1949 Le grandi correnti della mistica ebraica nel 1957 Shabbetai Zevì, nel 1960 La Kabbalà e il suo simbolismo, Judaica nel 1963. Questi lavori consistono nell’aver attribuito un autonomo valore storico alla Kabbalà, liberandola dal pesante giudizio del positivismo ebraico ottocentesco, che la considerava come un’ingombrante faragine di stranezze e di aberrazioni. Vale la pena sottolineare come la mistica dia luogo ad una letteratura particolarmente restia a sottomettersi a periodizzazioni scientifiche. Ci troviamo di fronte a un genere letterario in cui l’autore preferisce spesso l’anonimia oppure ricorre alla pseudoepigrafia, attribuendo il proprio scritto a qualche personaggio dell’antichità. Oggi noi possiamo avvalerci della lucida ricostruzione logico-scientifica di Scholem, che costituisce una solida base per ogni ulteriore studio. Egli tuttavia dovette affrontare l’ostilità dei circoli tradizionali e dell’ortodossia rabbinica per riportare chiarezza scientifica nelle paternità e nelle datazioni, sconfessando numerose attribuzioni sancite da una consuetudine secolare e abbassando molte date. Scholem pone il suo approccio storiografico allo studio del misticismo ebraico in diretto contrasto con quello della scuola ottocentesca della Wissenschaft des Judentums (scienza del giudaismo). L’analisi del giudaismo da parte di questo movimento ha, agli occhi di Scholem, due gravi carenze: (1) studia il giudaismo come un oggetto morto posto su un vetrino di microscopio anziché come un organismo vivente e (2) non tiene in considerazione il “fondamento” stesso del giudaismo, le forze irrazionali che vivificano la religione. Per Scholem le componenti mitiche e mistiche sono altrettanto importanti che quelle razionali. Tuttavia egli non vuole seguire le orme di chi ha abbracciato la mistica ma non la storia degli Ebrei. In particolare è in disaccordo con Martin Buber a cui rimprovera la personalizzazione dei concetti cabalistici e l’ignoranza della storia, della lingua e della patria ancestrale del popolo ebraico. Nella Weltanschauung di Scholem l’indagine del misticismo ebraico non può prescindere dal contesto storico. Partendo da una sorta di Gegengeschichte nitzschiana egli arriva ad includere nella storia “pubblica” molti degli aspetti meno “normativi” del giudaismo. Quest’impeto di conferire legittimità all’irrazionale deriva, come quello della Wissenschaft, più o meno direttamente da Buber. Tuttavia le vedute “contro-storiche” (gegengeschichtlich) di Scholem comportano il concetto di tradizione come forte legame tra gli Ebrei di ieri e gli Ebrei di oggi (adesione al sionismo). Specificamente Scholem concepisce la storia ebraica come formata grosso modo da tre stadi:
1) Durante il periodo biblico il monoteismo lotta contro il mito senza riuscire a sopraffarlo completamente.
2) Nel periodo talmudico parte delle “istituzioni” – per es. nozione del potere magico dell’adempimento dei sacramenti – viene eliminata a favore di un concetto più puro della trascendenza divina.
3) Nel periodo medievale, posti di fronte all’impossibilità di conciliare il Dio astratto della filosofia greca col Dio personale della Bibbia, i pensatori ebrei come Mosè Maimonide, nel loro tentativo di eliminare i residui del mito, snaturano la figura del Dio vivente. È a partire da quest’epoca che si sviluppa il misticismo inteso come sforzo teso a ritrovare l’essenza del Dio dei padri.
La nozione dei tre stadi, con le sue interrelazioni tra irrazionale e razionale, porta Scholem a formulare tesi assai controverse. Secondo la sua opinione è dalla Qabbalah luriana medievale che si sviluppò il movimento messianico cinquecentesco del sabbatianesimo. Per neutralizzare il sabbatianesimo, come sintesi hegeliana, sarebbe sorto il Chassidismo. Molti che aderivano al Chassidismo perché vi vedevano una congregazione ortodossa accolsero come uno scandalo l’idea che la loro comunità avesse un rapporto così stretto con un movimento “ereticale”. Similmente Scholem ipotizzò come fonte della Qabbalah duecentesca un ipotetico gnosticismo ebraico anteriore a quello cristiano. L’approccio storiografico di Scholem implicava anche una teoria linguistica. Diversamente da Buber egli credeva nella capacità del linguaggio di evocare realtà sovrannaturali. E, in contrasto con Benjamin, poneva l’ebraico in posizione privilegiata in quanto unica lingua in grado di adombrare la verità divina. Scholem immaginava i cabalisti come interpreti di una rivelazione linguistica preesistente.
GIACOMO MARRAMAO

A cura di Fabio Funiciello
Biografia
Allievo di Eugenio Garin, Giacomo Marramao nel 1969 si laurea in Filosofia all’Università di Firenze. Dal 1971 al 1975 prosegue gli studi all’Università di Francoforte, lavorando soprattutto intorno ai diversi filoni del marxismo italiano ed europeo. Nel 1971 pubblica Marxismo e revisionismo in Italia, rintracciando in Gentile la chiave di volta filosofica del marxismo italiano. Dal 1976 al 1995 insegna “Filosofia della politica” e “Storia delle dottrine politiche” presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Nel 1979 esce il suo studio Il politico e le trasformazioni, mentre nel 1985 pubblica Potere e secolarizzazione. È stato uno dei principali riscopritori del pensiero di Carl Schmitt.
Muovendo dallo studio del marxismo italiano ed europeo (Marxismo e revisionismo in Italia, 1971; Austromarxismo e socialismo di sinistra fra le due guerre, 1977), ha analizzato le categorie politiche della modernità (Potere e secolarizzazione, 1983), proponendone, in dialogo con i francofortesi (Il politico e le trasformazioni, 1979) e con M. Weber (L’ordine disincantato, 1985), una ricostruzione simbolico-genealogica. Secondo questa lettura, che riprende le ipotesi storico-filosofiche di K. Löwith, nelle forme moderne di organizzazione sociale si depositano significati che derivano da un processo di secolarizzazione dei contenuti religiosi, ossia dalla riproposizione in dimensione mondana dell’orizzonte simbolico cristiano. In particolare, la secolarizzazione ha il suo centro in un processo di «temporalizzazione della storia», in virtù del quale le categorie del tempo (che traducono l’escatologia cristiana in una generica apertura al futuro: progresso, rivoluzione, liberazione, etc.) assumono centralità crescente nelle rappresentazioni politiche della modernità. Su queste considerazioni, riprese anche in Cielo e Terra (1994),
Dopo il Leviatano (1995), Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione (2003), si è innestata via via una tematizzazione esplicita del problema filosofico del tempo. A Confronto con le concezioni di bergson e heidegger, che delineano con sfumature diverse una forma pura della temporalità, più originaria rispetto alle sue rappresentazioni/spazializzazioni, Marramao argomenta l’inscindibilità del nesso tempo-spazio e, aprendo il dialogo alle teorie fisiche contemporanee, riconduce la struttura del tempo a un profilo aporetico e impuro, rispetto a cui la dimensione dello spazio costituisce il riferimento formale per pensarne i paradossi. (Minima temporalia, 1990 e Kairos. Apologia del tempo debito, 1992).Nel 2008 ha pubblicato una raccolta di saggi dal titolo La Passione del Presente, in cui, attraverso l’analisi di alcuni termini “cardine” della modernità mondo, cerca di comprendere quali sono i problemi filosofici fondamentali che la filosofia politica contemporanea si trova ad affrontare.
Attualmente insegna “Filosofia politica e Filosofia Teoretica ” presso il dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma Tre. È anche direttore scientifico della Fondazione Basso-Issoco e membro del College International de Philosophie di Parigi.
Per fare un piccolo quadro del pensiero di Giacomo Marramao ci concentreremo su alcuni aspetti cardine della sua riflessione che sono:
– Globalizzazione
– Secolarizzazione
– Temporalità
Globalizzazione:
Nel libro Passaggio a Occidente il nostro si confronta con alcune riflessioni fondamentali della riflessione contemporanea nell’ambito della ricerca sulla globalizzazione cercando di evitare la tesi dell’Occidentalizzazione del mondo e cercando di delineare una politica universalista della differenza.
Le teorie con cui si confronta sono quelle di F. Fukuyama che sulla scia di Kojeve prospetta la Fine della Storia sotto l’omologazione universale dell’individualismo competitivo, la tesi del Conflitto di Civiltà che dopo il crollo del muro di Berlino vede lo scenario mondiale attraversato da un conflitto interculturale mondiale e la tesi di S. Latouche sull’espansione planetaria del dominio della tecnica sotto il controllo della ragion strumentale.
Il Marramao vede nella Globalizzazione un presupposto tipico della modernità nel passaggio da un mondo chiuso ad un universo circumnavigabile che ci apre all’incontro\scontro con le altre culture che nella nostra società si trasforma nell’incontro quotidiano con l’ospite nelle grandi metropoli e che mette continuamente in discussione la nostra identità.
Con la crisi dello Stato Nazione “incarnata dal Gelido Mostro del Leviatano” e del progetto del Leviatano Democratizzato di Rawls si vuole ricostruire l’universalità sul criterio della differenza cercando di ricostruire una sfera globale in cui non si vuole vedere il mondo come mero appiattimento della società sulla razionalità tecnico-economica che influenza tutto il mondo creando un unico modello di società e di pensiero ma cercare di approfittare della ricchezza di queste differenze per costruire una Cosmopoli Globale dove si può coltivare un sano politeismo dei valori.
Secolarizzazione
In Potere e Secolarizzazione Marramao cerca di contrapporre alla proliferazione del Post-Moderno in Filosofia una analisi della Secolarizzazione come Grande Racconto che ha origini nel
Profetiamo Ebraico e nelle Parole della Salvezza Cristiana.
La Temporalità Ebraico cristiana si caratterizza per essere 1)cumulativa 2)irreversibile 3)orientata al futuro e spezzando la concezione greca del tempo concepita come circolo è la prima forma di disincanto del mondo.
Per il nostro l’epoca contemporanea è caratterizzata dal passaggio dal Futuro come Promessa Dinamica a Minaccia in un epoca in cui dominano le “passioni tristi” e l’essere umano riesce a trovare con difficoltà un senso alla propria esistenza.
La discussione sulla Secolarizzazione comincia con il confronto con l’opera di Karl Lowith Significato e Fine della Storia in cui uno dei “figli di Heidegger” analizza i presupposti teologici della Filosofia della Storia cercando di mostrare come le Filosofie della Storia elaborate fino ad Hegel e Comte possiedono una matrice prettamente teologica che si fonda sulla visione biblica della Storia.
Interessante è il metodo utilizzato nel testo che ispirandosi al lessico della politica redatto da Koselleck parte da alcune parole chiave della modernità cercando farne la genealogia circoscrivendo i nuclei simbolici, le componenti semantiche e disponendo il testo a raggiera cercando di analizzare il problema da diversi punti di vista.
Temporalità
Nelle riflessioni sulla temporalità il nostro cerca di fare una ricostruzione genealogica delle concezioni della temporalità nate all’interno della riflessione occidentale partendo dall’analisi del Timeo di Platone e arrivando fino alle recenti discussioni sulla Freccia del Tempo in fisica e nella sua recente riflessione apre all’indagine temporalità\identità cercando di cercare una sintesi tra le posizioni analitiche e continentali.
Le posizioni che vengono fuori sono molto interessanti e varie u cui ci soffermeremo su un punto:
La critica alla società contemporanea in cui il presente viene dominato dalla fretta e in cui non si ha più tempo per fermarsi a vivere il presente.
Dopo una suggestiva ricostruzione dell’etimologia del latino tempus vengono prese in esame il “senso interno del tempo” ,la sindrome temporale della fretta e una via per riuscire a riappropriarsi della propria esistenza.
Il tempo kairologico è una intersezione tra le realtà divergenti del tempo privato e del tempo pubblico, il tempo privato varia da essere umano a seconda di numerose variabili che lo condizionano tra cui segnaliamo il mondo-ambiente in cui si trova a vivere e la situazione psicofisica fondamentale per il variare della temporalità che varia da individuo a individuo.
L’origine della sindrome della fretta viene fatta risalire al progetto moderno che cercando di razionalizzare il progetto escatologico ebraico-cristiano finisce per finire nel dominio della ragion strumentale che tende ad omogeneizzare il tutto senza cercare più uno scopo per il futuro cosi
alcuni essere umani rispondono alla sindrome della fretta o eternizzando il presente ripetendo sempre la stessa scena nevrotica per non essere riusciti ad elaborare il lutto altri pensando di arrivare sempre troppo tardi con l’incontro con l’attimo propizio pensando sempre di aver mancato la giusta occasione .
Con l’entrata in crisi del Progetto Moderno si può cercare la via d’uscita cercando di superare la visione cara a M. Weber per cui la razionalità strumentale è un tipico fenomeno dell’occidente e che non può sorgere in altre culture comprendendo ad esempio la Cina e il suo modo in cui si avvicina al capitalismo e aprendoci all’incontro con altre culture cosa da cui ormai non si può più sfuggire nella società contemporanea e imparando a vivere nel presente cercando di evitare di appiattire il Presente sul Futuro rinunciando a vivere in attesa di qualcosa che dovrebbe accadere.
LUCE IRIGARAY
Il pensiero della differenza: Luce Irigaray
Luce Irigaray (Belgio, 1930) è una filosofa e psicoanalista francese. Ha fatto parte dell’École Freudienne de Paris aperta da Jacques Lacan. Vicina al movimento delle donne, anche se non direttamente coinvolta in esso, Irigaray si sofferma sul legame senza parole delle donne tra loro e con la madre. Da simili riflessioni nasce la sua tesi di dottorato, Speculum. L’altra donna, del 1974, che costituisce una vera e propria critica radicale della concezione psicoanalitica della donna. Questa pubblicazione le costò l’espulsione dall’associazione psicoanalitica di Lacan. Le sue opere principali sono le seguenti: Sessi e genealogie (La Tartaruga, 1989), Io tu noi. Per una cultura della differenza (Bollati Boringhieri 1992), Essere due (Bollati Boringhieri, 1994), La democrazia comincia a due (Bollati Boringhieri, 1994), L’oblio dell’aria (Bollati Boringhieri, 1996), Tra Oriente e Occidente. Dalla singolarità alla comunità (Manifestolibri, 1997), Il respiro delle donne (Il Saggiatore, 1997), Amante marina di Friedrich Nietzsche (Luca Sossella Editore, 2003), In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiavi per una convivenza universale (Baldini Castoldi Dalai, 2006), La via dell’amore (Bollati Boringhieri 2008). La Irigaray sottolinea, innanzitutto, come il pensiero occidentale si sia cristallizzato sul modello platonico di un soggetto unico (Dio, l’Assoluto, l’Io), le cui immagini depotenziate sono invece i singoli soggetti concreti. In questo modo, l’Occidente riposa per Irigaray su una totale dimenticanza della donna. L’attenzione del pensiero contemporaneo per l’individualità concreta e la molteplicità (il riferimento è ad alcune tendenze dell’esistenzialismo francese) non hanno però intaccato il modello di riferimento della nostra cultura, che resta il maschio adulto. L’esempio che Irigaray porta a favore di questa affermazione è la teoria psicanalitica di Freud, dove la sessualità femminile è interpretata come una mancanza, quasi una nostalgia, di quella maschile (la donna scopre la sua sessualità accorgendosi della mancanza del pene e successivamente impiegherà la sua energia per ottenere il sesso maschile). Lo stesso titolo dell’opera della Irigaray – Speculum – è, da questo punto di vista, illuminante: la donna sarebbe soltanto una immagine riflessa del vero modello di riferimento, l’Uomo. Protagonista del libro della Irigaray è la differenza sessuale, contornata di peripezie filosofiche e psicanalitiche che dimostrano l’abilità conoscitiva dell’autrice. La differenza sessuale di cui parla Irigaray ha bisogno di un linguaggio che la determini, attraverso il quale se ne possa parlare, discutere e anche distruggre se è il caso. Per porre l’attenzione dei lettori su questo argomento, la filosofa parte da un’analisi della produzione freudiana sulla femminilità, come luogo privilegiato del discorso in cui cominciano a delinearsi valori e significati dedicati al mondo femminile, ma tutti determinati da soggetti maschili. Un sogno, quello cui si riferisce l’autrice, che permette di considerare il mondo femminile come copia di quello maschile. Niente di più sbagliato per la Irigaray. La filosofa esplora, in maniera dissacrante, le parti della psicanalisi che hanno coperto le figure femminili, fin quasi ad annullarle con quelle maschili. Un modo per cominciare è quello di rivedere il rapporto tra madre e figlia: dal complesso di Edipo fino al suo superamento perchè la bambina si affermi e acquisisca personalità. Nella seconda parte del libro non mancano i riferimenti ai grandi filosofi di tutti i tempi. Da Platone ad Aristotele, da Cartesio a Hegel, Luce Irigaray ci porta dall’analisi del rapporto materno-femminile alla questione dell’inconscio del pensiero occidentale. Tra sè e l’altro, il maschio pone uno specchio e il discorso filosofico che ha stabilito l’altro a partire da sé e ha dimenticato di fare i conti con la metria opaca, lo specchio, che separa le due posizioni. Questa logica maschilista si fa più acuta nelle donne. Da queste considerazioni prende piega una presa di posizione netta e chiara. Le donne per Luce Irugaray devono ritrovare se stesse e la loro dimensione, un processo che inizia con Speculum e che continuerà poi in tutte le opere successive. Corrosive e forti, queste le caratteristiche dei libri di Irigaray che le apriranno la strada verso la rottura con Lacan, il quale aveva sostenuto che i soggetti maschili e femminili acquisissero qualità dall’ingresso nella società. Uscendo dall’infanzia e superando il complesso di Edipo, proprio come aveva detto Freud. Un’altra critica è quella che la Irigaray muove a Simone De Beauvoir, compagna di Sartre ed esponente del cosiddetto “femminismo dell’uguaglianza”; qui la filosofa belga sottolinea l’errore (che però conferma anche la sua teoria sul maschilismo della cultura) di chi, come donna, volesse ottenere parità di condizioni e diritti cercando una uguaglianza con il modello maschile di riferimento della cultura occidentale. In questo modo, infatti, si finisce implicitamente per ammettere la validità del modello, che non viene contestato, ma che anzi si cerca di imitare e di raggiungere. Ma la critica a Simone De Beauvoir è solo uno spunto per affermare la intrinseca diversità della natura femminile: la differenza sessuale. Irigaray afferma a più riprese che ciò di cui bisogna prendere atto è il limite interno alla natura stessa dettato dal genere a cui apparteniamo. Vi è una forma di negativo (hegelianamente) non solo fra l’essere umano e la natura, ma nella natura stessa, che è Due: uomo e donna.
GIORGIO COLLI

Giorgio Colli nacque a Torino il 16 gennaio 1917. Ancora giovanissimo si diede alla scoperta dei filosofi, maturando sin dall’inizio la convinzione secondo cui per comprendere la filosofia occorre leggere direttamente i testi nella loro lingua originale. Al Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” ebbe come docenti Cesare Pavese e Leone Ginzburg. Prima del diploma aveva già letto tutti i Dialoghi di Platone. All’Università scelse di intraprendere gli studi giuridici e s’iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza. Ma tra una lezione e l’altra non trascurò affatto il suo interesse per la filosofia e, non a caso, scelse di chiudere la sua formazione universitaria con una tesi di laurea in Filosofia del Diritto dal titolo Politicità ellenica e Platone. D’accordo col relatore, il professor Gioele Solari, dedicò la prima parte della tesi al tema dell’interiorità dionisiaca e l’espressione apollinea in Grecia, mentre la seconda parte alla formazione giovanile di Platone. Laureatosi nel luglio del 1939, Colli ottenne un primo riconoscimento in questo stesso anno con la pubblicazione sulla Nuova Rivista Storica della seconda sezione della tesi che, sotto forma di articolo, fu intitolata Lo sviluppo del pensiero politico di Platone. Nel 1942 Colli vinse il concorso per l’insegnamento di storia e filosofia nei licei e si trasferì a Lucca. Qui iniziò a tradurre per l’editore Einaudi l’opera di K. Hildebrandt Platone, apparsa poi nel 1947. Oppositore convinto del fascismo, due anni più tardi dovette espatriare in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni del regime. Alla fine della guerra, prese contatti con Cesare Pavese, allora responsabile della casa editrice Einaudi, cui propose la realizzazione dell’edizioni in italiano delle opere complete di Nietzsche e Schopenhauer. Pavese, temendo probabilmente le forte strumentalizzazioni operate dal nazismo nei confronti di Nietzsche, ritenne opportuno favorire per il momento soltanto la pubblicazione dell’opera schopenhaueriana Parerga e Paralipomena. Rientrato a Lucca, Colli studiò e approfondì i temi della sua tesi di laurea stendendo così il suo primo libro, che prese il titolo eracliteo Physis kryptesthai pilei. Studi sulla filosofia greca e fu pubblicato dalla Tipografia del “Corriere della Sera” nel 1948. Dopo l’apparizione di questa prima opera occorrerà attendere un ventennio per l’uscita del secondo libro di Colli. A questo proposito, Mazzino Montanari, narrando come l’amico e maestro spese lunghi anni della sua esistenza a tradurre e a far circolare in Italia opere filosofiche scomode e “irritanti” per “la intellettualità accademico-politico dominante”, ricorda che “non la scrittura” ma “nell’azione” fu il fine della vita per Colli. “E l’azione cui egli si aspirava non era l’azione politica, neppure nel senso più alto che questo termine potrebbe avere, bensì era la formazione di una comunità di eletti e di eguali, uniti sotto il segno della cultura. Cultura intesa come vita filosofica secondo un modello antico, classico, greco”. Sotto il segno dell’azione va dunque ricondotto il grande sforzo di curatore e traduttore che Colli intraprese sin dall’inizio degli anni Quaranta. Ottenuta la libera docenza nel 1949, egli lasciò il liceo per iniziare come professore incaricato a tenere le sue lezioni presso la cattedra di Storia della Filosofia Antica dell’Università di Pisa. Le lezioni degli anni accademici 1948-49 e 1949-50 confluirono in due dispense curate dallo stesso Colli ed edite rispettivamente col titolo Il «Parmenide» platonico e Empedocle dalla Libreria Goliardica di Pisa. Contemporaneamente, Colli tradusse per Einuaudi le opere Da Hegel a Nietzsche di Karl Löwith (1949), Storia della filosofia moderna II di E. Cassirer (1953), l’Organon di Aristotele (1955), e la Critica della Ragion pura di Kant (1957). A quest’ultima doveva far seguito, stando ad un progetto di collana dei classici della filosofia concordato in un primo momento con l’editore torinese, la traduzione e l’edizione delle opere di Platone, del giovane Aristotele, di Spinoza, Melebranche, Schopenhauer e Nietzsche. Ma il progetto fu abbandonato a causa di alcuni dissidi sorti nel frattempo con Einaudi. Dopo un breve periodo dedicato a studi rigorosamente logici e razionali in vista di un’opera teoretica che per il momento non realizzò, Colli concordò con l’editore Boringhieri l’uscita di un’Enciclopedia degli autori classici. Iniziò così nel 1957 la raccolta di buone traduzioni di classici della filosofia, ma anche della storia, della scienza, della letteratura e della religione (comprese tutte le Upanishad antiche, i testi del canone buddistico e i classici della religiosità ebraica e araba). Più di cento volumi furono pubblicati tra il 1958 e il 1964. Intanto, fin dal 1959, Colli andava programmando nuovamente la traduzione italiana delle opere complete di Nietzsche. Ma la mancanza di un testo attendibile delle carte postume, l’insostenibilità filologica della Volontà di potenza, nonché le polemiche suscitate in Germania dal tentativo di Schlechta di riordinare tali frammenti, spinse Colli a cambiare radicalmente i suoi piani. Dopo una prima analisi dei manoscritti nietzschiani conservati nell’archivio Goethe-Schiller a Weimar, egli decise di coinvolgere il suo brillante allievo Mazzino Montanari nel progetto dell’edizione completa delle Opere di Nietzsche. Per farla in modo rigorosamente attendibile, occorreva ricostruire i testi sulla base dei manoscritti, ossia redigere un’edizione critica tedesca. Era un lavoro già di per sé vasto e difficile. A ciò si aggiunse il rifiuto degli editori tedeschi poco interessati all’impresa. Tra il 1961-62, dopo il rifiuto di Einaudi, Colli trovò l’appoggio di Luciano Foà che, per conto della neonata casa editrice Adelphi, decise di finanziare l’impresa insieme all’editore parigino Gallimard. Solo più tardi, dopo l’apparizione dei primi volumi in italiano e in francese, l’editore De Gruyter di Berlino si fece avanti per partecipare al progetto di Colli. Successivamente, si aggiungerà anche l’editore giapponese Hakusuisha. Raccolta una équipe di germanisti, Colli e Montanari lavorarono ininterrottamente sui manoscritti nietzschiani dal 1963 al 1970. Nel 1969 Colli pubblicò anche La filosofia dell’espressione, apprezzata giustamente come la sua principale opera teoretica. In rottura con le principali correnti filosofiche contemporanee, le pagine di Colli invitano il lettore a ripensare radicalmente alcuni temi essenziali della metafisica. Il termine guida espressione è inteso come “sostanza del mondo” che rimanda un’alterità giammai riconducibile alla sfera del nominabile. Ritenendo poi ormai conclusa per l’essenziale il lavoro su Nietzsche, Colli iniziò a coltivare l’idea di un’enciclopedia dell’antichità in cui raccogliere i testi della cultura greca apparsi prima di Socrate. Il 1974 venne pubblicata dall’Adelphi l’opera Dopo Nietzsche, nella quale Colli riprese molti interrogativi posti e risolti soltanto in maniera enigmatica dall’autore di Zarathustra. A distanza di un anno seguì La Nascita della Filosofia, saggio dedicato all’origine misteriosa della filosofia greca. Negli ultimi anni della sua vita Colli iniziò a scrivere la grandiosa opera de La sapienza greca, undici volumi in cui “restaurare” l’autenticità del pensiero antico, ovvero far rivivere quel periodo “sapenziale” che va dai miti di Orfeo ai primi filosofi. I primi due volumi di questa collana furono editi sempre da Adelphi tra il 1977 e il 1978. La morte sorprese Colli proprio mentre ultimava il terzo volume, quello su Eraclito, (apparso postumo nel 1980) il 6 gennaio 1979. Anna Maria Colli racconta a riguardo che la morte per Giorgio “arrivò fulminea e per un disegno del destino fermò la sua mano su un frammento” eracliteo, che può essere assunto quale “testimonianza del suo modo di essere: chi non spera l’insperabile non lo scoprirà, poiché è chiuso alla ricerca, e a esso non porta nessuna strada. Studioso appartato, lontano dalle correnti “in voga”, fedele a Nietzssche e Schopenhauer, scorse nell’antica sapienza presocratica l’autentico “logos” a cui ritornare. Il suo maggior contributo teoretico è in Filosofia dell’espressione (1969). Colli, oltre che filosofo, fu anche apprezzato traduttore dell’Organon di Aristotele e della Critica della ragion pura di Immanuel Kant, nonché docente di Storia della filosofia antica all’Università di Pisa e direttore di collana per diverse case editrici (Einaudi, Boringhieri, Adelphi). Come storico della filosofia, è stato particolarmente importante il suo contributo storico, filologico e critico esercitato su autori come Aristotele, Kant, Schopenhauer, Nietzsche. A tale proposito vanno ricordati i tre volumi sulla Sapienza greca, opera rimasta incompiuta a causa della sua morte e in cui sono raccolti i frammenti dei presocratici, e la prima e fondamentale edizione critica delle opere e degli epistolari di Nietzsche, condotta insieme al suo principale allievo Mazzino Montinari (tra i suoi allievi ricordiamo anche Sossio Giametta e Giuliano Campioni). Questa ultima operazione rappresenta senza dubbio uno dei più grandi meriti della coppia Colli-Montinari. In particolare la pubblicazione in edizione critica della Volontà di potenza evidenziò come la versione pubblicata nel 1901 da Elisabeth Förster Nietzsche (sorella del celebre filosofo tedesco) presentava numerose e discutibili manipolazioni in chiave razzista e xenofoba totalmente assenti nell’originale e introdotte volutamente dalla Förster. L’edizione critica delle opere nietzschiane diede avvio ad una profonda revisione degli studi su questo filosofo e in particolare mise in discussione molte interpretazioni che, proprio partendo dalla lettura “falsata” della Volontà di Potenza del 1901, sostenevano la vicinanza di questo autore a quelle correnti di “destra” che sarebbero poi sfociate successivamente nella tragica esperienza del nazismo. Tuttavia questo progetto editoriale fu connotato da molteplici difficoltà. In primo luogo Colli, non avendo alcun contatto con gli ambienti politici, difficilmente sarebbe riuscito ad accedere all’archivio Nietzsche di Weimar, dove erano conservati la gran parte dei manoscritti originali del filosofo tedesco. Negli anni sessanta infatti, quando il progetto fu concepito, Weimar apparteneva alla Repubblica Democratica Tedesca la quale attraverso numerosi “escamotage” burocratici di fatto impediva agli studiosi occidentali di accedere in qualsiasi modo alle Istituzione della DDR. Questo problema fu risolto dal fatto che Montinari, a differenza del suo maestro, era iscritto al PCI e anzi proprio attraverso di esso riuscì ad ottenere dai responsabili culturali del partito comunista della Germania orientale i permessi necessari per studiare nell’archivio Nietzsche. Un’ulteriore difficoltà fu determinata dal fatto che la casa editrice Einaudi, con la quale Colli e Montanari iniziarono a definire la pubblicazione delle opere nietzschiane decise all’improvviso, probabilmente per ragioni politiche, di non stampare le opere del “nazista” Nietzsche che invece furono accolte dalla casa editrice Adelphi, fondata da un ex einaudiano come Luciano Foà alla fine degli anni Cinquanta.
MAZZINO MONTINARI

Mazzino Montanari è lo storico della filosofia a cui dobbiamo, insieme a Giorgio Colli, la cura dell’ormai leggendaria edizione italiana delle opere di Friedrich Nietzsche. Nasce il 4 aprile 1928 a Lucca. E proprio al Liceo classico ‘Machiavelli’ della sua città avrà, dal 1942 al 1945, come insegnante di Filosofia Giorgio Colli, che naturalmente da grande studioso quale è stato, esercita un’influenza decisiva sulla sua formazione. Di Colli, Montanari sarà – insieme a Sossio Giametta – il principale allievo. Al suo professore Montinari deve il gusto della lettura diretta dei classici, la libera discussione in una comunità di amici, il primo incontro con un Nietzsche molto diverso da quello della propaganda fascista e il primo impegno politico (nel 1944 è lui a favorire la fuga di Colli in Valtellina). Vinto il concorso nazionale, Montinari entra alla Scuola Normale Superiore dove, dopo un anno dedicato alla filosofia, passa allo studio della storia. Sotto la guida di Delio Cantimori nel 1949 si laurea in Filosofia della Storia con una tesi sui movimenti ereticali a Lucca. Dopo aver usufruito, dal febbraio al marzo 1950, di una borsa di studio della Scuola Normale Superiore a Francoforte sul Meno, esercita dal novembre del 1950 fino alla fine del 1957 un’attività di carattere politico-culturale: a Roma presso le edizioni Rinascita (per un anno è direttore della libreria Rinascita), a Berlino Est dal maggio 1953 al maggio 1954, quindi di nuovo a Roma. Il suo lavoro si svolge nell’ambito della cultura tedesca: classici del marxismo, storia del movimento operaio. Di questa fase ricordiamo la traduzione della “Storia della socialdemocrazia tedesca” di Franz Mehring (Editori Riuniti, 1961). Dal giorno 1 gennaio 1958 si trasferisce a Firenze e collabora con l’ormai inseparabile Colli all'”Enciclopedia di autori classici” Boringhieri. Mazzino Montanari ha lavorato molto anche in proprio. Tra le sue traduzioni, oltre a quelle dell’immancabile Nietzsche (fra cui “Schopenhauer come educatore”, significativo esordio della collana del 1958), ricordiamo la “Teoria della natura” di Goethe (1958), lo “Sullo studio della storia” Burckhardt (1958) e il fondamentale “Parerga e paralipomeni” di Schopenhauer (1963). In questo enorme sforzo culturale va inserita di principio anche la traduzione dei vari carteggi di Nietzsche, corredati da un ricco e serio apparato di note, che costituiscono per la cultura italiana una novità assoluta nella trattazione di questo autore. Coinvolto dunque da Colli nel progetto dell’edizione critica delle opere di Nietzsche, Montinari decide di stabilirsi a Weimar, dove vive dal 1963 al 1970 per accedere all’Archivio Goethe-Schiller. In questo periodo sposa Sigrid Oloff, cittadina della Repubblica Democratica Tedesca. Dall’anno accademico 1971/72 insegna Lingua e Letteratura tedesca prima presso la Facoltà di Lettere e Filosofiadell’Università di Urbino, poi presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze, infine dal novembre 1984 – dopo essere stato a Berlino Gastprofessor alla Freie Universität (1980/81) e fellow del Wissenschaftkolleg – Institute for Advanced Study (1981/82) – presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. Numerosi sono i riconoscimenti internazionali degli ultimi anni per la sua attività di editore e di germanista (tra questi, il prestigioso Gundolf-Preis). Nel 1967 appare un profilo di Nietzsche in cui Montinari abbozza una sua prima interpretazione complessiva: l’impostazione storica e la sicurezza e l’ampiezza delle fonti avevano segnato una radicale novità di approccio. Nel 1975 pubblica “Nietzsche” (Ubaldini; nuova edizione “Che cosa ha detto Nietzsche”, Adelphi, 1999). Dal 1968 all’anno della sua morte pubblica numerosi articoli e saggi su riviste specializzate italiane, tedesche, inglesi, su Nietzsche, sui problemi e metodi dell’edizione, su Heine, Goethe, Mann,Wagner, Lou Salomé, Lukàcs, Bäumler, Cantimori. Dopo la morte di Colli, diverse sono le introduzioni ai singoli volumi delle Opere di Nietzsche e agli scritti di Nietzsche apparsi nella collana “Piccola Biblioteca Adelphi” (per la quale aveva curato nel 1977 “La mia vita”, raccolta di scritti biografici giovanili di Nietzsche tradotta da M. Carpitella). Sue inoltre sono le introduzioni a Robert Musil “Sulle teorie di Mach” (Adelphi, 1973; di cui ha curato anche la traduzione); a R. Kunze, “Sentieri sensibili” (Einaudi, 1982); al carteggio Sigmund Freud-Lou Andreas Salomé, “Eros e conoscenza” (Boringhieri, 1983). Nell’ultimo periodo si dedicò in particolare all’analisi del rapporto fra Nietzsche e la cultura francese a lui contemporanea; ne sono testimonianza il saggio “Nietzsche e la ‘décadence'” (in “D’Annunzio e la cultura germanica”, Pescara, 1984). E’ stato con-direttore fin dall’anno della fondazione (1972) dell’annuario internazionale Nietzsche-Studien e della serie Monographien und Texte für die Nietzsche-Forschung (de Gruyter). Infine ha coordinato dal 1983 la ricerca nazionale, da lui promossa, “La biblioteca e le letture di Nietzsche”. La sera del giorno lunedì 24 novembre 1986 si è spento nella sua abitazione di Settignano, Firenze.
ANDREA EMO

A cura di Raffaele Iannuzzi
Andrea Emo fu un filosofo che scelse la via della “clausura” e dell’auto-esclusione dal mondo civile, un pensatore di grande profondità ed acume, oggi riscoperto e valorizzato, anche per la sua fibra “teologica”. Nato il 14 ottobre 1901 a Battaglia Terme in provincia di Padova, Andrea Emo fu il primogenito di un’antica e nobile famiglia di origine veneziano-patavina da parte di padre, e calabro-napoletana per parte materna. Nel 1938, Andrea sposò Giuseppina Pignatelli dei principi di Monteroduni, da cui ebbe due figlie, Marina ed Emilia. Allievo di Gentile, riuscì a costruire una sua figura di pensiero addensando appunti e note filosofiche e teologiche su centinaia di quaderni, che volle tenere rigorosamente inediti, una vera summa philosophiae ricca e sofisticata. Morì, dopo lunga malattia, a Roma, l’11 dicembre 1983. Al centro della filosofia di Emo campeggia quanto affermato in queste righe:
“Il problema è questo: di quali fedi si nutre e sussiste il mondo moderno; quale è la fede autentica che lo sostiene nella vita che gli dà la forza dell’attività e la convinzione di partecipare con la sua vita (o la sua azione o il suo essere) alla immortalità, cioè all’assoluto? Ogni uomo ha bisogno dell’assoluto e pertanto il suo problema è questa partecipazione all’assoluto”.
In questo quadro teoretico, si inseriscono alcuni snodi filosofici che dilatano lo spazio del pensiero di Emo fino a farlo implicare con l’Incarnazione di Cristo e la “religione dell’individuo”. La persona è uno dei rovelli filosofici del filosofo e la critica radicale alle religioni secolari fondate su una falsa mistica del Collettivo, il comunismo in testa, fa da pendant a questa assunzione di partenza. Emo ha una mistica del rovesciamento del Sacro, da figura collettiva e socialmente stabilizzante, a sostanza della religione dell’individuo. Non esiste niente fuori di questa unicità soggettiva ed individuale, l’unica realtà da difendere, contro le chimere collettivistiche (qui Emo scaglia dardi acuminati anche contro lo Stato etico di Gentile), è il soggetto, l’individuo, ultimamente la persona (termini che il filosofo spesso usa come sinonimi). “L’individuo non può essere un dato; esso può essere solo un soggetto cioè una resurrezione”. “Ogni rinascita è spirituale”, dunque l’età moderna, secondo la prospettiva indicata da Emo, o sarà nuovamente religiosa, per parafrasare Malraux, o non sarà. Ci vuole una fede, questo è certo, osserva il filosofo, ma quale fede? Quale sarà la fede dei laici? Non potrà essere quella collettivistico-sociale, fallimentare e violenta; ma anche quella cristiana rischia di essere contraria alla libertà di coscienza, in special modo nell’alveo cattolico. “I cristiani sono nati sotto il segno dello scandalo”; ed oggi, nella Chiesa, che fine ha fatto questo scandalo originario? A questo punto, compiendo uno scarto evidente, Emo introduce il tema della libertà individuale, sganciandola completamente da qualsiasi legame, anche religioso-sacrale. L’uomo potrà essere finalmente libero solo uscendo da qualsiasi vincolo di fede e da qualsiasi forma di obbedienza ad ogni autorità ecclesiastica. Altrimenti siamo ancora nel pieno del totalitarismo collettivista, dal Leviatano comunista al Leviatano cattolico, ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. L’idea filosofica della libertà personale vive e cresce solo nell’intimo della coscienza. Ogni coartazione morale nei confronti della coscienza potrà soltanto essere, nel tempo, l’anticamera del totalitarismo. Nella fede ciò che è irriducibile è l’amore, poiché quest’ultimo si rivolge all’individualità personale, al “singolo”. Leggiamo un passaggio filosofico veramente importante:
“Perché in ogni fede vi è qualcosa di scandaloso e di vergognoso? Perché vi è qualcosa di vergognoso nella verità e nella vita stessa? Forse l’elemento vergognoso è l’individualità pura attorno a cui verte la fede e che si crea con la sua negazione; l’individualità è sempre nuda e la nudità è scandalosa. I vestiti sono l’uniforme della società. Invano l’uomo (e la donna) credono di distinguersi con le vesti; e credono che la nudità sia uniformità. In realtà le vesti sono il riconoscimento della società, del sociale. Ma le vesti sarebbero nulla se non fossero animate dalla vita di una nudità. La veste è orgogliosa della nudità che essa socializza”.
Emo rappresenta certamente uno scenario filosofico originale e seccamente interno ad una tensione teoretica che fa della persona la polarità positiva del mondo. Poi è anche vero che in Emo, almeno in questi quaderni del 1953, non troviamo una compiuta filosofia del Sacro né una teologia in nuce. E’ pur vero, in ogni caso, che un pensatore così vada seguito, con curiosità ed attenzione; è proprio da alcuni marginali individualisti che il novecento ha spesso ricavato nuova linfa vitale e lucida apprensione al vero.
LEV ISAAKOVIČ ŠESTOV
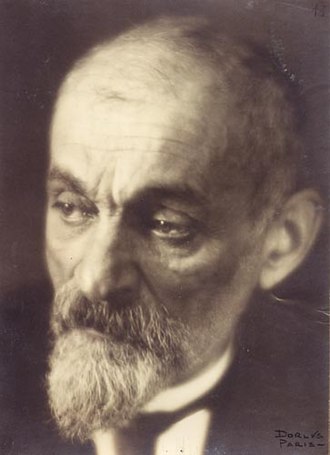
Lev Isaakovič Šestov (Kiev, 31 gennaio 1866 – Parigi, 19 novembre 1938) è stato un filosofo russo di origine ebraica, esponente dell’esistenzialismo. Lev Šestov, nacque il 31 gennaio 1866 a Kiev in una famiglia ebraica. Ebbe un’educazione irregolare, segnata da tanti trasferimenti da una scuola all’altra a causa dei suoi scontri con le autorità. Avrebbe voluto studiare diritto e matematica all’Università di Mosca ma, dopo uno scontro con l’ispettore degli studenti, fu rimandato a Kiev, dove completò i suoi studi. La dissertazione che presentò gli impedì di divenire dottore in legge poiché fu rifiutata, in quanto troppo rivoluzionaria. nel 1898 entrò a far parte di un circolo di prominenti intellettuali e artisti russi, che includeva Nikolaj Berdjaev, Sergej Djagilev, Dmitrij Merežkovskij e Vasilij Rozanov. Šestov contribuì con i suoi articoli al giornale pubblicato dal circolo e, durante questo periodo, completò la sua prima opera filosofica maggiore: Il bene nell’insegnamento di Tolstoj e Nietzsche (1899) (sia Tolstoj sia Nietzsche ebbero, insieme a Dostoevskij, una profonda influenza sulla sua filosofia). Nel 1903 pubblicò una delle sue opere maggiori, La filosofia della tragedia. Dostoevskij e Nietzsche, seguito nel 1905 da Tutto è possibile, dove adottò uno stile aforistico di stampo nietzscheano e accennò ad alcuni temi – religione, razionalismo, scienza – che avrebbe poi sviluppato pienamente in seguito. Tra le sue opere ricordiamo inoltre L’apoteosi dello sradicamento (1905), Potestas Clavium (1919), Sulla bilancia di Giobbe. Peregrinazioni attraverso le anime (1929), Kierkegaard e la filosofia esistenziale(1934), Atene e Gerusalemme. Saggio di Filosofia Religiosa (1938). Il lavoro di Šestov conobbe inizialmente pochi consensi, e critica fu anche la più stretta cerchia dei suoi amici che vedevano, nella sua rinuncia a ragione e a metafisica, una deriva verso il nichilismo. Nel 1908 si trasferì a Friburgo, in Germania, dove visse fino a quando, nel 1910, non si trasferì nel villaggio svizzero di Coppet. Furono anni di prolifico lavoro, durante i quali pubblicò La grande vigilia e Le penultime parole. Ritornò a Mosca in piena Prima guerra mondiale, nel 1915, quando suo figlio Sergej fu ucciso in combattimento dai tedeschi. In questo periodo il suo lavoro divenne più attento ai problemi della religione e della teologia. L’avvento dei Bolscevichi al governo rese la vita difficile a Šestov: nel 1919, con feroce barbarie, i marxisti gli imposero di scrivere una difesa della dottrina marxista come introduzione al suo nuovo lavoro Potestas Clavium, senza la quale non sarebbe stato pubblicato. Šestov si rifiutò di chinare il capo all’efferata dittatura marxista – che aveva schiavizzato l’uomo anziché liberarlo – e ritornò a Kiev, dove insegnò filosofia greca all’università. Il disaccordo con il regime sovietico portò Šestov a intraprendere un lungo itinerario lontano dalla Russia che lo portò ad approdare in Francia (1921), dove divenne popolare grazie al riconoscimento della sua originalità. Fu invitato a collaborare con riviste di filosofia e, negli anni tra le due guerre, continuò a sviluppare il suo pensiero (componendo tra l’altro un’opera atipica come Sulla bilancia di Giobbe) fino a diventare un filosofo di grande influenza, per quanto non partecipante ai circuiti accademici. Si immerse nello studio dei grandi filosofi, soprattutto Pascal e Plotino, tenendo nel frattempo lezioni alla Sorbona (1925). Nel 1926 incontrò Edmund Husserl, con il quale mantenne una cordiale relazione nonostante le radicali differenze tra le loro filosofie. Nel 1929, durante un viaggio a Friburgo, incontrò Martin Heidegger e intraprese uno studio più approfondito del lavoro di Kierkegaard. Fu per lui una scoperta, che lo portò a rendersi conto che le loro filosofie avevano forti somiglianze (per esempio, il rigetto dell’idealismo e la convinzione che la conoscenza umana passì più attraverso il pensiero soggettivo che la ragione oggettiva e totalitaria. Comunque, Šestov aveva già maturato indipendentemente dal filosofo danese il proprio pensiero, e riconobbe in quest’ultimo un “lottatore sconfitto”, arresosi prima della fine alla “Necessità”, come testimonia Kierkegaard e la filosofia esistenzialista, edito nel 1936, opera fondamentale del proto esistenzialismo. Ammalato, continuò a lavorare intorno alla sua opera capitale, Atene e Gerusalemme, dove spiega perché la ragione debba essere esclusa dalla filosofia. Il metodo scientifico, sostiene, ha reso la filosofia e la scienza incompatibili fra loro. Se la scienza si occupa di osservazioni empiriche, la filosofia al contrario si deve occupare per Šestov di libertà, di Dio, di immortalità: problemi, conclude, dove la scienza è del tutto inutile. Nel 1938 cadde gravemente malato; morì il 19 novembre in una clinica della capitale francese. Volle che durante la sua sepoltura fosse recitato il Kaddish, anche per testimoniare la sua appartenenza carnale ad Israele. Questo particolare è ribadito da Benjamin Fondane. La filosofia di Šestov non presenta unitarietà sistematica, né un insieme coerente di proposizioni, e nemmeno un’esposizione teoretica dei problemi filosofici che affronta. Gran parte del suo lavoro è di fatto frammentario, sia nella forma (aforismi, non linearità, più espressività che argomentatività) sia nei contenuti; ogni pagina sembra contraddire la precedente, e sempre Šestov ricerca il paradosso. Questo perché Šestov ritiene che la vita stessa sia, in ultima analisi, profondamente paradossale, impossibile da comprendere attraverso un’indagine logico-razionale. Šestov crede che nessuna teoria possa risolvere il mistero della vita, perciò la sua filosofia non risolve problemi, ma li crea, e prova a rendere l’apparire della vita il più enigmatico possibile. Punto di partenza di Šestov non è una teoria, ma un’esperienza di vita: l’esperienza della perdita, ovvero del venir meno delle certezze, dalla libertà, del senso. La radice della perdita è ciò che spesso chiama necessità, ma anche ragione, idealismo, fato: un certo modo di pensare (ma anche allo stesso tempo un aspetto reale del mondo) che sottomette la vita a idee, astrazioni, generalizzazioni e così facendo la sopprime, ignorando l’unicità e la vitalità del reale. “Ragione” è l’obbedienza e l’accettazione di “certezze” che ci dicono che determinate cose sono eterne e immutabili, mentre altre sono impossibili. È questo il motivo per cui la sua filosofia è una forma di irrazionalismo, anche se Šestov non si oppone affatto alla ragione o alla scienza, ma soltanto al razionalismo e allo scientismo: la tendenza a considerare la ragione come una sorta di Dio onnipotente e onnisciente. La sua filosofia è anche una forma di personalismo, giacché le persone non possono essere ridotte a idee, strutture sociali o comunità mistiche. Spiega Šestov in Atene e Gerusalemme:
“Ma perché attribuire a Dio, al Dio che non ha limiti né di tempo né di spazio, lo stesso rispetto e amore per l’ordine? Perché parlare sempre di “totale unità”? Se Dio ama gli uomini, che bisogna ha to subordinare gli uomini alla sua volontà divina e di privarli della loro stessa volontà, la cosa più preziosa che ha donato loro? Non esiste alcuna necessità. Di conseguenza, l’idea di una totale unità è un’idea assolutamente falsa (…). Non è vietato per la ragione parlare di unità, o anche di più unità, ma essa deve rinunciare all’idea di unità totale”.
Attraverso questo attacco all’autoevidenza, Šestov rimanda al fatto che siamo tutti allo stesso modo soli con la nostra sofferenza, e che non possiamo essere aiutati dagli altri, né tanto meno dalla filosofia. Ed è questo il motivo per il quale non ha elaborato un sistema filosofico organico. Ma la perdita, la disperazione, è solo la “penultima” parola. L’ultima parola non può essere detta in un linguaggio umano, né può essere catturata in una teoria. La filosofia di Šestov inizia con la perdita, il suo intero pensiero è disperato, ma Šestov tenta di individuare qualcosa oltre alla perdita, e oltre alla filosofia. È ciò che chiama “fede”: non una credenza, non una certezza, ma un altro modo di pensare che si soffermi nel mezzo del dubbio e dell’insicurezza più profondi. È l’esperienza che “tutto è possibile” delineata da Dostoevskij ne I fratelli Karamazov. L’opposto della necessità non è il caso o l’accidente, ma la possibilità: che esista un Dio che dia una libertà senza limiti o muri invalicabili. Šestov riafferma che dobbiamo continuare a combattere contro il caso e contro la necessità, anche se un esito vittorioso non è affatto garantito. E proprio nel momento in cui tutti gli oracoli sono ridotti al silenzio, allora noi dovremmo abbandonarci a Dio, colui che solo può sostenere l’anima sofferente. Non soltanto nell’omonima opera principale, ma in tutto il pensiero di Šestov ricorre l’immagine, metaforica come gran parte del suo pensiero, del contrasto tra Atene e Gerusalemme, a volte anche definiti come i due piatti della bilancia che misura il valore della vita umana. Atene, per Šestov, è la visione del mondo dominata dalla razionalità: per riprendere Hegel, è quella dove è reale soltanto ciò che è razionale, misurabile, verificabile; è il mondo visto con gli occhi della scienza, retto dalla logica e dalla matematica. Ma, per quanto non intuitivamente, Šestov insiste nell’affermare che questa visione del mondo è soltanto una delle possibilità, indubbiamente utile per la vita quotidiana, ma del tutto insufficiente per placare le ansie di senso dell’uomo. Ad essa, contrappone Gerusalemme, il regno di ciò che c’è di più prezioso (il to timiòtaton di Plotino): l’emozione, il sentimento, l’amore, il paradosso, la fede, pefino l’arbitrio e il capriccio. Non c’è nessun motivo per investire tutto su un piatto solo, argomenta Šestov, e men che mai su quello di Atene. Il pensiero di Šestov, pur originale e ricco di spunti, non conobbe una vasta diffusione, anche se tra i suoi estimatori si contano nomi di spicco della cultura europea del Novecento. I primi ad apprezzarne il valore furono, naturalmente, i filosofi e teologi russi coevi, come Nikolaj Berdjaev e Sergej Bulgakov.
Importante fu anche il suo lascito in Francia, dovuto soprattutto alle pagine che dedicarono a Šestov Albert Camus (che sul suo pensiero elaborò una sezione de Il mito di Sisifo), Benjamin Fondane, Emil Cioran e Gilles Deleuze; in Inghilterra la sua fortuna è legata soprattutto all’interessamento di D.H. Lawrence.
SAMUEL HUNTINGTON

“La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro“.
Samuel Phillips Huntington (18 aprile 1927 – Marthàs Vineyard, 24 dicembre 2008) è stato un politologo statunitense noto per la sua analisi della relazioni tra governo civile e potere militare, i suoi studi sui colpi di Stato e le sue tesi sugli attori politici principali del ventunesimo secolo: le civiltà che tendono a sostituire gli Stati-nazione. Negli ultimi anni si era occupato delle minacce poste agli Stati Uniti dall’immigrazione. È stato docente all’Università di Harvard e membro del Consiglio per le Relazioni Estere. Dopo la Seconda guerra mondiale, svolse un ruolo importante nel lancio del movimento neo-conservatore insieme a Irving Kristol, Norman Podhoretz, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, Jeane Kirkpatrick e James Q. Wilson. Si tratta di allievi di Leo Strauss, il filosofo politico di origine ebraica, che ammirava la lettura di Nietzsche, Heidegger e Carl Schmitt. Huntington divenne famoso negli anni ’60 con la pubblicazione del saggio Political Order in Changing Societies, un lavoro che sfidava le teorie convenzionali sulla modernizzazione, le quali sostenevano che il progresso economico e sociale porterebbe alla nascita di democrazie stabili nei Paesi di recente Decolonizzazione. È morto il 24 dicembre 2008 nell’isola di Marthàs Vineyard, in Massachusetts. Celebre soprattutto per aver scritto il saggio Scontro di civiltà, più volte invocato dopo l’evento epocale dell’11 settembre del 2000, Huntington era nato ideologicamente nel gruppo degli allievi di Leo Strauss che lanciarono il movimento neo-con. Autore di 17 libri e un centinaio di articoli scientifici, nel 1993, con otto anni di anticipo sugli attentati di al Qaeda, la guerra in Afghanistan e l’Iraq, aveva scritto su Foreign Affairs che “la prossima guerra, se ci sarà, sarà una guerra tra civiltà”. Nel saggio Scontro di Civiltà, rielaborato nel 1996 in un libro tradotto in 39 lingue, lo studioso americano aveva sostenuto che, sotto la spinta della modernizzazione, la politica si sta ristrutturando lungo “faglie culturali”. E tra le grandi civiltà contrapposte in un prossimo conflitto aveva indicato anche l’Occidente e l’Islam. Bollata come semplificata e semplicistica, la tesi di Huntington ipotizzava che nel mondo post guerra fredda le alleanze determinate da motivi ideologici o da rapporti con le superpotenze avessero lasciato il campo libero a nuovi confini ridisegnati perchè coincidano con quelli culturali. Huntington aveva elencato nel suo saggio sei diverse civiltà: islamica, slavo-ortodossa, confuciana, indù, giapponese e occidentale. “La Guerra fredda è finita con il crollo della cortina di ferro. Con la scomparsa delle divisioni ideologiche in Europa, la faglia tra cristianità occidentale e cristianità ortodossa e Islam è riemersa”, aveva scritto Huntington, osservando che “nel momento in cui la gente comincia a definire la propria identità in termini di etnia e religione, è sempre più comune il vedere un ‘noi’ contrapposto a un ‘loro’ nelle relazioni tra popoli di razza e fedi diverse”. Nel 1993, Huntington diede il via a un dibattito tra i teorici delle relazioni internazionali con la pubblicazione in Foreign Affairs di un articolo estremamente influente e citato, intitolato “The Clash of Civilizations?” (Lo scontro di civiltà?). L’articolo si opponeva a un’altra tesi politica relativa alle dinamiche principali della geopolitica post-Guerra Fredda teorizzata da Francis Fukuyama in La fine della Storia. Huntington in seguito ampliò l’articolo, facendolo diventare un libro, pubblicato nel 1996 da Simon and Schuster, intitolato The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order – (Lo scontro delle civiltà e la nuova costruzione dell’ordine mondiale). Secondo l’articolo e il libro, i conflitti successivi alla Guerra Fredda si verificherebbero con maggiore frequenza e violenza lungo le linee di divisione culturali ( o di civiltà, come quella islamica, occidentale, sinica, ecc.) e non più politico-ideologiche, come accadeva nel XX secolo, durante la Guerra Fredda. Huntington crede che la divisione del mondo in civiltà descriva il mondo meglio della suddivisione classica in Stati sovrani. Suppone infatti che, per capire i conflitti presenti e futuri, siano da comprendere innanzitutto le divergenze culturali, e che la cultura (piuttosto che lo Stato) debba essere accettata come luogo di scontro. Per questo motivo sottolinea che le nazioni occidentali potrebbero perdere il loro predominio sul mondo se non saranno in grado di riconoscere la natura inconciliabile di questa tensione. L’articolo del 1993 The Clash of Civilizations?si opponeva a un’altra tesi politica relativa alle dinamiche principali della geopolitica post-Guerra Fredda teorizzata da Francis Fukuyama in La fine della Storia (The End of History). Huntington in seguito ampliò l’articolo, facendolo diventare un libro, pubblicato nel 1996 da Simon and Schuster, intitolato The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Lo scontro delle civiltà e la nuova costruzione dell’ordine mondiale). Secondo Huntington, i conflitti successivi alla Guerra Fredda si verificherebbero con maggiore frequenza e violenza lungo le linee di divisione culturali ( o di civiltà, come quella islamica, occidentale, sinica, ecc.) e non più politico-ideologiche, come accadeva nel XX secolo, durante la Guerra Fredda. Huntington crede che la divisione del mondo in civiltà descriva il mondo meglio della suddivisione classica in Stati sovrani. Suppone infatti che, per capire i conflitti presenti e futuri, siano da comprendere innanzitutto le divergenze culturali, e che la cultura (piuttosto che lo Stato) debba essere accettata come luogo di scontro. Per questo motivo sottolinea che le nazioni occidentali potrebbero perdere il loro predominio sul mondo se non saranno in grado di riconoscere la natura inconciliabile di questa tensione. La visione dello studioso anche all’epoca dell’uscita del saggio aveva tuttavia provocato polemiche. Respingendo la tesi del professore di Harvard, il suo collega libanese trapiantato negli Usa Fouad Adjani aveva obiettato che il mondo islamico non è così monolitico come è descritto su ‘Foreign Affairs’. In Iran – aveva scritto Adjani – molti giovani si ribellano agli imam fondamentalisti. In Iraq Saddam Hussein è salito al potere come leader secolare. E sia Egitto che Giordania hanno leadership capaci di dialogare con Israele. In altre parole, secondo Adjani, quello dell’Islam era “un mondo che si divide e suddivide”.
CARLO SINI

Carlo Sini (Bologna, 1933) è un filosofo italiano. Laureatosi con Enzo Paci, è attualmente titolare della cattedra di filosofia teoretica dell’Università Statale di Milano. È membro dell’Accademia dei Lincei e dell’Institut International de Philosophie di Parigi. Sini è stato tra i primi ad introdurre all’attenzione del pubblico italiano l’importanza dell’opera di Charles Sanders Peirce, e ha inoltre proposto un filone di ricerca sulla convergenza teoretica dei percorsi filosofici di Peirce e Heidegger sul filo dell’ermeneutica benché la sua formazione didattica fosse di orientamento prevalentemente fenomenologico. Tra le sue opere più importanti ricordiamo: Passare il segno (1981), I Segni dell’anima (1989), Etica della scrittura (1992), Filosofia teoretica (1994), Filosofia e scrittura (1994), Teoria e pratica del foglio-mondo (1998), Gli abiti, le pratiche, i saperi (1996), Idoli della conoscenza (2000), La scrittura e il debito (2002), Figure dell’enciclopedia (2004 e seguenti), Archivio Spinoza. La verità e la vita (2005), Il gioco del silenzio (2006), Eracle al bivio. Semiotica e filosofia (2007), Da parte a parte. Apologia del relativo (2008). La proposta teoretica di Sini si è in seguito concentrata sul tema della scrittura e sulla centralità dell’alfabeto greco come forma logica del pensiero occidentale. In particolare, in “Figure dell’enciclopedia filosofica”, Sini rende conto della radicalità del gesto istitutivo platonico e della nascita della filosofia in modo da illuminare la genealogia della nostra civiltà e le figure del suo destino. Questa pubblicazione si misura con nodi problematici e profondi della nostra cultura. Viene mostrata la verità del gesto filosofico di Platone nel tratto tecnologico della parola alfabetica che trasforma la relazione al mondo in “cosità”. La pratica del concetto, infatti, in-forma il paradigma dell’oggettività e traduce le “sterminate antichità” dell’umano all’interno dell’ambito cronotopico della visione logica elaborata dalla scansione alfabetica del mondo (con la conseguente nascita del tempo e del sapere storico). All’educazione mitologica dell’uomo si sostituisce l’educazione psichica dell’anima nella rimozione delle qualità sensibili della vita vissuta. Prima operazione di ingegneria genetica che comporta sia la nascita del soggetto morale nella paideia del bio-politico (come Nietzsche aveva intuito) sia il conseguente destino nichilista rivelato dall’epoca contemporanea intesa come “epoca del disincanto”, secondo la nota definizione di Max Weber. Ma l’intreccio, che dalla preistoria conduce ai nostri giorni, rinvia al desiderio e all’iscrizione originaria che danza nelle figure della sessualità e della morte. La soglia così dischiusa, annunciata dalla verità analogica dell’evento mimato nella generazione, transita il movente desiderante nel “desiderio di vita eterna”. Platone e la logica disgiuntiva hegeliana rappresentano i due poli più rilevanti di questa consapevolezza lancinante. Addirittura, tutta la filosofia platonica è probabilmente da pensare come la domanda più alta e profonda che sia mai stata posta alla sapienza dionisiaca. E così, dagli ominidi alla società dell’informazione (sul filo delle pratiche che ne circoscrivono le traiettorie) la trama del senso transita dai “signa” ai “segni”, disegnando le coordinate del nostro tempo e il predominio della visione scientifica e delle sue figure che dileguano la consistenza oggettuale dell’oggettività, profilando nel rituale pubblico del potere finanziario, e nella conseguente imposizione dell’universalità oggettiva, un paradosso costitutivo che nasconde nuove e positive opportunità ancora tutte da scoprire (e attualmente mascherate dalla deleteria mercificazione imperante). Delineando nuove occasioni di senso, le Figure dell’enciclopedia invitano a “sognare più vero”, vale a dire ad abitare la conoscenza filosofica nell’esercizio dell’evento del significato nella concretezza delle sue pratiche. Ethos di una nuova scrittura della soggezione del mortale al desiderio, nell’apertura al transito della vita eterna.
REINER SCHÜRMANN
A cura di Luigi Santonastaso
BIOGRAFIA
Nato ad Amsterdam il 4 Febbraio 1941 da genitori tedeschi.
1960: studia al “gymnasium Krefeld” in Germania.
1962-1969: studia alla facoltà Domenicana di teologia e filosofia di Le Saulchoir a Essonnes in Francia; e frequenta saltuariamente corsi all’Università di Monaco e Friburgo.
1969: laurea .
1970: ordinato prete.
1971: diploma all’Istituto di Studi Politici di Parigi; dottorato di terzo livello in filosofia alla Sorbona di Parigi.
1972: pubblicazione di Meister Eckhart o la gioia errante.
1971-1972: insegna filosofia all’Univeristà Cattolica americana.
1972-1975: docente di filosofia all’Università di Duquesne.
1975: lascia il clero e inizia a insegnare alla Nuova Scuola per la Ricerca Sociale, dove resterà fino alla sua morte.
1976: pubblica Le Origini. Il libro ha vinto il premio Broquette-Gonin dell’Accademia francese.
1980: di nuovo docente universitario alla Nuova Scuola per la Ricerca Sociale.
1981: dottorato di Lettere e Scienze umane alla Sorbona di Parigi.
1982: pubblica Il principio dell’anarchia: Heidegger e la questione dell’agire.
1987: naturalizzato americano.
1988: la traduzione in inglese de Il principio dell’anarchia è scelto come il più importante libro per l’anno 1987-1988 dalla rivista “Choice”.
Muore di AIDS a New York il 20 Agosto del 1993.
IL PENSIERO
Reiner Schürmann fu professore di filosofia alla New School for Social Research a New York. Nato ad Amsterdam nel 1941 da genitori tedeschi, Schürmann scrisse tutti i suoi più importanti lavori in francese. Direttore della facoltà di filosofia alla New School for Social Research di New York fino alla sua morte, fu autore di tre notevoli lavori filosofici: Meister Eckhart e la gioia errante, Il principio dell’anarchia, Heidegger e la questione dell’agire e, infine, l’enorme lavoro Des Hégémonies brisées (pubblicato postumo nel 1996). Schürmann studiò filosofia e teologia con i domenicani presso il centro studi di Salchuoir vicino Parigi tra il 1962 e il 1969 ed ebbe il dottorato di filosofia all’Università Sorbonne nel 1981. Fu come prete domenicano che arrivò per la prima volta negli Stati Uniti nel 1971, insegnando prima alla Catholic University di Washington, poi all’Università Duquesne di Pittsburgh. Nell’unico suo lavoro letterario Le Origini, per il quale ricevette il premio dell’Accademia francese nel 1977, egli fornisce un resoconto autobiografico dell’errare, un andare alla ricerca della redenzione di un passato pieno di memorie, di colpe e disperazione, essendo nato in Germania durante la seconda guerra mondiale (troppo tardi per vedere la guerra troppo presto per dimenticarla). Nel 1976 egli lascia il sacerdozio ed inizia ad insegnare filosofia alla New School come “protetto” di Hannan Arendt. Uno dei migliori e più famosi lavori – Heidegger sull’essere e l’agire:dai principi alla’anarchia (1990) – è anche uno dei migliori lavori su Martin Heidegger e la teoria sociale. Schürmann mette in evidenza le differenze tra le conclusioni di Heidegger pensatore e la fede di Heidegger uomo, e incidentalmente mostra l’onesta intellettuale di Heidegger nel seguire questi pensieri a dispetto della sua educazione personale e della sua fede. Schürmann morì di complicazioni causate dall’AIDS il 20 Agosto 1993 a New York. In Italia, l’opera di Schürmann è stata introdotta soprattutto ad opera di un allievo di Vattimo, Alberto Martinengo (cfr. Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008).
SLAVOJ ŽIŽEK

A cura di Luigi Santonastaso
Slavoj Žižek è professore all’Istituto di Sociologia di Lubiana e all’European Graduate School (EGS). Žižek fu professore al dipartimento di psicoanalisi all’università di Parigi nel 1982-1983 e nel 1985-1986 al centro per gli studi per la psicoanalisi e l’arte a Buffalo, nel 1991-1992 al dipartimento di letteratura comparata all’università del Minnesota, Minneapolis nel 1992, alla Tulane University a New Orleans nel 1993, nel 1994 alla Cardozo Law School a New York, nel 1995 alla Columbia University, nel 1996 alla Princeton University, nel 1997 alla New School for Social Research, nel 1998 all’University of Michigan, nel 1999 alla Georgetown University di Washington. Egli è ritornato come membro alla facoltà dell’European Graduate School. Negli ultimi venti anni ha partecipato a simposi internazionali di filosofia, psicoanalisi e critica culturale in USA, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Islanda, Austria, Australia, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, Brasile, Messico, Israele, Romania, Ungheria e Giappone. Žižek è il fondatore e presidente della Society for Theoretical Psychoanalysis a Ljubljana. Egli usa la cultura popolare per spiegare la teoria di Jacques Lacan sulla politica e la cultura popolare. Nasce nel 1949 a Lubiana in Slovenia dove vive tuttora e tiene conferenze in tutte le università del mondo. Fu analizzato da Jacques Alain Miller, genero di Jacques Lacan, ed è probabilmente il più prolifico post-lacaniano, avendo pubblicato circa cinquanta libri, incluse le traduzioni in una dozzine di lingue. Egli è di sinistra e, oltre ad essere influenzato da Lacan, lo fu anche da Marx, Hegel e Schelling. Per il carattere, egli assomiglia ad un rivoluzionario piuttosto che ad un teorico. Fu politicamente attivo in Slovenia durante gli anni Ottanta, candidato alla presidenza della Repubblica della Slovenia nel 1990. La maggior parte dei suoi lavori sono morali e politici piuttosto che teoretici. Ha un carisma ed un energia notevoli ed è un affascinante conferenziere nella tradizione di Lacan e Kojeve. Žižek ha gettato luce in quelli che possono essere solo definiti “studi culturali” (anche se egli disprezzerebbe la caratterizzazione). Egli è un effettivo interprete del male lacaniano e come seguace del “liberatore” francese di Freud, il Lacan di Žižek è quasi esclusivamente trascritto in giochi di lingua che ipnotizzano o parabole intellettuali. Ha una comprensione enciclopedica delle correnti politiche, filosofiche, letterarie, artistiche, cinematografiche e della cultura popolare; inoltre non ha scrupoli nel gettarle tutte nella sua immaginazione – è la prima ragione che ha abbagliato i suoi pari e confuso i suoi critici per più di dieci anni. Originariamente il fine sembra essere quello di demolire le coordinate di un’egemonia liberale che permette eccesso e aberrazione, sebbene non minacci le vere coordinate. Egli suggerisce che le vere coordinate sono più nascoste di quanto crediamo. La produzione della differenza culturale è per Žižek la produzione di un sogno inefficace, che richiama forse “1984” di Orwell o persino “Brazil” di Terry Gilliam, dove una specie di pastoralismo generico o natura attribuita sostituisce la libertà come se fosse il retro di questo film noir. Žižek ha affermato che l’ultimo capitalismo moderno ha prodotto un’intera gamma di seduzioni alternative per tenere l’occhio e il cervello lontani dal reale. Il reale esiste solo come frammento, allontanandosi all’orizzonte come fantasia e illusione. Questi sogni e incubi sono strutturali e sistematici e fanno parte delle coordinate della cultura egemone. Essa, “l’insieme prevalente di coordinate”, tenta spesso di tenerci lontano il reale e, d’altronde, questo reale contaminato deve essere continuamente purificato. Žižek dà il via alla reinterpretazione dell’idea di forma liberata effettivamente dall’idea di forma radicale: non si dovrebbe confondere questa nozione propriamente dialettica di forma con la nozione multiculturale di forma come cornice neutrale della moltitudine di parti narranti non solo in letteratura ma anche in politica, religione, scienze; esse sono tutte parti narranti, storie che noi stiamo raccontando a noi stessi su noi stessi e l’obiettivo ultimo dell’etica è garantire lo spazio neutrale in cui questa moltitudine possa coesistere pacificamente. In cui ognuno, dalle minoranze etniche a quelle sessuali, avrà la possibilità o il diritto di narrare la propria storia. La nozione dialettica di forma segna precisamente l’impossibilità di questa nozione liberale di forma: la forma non ha niente a che vedere con il formalismo, con l’idea di forma neutrale. Indipendente dai suoi contenuti particolari, rappresenta piuttosto il nucleo traumatico del reale. Žižek è interessato nello spiegare il reale lacaniano in mezzo alla propaganda dei sistemi. Nell’opera su Lenin (Tredici volte Lenin) insiste sul momento in cui Lenin capì che la politica poteva un giorno dissolversi per una utopia tecnocratica e agronomica (la pura gestione delle cose). Ciò che Lenin sbaglia è immateriale, poiché Žižek sta estraendo il significato di Lenin dal continuum storico, che include quel fallimento (lo stalinismo). La versione di Lenin che Žižek sceglie spesso è apparentemente (per sua propria ammissione) il Lenin della rivoluzione di Ottobre. In questa critica del capitalismo contemporaneo Žižek non trova solo le condizioni che Marx profetizzò ma anche quelle condizioni che concretizzò e rese intangibili. Un certo eccesso era tenuto sotto controllo nella storia precedente, percepito come perversione individuabile, una deviazione elevata nel capitalismo come vero principio di vita sociale, nel movimento speculativo del denaro che genera più denaro, di un sistema che può sopravvivere rivoluzionando costantemente le sue stesse condizioni. Marx fissò l’antagonismo nell’opposizione tra il valore d’uso e il valore di scambio: nel capitalismo le potenzialità di questa opposizione sono realizzate pienamente, il dominio del valore di scambio acquista autonomia ed è trasformato nello spettro autonomizzato del capitale speculativo, che necessita delle capacità produttive e della gente reale solo come incarnazione temporale superflua. Nell’era della globalizzazione, poi, la questione principale è la seguente: oggi il capitalista virtuale non funziona in maniera omologa – il suo valore è zero, egli opera appena con il plusvalore prendendolo in prestito dal futuro? In una svolta rivoluzionaria autentica, il futuro utopistico non è pienamente realizzato, in questo caso, non è semplicemente rievocato come una promessa che giustifica la violenza attuale – piuttosto come se fosse in una sospensione di temporaneità, nel breve circuito tra presente e futuro, noi siamo come se per Grazia il futuro utopistico è già a portata di mano per essere affermato. La rivoluzione non è sperimentata come una difficoltà presente che dobbiamo tollerare per la felicità e la libertà delle generazioni future ma come avversità attuale oltre la quale questa felicità futura ha gettato la sua ombra – in essa noi già siamo liberi mentre combattiamo per la libertà, già siamo felici mentre combattiamo per la felicità nonostante le circostanze. La rivoluzione non è una scommessa alla Merleau-Ponty, un atto sospeso nel futuro anteriore per essere legittimata o delegittimata mediante risultati a lungo termine; e come se fosse la propria prova ontologica, un segno immediato della sua propria verità. L’obiettivo di Žižek è promuovere e produrre una critica sprezzante delle catene strutturali che tengono schiavo l’uomo moderno. La sua nostalgia è per i gesti: il meta-reale, l’universale, il formale. Questa resistenza è la risposta alla domanda perché Lenin? Il Lenin che rende formale questo contenuto e che trasforma una serie di nozioni comuni in una formazione teoretica davvero sovversiva.
REINHART KOSELLECK

LA VITA
Reinhart Koselleck (Görlitz 23 aprile 1923 – Bad Oeynhausen 3 febbraio 2006), volontario nel 1941 nella Wehrmacht, rimase fino al 1945 prigioniero a Karaganda (nel Kazakistan centro-settentrionale). Successivamente, tra il 1947 e il 1953, studiò storia, filosofia, diritto e sociologia in Germania presso l’Università di Heidelberg e, in Inghilterra, presso l’Università di Bristol. Tra i suoi principali maestri figurano Martin Heidegger, Karl Löwith, Carl Schmitt, Hans-Georg Gadamer, Werner Conze. Conseguì la laurea nel 1954 con il suo lavoro (poi pubblicato nel 1959) Kritik und Krise. Pathogenese der Bürgerlichen Welt (tr. it. a cura di P. Schiera, Critica illuministica e crisi della società borghese, Il Mulino, Bologna 1972), in cui fu decisiva l’influenza di Schmitt e di Brunner. Dal 1954 al 1956, Koselleck fu assistente all’Università di Bristol, e successivamente divenne assistente al “seminario di storia” dell’Università di Heidelberg; città in cui prese parte, dal 1960 al 1965, al gruppo Arbeitskreis für Moderne Sozialgeschichte, di cui divenne in seguito presidente (1986). Ottenne l’abilitazione, nel 1965, con la ricerca Preußen zwischen Reform und Revolution, pubblicata poi nel 1967 (Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848; tr. it. a cura di M. Cupellaro, La Prussia tra riforma e rivoluzione, 1791-1848, Il Mulino, Bologna 1988). Nel 1966 venne chiamato all’Università di Bochum come docente di “scienza della politica”. Dal 1968 divenne professore ordinario presso l’Università di Heidelberg, dove cominciò a insegnare “storia moderna”. Successivamente, a partire dal 1973, passò all’Università di Bielefeld, dove insegnò “teoria della storia” (Theorie der Geschichte) e nel 1988 venne nominato “professore emerito”. Prese attivamente parte al Zentrum für interdisziplinäre Forschung dell’Università di Bielefeld, di cui divenne direttore nel 1974. Fu visiting professor presso le università di Tokyo, di Parigi, di Chicago e di New York.
IL PENSIERO
Il nome di Reinhart Koselleck è legato soprattutto all’impresa della “storia dei concetti” (Begriffsgeschichte) e a opere come Futuro passato (Vergangene Zukunft, 1979), Strati del tempo (Zeitschichten, 2000), nonché il monumentale dizionario Concetti fondamentali della storia. Lessico storico della lingua politico-sociale in Germania (Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland). Quest’ultimo progetto, avviatosi a partire dal 1972 sotto la supervisione di Koselleck, Otto Brunner e Werner Conze, ha avuto un periodo di gestazione che si è esteso fino al 1997. Con i suoi nove volumi (sette di testi e due di indici), consta complessivamente di più di novemila pagine, segnando una vera e propria svolta paradigmatica nel modo di concepire e di praticare la Begriffsgeschichte: i “concetti storici fondamentali” presi in esame sono 212, spesso raggruppati per concetti semantici (come ad esempio Brüderlichkeit, Bruderschaft, Brüderschaft, Verbrüderung, Bruderliebe) e distribuiti in 119 articoli redatti da 109 autori (spesso con più autori per ciascun articolo), con particolare attenzione per i registri (che, redatti in diverse lingue, comprendono fonti di diritto, bibliche, autoriali e per nome). L’intento programmatico dell’opera è quello di scrutinare il lessico politico-sociale tedesco dal Settecento al Novecento, con particolare attenzione per quell’“epoca d’oro” per i concetti storici che fu – secondo gli autori dell’Historisches Lexikon – la Sattelzeit, l’“epoca-sella” (o “soglia epocale”) racchiusa tra i due estremi del 1750 e del 1850. In tale “soglia epocale” si sarebbe verificato un radicale riorientamento di tutta la galassia dei concetti storici fondamentali. E da tale riorientamento, secondo Koselleck, si potrebbe inferire la svolta moderna, ossia il diverso rapporto che con la dimensione della temporalità – come subito diremo – ha instaurato il mondo moderno. Nella Introduzione (Einleitung) scritta nel 1967 ai Geschichtliche Grundbegriffe Koselleck chiarisce i presupposti metodologici e filosofici dell’opera, tracciando un quadro complessivo delle acquisizioni generali della sua Begriffsgeschichte e ripercorrendone succintamente i risultati.
Il Lexikon – spiega Koselleck – si propone di indagare in modo storico-genetico, secondo il metodo della Begriffsgeschichte, i “concetti-guida del movimento storico” (Leitbegriffe der geschichtlichen Bewegung) dall’antichità – l’epoca in cui tali concetti vennero originariamente formulati – fino al mondo moderno. Tali “concetti fondamentali della storia” (geschichtliche Grundbegriffe) sono quelli che hanno accompagnato la millenaria esperienza sociale e politica dell’Occidente (dal concetto di “democrazia” a quello di “libertà”, da quello di “crisi” a quello di “storia”). Essi devono essere intesi “nello stesso tempo come fattori e come indicatori del movimento storico” (zugleich als Faktoren und als Indikatoren geschichtlicher Bewegung), in quanto non si limitano a registrare e, per così dire, a “cristallizzare” in concetti riflessivi i mutamenti storici avvenuti, ma sono autonomamente dotati di una loro “forza” in grado di “muovere” la storia, generando il mutamento socio-politico. L’esperienza storica è, per Koselleck, sempre anche esperienza politica, secondo l’insegnamento di Carl Schmitt.
È questa tensione tra realtà storica e concetti il principale architrave che sorregge la riflessione koselleckiana sulla storia nelle sue molteplici determinazioni. Dopo aver ravvisato il compito fondamentale della Begriffsgeschichte posta in essere con il Lexikon nella ricostruzione del mutamento dei concetti fondamentali della storia biunivocamente connesso con il mutamento delle esperienze storiche, politiche e sociali che si sono succedute nella vicenda occidentale (e, nella fattispecie, tedesca), Koselleck spiega che, lungi dal configurarsi come una mera ricostruzione begriffsgeschichtlich, e dunque avulsa da ogni costellazione teorica e, più specificatamente, filosofica, la disamina concettuale condotta nel Lexikon risponde a un’esigenza più ambiziosa: la comprensione della “dissoluzione del mondo antico e l’origine di quello moderno nella storia della sua registrazione concettuale” (Auflösung der alten und die Entstehung der modernen Welt in der Geschichte ihrer begrifflichen Erfassung). Contrariamente alle apparenze, non si tratta allora di una mera ricostruzione storico-genetica dei concetti fine a se stessa: il Lexikon aspira a venire a capo del processo “sfaccettato e pluridimensionale” della modernità. L’esame che il Lexikon conduce dei concetti della politica e del loro riorientamento diventa allora la chiave d’accesso per comprendere la modernità in quanto tale attraverso lo scarto che la separa dalle epoche precedenti.
Secondo le aspirazioni di Koselleck, la “storia concettuale” acquista così lo statuto di metodo per indagare sull’origine e sul “progetto” della modernità, esplorata attraverso i “concetti fondamentali” in cui si sono condensate le sue esperienze socio-politiche, le sue aspettative e, non da ultimo, le sue promesse di emancipazione universale proiettate nell’avvenire. Posto in altri termini, il problema che anima il Lexikon e, più in generale, il “sistema” di pensiero koselleckiano si risolve nel suo tentativo di tematizzare “la registrazione linguistica del mondo moderno, il suo prendere e costruire la consapevolezza tramite i concetti” (die sprachliche Erfassung der modernen Welt, ihre Bewußtwerdung und Bewußtmachung durch Begriffe). Tramite la chiara esposizione di questo obiettivo storico-filosofico di comprensione della modernità tramite il linguaggio con cui essa si è espressa, Koselleck svela la sua vera identità non solo – né soprattutto – di Begriffshitoriker, ma anche di “filosofo della storia”, nel senso di “pensatore dell’intero”, in grado di mettere a punto un’interpretazione olistica che tratteggi il movimento generale della storia oltre la molteplicità prismatica dei suoi singoli eventi, nel tentativo di elaborare una lettura complessiva delle strutture del tempo storico, centrata sul periodo compreso tra il 1750 e il 1850 – da Koselleck battezzato Sattelzeit – e inteso come vera e propria “cerniera” tra il mondo premoderno e quello moderno in senso stretto.
La Begriffsgeschichte deve essere intesa non come un esercizio storiografico fine a se stesso, ma piuttosto – in termini storico-filosofici – come via privilegiata per sondare concettualmente la modernità, per diagnosticarne l’essenza più intima, per misurarne i confini e per far emergere il nuovo rapporto da essa instaurato con le dimensioni del passato e dell’avvenire. È questa, a nostro avviso, la cifra autentica della riflessione koselleckiana, che assumeremo come stella polare per orientarci nella nostra indagine; tanto più che solo se si tiene fermo il presupposto dell’interpretazione generale della modernità come chiave di volta della riflessione koselleckiana diventa possibile comprendere, senza fraintendimenti, l’arcipelago di concetti e di teorie in cui si snoda, spesso in modo frammentario ed eterogeneo, l’analisi del nostro autore. Tutte le teorie e i concetti elaborati da Koselleck ruotano attorno a un’orbita al cui centro stanno il problema della modernità e, insieme, la modernità come problema.
È solo da questa prospettiva, esposta nel modo più chiaro nella Einleitung del Lexikon (ma poi anche nei saggi di Futuro passato), che diventa possibile prendere coscienza di come il ricco apparato concettuale e categorico sistematizzato da Koselleck “faccia presa” sulla realtà storica e delinei un quadro interpretativo originale, in cui storia e filosofia vengono sapientemente coniugate in un inedito equilibrio. Per questa via, le teorie e i concetti elaborati dall’autore, pur nella loro molteplicità irriducibile, trovano un’unitarietà esplicativa se riferiti a quel “fenomeno modernità” che, da angolature diverse e non sempre sovrapponibili, cercano di “sezionare” nel modo più efficace, più ricco e più pluridisciplinare: lasciando comunque irrisolti non pochi dei problemi che si proponevano di sciogliere, e aprendone talvolta di nuovi, su cui ci soffermeremo più diffusamente soprattutto nelle appendici del nostro lavoro. Il presupposto filosofico fondamentale dell’indagine koselleckiana sui “concetti fondamentali della storia” risiede, come si è detto, nel fare affiorare il significato della modernità attraverso la sua stessa espressività concettuale. Più in generale – e questo è il secondo presupposto storico-filosofico su cui si regge l’analisi del nostro autore – “l’anticipazione euristica” (heuristischer Vorgriff) del Lexikon sta nella “supposizione” (Vermutung) che nel già rievocato periodo a cavallo tra il 1750 e il 1850 si verifichi qualcosa di insospettato e di sorprendente: che, cioè, la galassia dei concetti fondamentali della storia sia andata, complessivamente, incontro a un epocale e “profondo mutamento di significato” (tiefgreifender Bedeutungswandel) che ne ha, in un certo senso, stravolto la struttura interna, rendendoli gravidi di nuove esperienze e, soprattutto, di nuove aspettative, sconosciute a tutte le epoche precedenti. A questo mutamento concettuale corrisponde – con una corrispondenza, in realtà, tutt’altro che univoca e, anzi, assai difficile da definire – un vero e proprio “mutamento di esperienza” (Erfahrungswandel). In altri termini, le decisive novità storiche susseguitesi con incredibile rapidità tra il 1750 e il 1850 hanno, da un lato, reso del tutto inadeguati i vecchi concetti fondamentali, ormai incapaci di dare voce a una realtà cambiata radicalmente nelle sue strutture più profonde, e, dall’altro, si sono rivestiti di nuovi significati e di nuove aspettative rivolte al futuro che erano del tutto impensabili prima di quel periodo. In questa risemantizzazione della costellazione concettuale è possibile individuare i segni di un mutamento epocale paradigmatico (l’atto di nascita del mondo moderno) e, insieme, diagnosticare l’essenza del nuovo mondo, la sua nuova relazione con la dimensione del futuro come orizzonte privilegiato. Alla luce di questo intenso processo di profonda trasformazione socio-politica, culminato nella Rivoluzione francese e nei suoi esiti, “concetti fondamentali della storia” come “repubblica”, “democrazia” e “crisi” si sono colorati di nuove sfumature semantiche, e le esperienze passate racchiuse in essi sono arretrate sullo sfondo, lasciando spazio a una folta schiera di aspettative orientate verso un futuro diverso e migliore. Con la grammatica di Futuro passato, lo “spazio dell’esperienza” (Erfahrungsraum) arretra sullo sfondo e diventa egemonico l’“orizzonte dell’aspettativa” (Erwartungshorizont), ossia quella tensione verso un futuro diverso e migliore che, per Koselleck, costituisce la spina dorsale del mondo moderno. Tra il 1750 e il 1850, l’avvenire irrompe nei concetti storici fondamentali. A emergere in primo piano è, improvvisamente, la tensione verso un avvenire nuovo e inaccostabile, nella sua novità dirompente, alle esperienze passate. Dato il nesso biunivoco tra concetti e realtà storica, secondo Koselleck da questo slittamento nell’ambito dei concetti è lecito inferire una svolta epocale sul piano storico: svolta che coincide con la nascita della modernità. Se dall’antichità alla prima metà del XVIII secolo “i concetti erano caratterizzati dalla capacità di ricapitolare in una sola espressione le esperienze accumulate fino a quel momento”, nella convinzione che esse potessero anticipare un futuro che, per quanto diverso, non si sarebbe mai potuto allontanare completamente dalle esperienze passate, con la svolta epocale del 1750 si verifica una svolta tale per cui “il rapporto del concetto con ciò che è concepito si inverte”, nella misura in cui i geschichtliche Grundbegriffe cessano di riferirsi a situazioni pregresse e alludono prospetticamente a progetti, a esperienze politiche nuove e non rintracciabili nel passato né interpretabili alla luce di esso.
Nella Sattelzeit andrebbe allora identificata una soglia tra due epoche o, da un’altra angolatura, tra due diversi paradigmi interpretativi del tempo, tra due diversi modi di relazionare tra loro le dimensioni del passato e del futuro. Così scrive Koselleck in Strati del tempo:
“Un’ipotesi per il nostro lessico dei concetti storici fondamentali è che il linguaggio politico-sociale (die politisch-soziale Sprache), a partire dal XVIII secolo, si sia trasformato, nonostante l’uso comune delle stesse parole, e che da allora sia stata articolata una “nuova epoca” (neue Zeit). Coefficienti di mutamento e di accelerazione trasformano vecchi campi di significato e, con ciò stesso, l’esperienza politica e sociale”.
La risemantizzazione infuturante del mondo socio-politico intervenuta nel corso della “soglia epocale” costituisce, sotto questo profilo, il “grimaldello” fondamentale per accedere all’essenza del mondo moderno, al suo nuovo intreccio delle tre dimensioni temporali. Scrive Koselleck nel 1972:
“L’anticipazione teoretica (der theoretische Vorgriff) della cosiddetta epoca-sella (Sattelzeit) tra il 1750 circa e il 1850 circa è dunque quella secondo cui in questo lasso di tempo ha avuto luogo una denaturalizzazione della precedente esperienza del tempo (Denaturalisierung der alten Zeiterfahrung). – La lenta perdita dei contenuti di significato aristotelici, che rimandano ancora a un tempo storico naturale, ripetibile e statico, è l’indicatore negativo di un movimento, che si lascia descrivere come cominciamento dell’età moderna (Beginn der Neuzeit). Antiche parole, come democrazia, libertà, Stato, a partire dal 1770 circa indicano un nuovo orizzonte futuro (Zukunfstshorizont), che circoscrive diversamente il contenuto del concetto; topoi tramandati guadagnano contenuti di aspettativa (Erwartungsgehalte), che in essi non erano prima presenti. Un comun denominatore del vocabolario politico-sociale consiste nel fatto che affiorano, in dimensioni crescenti, criteri di movimento (Bewegungskriterien). Come sia fruttuosa questa anticipazione euristica (heuristischer Vorgriff), si dimostra attraverso un gran numero di articoli, che tematizzano i concetti di movimento (Bewegungsbegriffe) stessi, come il progresso, la storia o lo sviluppo. Nonostante le vecchie parole, si ha a che fare con dei neologismi (Neologismen), che a partire dal 1770 circa guadagnano un coefficiente temporale di cambiamento (temporaler Veränderungskoeffizienten). Ciò fornisce un forte stimolo a leggere e a intendere d’ora in poi anche altri, vecchi concetti del linguaggio politico nel loro potenziale carattere di movimento (Bewegungscharakter). L’ipotesi di una denaturalizzazione dell’esperienza storica del tempo, che opera all’interno della semantica politico-sociale, viene avvalorata tramite il sorgere della moderna filosofia della storia, che si inserisce nel vocabolario”.
La tensione “infuturante” del mondo moderno verso un “domani” dai contorni incerti ma, in ogni caso, migliore – questa, in termini generalissimi, la cifra della Neuzeit secondo Koselleck – viene così a cristallizzarsi nei concetti con cui la modernità pensa se stessa. Tali concetti non sono soltanto il riflesso passivo di un mutato contesto storico-sociale: sono anche i “fattori”, gli elementi ideali che l’hanno reso possibile, dischiudendo – grazie alla loro tensione interna verso l’avvenire – un futuro aperto e ormai del tutto disgiunto dalla ricca gamma delle esperienze del passato. Esplorati tramite le lenti del Begriffshistoriker, tutti i concetti fondamentali della storia vanno incontro, durante quella Sattelzeit durata a malapena cent’anni, a un quadruplice processo di “democraticizzazione”, “temporalizzazione”, “ideologicizzazione” e “politicizzazione” che corrisponde pienamente al movimento generale – non solo concettuale – della modernità.
In forza di questi presupposti, si chiarisce ulteriormente il disegno koselleckiano di accertamento storico-filosofico della modernità che anima l’esperienza della “storia concettuale”: “tutti i concetti della storia testimoniano insieme un nuovo rapporto con le cose, un rapporto mutato nei confronti della natura e della storia, del mondo e del tempo, in breve: l’inizio della modernità”. Diventa così possibile studiare l’esperienza della Neuzeit attraverso il lessico storico, filosofico, politico e sociale con cui si è espressa, per scoprire che essa si è configurata e si è concepita, nel suo complesso, come “progresso lanciato verso la perfezione”, secondo l’espressione di Futuro passato: ossia come ambizioso tentativo di connettere il progresso tecnico e scientifico che si andava sviluppando con ritmi accelerati nel XVIII secolo con un generale progresso della società, della politica e, più in generale, della totalità olistica della storia.
Questa irresistibile spinta “futuro-centrica” che innerva l’esperienza moderna nelle sue diverse realizzazioni risulta lampante se solo si considera l’inaggirabile tensione verso l’avvenire di cui sono carichi concetti tipicamente moderni come quello di “rivoluzione” o quello di “democrazia”: la grande novità della modernità sta, sotto questo profilo, nell’aver sottratto questi concetti fondamentali della storia alle tradizionali esperienze passate su cui erano tradizionalmente fondati e nell’averli volti, con una torsione di centottanta gradi, verso l’avvenire, trasformandoli in altrettanti progetti politici e sociali da compiersi un futuro atteso con speranza. È esattamente in virtù dell’assunzione della Sattelzeit come momento “assiale” di trasformazione decisiva dei concetti e, con essi, della realtà storico-sociale moderna che si spiega l’insistenza del dizionario su questo snodo fondamentale della storia moderna e, più precisamente, “sulla concettualità moderna” (auf der “neutzeitlichen” Begrifflichkeit). Quest’ultima è intesa come il punto focale in cui il mutamento storico che segna la rottura con il mondo premoderno viene definitivamente registrato, tramite la sua concettualizzazione, e reso possibile, tramite l’apertura di un orizzonte futuro punteggiato da progetti da realizzare. Come vedremo, Koselleck lascia (consapevolmente) irrisolta la tensione tra “concetti” e “realtà” su cui è sospesa la sua riflessione. Così, da una parte, egli chiarisce come la tendenza “infuturante” dei principali concetti storici del mondo moderno dipenda, in larga parte, dal mutamento accelerato delle strutture provocato dalla catena di rivoluzionamenti tecnici e scientifici innescata dalla Rivoluzione industriale: mutamento che, compendiabile nella formula “sempre più progressi in sempre minor tempo”, ha contribuito a dischiudere nell’immaginario dell’uomo moderno un orizzonte aperto, un futuro diverso, migliore e progettualmente pianificabile. Dall’altra parte, tuttavia, Koselleck scongiura il rischio di una nuova forma di determinismo “materialistico” sostenendo apertamente che sono i concetti stessi ad agire biunivocamente sulla realtà, contribuendo – con la loro spinta in avanti verso il novum del futuro – a favorire l’accelerazione tecnica, scientifica, storica e del “tempo della vita” che contraddistingue il mondo moderno, sospeso in un incantesimo di “dromomania” e di ininterrotta “lotta contro il tempo”.
Dal nuovo punto di vista sulla modernità acquisito tramite la Begriffsgeschichte derivano non poche conseguenze, con le quali ci misureremo nel corso della nostra indagine ma che è bene fin da ora porre in evidenza almeno per cenni. In primo luogo, ciascuno dei geschichtiliche Grundbegriffe viene a configurarsi come un “Giano” bifronte, il cui sguardo è rivolto retrospettivamente al passato e, insieme, prospetticamente in avanti, verso un futuro a venire. Concetti come “democrazia” o “repubblica”, fino alle soglie del XVIII secolo, erano tendenzialmente “concetti di esperienza” che si riferivano a un passato assunto in forma paradigmatica come campo semantico e d’azione: poi, una volta travolti dal movimento infuturante della Sattelzeit, tali concetti si sono riorientati “in avanti”, hanno preso a precorrere nella coscienza anticipante dell’Illuminismo esperienze future, destando il sospetto diffuso – che ha assunto poi in Marx non meno che in Condorcet la forma di un’ossessione – di vivere in un’epoca di transizione, puro passaggio in vista di una redenzione finale collocata nelle regioni dell’avvenire. Tutti i concetti della storia – questo il corollario decisivo dell’impostazione koselleckiana – sono composti da diversi “strati del tempo” (Zeitschichten), che sono andati depositandosi gradualmente, imprimendo sui singoli concetti diversi modi di rapportarsi al passato e al futuro. Così, per portare un solo esempio, il moderno concetto di “democrazia” non è composto soltanto dagli “strati” del tempo più recenti, subentrati con l’avvento del mondo moderno: in esso continuano a permanere, in profondità, gli “strati” più antichi, i significati che esso racchiudeva in passato.
Ecco stagliarsi ancora una volta sullo sfondo il problema della modernità e della sua tutt’altro che lineare relazione con l’orizzonte del futuro: da questa irrisolta tensione in avanti intorno alla quale gravita il progetto della modernità, Koselleck ha preso le mosse per ridefinire, in modo originale (pur rivelando un’incancellabile impronta heideggeriana), il carattere storico del rapporto con la storia, assumendo le due categorie, dialetticamente connesse, dello “spazio dell’esperienza” (Erfahrungsraum) e dell’“orizzonte dell’aspettativa” (Erwartungshorizont) come categorie metastoriche che rendono possibile in ogni epoca il rapporto con la storia di quell’“essere storico” e strutturalmente “ontocronico” che è l’uomo. Se nel mondo premoderno era egemonico lo “spazio dell’esperienza”, in virtù del quale si poteva concepire la storia – con i suoi esempi paradigmatici e sempre validi – come magistra vitae, nel mondo moderno a dominare è l’orizzonte dell’aspettativa, ossia la dimensione del futuro: il fatto che per la modernità la verità risieda nel “domani” più che nell’“oggi” implica l’azzeramento delle esperienze pregresse, liquidate come grossolani errori ormai superati (secondo la maniera illuministica di leggere la storia passata) o, nella migliore delle ipotesi, come eventi passati e, dunque, del tutto trascurabili in riferimento al “futuro aperto” da cui sembra “calamitato” il mondo moderno. Con l’avvento della modernità, tutti i “concetti fondamentali della storia” – per tornare sul terreno proprio della Begriffsgeschichte – assistono al mutamento paradigmatico della propria struttura interna e, travolti essi stessi dall’accelerazione della storia in corso, si trasformano repentinamente in “concetti futurizzanti” (Zukunftsbegriffe), “concetti di aspettativa” (Erwartungsbegriffe) e “concetti dinamici” (Bewegungsbegriffe): è in questo processo – come vedremo – che deve essere rintracciata la genesi dei concetti “collettivi singolari” (Kollektivsingularen), trascendentali e riflessivi, come “storia” e “progresso”, che racchiudono in sé le molteplici “storie” e i molteplici “progressi” premoderni in un unico concetto unificato, “sincronizzato” con la freccia del tempo e, pertanto, incontenibilmente orientato in avanti. È così, del resto, che nascono nella Sattelzeit, a un sol parto, il concetto denaturalizzato di “storia in sé e per sé” e la “filosofia della storia” come riflessione trascendentale sulla concatenazione degli eventi assunta come processo teleologicamente orientato.
EMILE BOUTROUX

Un caso a sè è quello di Émile Boutroux (1845-1921). Allievo di Lachelier, egli è stato una figura di rilievo all’interno del dibattito sul pensiero positivistico. A differenza che per Lachelier e per Ravaisson, per Boutroux il rinnovamento della filosofia non può consistere nell’ individuazione di temi o princìpi che, se indubbiamente si differenziano dagli sterili dettami dell’ultimo positivismo, non emergono però da un reale confronto con la problematica scientifica. Ciò che invece occorre, a suo avviso, è proprio la dimostrazione (da effettuarsi mediante una diretta analisi della struttura della scienza) dell’inadeguatezza delle procedure scientifiche tradizionali a rendere conto della vera natura della realtà. La contingenza delle leggi di natura (1874), la prima e più famosa opera di Boutroux, e il successivo L’idea della legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanee (1895) costituiscono, da questo punto di vista, una vera e propria rottura all’interno della filosofia francese. Sarà grazie a tali opere che la filosofia spiritualistica successiva potrà riconoscere il rilievo filosofico delle ricerche sul sapere scientifico e, insieme, interrogare la realtà (soprattutto storico-umana) con strumenti ‘altri’ da quelli stabiliti dalle scienze fisico-naturali. Oggetto della prima indagine di Boutroux sono le stesse realtà sulle quali verte l’indagine scientifica: la materia, i corpi, l’organismo, l’uomo. Mostrando di accettare (almeno in questo) la lezione comtiana, anche Boutroux considera queste realtà ordinate secondo la loro complessità crescente, la quale le rende irriducibili l’una all’altra. Ma mentre per il positivismo sussisteva la possibilità (o addirittura il dovere) di descriverne i rapporti in termini causali, ciò è per Boutroux assolutamente impossibile. A suo avviso, infatti, il principio di causalità presuppone un’uniformità tra l’effetto e la causa: senonché, dal momento che nell’effetto c’è sempre qualcosa di più e di diverso rispetto a quanto è dato nella causa, tale uniformità non esiste. Di conseguenza non si possono ammettere tra diversi ordini di realtà rapporti di tipo causale. E mentre la caratteristica peculiare di questi ultimi rapporti è per Boutroux (che ha ancora in mente la concezione tradizionale della causalità) la necessità, la caratteristica peculiare che i fenomeni possiedono nelle loro relazioni reciproche è la libertà o (contingenza). In altri termini, ogni ordine di realtà, proprio perché diverso rispetto agli altri, si configura come ordine autonomo e irriducibile: così i corpi sono contingenti rispetto alla materia, la vita lo è rispetto ai corpi e alle leggi fisico-chimiche che li governano; e la vita spirituale (la coscienza di sé, l’attività riflessiva) lo è rispetto ad ogni altro ordine di realtà. Relativamente all’agire, i motivi non dovranno più essere considerati come cause necessitanti: essi diventano tali solo a posteriori, nella riflessione, mentre all’inizio c’è un atto della volontà, ossia una libera scelta. A conferma dell’influenza esercitata dalla filosofia di Boutroux su una parte della filosofia francese novecentesca, va rilevato che la soluzione anticausalistica del rapporto fra motivazioni e volontà ritorna, in forme sostanzialmente identiche, sia in Bergson che in Sartre. Va però ricordato che il mondo pluralistico e contingentistico delineato nel testo principale di Boutroux viene organizzato da ultimo in un’assai tradizionale gerarchia ontologica culminante in Dio, concepito come ” non soltanto il creatore del mondo, ma anche la Provvidenza che veglia sia sui dettagli che sull’insieme “. Inoltre, assai raramente la successiva filosofia della scienza accetterà di trasformare (come tendeva a fare Boutroux) le differenze metodologiche fra le singole scienze in differenze ontologiche tra i corrispondenti ambiti di realtà. In L’idea della legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanea , presi in esame vari gruppi di leggi (da quelle logiche a quelle sociologiche) e mostratane la reciproca irriducibilità, Boutroux procede ad una classificazione delle stesse secondo il criterio del cosiddetto ” potere necessitante “. La sola legge assolutamente necessitante è per il filosofo francese il principio logico di identità (A=A), che però appare contemporaneamente il più impotente a far conoscere la realtà. Da qui la conclusione di Boutroux: una legge è tanto più necessitante quanto più è astratta e lontana dalla realtà ; e, viceversa, è tanto meno necessitante quanto più è vicina ad essa (fino ad essere di valore necessitante nullo nel caso delle leggi psicologiche) . Per quanto riguarda le leggi di natura – o meglio, come scrisse Boutroux, ” quelle che noi chiamiamo leggi della natura ” – esse sono per lui solo ” l’insieme dei metodi che abbiamo trovato per assimilare le cose alla nostra intelligenza e piegarle al cambiamento delle nostre volontà “. In altri termini le leggi, ben lungi dall’essere dettami oggettivi della realtà, sono solo degli schemi pratici coi quali gli uomini organizzano secondo i loro interessi i fenomeni e i loro rapporti. Questo è l’aspetto per il quale Boutroux si è più validamente collegato coll’indirizzo pragmatistico, che ebbe in effetti un notevole sviluppo in Francia (uno dei suoi esponenti più significativi fu Édouard Le Roy, 1870-1954) e la cui caratteristica rispetto al pragmatismo americano e italiano fu un’assai maggiore inclinazione verso esiti di tipo spiritualistico e religioso.
CARL SCHMITT

“Credo che nell’ultimo secolo l’essenza del potere umano si sia svelata a noi in un significato del tutto particolare. Infatti è strano che la tesi della malvagità del potere si sia diffusa proprio a partire dal XIX secolo. Avevamo pensato di aver risolto o almeno appianato il problema del potere, affermando che il potere non proviene nè da dio nè dalla natura, ma piuttosto da un patto che gli uomini stipulano tra loro. Che cosa dovrebbe ancora temere l’uomo, se dio è morto e il lupo non è altro che uno spauracchio per bambini? Ma proprio dall’epoca in cui questa umanizzazione del potere sembra essersi definitivamente realizzata – e cioè dalla Rivoluzione Francese – dilaga irresistibilmente la convinzione che il potere sia in sé malvagio. Il detto ‘dio è morto’ e l’altra enunciazione ‘il potere è in sé malvagio’ derivano entrambi dallo stesso periodo storico e dalla stessa situazione, vogliono dire la stessa cosa” (Geschpräch über die Macht und den Zugang zum Machtaber, 1954).
Tra i pensatori sostenitori del regime nazista, instaurato nel 1933, uno dei più importanti fu Carl Schmitt (1888-1985), teorico della politica e del diritto. Nato da famiglia cattolica in Renania, compiuti gli studi di legge, insegnò dopo la guerra nelle università di Greifswald e Bonn e nel 1928 ottenne la cattedra di Diritto nella scuola di specializzazione in amministrazione commerciale di Berlino, dove strinse amicizia con Jünger; nel 1933 si iscrisse al Partito nazionalsocialista, fu nominato consigliere di Stato prussiano e ottenne la cattedra di Diritto pubblico a Berlino. Dopo il massacro delle SA del 1934, egli si tenne un po’ in disparte dal regime, in quanto il gruppo che faceva capo a Rosemberg non approvava il primato da lui accordato allo Stato rispetto al popolo e al partito. Egli difese, però, le leggi che nel 1935 sopprimevano i diritti civili degli ebrei e accentuò il suo antisemitismo, così come in seguito giustificherà e glorificherà la guerra e le vittorie di Hitler. Nel 1945 fu arrestato dagli alleati, venne internato in un campo e nel 1947 fu indiziato per crimini di guerra nel processo di Norimberga, dove si difese sostenendo che i suoi scritti erano soltanto analisi teoriche. Una volta rilasciato, si ritirò a vita privata a Plettemberg, sua città natale, dove trascorse i suoi ultimi anni di vita. In uno dei suoi primi scritti, Il valore dello Stato e il significato dell’individuo (1914), Schmitt muove una critica alla civiltà moderna, priva di anima e ossessionata dalla ricerca della sicurezza e del benessere materiale; egli non condivide, però, la concezione dell’austriaco Othmar Spann (1878-1950) di uno Stato organico, articolato in corporazioni esprimenti la strutturazione gerarchica della società in ceti. L’esperienza dell’emanazione di leggi marziali durante la guerra fa maturare in lui l’idea che non sono scopi morali, ma i pericoli concreti a determinare l’azione dello Stato. In tutto il corso della sua opera, Schmitt si mantiene fedele al principio dell’obbedienza dovuta all’autorità legalmente costituita: il concetto centrale del suo pensiero è sempre quello di Stato, concepito come entità politica sovrana, con la quale si identifica il popolo. E’ per questo che lo studio dello Stato non può essere affrontato in termini meramente formali, come pretendeva, ad esempio, Kelsen; bisogna, invece, partire dalle situazioni concrete, tenendo conto dei mutamenti politici e sociali; in questo senso Schmitt è favorevole all’utilizzazione di indagini sociologiche e di scienza politica nell’ambito della riflessione giuridica. Il problema essenziale consiste nel garantire la sicurezza dello Stato e la perseverazione dell’ordine costituzionale esistente: è per questo che il pensiero politico si Schmitt è conservatore e non rivoluzionario. Il momento fondamentale affiora nel caso in cui l’ordine e l’esistenza dello Stato sono messi in pericolo. Gli interrogativi diventano allora: entro quali limiti è lecito sospendere la legge costituzionale per fra fronte a tale pericolo e chi ha il potere di decidere questa sospensione? Ad essi, Schmitt, prova a rispondere attraverso vari scritti, in particolare con La dittatura (1921) e Teologia politica (1922). L’esperienza sovietica mostra che l’instaurazione di una dittatura può modificare l’ordine esistente e, quindi, essere rivoluzionaria; Schmitt distingue, invece, fra misure temporanee e leggi permanenti e considera lecita una dittatura soltanto in quanto misura temporanea ed eccezionale, volta a ristabilire l’ordine e la sicurezza e, quindi, a difendere la costituzione in vigore. Se, infatti, queste misure transitorie si trasformano in leggi, si dissolve lo Stato di diritto esistente. Ma chi decide che ci si trova in una condizione di eccezione, nella quale lo Stato è in pericolo e servono misure per contrastarlo? Le norme non possono decidere quando esiste questa situazione né sono in grado di affrontarla, prevedendo in anticipo le misure da prendere di fronte a condizioni eccezionali e cangevoli; al massimo, la costituzione può indicare chi assume in questi casi l’autorità legale, cioè chi è sovrano e può dichiarare lo stato di eccezione e istituire la dittatura per risolvere la crisi. La conclusione a cui perviene l’analisi di Schmitt è, quindi, la tesi che la sovranità risiede in chi possiede l’autorità e il potere di decidere lo stato di eccezione . Il sistema politico non può fondersi soltanto su una norma giuridica fondamentale o su procedure tecniche di governo; è necessaria , invece, un’autorità che decida e garantisca la legalità. Queste decisioni non possono scaturire dalla discussione pubblica nel consesso parlamentare: la debolezza e l’instabilità dei governi, espressi da regime parlamentare nella repubblica di Weimar, appaiono a Schmitt una conferma della sua diagnosi. Senza un’autorità sovrana in grado di decidere che cos’è giusto in un caso particolare, esiste soltanto una lotta di gruppi, che combattono ognuno in nome della giustizia e dell’ordine. Questi appelli, come quelli ai diritti naturali alla ragione, sono soltanto mezzi con i quali questi gruppi giustificano la propria posizione e diffamano gli avversari. Fermamente convinto dell’inefficacia di fattori morali nella politica, Schmitt inclina sempre più verso una forma di realismo politico, ispirato anche al pensiero di Hobbes. Sullo sfondo c’è una concezione pessimistica della natura umana : la politica non sarebbe necessaria tra uomini buoni. Ogni teoria politica presuppone, secondo Schmitt, che l’uomo sia un essere pericoloso e che caratteristica fondamentale della politica sia l’inimicizia. In uno scritto del 1927, intitolato Il concetto politico , egli scorge nella distinzione amico-nemico la distinzione specifica: il politico rappresenta l’antagonismo più estremo. Il nemico non è colui con il quale si è in concorrenza sul piano economico o verso il quale si prova avversione e odio personale: nemico è solo quello pubblico, cosicchè la distinzione amico-nemico indica solo ” l’estremo grado di intensità di un’associazione o dissociazione “. Nemico politico è l’altro, lo straniero, con il quale possono insorgere conflitti, ma questo non vuol dire che la sfera del politico coincida con la guerra: questa può essere una conseguenza dell’inimicizia, ma non ne è né lo scopo né il contenuto, tanto è vero che in determinati casi può essere più “politico” evitarla. Lo Stato è l’entità politica decisiva, perché solo ad esso appartiene lo jus belli : solo esso può determinare il nemico, promuovere la guerra e richiedere ai suoi membri il sacrificio estremo. In quanto tale, lo Stato è superiore a ogni altra entità politica o sociale, cosicchè classi o gruppi sociali antagonistici, partiti e associazioni possono esistere finchè non mettono in pericolo l’ordine legale e politico stabilito. La funzione primaria dello Stato, dunque, non si esprime nel fare la guerra o nel controllare la vita privata dei cittadini, ma nello stabilire l’ordine e la sicurezza: in casi estremi, esso può decidere qual è il nemico interno, cioè dichiarare tale il gruppo che minaccia l’esistenza dello Stato stesso. Quando il contrasto interno amico-nemico si trasforma in un conflitto armato fra gruppi, allora lo Stato non è più l’entità politica decisiva e ne segue la guerra civile, nella quale ogni gruppo fa valere una propria distinzione amico-nemico. Un mondo da cui fosse esclusa la possibilità della guerra esterna o della guerra civile, sarebbe privo della distinzione amico-nemico e, quindi, della dimensione del “politico”. Sulla base di questi presupposti, Schmitt affronta in vari scritti, come ad esempio la Dottrina della costituzione (1928), Il custode della costituzione (1931) e Legalità e legittimità (1932), il problema della costituzione . La costituzione è più di un insieme di leggi, in quanto determina la forma specifica dell’ordinamento politico, che può essere monarchico o democratico o comunista: nessuna costituzione, infatti, può essere neutrale rispetto ai principi e ai valori che essa rappresenta e che possono essere la democrazie o la proprietà privata o la libertà religiosa e così via. La costituzione dunque, non deriva da una normatività legale, ma dalla decisione politica di quelli che detengono il potere garantito costituzionalmente. La costituzione è inviolabile : neppure una maggioranza legale ha l’autorità per trasformarla in un nuovo tipo di ordinamento politico. Bisogna dunque che esista una forza neutrale al di sopra della molteplicità degli interessi antagonistici, la quale rappresenti la totalità del popolo tedesco e sia custode e garante della costituzione: essa deve essere un’autorità politica, che Schmitt identifica con il presidente della repubblica, nominato direttamente dal popolo e, perciò, indipendente da deboli maggioranze parlamentari e dotato del potere di sciogliere il parlamento e di indire nuove elezioni. Una costituzione non deve mai offrire i mezzi legali per la propria distruzione, cosicchè il concetto di uguale possibilità per i partiti politici di acquisire legalmente il potere ha senso soltanto se quei partiti accettano la legittimità della costituzione. Altrimenti un partito anticostituzionale, una volta conquistato legalmente il potere attraverso libere elezioni, potrebbe usare la sua autorità legale per abbattere la costituzione. Se si vuole evitare questo, è necessario che al presidente spetti decidere quali gruppi o partiti politici non devono usufruire del principio dell’uguale possibilità di acquistare legalmente il potere; in tal modo, egli è il vero garante della costituzione. In opposizione a Kelsen, col quale fu in aperta polemica, Schmitt è convinto che la teoria del diritto come “norma” non sia una teoria davvero originaria, giacché il normativismo implica già l’esistenza di norme poste in essere da un’autorità, la quale secondo Schmitt impone le norme facendo valere la propria volontà sotto forma di decisione (di qui il termine “decisionismo”, così caro a Schmitt). Per Schmitt, il punto di forza del decisionismo risiede nell’essere il momento di congiuntura tra l’elemento giuridico e quello politico, tra la volontà che pone ordine al caos e la ragione giuridica che conferisce una forma a tale ordine. Quest’ultimo è il prodotto di un’energia che mette ordine e che poi si cristallizza in una forma. L’esempio classico del decisionismo che Schmitt adduce è quello di Thomas Hobbes, autore nel quale il passaggio dal caos all’ordine è lampante, e vi è una teorizzazione della sovranità, di quella nozione centrale nella dottrina moderna dello Stato da Jean Bodin in avanti. La nozione di sovranità è cardinale per il decisionismo, giacché nulla più di essa mette in luce il carattere originario del decisionismo, l’idea che la legge scaturisca dalla decisione. Nel suo già citato scritto intitolato Teologia politica, Schmitt dà una definizione di sovranità destinata a godere di grande fortuna: “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. In quest’ottica, la sovranità non è soltanto la summa potestas che si esercita in condizioni normali, ma è un potere originario, è il momento nel quale si rivela la vera origine del potere. Nello stato d’eccezione, vale a dire nel conflitto (in caso di minaccia dall’esterno o in caso di guerra civile all’interno dello Stato), quando cioè si prospetta la minaccia di sopravvivenza per il collettivo, diventa possibile identificare chi è il sovrano, colui il quale decide sullo stato di eccezione. Il sovrano è colui il quale identifica i soggetti che connotano tale stato di eccezione e prende posizione a favore dell’uno e contro l’altro: in altri termini, egli sceglie chi è amico e chi è nemico. Infatti, come abbiamo visto, a partire dal saggio su Il concetto del politico Schmitt è convinto che l’essenza del politico – in netta polemica col positivismo giuridico, per il quale il politico è definito in base al concetto di Stato, poi a sua volta definito in base al concetto di politico, in un circolo vizioso perverso – stia nella possibilità di distinguere tra chi è amico e chi è nemico. Lo Stato organizza gli amici e li attrezza in maniera adeguata per affrontare la minaccia proveniente dai nemici: ben si capisce, allora, come sovrano sia chi decide su chi è amico e chi è nemico. Tutte le decisioni politiche avvengono in questa maniera: la decisione come tipo originario fonda sempre un ordine a partire da una minaccia che ha una valenza intrinsecamente politica. La decisione del sovrano avviene sempre in uno stato di eccezione: e Schmitt rileva come il normativismo alla Kelsen funzioni soltanto là dove c’è già una normalità dei rapporti e il conflitto è stato risolto; infatti, non è la norma a creare la normalità, ma, piuttosto, è la normalità a rendere possibile l’attuarsi della norma. La normalità è prodotta dalla decisione sovrana, che instaura l’ordine: e, a sua volta, la decisione presuppone un’organizzazione concreta di potere, un’istituzione. Per Schmitt, la costituzione non è un mero insieme di leggi costituzionali, che necessitano di un ordine sovrano per diventare attive. Anche sul piano dell’arena internazionale, regnano le decisioni, le quali sono decisioni di guerra, giacché si decide sempre su chi è amico e chi è nemico. Il nemico in questione, spiega Schmitt, non è mai il “nemico personale” (inimicus), ma sempre il “nemico pubblico” (hostis): mentre il primo, secondo l’insegnamento dei Vangeli, dev’essere amato, il secondo deve essere combattuto. Schmitt chiarisce a più riprese come il sovrano non sia altro che una secolarizzazione del Dio cristiano: infatti, come Dio crea il mondo ex nihilo sulla base della sua volontà (e non della ragione), così il sovrano crea dal nulla l’ordine giuridico, prendendo una decisione che scaturisce dalla volontà e non dalla ragione. È in questo senso che Schmitt parla, in Teologia politica, del “Dio onnipotente che è divenuto l’onnipotente legislatore”. Come diceva Hobbes, il primo decisionista della storia, “auctoritas, non veritas, facit legem”. Nel 1933 il Partito nazionalsocialista giunse al potere e la vecchia costituzione fu eliminata; Schmitt accettò il nuovo regime come legittimo e celebrò la figura di Hitler in quanto Führer, capo e guida della nazione, responsabile di tutte le decisioni. Le sue indagini si concentrarono allora soprattutto su questioni di diritto e di politica internazionale. In opposizione alle pretese universalistiche delle democrazie occidentali e del bolscevismo, egli riprese da Hitler la nozione di spazio vitale, che consentiva di giustificare l’espansionismo militaristico della Germania. A questi temi di diritto internazionale dedicò, in particolare, l’opera Terra e mare (1942) e, nel dopoguerra, Il nomos della terra internazionale dello Jus publicum europaeum (1950). Nell’età moderna il diritto pubblico europeo, agli occhi di Schmitt, è ormai sulla via del tramonto, in quanto ha perso il suo centro di riferimento, costituito dalla terra in opposizione al mare. L’Inghilterra, conquistando le terre del nuovo mondo, si è affermata come potenza marittima e imperiale: essa è il Leviatano, che si oppone alla potenza terrestre (Behemoth) rappresentata dagli Stati continentali, fondati sull’identità collettiva della nazione e sulla difesa della patria e dell’integrità territoriale. Nell’affermazione di questo impero marittimo mondiale si nasconde, secondo Schmitt, il germe della rovina, perché conduce alla trasformazione del diritto fra gli Stati in diritto privato internazionale, cioè in diritto commerciale, e introduce una forma di moralismo universalistico, politicamente pericoloso, perché fa appello al concetto discriminatorio di guerra giusta. Questo vuol dire che sta giungendo alla fine, secondo Schmitt, l’epoca della statualità e, con il concetto di Stato, si dissolvono le distinzioni fra diritto pubblico e diritto privato e fra diritto statale e interstatale. Ma con il venir meno del freno della statualità, cadono le barriere frapposte dalla hobbesiana guerra di tutti contro tutti. La guerra moderna, dice Schmitt, in Teoria del partigiano (1963), è una guerra partigiana, cioè ha la sua radice nelle ideologie e non trova più limiti nello Stato, anzi si radica all’interno dello Stato e della società. Il partigiano, infatti, non difende la terra da un’occupazione, ma conduce una lotta in nome di una propria verità ideologica in tal modo, egli sostituisce al nemico pubblico un nuovo nemico privato e regredisce, pertanto, alla barbarie. Questa crisi della politicità è in rapporto, secondo Schmitt, con il predominio dell’economia e della tecnica nel mondo contemporaneo, dove lo Stato si trova ridotto ad assolvere una semplice funzione puramente burocratica e organizzativa, al servizio del dominio economico sull’uomo. In tal modo anche il pensiero di Schmitt si conclude con una critica alla modernità, in sintonia con pensatori ai quali si sentiva vicino, come, ad esempio, Jünger e Heidegger.
PAUL FEYERABEND

A cura di Diego Fusaro
Le scienze della materia e le scienze dello spirito non solo sono differenti, ma devono essere tenute separate, altrimenti non rappresentano correttamente la realtà. (Ambiguità e armonia)
Lo sviluppo più radicale ed estremo di certe posizioni è presente nei saggi del filosofo viennese (ma trapiantato già intorno al 1950 in Inghilterra, poi anche negli Stati Uniti) Paul K. Feyerabend, nato nel 1924 a Vienna e deceduto nel 1994 in Svizzera. Allievo dapprima di Wittgenstein e poi più a lungo di Popper, legato in più modi a studiosi come Kuhn e Lakatos, Feyerabend ha sottoposto l’epistemologia neopositivistica a una critica impietosa che ha presto coinvolto l’intera tradizione razionalistica, non escluso il “razionalismo critico” popperiano. Dopo essersi fatto conoscere nella comunità filosofico-scientifica con una ricca serie di saggi poi raccolti in vari volumi (in particolare Il realismo scientifico e l’autorità della scienza , 1978, e I problemi dell’empirismo , 1980), Feyerabend ha conquistato una più ampia risonanza con un libro irriverente e provocatorio, intitolato emblematicamente Contro il metodo (1975). Negli anni seguenti egli ha approfondito non solo e non tanto i motivi più strettamente epistemologici della sua riflessione quanto un’analisi della scienza dal punto di vista pratico-politico. Il sapere scientifico, di cui già prima lo studioso aveva sottolineato i contenuti pragmatici e ‘impuri’, viene ora essenzialmente esaminato come impresa tutta celata entro il tessuto sociale della realtà. Esso va valutato non tanto per i suoi presunti valori di conoscenza e verità ‘oggettiva’ quanto per i contributi che offre e, in misura non minore, per gli ostacoli che pone al progresso umano: un progresso interpretato non già, positivisticamente, come accumulo di certezze o, popperianamente, come approssimazione al vero, bensì come emancipazione sociale ed etico-politica dell’umanità. I documenti più significativi di questo ‘ultimo’ Feyerabend sono gli scritti raccolti in La scienza in una società libera (1978), in Scienza come arte (1984) e in Addio alla ragione (1987). Nel corso della sua battagli contro l’epistemologia neopositivistica e razionalistico-popperiana Feyerabend ha toccato una cospicua serie di questioni teoriche. Quelle di carattere più generale e, insieme, di maggior rilievo sono forse le seguenti: a) l’effettiva natura e fisionomia dell’impresa scientifica; : b) la necessità e i modi di un’interpretazione ‘liberalizzata’ delle procedure della scienza; : c) il primato della teoria e la determinazione dei criteri di valutazione del sapere scientifico. Circa il primo punto, la polemica feyerabendiana contro la tradizione neopositivistica (e in parte popperiana) è particolarmente radicale. Per tale tradizione, afferma Feyerabend, la scienza è una costruzione esclusivamente teorico-cognitiva ‘pura’ caratterizzata dall’osservanza di principi procedurali ben precisi e invarianti (il cosiddetto ‘metodo’), e da giudicare secondo criteri pur essi teorici-‘puri’ e universali. La concezione epismetologica alternativa delineata dallo studioso austriaco è profondamente diversa. Per Feyerabend la scienza è anzitutto un’impresa per più versi ‘impura’, nel senso che è generata, nutrita e orientata da forti componenti storico-culturali, pratico-sociali e perfino ideologiche. Sono, insomma, interessi e fini reali molto più che astratti dettami teorico-epistemologici a guidare e sviluppare il cammino del sapere. In secondo luogo, tale sapere è in ‘cammino’ in senso pregnante. Mentre la tradizione razionalistico-popperiana ha disegnato un’immagine fondamentalmente univoca ed in temporale della scienza vera, Feyerabend pone l’accendo sulla dimensione temporale, dinamica e irriducibilmente plurale del sapere scientifico. E’ da questo punto di vista che, contrapponendosi di nuovo in modo frontale a un ben preciso indirizzo epistemologico, il filosofo austriaco sottolinea la costitutiva storicità e la conseguente mutevolezza dei princìpi, dei metodi e degli obiettivi della scienza. Reciprocamente, un approccio storico a quest’ultima attesta in modo eloquente la complessità degli ‘ingredienti’ dell’impresa scientifica e l’impossibilità di valutarne le procedure e i risultati secondo l’ottica di princìpi generali-astratti. In tale prospettiva particolarmente interessanti appaiono certe considerazioni sul ‘: caso Galileo ‘ contenute in Contro il metodo . Non soltanto, afferma Feyerabend, è essenzialmente una lettura non filosofico-epistemologica ma storica a consentire l’individuazione delle componenti e delle sollecitazioni che hanno portato Galileo a determinate scoperte; ma è da aggiungere che lo scienziato pisano avrebbe, per così dire, meritato la bocciatura se fosse stato esaminato secondo i paradigmi strettamente razionalistici privilegiati da neopositivisti vecchi e nuovi: e invero, quante indebite generalizzazioni, quante disinvolture teoriche proibite dal ‘giusto’ metodo sono rintracciabili nell’opera galileiana…E allora, delle due l’una: o le acquisizioni cognitive della fisica di Galileo sono false, o le regole del metodo possono, e talora debbono, essere trasgredite. E’ sulla base di quanto precede che Feyerabend ha proposto una radicale : ‘liberalizzazione’ dell’epistemologia razionalistico-‘metodologica’ tradizionale . Essa consiste, almeno in prima istanza, nell’individuazione e nella valorizzazione dei metodi (al plurale), delle procedure (talora inattese e sorprendenti) che la scienza segue effettivamente, e grazie ai quali essa acquista sempre maggior forza ed efficacia. Sotto questo profilo, di particolare rilievo appare la teorizzazione, nei Problemi dell’empirismo , del principio della tenacia e del principio della proliferazione. Il primo (ripreso da Kuhn, che però lo riferiva solo ai periodi di “scienza normale”) si contrappose alla tesi, particolarmente cara a Popper, secondo cui una teoria falsificata dai fatti deve essere abbandonata immediatamente. Al contrario, il : principio della tenacia suggerisce di mantenere una teoria anche se ci sono dei dati con essa incompatibili. Abbandonare una teoria alla prima difficoltà significa perdere la possibilità di sfruttare le sue potenzialità nascoste, ossia la possibilità che questa teoria si riveli feconda in un nuovo contesto e in rapporto a nuovi obiettivi. Secondo Feyerabend, non esiste del resto una teoria che sia in accordo con tutti i fatti compresi nel suo campo di applicazione: seguendo alla lettera il principio di falsificazione di Popper si dovrebbero quindi abbandonare tutte le teorie scientifiche. Quanto al : principio di proliferazione (già presente in Popper), esso afferma, contro ogni forma di monismo teorico, che la scienza non solo non può identificarsi con un’unica teoria ed un unico metodo, ma progredisce proprio attraverso la discussione critica fra teorie alternative. E’ bene, pertanto, che si sviluppino concezioni diverse rispetto a quella più accreditata, per quanto giustificata e autorevole possa apparire, affinché tale discussione sia possibile. In vari altri saggi, e da ultimo in Contro il metodo , Feyerabend ha ulteriormente radicalizzato le sue posizioni. La tesi difesa ora è che la scienza non solo non può seguire meccanicamente i principi dettati dal metodo, ma anzi ricava un beneficio a trasgredirli. La stessa esperienza storica attesta che il sapere scientifico assai spesso progredisce mettendo tra parentesi le regole, violando norme e dettami teorici, creando con astuta disinvoltura quelle che l’epistemologia tradizionale ha chiamato polemicamente le “ipotesi ad hoc”: ” Ci sono delle circostanze ” – leggiamo a questo proposito nel saggio feyerabendiano – ” nelle quali è consigliato introdurre, elaborare e difendere ipotesi ad hoc, o ipotesi il cui contenuto sia minore rispetto a quello delle ipotesi alternative esistenti e adeguate empiricamente, oppure ancora ipotesi autocontradditorie, ecc. ” E’ sulla base di tutto ciò che Feyerabend arriva infine ad affermare la sua concezione teorica più celebre e discussa: il cosiddetto ” anarchismo epistemologico “. Esso consiste in due princìpi strettamente congiunti tra loro: la risoluta negazione (non priva di elementi estremistici e provocatori) della necessità, validità e ineludibilità del metodo nella scienza; e la tesi (non meno paradossale) che, nella scienza, ” qualsiasi cosa va bene “: nel senso che l’impresa scientifica è così fatta da potersi avvalere, per i propri scopi, delle pratiche d’indagine e delle ” astuzie della ragione ” più diverse, imprevedibili e trasgressive. Naturalmente, riconosce Feyerabend, tutto ciò potrà sconcertare molto da un punto di vista strettamente razionalistico: d’altra parte non solo la riflessione teorica ma anche l’esperienza storica attesta che le cose stanno proprio così.
” L’idea di un metodo che contenga princìpi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida dell’attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando viene messa a confronto con i risultati della ricerca storica. Troviamo infatti che non c’è una singola norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata nell’epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza. Diviene evidente anche che tali violazioni non sono eventi accidentali, che non sono il risultato di un sapere insufficiente o disattenzioni che avrebbero potuto essere evitate. Al contrario, vediamo che tali violazioni sono necessarie per il progetto scientifico. In effetti, uno dei caratteri che più colpiscono delle recenti discussioni sulla storia e la filosofia della scienza è la presa di coscienza del fatto che eventi e sviluppi come l’invenzione dell’atomismo nell’antichità, la rivelazione copernicana, l’avvento della teoria atomica moderna […], il graduale emergere della terrai ondulatoria della luce si verificano solo perché alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche ‘ovvie’, o perché involontariamente le violarono. “
Il terzo ‘nodo’ cruciale del pensiero feyerabendiano riguarda il rapporto fra teoria e fatti (o fra enunciati teorici ed enunciati osservativi-fattuali) nella conoscenza scientifica. Riprendendo una tesi non nuova, e sviluppata in anni recenti con particolare vigore da Norman R. Hanson ( I modelli della scoperta scientifica , 1958), Feyerabend respinge sia l’assunto dell’esistenza in sede cognitiva di dati fattuali indipendenti dal pensiero e assumibili come criteri oggettivi di verifica dei giudizi sul mondo, sia il principio della distinzione tra asserzioni teoriche e asserzioni osservative. In particolare tale distinzione (di importanza cruciale all’interno dell’epistemologia neopositivistica) crolla non appena si scopre che queste ultime asserzioni dipendono in più modi dalle prime: noi comprendiamo gli enunciati osservativi anche più apparentemente oggettivi ed auto-evidenti solo all’interno di una determinata teoria. Anzi, più in generale, per Feyerabend vale il principio che qualsiasi termine cognitivo è definito solo dal contesto teorico nel quale è incorporato: esso è, per usare un’espressione assai cara ad un ben preciso orientamento epistemologico, “carico di teoria”. Una conseguenza di ciò è che neanche i dati/concetti più ‘elementari’ e ‘neutrali’ della scienza possono essere assunti in modo universale-oggettivo: i loro significati sono inestricabilmente intrecciati ai diversi quadri teorici entro i quali vengono enunciati e usati. Così ad esempio, spiega Feyerabend, il termine ‘massa’ ben lungi dall’avere almeno in sé e per sé un’accezione univoca, assume un certo senso nell’universo linguistico-concettuale di Newton e un altro senso nell’universo linguistico-concettuale di Einstein: ” la massa classica e la massa relativistica non denotano l’identico concetto, e gli assunti sulla costanza delle masse classiche e relativistiche hanno significati diversi “. Questa tesi, detta della ” varianza del significato “, impone limiti assai severi a certe ambizioni riduzionistico-unificazionistiche dell’epistemologia neopositivistica. In effetti, se i significati dei termini (anche formalmente identici tra loro) che compaiono in diverse concezioni sono sempre teoricamente connotati e differenziati, allora diventa estremamente arduo ridurre una concezione all’altra: le loro peculiarità linguistico-concettuali possono essere tali da rendere difficile (se non, spesso, impossibile) la loro reciproca traduzione e perfino la loro reciproca comprensione. Per questa strada Feyerabend arriva a sostenere il principio dell’incommensurabilità delle teorie in modo assai prossimo a quello del Kuhn più radicale. Non meno radicale appare la posizione del filosofo austriaco a proposito del confronto e della valutazione delle teorie scientifiche. Qui il referente polemico è l’assunto neopositivistico (e in parte popperiano) che una teoria (T2) è migliore di un’altra teoria (T1) se e solo se riesce a contenere quest’ultima come suo caso particolare. Tale assunto implica a ben guardare tre condizioni: a) che T2 riesca a spiegare gli stessi fatti di T1, ossia i suoi “successi”; b) che risolva gli eventuali problemi o anomalie di T1, ossia i suoi “insuccessi”; c) che spieghi in aggiunta fatti nuovi, ossia che abbia un maggior contenuto empirico. Senonché, osserva Feyerabend, come si possono fare queste valutazioni dal momento che le teorie non hanno necessariamente gli stessi fini, non parlano necessariamente degli stessi fatti (anche quando usano gli stessi termini/concetti), e questi ultimi, che pure dovrebbero costituire la base del confronto tra le teorie, sono essi stessi prodotto di teoria e dunque niente e affatto oggettivi? Inoltre, secondo Feyerabend, il punto c) si ottiene a spese del punto a): molto spesso, infatti, una nuova teoria allarga certamente l’orizzonte delle conoscenze empiriche, ma a prezzo di lasciar cadere alcuni fatti spiegati dalla vecchia teoria. In altre parole, nel passaggio da una teoria T1, ad una teoria T2, raramente si conserva tutto il significato esplicativo della teoria rimpiazzata. Una delle principali conseguenze di ciò è che, non essendo possibile determinare se due teorie hanno a che fare esattamente con lo stesso ambito di fatti ed essendo ogni trasformazione o evoluzione di teorie accompagnata da possibili perdite parziali, la concezione neopositivistica (ma anche popperiana) della scienza come accumulazione progressiva di conoscenze o come approssimazione graduale alla verità risulta irrimediabilmente compromessa: Feyerabend fa cadere così un altro caposaldo di un ben preciso orientamento epistemologico. Alla luce di quanto precede, non sorprende che l’epistemologia feyerabendiana arrivi ad esiti radicalmente pragmatici e relativistici . Per un verso la valutazione e la stessa interpretazione della teoria poggia su criteri in larga misura extra-logici e non necessariamente cognitivi: la scelta di una teoria, la preferenza di una concezione fra più concezioni rivali, ben lungi dal possedere un qualche fondamento razionale-oggettivo, risponde a criteri di tipo pratico – la rilevanza, l’efficacia, il successo, ecc. Per un altro verso, l’agire della scienza e dello scienziato, privo com’è di riferimenti (teorico o fattuali) di carattere universale, non può non ispirarsi a princìpi e obiettivi di carattere particolare, che valgono solo in rapporto ad ambiti e criteri locali, contestuali, assai difficilmente generalizzabili.
ROSENZWEIG

Franz Rosenzweig nacque a Kassel (Germania) il 25 dicembre 1886 in una famiglia ebrea di raffinata cultura. Studiò in un primo tempo medicina, ma poi si allontanò da tali studi per dedicarsi in toto alla storia e alla filosofia, annoverando fra i suoi maestri Rickert e Meinecke. Rosenzweig – ebreo ma con tiepidi sentimenti religiosi – progettò di convertirsi alla religione cristiana, ma dopo un’intensa e lunga crisi – che segnò il punto nodale della sua vita – riscoprì l’antica religione e decise – nell’ottobre del 1913 – di rimanere ebreo. Affetto da una gravissima malattia, restò paralizzato e riuscì a studiare solamente in virtù delle cure prestategli dalla moglie, alla quale indicava, su uno speciale apparecchio, le lettere dell’alfabeto che compongono le parole. Morì nel 1929, a soli quarantatré anni di età. Le sue opere principali, degne di menzione, sono: Hegel e lo Stato (1920), La Stella della redenzione (1921) e Il nuovo pensiero (1925). Alla base del pensiero filosofico di Rosenzweig sta il netto rifiuto delle pretese idealistiche e totalizzanti della filosofia, la quale, pur radicandosi nella limitata condizione mortale del singolo, finisce per negare la realtà della morte e del tempo. Da ciò deriva la tesi a effetto con cui Rosenzweig apre il suo complesso capolavoro, la paura della morte genera la filosofia, ma la filosofia nega la realtà della morte:
“Rigettare la paura che attanaglia ciò ch’è terrestre, strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all’Ade il suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia” (La Stella della redenzione).
Infatti, pur traendo origine dal timore della morte, la filosofia tenta di circuire l’uomo attraverso l’idea del Tutto:
“Poiché, certo, un Tutto non morrebbe e nel Tutto nulla morirebbe. Soltanto ciò ch’è singolo può morire, e tutto ciò ch’è mortale è solo” (La Stella della redenzione).
Pur muovendosi nella medesima atmosfera esistenzialistica del primo Heidegger – quello prima della Kehre -, a cominciare dal tema della natura irriducibilmente personale della morte (che per Heidegger è la nostra possibilità più autentica), Rosenzweig non tematizza l’uomo senza Dio (gottlos), ma l’uomo immerso in un insieme di rapporti al cui vertice stanno la comunità, il mondo e Dio. In particolare, egli si impegna nella ricerca di un “nuovo pensiero” (da qui il titolo di una sua celebre opera) alternativo a quella tradizione filosofica che va “dalla Jonia fino a Jena“. I caratteri cardinali di questo nuovo pensiero, che dopo aver demolito le totalità speculative del passato mira ad edificare una nuova totalità rispettosa delle esigenze del singolo, sono la fedeltà all’esperienza (ovvero alla concretezza del reale) e l’unione di filosofia e teologia (ossia l’individuazione di una filosofia teologica, o – se preferiamo – di una teologia filosofica, capace di procedere al di là dei limiti della filosofia e della teologia tradizionali). Secondo Rosenzweig, ogni uomo vive di due cose: credere e sapere. Parlando riduttivisticamente per esse di religione e di filosofia, se ne fanno meramente delle discipline specialistiche, una mera faccenda privata che non toccherebbe la concretezza pubblica della vita. Non che fede e sapere siano lo stesso: la fede è dono, invece il sapere è acquisizione. Eppure anche la fede è in relazione con un’attività e con il sapere: “l’azione non è opera di una libertà […] bensì l’adempimento di una preghiera“. Nel rapporto fra docente e allievo indicato da Rosenzweig sta forse il suo messaggio educativo ancora oggi innovatore: il docente non deve soltanto insegnare, ma innanzitutto sapere ascoltare. Questo crea un rapporto interpersonale fondato sull’oralità capace di instaurare una vera e propria amicizia. La rottura della totalità idealistico/panteistica fa sì che il pensiero si trovi dinanzi ai tre elementi di base che costituiscono da sempre il nucleo della sua esperienza dell’essere: Dio, il mondo e l’uomo. Siffatti elementi, dotati di una natura pre-riflessiva e meta-fisica, che li colloca al di là del pensare concettualmente fissato, non devono però essere colti nel loro isolamento e nella loro separatezza (come avviene nella percezione astratta o pagana delle cose), ma nella loro connessione reciproca. Il legame che connette Dio al mondo è la creazione; il legame che connette Dio all’uomo è la rivelazione; il legame che collega il mondo all’uomo è la redenzione. La creazione si attua in un dire che permea le cose – “Egli disse e la cosa fu” (Sal. 33,9) – facendo sì che la sequenza del reale si risolva nella trama linguistica che al vivifica. Particolar rilievo assume dunque il linguaggio, concepito come la forma stessa delle relazioni che collegano Dio, l’uomo e il mondo. I concetti teologici di base – creazione, rivelazione, redenzione – divengono quindi in Rosenzweig vere e proprie “categorie ontologiche“, come ha brillantemente rilevato Lévinas. Con il risultato di fare della religione (da religare, “unire”) la struttura e la verità profonda dell’essere. Della verità religiosa ebraismo e cristianesimo, nella loro complementarità, rappresentano le incarnazioni più elevate: di tale verità – prosegue Rosenzweig – occorre che i singoli e i popoli rechino testimonianza, giacchè – egli ammonisce – il “camminare nella luce del volto di Dio” – cioè il muoversi all’interno dello spazio aperto dalla Stella della redenzione – è unicamente dato a chi segue le parole che la bocca di Dio emana. Come affiora dai versi del profeta antico Michea (6,8) riportati dalla Stella: “Egli ti ha detto, o uomo, ciò che è bene e ciò che esige da te l’Eterno tuo Dio, cioè praticare la giustizia, essere buono nel cuore e camminare in semplicità con il tuo Dio“. Partito dalla constatazione della morte, il libro di Rosenzweig, passato attraverso la rivelazione e l’amore, mette quindi capo al “non-più-libro” della vita, ovvero all’impegno etico/religioso nei confronti dell’esistente e del prossimo. Egli cercò di opporsi con risolutezza all’idealismo, che considerava la base culturale dello stato totalitario (tema a cui dedica il suo scritto Hegel e lo Stato), contrapponendo ad esso la concretezza dell’io e dell’esistenza, che sono legati al futuro, ma anche al nulla, alla morte e alla trascendenza. Egli mette tra l’altro in evidenza quanto la filosofia sia inadeguata di fronte alla morte e quanto lo sia anche la solitudine del suicidio: “nel timore della morte egli [l’uomo] deve rimanere“, asserisce Rosenzweig.
“Dalla morte, dal timore della morte prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il Tutto. Rigettare la paura che attanaglia ciò ch’è terrestre, strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all’Ade il suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. Tutto quanto è mortale vive in questa paura della morte, ogni nuova nascita aggiunge nuovo motivo di paura perché accresce il numero di ciò che deve morire. Senza posa il grembo instancabile della terra partorisce il nuovo e ciascuno è indefettibilmente votato alla morte, ciascuno attende con timore e tremore il giorno del suo viaggio nelle tenebre. Ma la filosofia nega queste paure della terra. Essa strappa oltre la fossa che si spalanca a ogni passo. Permette che il corpo sia consegnato all’abisso, ma l’anima, libera, lo sfugge librandosi in volo. Che la paura della morte nulla sappia di una pretesa divisione in anima e corpo, che essa urli: io, io, io! e non voglia saperne di far risalire la paura esclusivamente al “corpo”, che importa questo alla filosofia? L’uomo si appiatti pure come un verme nelle fenditure della nuda terra davanti al sibilare dei colpi della cieca morte implacabile, e poi senta violentemente, inevitabilmente senta quanto altrimenti non avrebbe mai percepito: che se mai morisse, il suo io sarebbe soltanto un illud e perciò, con tutta la voce che gli resta in gola urli, urli ancora il suo io in faccia all’implacabile che lo minaccia di un cosí inconcepibile annientamento. A tutta questa miseria la filosofia rivolge il suo vacuo sorriso e alla creatura, che è squassata in tutte le membra dalla paura del suo aldiqua, mostra con l’indice teso un aldilà di cui essa nulla vuol sapere. Perché l’uomo non vuol affatto sottrarsi a chissà quali catene, vuol rimanere, vuole vivere. La filosofia che davanti a lui esalta la morte come la propria prediletta e come la nobile occasione per sottrarsi alle angustie della vita, sembra soltanto prendersi gioco di lui. L’uomo sente fin troppo bene di essere condannato alla morte, ma non al suicidio. E quella raccomandazione filosofica saprebbe soltanto suggerire il suicidio, non rendere accettabile la morte che a tutti incombe. Il suicidio non è la morte naturale, bensí quella assolutamente contro natura. La raccapricciante capacità di suicidarsi distingue l’uomo da tutti gli esseri che conosciamo e che non conosciamo. Essa designa addirittura l’atto di uscire dall’ambito complessivo della natura. Certo è necessario che almeno una volta nella vita un uomo si spinga fuori; egli deve accostare a sé almeno una volta in trepida meditazione la fiala preziosa, egli deve essersi sentito almeno una volta in tutta la propria terribile povertà, solitudine e lacerante separazione dal mondo intero ed essere rimasto un’intera notte faccia a faccia con il nulla. Ma la terra lo reclama di nuovo. Non gli è concesso, quella notte, bere fino in fondo la pozione. Per sfuggire alla strettoia del nulla un’altra via gli è destinata, una via diversa da questo precipitare nelle fauci dell’abisso. L’uomo non deve rigettare da sé la paura terrena, nel timore della morte egli deve rimanere” (La Stella della redenzione).
DARIO ANTISERI

VITA E OPERE
Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, laureato in Filosofia presso l’Università di Perugia nel 1963, professore Ordinario di Metodologia delle scienze sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss, è stato Preside della Facoltà di Scienze politiche della Luiss dal 1994 al 1998. Dopo la laurea in Italia, ha studiato (1963-67) Filosofia della scienza, Logica matematica e Filosofia del linguaggio rispettivamente presso le Università di Vienna, Münster e Oxford. Libero docente nel 1968 in Filosofia teoretica, ha insegnato materie filosofiche presso le Università di Roma “La Sapienza” e Siena. Ordinario di Filosofia del linguaggio presso l’Università di Padova (1975-86), ha qui insegnato anche Filosofia della scienza presso la Scuola di specializzazione in Filosofia della scienza, di cui è stato Direttore nel biennio 1980-82. Nel 1986 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze politiche della Luiss a ricoprire la cattedra di Metodologia delle scienze sociali. Sempre presso la Luiss è Direttore del Centro di metodologia delle scienze sociali. È membro dell’Istituto accademico di Roma e membro dell’Accademia italo-tedesca di Merano. E’ specialista del moderno pensiero liberale angloamericano e austriaco. Dario Antiseri è tra i più solidi filosofi del nostro tempo. Il suo pensiero non ha nulla di debole. È fortemente positivo ed è agli antipodi di ogni dogmatismo. In collaborazione con Giovanni Reale, è autore del più diffuso testo di filosofia in uso nelle scuole superiori italiane, molto tradotto anche all’estero. Insieme hanno ricevuto recentemente anche una sorprendente laurea ad honorem dall’università di Mosca, in quello che è stato per decenni il tempio del dogma ateo e materialista. Nell’aula del Consiglio della facoltà di Filosofia gremita da professori, dottorandi e autorità accademiche il rettore dell’Università ha conferito l’alto riconoscimento di Dottore Honoris Causa ai due studiosi italiani, Dario Antiseri (Luiss) e Giovanni Reale (Cattolica di Milano), la cui Storia della Filosofia Occidentale pubblicata in russo in quattro volumi è diventata un bestseller nazionale. Il libro, venduto in centinaia di migliaia di copie, per vari mesi ha occupato il secondo posto nella classifica generale dei libri più venduti. In tutte le università russe il libro di Antiseri e Reale è diventato il testo principale delle facoltà umanistiche. I lettori russi sono stati particolarmente colpiti dall’approccio di Antiseri e Reale, che vedono la storia della filosofia come una competizione tra teorie e prospettive filosofiche diverse. Gli autori hanno dimostrato che la ricerca della verità si fonda sulla consapevolezza della propria fallibilità, che è una negazione delle pretese del marxismo-leninismo al monopolio della “verità”. Il libro è un’appassionata difesa dei valori della società aperta, della democrazia e della libertà di pensiero. Tra le opere di Antiseri ricordiamo: “Karl R. Popper: epistemologia e società aperta” (Roma, Armando, 1972); “Perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa per la fede” (Brescia, Queriniana, 1991); “Teoria unificata del metodo” (Padova, Liviana, 1981); “Il mestiere del filosofo. Didattica della filosofia” (Roma, Armando, 1992); “Le concezioni pedagogiche-didattiche di G. Vailati. Motivi di attualità”, in Pedagogia e Vita, n.3, La Scuola, Brescia, 1988; “Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base”, La Scuola, Brescia, 1985; “Epistemologia e didattica delle scienze”, Armando, Roma, 1977; “Il pensiero di K.Popper: intervista di Armando Armando”, Servizio Informazioni Avio, n.3-4, Armando, Roma, 1977; “L’interdisciplinarità”, Servizio Informazioni Avio, n. 11-12, Armando, Roma, 1977; “Regole della democrazia e logica della ricerca”, Armando, Roma, 1977; “I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare”, Armando, Roma, 1975; “Epistemologia contemporanea e didattica della storia”, Armando, Roma, 1974.
Pubblicazioni recenti
Monografie
– L’agonia dei partiti politici, Rubbettino, Messina, 1999.
– Credere dopo la filosofia del secolo XX, Armando, Roma, 1999 (trad. tedesca, Monaco, 2001).
– Destra e sinistra: due parole ormai inutili, Rubbettino, Soveria Mannelli, Messina, 1999.
– Liberali: quelli veri e quelli falsi, Rubbettino, Messina, 1998.
– Trattato di metodologia delle scienze sociali, Utet, Torino, 1997.
– Storia della filosofia (in coll. con G. Reale), voll. 3, La Scuola, Brescia,199931; opera tradotta in spagnolo, portoghese e russo.
Introduzioni
– Introduzione all’edizione italiana di F.A. von Hayek, “La presunzione fatale”, Rusconi, 1997.
– Introduzione a L. von Mises, “Liberismo”, Rubbettino, Messina, 1997.
– Introduzione a F.A. von Hayek, “L’abuso della ragione”, Seam, Roma, 1997.
– Introduzione e traduzione di K. R. Popper, “Tutta la vita è risolvere problemi”, Rusconi, Milano, 1998.
Antologie
– Friedrich A. von Hayek (in coll. con L. Infantino), tradotto anche in russo, Rubbettino, Messina, 1998.
TUNNEL COGNITIVI
In non pochi casi la nostra mente tende ad infilarsi in un tunnel e diventa incapace di vedere attorno, di inquadrare il problema in una visione più ampia. Non siamo mai tanto vicini all’irrazionalità come quanto siamo convintissimi di essere razionali. Si annidano insomma nella nostra mente dei tunnel cognitivi, che imbocchiamo a testa bassa, senza dubbi, ignorando ciò che pure, in un altro angolo del cervello, è lì pronto a darci informazioni contrarie ai nostri affrettati giudizi. Per abitudine, pigrizia, pregiudizio, diamo per scontate verità che non lo sono affatto: decidiamo in base a criteri in apparenza solidissimi, ma di fatto assai deboli: siamo succubi della nostra ignoranza, superficialità, rigidità, capricciosità. La nostra più grande illusione diventa lo scientismo, quel complesso di credenze e di valori che finiscono per attribuire alla scienza il ruolo di unico strumento di conoscenza in grado di risolvere qualsiasi problema dell’uomo. La scienza, invece, non è un sistema di asserzioni certe o stabilite una volta per tutte, non è una conoscenza assoluta e non potrà mai pretendere di aver raggiunto la verità. Il vecchio ideale scientifico della conoscenza assolutamente certa si è rivelato un idolo. Dobbiamo pertanto guardare alla scienza non come ad un corpo di conoscenze certe e definitive, ma piuttosto come ad un sistema di ipotesi, ad una rete di teorie con le quali lavoriamo sin quando queste teorie superano i controlli. Le varie forme del mito della certezza sono mera illusione, un’illusione pericolosa per il processo della conoscenza, ma anche per lo sviluppo della vita morale. Per Antiseri la conoscenza scientifica inizia sempre dai problemi. Chi non è in grado di provare né stupore né sorpresa è come morto, è come se i suoi occhi fossero spenti. Noi inciampiamo nei problemi perché siamo una memoria, siamo eredi di una tradizione in evoluzione. E quando un pezzo di realtà urta contro un’aspettativa incastonata nella nostra memoria, allora sorge il problema. Un problema è sempre un’aspettativa delusa. La ricerca parte dai problemi, ma per scoprire la verità, dobbiamo imparare a sognare, perché non c’è nessun modo logico per avere nuove idee per risolvere i problemi. Dobbiamo tentare, immaginare, costruire ipotesi. L’aggancio tra mondo possibile (costituito dall’ipotesi) e realtà viene decretato nel processo della prova. Le ipotesi vengono provate e la prova consiste in severi tentativi di smentire o falsificare la soluzione proposta. Lanciamo ipotesi, perché desideriamo trovare in esse errori il più presto possibile per poterli eliminare subito proponendo teorie migliori, più simili al vero, più ricche di contenuto informativo e quindi più controllabili. Ogni giorno nella ricerca scientifica si corregge un errore, ogni giorno si migliora una verità, ogni giorno si impara. Problemi – teorie – critiche: sono questi i punti cardinali della logica della ricerca. In una tale concezione l’errore è l’immane potenza della ricerca scientifica, è il motore della crescita della conoscenza. Non va dimenticato che la nostra tradizione culturale non ha dato nel passato, soprattutto quello più recente, il dovuto rilievo al sapere scientifico.
SULLE ORME DI POPPER
“Nel campo di coloro che cercano la verità non esiste alcuna autorità umana. Chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli dei”. (A.Einstein)
La metodologia (o teoria della scienza o epistemologia) consiste in quel complesso di indagini destinate a rispondere a domande come queste: “Cosa fa il ricercatore quando fa ricerca ? Come procede? E da dove parte? In che modo si distingue il suo discorso da quello di un filosofo, da quello di un moralista o da quello dell’uomo religioso ? – Che cosa vuol dire spiegare scientificamente un fenomeno? (…) Che ruolo gioca la fantasia nella ricerca scientifica ? Qual è il rapporto fra teoria ed esperienza? Come si fissa un protocollo? L’errore quale funzione svolge nello avanzamento della conoscenza scientifica ? E se nella scienza nulla vi è di certo (in quanto la storia della scienza è la storia di teorie superate, di teorie cioè confutate), cosa vorrà allora mai dire che la scienza è oggettiva ? E infine, in che consiste la prova di teoria ?” (1) L’insieme di risposte a queste e simili domande si chiama metodologia o epistemologia. Tutto ciò ci porta alla teoria generale della conoscenza scientifica, vale a dire all’epistemologia. Per Antiseri le teorie di fondo (2) dell’epistemologia si possono sintetizzare in alcune tesi:
1 Tutta la conoscenza scientifica è ipotetica e congetturale.
2 L’accrescimento della conoscenza scientifica consiste nell’imparare dagli errori che abbiamo commesso: in primo luogo osando commetterli – proponendo arditamente teorie nuove – e, in secondo luogo, andando sistematicamente alla ricerca degli errori mediante la discussione critica e l’esame critico delle nostre idee.
3 Gli esperimenti sono costantemente guidati dalla teoria, da mezze idee teoriche, di cui spesso lo sperimentatore non è consapevole, da ipotesi sulle fonti possibili di errori sperimentali, da speranze o congetture intorno a quello che sarà un esperimento fruttuoso.
4 L’obiettività scientifica consiste soltanto nell’approccio critico. Sarebbe un errore pensare che gli scienziati sono più “obiettivi”. A farci tendere alla oggettività non è l’obiettività, o il distacco, del singolo scienziato, ma la scienza stessa, o quello che possiamo chiamare la cooperazione allo stesso tempo amichevole e ostile fra gli scienziati, cioè la loro prontezza a criticarsi reciprocamente. Il metodo della scienza è il metodo della discussione critica, ed è estremamente importante che le teorie critiche siano difese tenacemente.
5 La parte fondamentale che nella scienza hanno le teorie, le ipotesi, o congetture, fa sì che sia importante distinguere fra teorie controllabili, o falsificabili, e teorie non controllabili o non falsificabili.
6 Così si può dire che ogni teoria che possa essere sottoposta a controlli vieta che certi eventi accadono. Una teoria parla della realtà empirica solo nella misura in cui le pone limiti. 7 Nessuna teoria può dirci qualcosa intorno al mondo empirico, a meno che non sia in linea di principio in grado di entrare in collisione con il mondo empirico; e ciò significa, esattamente, che deve essere confutabile.
8 La controllabilità ha gradi: una teoria che asserisca di più, e dunque assuma rischi più grandi, è controllabile meglio di una teoria che asserisca molto poco.
9 I controlli possono essere graduati secondo che siano più o meno severi. Ad esempio, i controlli qualitativi sono, in linea generale, più severi dei controlli quantitativi. 10 L’approccio critico è collegato con l’idea di sottoporre a controlli, ossia di tentare di confutare, o di falsificare, le congetture.
In campo medico il discorso del metodo è stato sempre rilevante: il medico attento vede mutare, nel corso della sua esperienza, teorie e terapie; e vede questo fatto meglio di chiunque altro in quanto la medicina, scienza tipicamente interdisciplinare, ingloba, per le sue spiegazioni, teorie fisiche, chimiche, biologiche. Queste teorie mutano, si commettono errori ma si cerca di correggerli. Anche in Italia si è intensificato, soprattutto in questi ultimi anni, l’influsso del pensiero di K.R.Popper, il noto filosofo di origine viennese, professore emerito dell’Università di Londra. Popper è figura di primo piano ormai in tutto il mondo. La forza delle sue teorie ed argomentazioni è tale da aver provocato un vero terremoto, e non solo nel campo dell’epistemologia e nell’ambito della teoria politica. E’ un fatto notevole per la storia del pensiero richiamare alla memoria il “fallibilismo” di Popper, la concezione, cioè, che nella conoscenza nulla vi è di certo e che noi andiamo avanti per tentativi ed errori. E quando, più di recente, il pensiero di Popper ha cominciato a diffondersi, sono stati i medici e i biologi (molto prima degli stessi filosofi) a rendersi conto della validità e dell’estrema rilevanza della filosofia di Popper, per una seria impostazione della metodologia della ricerca. Nel 1978 è stata pubblicata dall’editore Armando di Roma l’“autobiografia intellettuale” di K.R.Popper con il titolo “La ricerca non ha fine” (3). Si tratta di un libro tradotto in molte lingue che ha rappresentato un grande evento per la cultura internazionale. Le idee di Popper rappresentano forse lo sviluppo più importante nella filosofia del ventesimo secolo. Dario Antiseri (4) – anche più di Marcello Pera – è l’autore che più di ogni altro ha fatto conoscere in Italia e all’estero l’opera di Popper.
LA CACCIA ALL’ERRORE
La teoria fondamentale della filosofia di Karl Popper è il “fallibilismo”, vale a dire l’idea che noi nella scienza e nella conoscenza possiamo sbagliare: o meglio ancora, l’idea che ogni teoria, se vuole candidarsi al regno delle teorie scientifiche, deve essere controllabile, criticabile, falsificabile, cioè smentibile. Nella scienza non c’è certezza. La scienza è fallibile perché la scienza è umana. L’uomo di scienza è un uomo che ha inciampato o inciampa nei problemi. Per capire cosa significa inciampare in un problema, basterà pensare all’odierno problema del cancro. Ebbene, cosa fa l’uomo di scienza una volta che ha inciampato nel problema? Lo scienziato, provocato dal problema, cerca di risolverlo e cerca di risolverlo scatenando la sua fantasia costruttrice di congetture, di sospetti, di speranze, di ipotesi, in una parola: di teorie. Lo scienziato, insomma, per risolvere i problemi costruisce o inventa mondi possibili con la speranza che uno di questi mondi possa descrivere, spiegare e prevedere quel pezzo o quell’aspetto del mondo reale, portato a galla dal problema. Quindi: problemi e teorie. Il terzo stadio della logica della ricerca ci è dato dalla prova che consiste in un severo meccanismo di controllo delle teorie, al fine di vedere se le osservazioni e gli esperimenti confermano o smentiscono le ipotesi in competizione per la soluzione del problema. Chi ha paura dell’errore ha paura della fallibilità umana, ha paura di essere uomo. Pretende diabolicamente, di essere come Dio, di essere infallibile. Il controllo e la prova sono una sistematica caccia agli errori nelle teorie. Dobbiamo trovare errore il prima possibile, ovviamente per poterli eliminare il prima possibile. Per Popper il metodo della scienza consiste in questi tre passaggi: 1] problemi, 2] teorie, 3] critiche. Bisogna affrontare tre grossi problemi: il problema dell’errore, quello della verità e il problema della storiografia della scienza. L’epistemologia popperiana rende conto dell’immane potenza dell’errore che è uno degli ingredienti più importanti della ricerca e della storia della ricerca. Diceva Oscar Wilde: “Esperienza è il nome che ciascuno di noi dà ai propri errori”. E Robert Oppenheimer asserì: “Nella scienza si va avanti perché non si sbaglia mai due volte nello stesso modo” (5). Nella soluzione dei problemi che ci stanno a cuore procediamo per tentativi ed errori. Popper è dell’avviso che la differenza “tra l’ameba di Einstein è una sola: all’ameba dispiace sbagliare. Einstein, invece, è stuzzicato dal piacere di trovare un errore nella propria teoria. Mentre l’ameba muore con la teoria errata, Einstein fa morire la teoria al posto suo. Il moscone sbatte contro il vetro e torna indietro, sbatte ancora e torna di nuovo indietro, e sbatte ancora…finché muore, muore con la sua teoria errata” (6). Noi, invece, se erriamo facciamo tesoro dei nostri errori costruendo teorie sempre migliori, più potenti dal punto di vista esplicativo, più ricche di contenuto informativo, teorie in grado di spiegare anche quei fattori che hanno messo in ginocchio le teorie precedenti. Avanziamo, quindi, sul sentiero delle congetture e delle smentite verso teorie sempre più potenti, anche se mai onnipotenti, poiché di principio sempre falsificabili. E con ciò siamo al problema della verità. La verità per Popper non è mai un possesso. Possiamo sempre correggerci. Tutto ciò aiuta a farci rendere conto della storia della scienza che è molto più complessa della logica della scienza. La storia della scienza è la splendida storia di una serie discontinua, contorta e tormentata di teorie sbagliate. E’ una storia di errori continuamente eliminati, prima individuati, e prima ancora commessi per risolvere i problemi. Evitare gli errori, ha scritto Popper, è un ideale meschino. Siamo fallibili: abbiamo sbagliato e sbaglieremo. L’importante è andare a caccia di questi errori e poi avere il coraggio di eliminarli respingendoli nel limbo delle teorie errate. Noi siamo orgogliosi dei nostri errori. La storia della scienza è un cimitero di teorie errate. E’ vero. Ma essa è un cimitero di eroi. L’errore nella scienza non è certo nel concepire come il peccato in religione. Esso è il motore della scienza. Tutto questo apre nuovi orizzonti nella teoria pedagogica e nella pratica dell’insegnamento (7). Non c’è miglior sinonimo di “razionale” che il termine “critico”: criticare vuol dire falsificare, smentire quel che si è detto, trovare un errore nella teoria proposta, al fine di far avanzare una teoria migliore, che riesca a render conto anche di quei fatti o eventi che hanno mandato in frantumi la teoria precedente. Pertanto educare alla mentalità critica equivale ad educare a riconoscere i nostri errori e quelli degli altri. L’educazione critica è l’educazione alla caccia sistematica dei nostri errori e degli errori altrui. Sempre di più si ingrossa la schiera di quanti imitano mentalmente il comportamento dell’ameba. “Infatti siamo, ormai, circondati di infallibili. E questi infallibili sentono e non descrivono; esclamano e non argomentano; hanno paura e non si correggono; giudicano e non analizzano, distruggono e non costruiscono; si ubriacano dei migliori mondi possibili e a due mani lavorano, di fatto, perché questo mondo scivoli verso la notte del peggiore dei mondi possibili” (8). Ciò che resta è l’illusione magica dell’onnipotenza dello slogan e delle imprecazioni. Non ci si accorge che le imprecazioni e gli slogan hanno solo potenza sulle menti che li producono. Hanno il potere di anestetizzare i cervelli, di illudersi che le cose possano cambiare con uno slogan o che i problemi possano risolversi lanciando imprecazioni. Se non vogliamo regredire a comportamenti mentale esclusivi degli animali e perdere così il nostro essere uomini, dobbiamo portare avanti la nostra tradizione razionale fatta di problemi, di teorie audaci e di critiche severe, e regolata da standard quali la verità delle asserzioni e la validità delle argomentazioni. Dobbiamo seguitare ad essere razionali, cioè critici, se non vogliamo fare la fine dell’ameba, se vogliamo evitare di fare la fine del moscone che sbatte contro il vetro. Non dobbiamo immunizzare le nostre teorie e le nostre proposte, ma dobbiamo il più chiaramente possibile esporle alla critica. Più saremo chiari più saremo comprensibili. Se saremo comprensibili, gli altri ci potranno criticare, potranno trovare in noi degli errori, e quindi migliorarci. Non si è razionali se, invece di esporre le nostre teorie alla critica, le proteggiamo o con l’oscurità del nostro linguaggio, o con la continua invenzione immunizzante di ipotesi ad hoc. “E si capisce allora che non si comportano da esseri razionali, da esseri critici e quindi umani, né coloro che (al pari dei polipi che per proteggersi si gettano il nero) sprofondano nella notte dei discorsi pretenziosi e oscuri, né coloro che davanti al primo accenno di critica stanno lì a sentenziare con un fascio di cartelle cliniche alla mano che sei un “represso”, un “inibito”, un “alienato” o un “reazionario” o peggio ancora” (9). La scienza che pretende di essere intoccabile, assoluta, costruita per l’eternità non è scienza, è teologia della peggior specie. La scienza non ha fonti autorevoli, ogni teoria nasce per morire. Anzi, prima muore, meglio è, poiché prima muore prima avremo trovato quell’errore che ci farà fare un balzo in avanti. Chi ha paura dell’errore ha paura della fallibilità umana, ha paura di essere uomo. Pretende diabolicamente, di essere come Dio, di essere infallibile.
LA VERITA’ E LA TRADIZIONE CRITICA
L’infallibilità possiede la verità, gli altri sono nell’errore, e debbono essere ricondotti sulla retta via. Oggi viviamo in un mondo di infallibili e di utopisti, di giudici e di moralisti assolutisti pieni di odio e di vendetta, soprattutto pieni di verità. “Magistrati della verità”, “nel campo di coloro che cercano la verità – disse infatti Einstein – non esiste alcuna autorità umana. Chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli dei” (10). “La verità non è un possesso, come pretendono assolutisti, dogmatici ed essenzialismi di ogni specie. La verità la si conquista con fatica (e spesso con fortuna) un po’ alla volta: ed è strano che coloro che dicono di conoscere la verità nella sua totalità non sappiano curare ancora il cancro o non si avvedono che ogni verità, anche piccola, è costata sofferenze e fatiche di secoli. La verità non è un possesso, è una conquista che si fa a fatica, un po’ alla volta, tentando, sbagliando e correggendosi. La verità è un ideale regolativo. Ci avviciniamo continuamente alla verità per mezzo di teorie sempre più simili al vero, costruendo e provando teorie sempre più ricche di contenuto informativo” (11). Bisogna avere il coraggio e l’accortezza di andare sistematicamente alla caccia degli errori, se vogliamo andare avanti, se amiamo la verità per costruire e provare teorie migliori sempre più ricche di contenuto informativo, sempre più simili al vero. L’Occidente si caratterizza, tra l’altro, perché è erede di quella che si chiama tradizione razionale o tradizione critica che è nata, come ci ricorda Popper, con la scuola nella quale si consentiva ed incoraggiava la discussione critica fra scuole diverse, e, ancor più sorprendente, all’interno di una stessa scuola. Fu proprio Talete a fondare la tradizione di libertà basata sul rapporto tra maestro e allievo. La scuola ionica fu la prima n cui gli allievi criticarono i loro maestri, una generazione dopo l’altra. Si possono avere pochi dubbi sul fatto che la tradizione greca della critica filosofica ebbe la propria fonte principale nella Jonia. L’introduzione della critica fu un’innovazione senza precedenti in quanto comportò una rottura con la scuola dogmatica, che ammette un’unica dottrina della scuola, e l’introduzione al suo posto di una tradizione che ammette una pluralità di dottrine, tutte miranti al perseguimento della verità attraverso la discussione critica. La tradizione critica o razionalistica fu fondata in quella sola occasione. Si esaurì dopo due o tre secoli, forse in seguito all’affermarsi della dottrina aristotelica dell’episteme, della conoscenza certa e dimostrabile. Essa venne riscoperta e consapevolmente restaurata nel Rinascimento, specialmente ad opera di Galileo Galilei (12). La tradizione della discussione critica non è dato acquisito una volta per tutte: essa è un compito, una conquista da mantenere. Una volta che si saranno capite e accettate tutte le sue regole, non si sarà né scettici né dogmatici. “essa ci mette sulle spalle la croce dell’inquietudine e della responsabilità personale contrariamente al dogmatismo che, invece accarezza la nostra ignoranza e dà il senso dell’onnipotenza. Le idee dei dogmatici, ebbe a dire Bernard, non fanno altro che lusingare il loro orgoglio e nascondere la loro ignoranza” (13). Lo scolastico e il sistematico non dubitano mai delle loro ipotesi alle quali vorrebbero ricondurre tutto; essi sono orgogliosi e intolleranti e non accettano alcuna contraddizione, poiché non ammettono che l’ipotesi originaria possa essere sbagliata.
IL METODO SCIENTIFICO
La tradizione critica è un compito. E’ un dovere comportarsi come Einstein piuttosto che agire come l’ameba. E’ un dovere a volte duro, una fatica, poiché è più facile fare come l’ameba. Questo dovere, questo compito, trova il suo luogo naturale nell’esercizio della razionalità scientifica, nella consapevole assunzione del metodo scientifico allorché ci si trova davanti ai problemi da risolvere. Cerchiamo di descrivere sinteticamente la concezione del metodo scientifico raccogliendo ed ordinando le osservazioni fatte nei paragrafi precedenti. Il metodo scientifico si può riassumere in questi tre momenti:
1] Inciampiamo in qualche problema;
2] ne tentiamo la soluzione proponendo, ad esempio. Qualche nuova teoria;
3] impariamo dai nostri errori, specialmente da quelli a noi svelati dalla discussione critica.
Per dirla in tre parole: problemi, teorie, critiche. “La ricerca inizia sempre da problemi, pratici e teorici. E chi è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto; i suoi occhi sono spenti. E’ questa l’opinione di Einstein. Ma è ovvio che noi inciampiamo nei problemi (e in questi piuttosto che altri) perché siamo una memoria, siamo eredi di una tradizione in evoluzione. E quando un pezzo di realtà urta contro una aspettativa incastonata nella nostra memoria, allora insorge un problema. Un problema è sempre un’aspettativa delusa (14). La ricerca parte dai problemi. Ma per scoprire la verità dobbiamo imparare a sognare, perché non c’è nessun metodo logico per avere nuove idee. Dobbiamo tentare, immaginare, costruire ipotesi, inventare mondi possibili con la speranza che uno di questi mondi riesca a rendere conto del frammento di realtà affiorato con il problema” (15). L’aggancio tra mondo possibile (costituito dall’ipotesi) e realtà viene decretato nel processo della prova. Le ipotesi vengono provate. La prova consiste in severi tentativi di smentire o falsificare la soluzione proposta. Vogliamo smentire le ipotesi, perché desideriamo trovare in esse degli errori. Vogliamo trovare degli errori il più presto possibile per poterli eliminare subito proponendo teorie migliori, più simili al vero, più ricche di contenuto informativo e quindi più controllabili. L’esperimento e l’osservazione sono il tribunale dell’immaginazione teorica. Esperienza è il nome che ciascuno di noi dà ai propri errori. Nella scienza si va avanti perché non si sbaglia mai due volte allo stesso modo. Ogni giorno, nella ricerca scientifica, si corregge un errore, si migliora la verità, ogni giorno erriamo meno della vigilia e impariamo a sperare di fare meglio del domani. Problemi, teorie, critiche: sono questi i punti cardinali della logica della ricerca. Se le cose stanno così, anche lo storiografo della scienza dovrà partire dalla ricostruzione congetturale di stati problematici oggettivi, per poter successivamente capire la rilevanza delle teorie proposte come soluzioni dei problemi, e passare, infine, all’analisi dei tipi di prove addotte pro o contro le teorie proposte. Certo, la scienza, oltre ad una logica, ha anche una storia. Nella storia della scienza ci sono più cose di quante se ne possono supporre nella logica della scienza. “Problemi – teorie – critiche: è questa la logica della ricerca scientifica e, simultaneamente, lo schema evolutivo della scienza. Ma dove sono i problemi dell’insegnamento delle scienze ? In genere, i problemi, nell’insegnamento delle scienze non esistono. E, quando esistono, sono in fondo al testo, stampati in corpo minore, concepiti come il banco di prova di quanto di teorico un alunno avrebbe dovuto apprendere senza motivazione alcuna. Eppure, è chiaro che non si danno risposte se non si pongono domande” (16). Per questo, bisogna partire dai problemi dei ragazzi e offrire o cercare teorie per la soluzione. Se una comunità scolastica avrà inciampato in problemi entusiasmanti non ci sarà pericolo né del nozionismo né del “ricerchiamo”. Sono i problemi e le teorie, infatti, che hanno il potere di vivificare una nozione o una informazione irrilevante. Un problema e una teoria trasformano una nozione qualsiasi in una nozione rilevante o importante: rilevante per il problema e per la conferma o la smentita di quelle teorie in competizione. D’altro canto, l’epistemologia ci indica la via di un sistematico sfruttamento pedagogico dell’errore. La storia della scienza è la storia di errori individuati e poi eliminati e in primo luogo commessi. Occorre dunque avere il coraggio di sbagliare se vogliamo andare avanti, se vogliamo risolvere i problemi. Se amiamo la verità, dobbiamo amare di essere criticati e di criticare. Per tutto ciò la scoperta di un errore, dovrà essere salutata da un momento di gioia. Non ogni verità, infatti, ci indica una via da seguire, ma ogni errore ci indica una via da evitare. Non c’è da vergognarsi dei propri errori; c’è invece da vergognarsi del desiderio di coprire l’errore, della volontà di immunizzare le nostre teorie dalla critica. Il metodo scientifico ci fa distinguere l’ameba da Einstein (17). Il metodo non è da confondersi con le tecniche di prova o, come spesso si dice, con le metodiche. Proprio su questo ultimo punto occorre insistere un po’ perché resta proprio qui la sorgente di continue confusioni. Il metodo della ricerca, infatti, non è da confondersi con le tecniche di prova. Queste variano da ambito ad ambito, anzi da problema a problema, ma il metodo resta unico. Le tecniche di prova mutano da ambito ad ambito, da disciplina a disciplina. Di più: mutano da problema a problema (combinandosi e disgiungendosi). Eppure, le teorie delle diverse discipline (fisica, filologia, chimica, sociologia, biologia, economia, psicologia, ecc.) le diciamo tutte scientifiche, pur provandole con tecniche o metodiche o mezzi diversi, se rispettano i canoni del metodo scientifico. Il metodo scientifico è unico. E’ costruibile una teoria unificata del metodo o della metodologia scientifica. Nella scienza non ci sono semi-dei. Non c’è garanzia contro l’errore. Possiamo sempre sbagliare. Andiamo a caccia dei nostri errori per migliorarci. I nostri errori, infatti, sono i segnali di senso vietato sul difficile sentiero che ci porta fuori dall’oscurità della caverna.
LE SGRAMMATICATURE DEL PENSIERO
La nostra scuola è malata. Malata di tante malattie. Si parla di ricerca, e si danno nozioni, nozioni irrilevanti per i problemi e le teorie. Si parla di critica e si offrono dogmi. Si parla di spontaneità e s’impongono interessi. Si parla di analisi, ma si producono slogan. Mai, come oggi, si parla di confronto, ma guai ad avanzare una tesi divergente: una schiera di inquisitori, tutti possessori o legittimi interpreti della verità, ti saltano addosso. Escono uno appresso all’altro libri sulla creatività, ma il conformismo è dilagante. “Nozionismo, ricerchismo, dogmatismo, confusione, conformismo e intimidazione morale non sono parole al vento. Indicano malattie precise. E sono anche, e prima di tutto, contravvenzioni continue alle prescrizioni della metodologia scientifica. Sono sgrammaticature del pensiero” (18). Ecco perché è importante insegnare a pensare scientificamente: a guardare ai problemi, a cercare o a inventare congetture e a provarle; a trovare errori e a tentare di eliminarli. E’ importante insegnare a pensare così. Significa curare la continua tentazione di cadere nel nozionismo (e quindi nel disinteresse) e nel dogmatismo (e pertanto nello slogan e nella violenza). Significa capire che i problemi non si possono risolvere lanciando gli improperi. A questo scopo è di estrema rilevanza ed è urgente portare gli studenti a contatto con la storia della scienza, con la storia faticosa, piena di audacia, di tenacia, di sofferenze, di errori, di colpi di fortuna e di ostacoli, con la storia che gli uomini di scienza hanno fatto per conquistare, pezzo a pezzo, anche quelle verità che a noi oggi sembrano tanto banali. Nelle nostre scuole la storia della scienza è pressoché assente. Quello che soprattutto sconcerta è come si possa pensare di capire il mondo moderno se non si capisce veramente quali e quanti problemi la scienza ha generato. Noi di pestilenze e di malattie infettive abbiamo forse si o no l’idea: ma le stragi di peste, di vaiolo o di colera hanno decimato eserciti o spopolato città; sono state una delle cause principali del crollo di alcune civiltà. Ebbene, l’immunologia ha risolto questi problemi, ma risolvendo questi problemi, ha contribuito in larghissima misura a generare l’altro urgente problema della sovrappopolazione. La scoperta del vapore è stata una delle ragioni principali della rivoluzione industriale. L’utilizzazione del petrolio, come fonte di energia, ha fatto venire alla ribalta del mondo politico i paesi ricchi di petrolio; e la scoperta di una fonte di energia non inquinante a e buon mercato potrebbe in poco tempo sconvolgere dalle radici i rapporti economici e politici internazionali. La polvere da sparo rese la guerra più terribile; l’energia atomica l’ ha resa inconcepibile. L’elettricità ha reso giorno la notte; e se proviamo a pensare ad un mondo senza elettricità, forse siamo indotti a pensarlo inabitabile, eppure l’elettricità ha poche decine di anni. “La scienza ha risolto problemi; la scienza ha generato problemi: la scienza rovescia sul mondo delle cose e degli uomini valanghe di conseguenze. Se ci interessa la storia degli uomini, la storia cosiddetta civile, non possiamo trascurare la storia della scienza” (19).
LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
Antiseri ha dedicato due studi fondamentali a “Epistemologia e didattica delle scienze” (20) e a “Epistemologia contemporanea e didattica della storia” (21). In questi studi egli compie una specie di inventario delle conseguenze didattiche che si pongono trarre dalle premesse epistemologiche. Perché epistemologia e didattica e non epistemologia e pedagogia? Un discorso puramente pedagogico farebbe correre il rischio di non affrontare i problemi reali e concreti dell’opera educativa e didattica. Il rapporto tra pedagogia e didattica nel pensiero di Popper ed Antiseri è diretto. Non è che la didattica si identifichi con la pedagogia, però un discorso pedagogico coerente e corretto conduce alla didattica come momento in cui il problema pedagogico trova la sua risoluzione. Per questo Antiseri insiste sul rapporto Epistemologia – didattica sottolineando, in larga misura, il discorso pedagogico. Del resto crediamo giustificata questa posizione proprio per non cadere nel verbalismo pedagogico in cui sono fin troppo pieni i manuali scolastici. Ciò di cui abbiamo bisogno è di affrontare problemi concreti e su basi epistemologiche, cioè corretti sul piano logico, produrre ipotesi significative di soluzione, provarle per individuare gli errori, superarli, come deve fare ogni ricerca logica che voglia effettivamente far progredire l’uomo. Proprio sulla base del discorso epistemologico possiamo considerare la didattica una scienza applicata, perché essa punta l’attenzione sulle condizioni iniziali del processo educativo e, sulla base di queste, perviene ad ipotizzare ed a dedurre possibili fatti e sviluppi futuri. La didattica come tutte le scienze, procede attraverso problemi, teorie, critiche. I problemi sono quelli che la realtà stessa dell’opera educativa pone incessantemente. Come per le altre scienze, anche qui occorre selezionare i più fecondi. Le teorie sono tentativi di risolvere problemi, tentativi fondati su ipotesi razionali. Le critiche, sono le prove delle teorie finalizzate alla scoperta degli errori, in modo da pervenire a teorie sempre migliori, più efficaci e più produttive, meno falsificabili, anche se non ve ne potrà mai essere una senza errori. L’insegnamento, per risultare veramente motivato, cioè tale da suscitare l’interesse e la partecipazione degli allievi, deve partire dai problemi. Si dice spesso che il punto di partenza devono essere sempre le esperienze. Come si è dimostrato le esperienze sono insignificanti fino a quando non divengono problemi. L’insegnamento di ogni disciplina dalle scienze alla storia, dalla lingua alla matematica, punterà sul valore della tradizione (22). Non si può partire daccapo, cioè ignorare la cultura attuale, che è frutto di sofferenze ed esperienze di generazioni e generazioni. Se il punto di partenza sono i problemi emergenti dalla tradizione, gli sviluppi dell’insegnamento si possono individuare nei seguenti punti:
Interdisciplinarità
“Ad evitare pseudo-problemi sarà bene dire subito che cosa non è l’interdisciplinarità. Ebbene, l’interdisciplinarità, prima di ogni cosa, non consiste nel parlare di tutto o un po’ di tutto. I tuttologi possono fare solo discorsi da bottega di barbiere. L’insegnante tuttologo potrà, al massimo, essere un salottiero dilettante, ovviamente presuntuoso ed ignorante. L’onnisciente è un dilettante. (…) L’interdisciplinarità non consiste nemmeno, come spesso si dice e si fa, nel prendere un periodo, un autore, un evento o una istituzione per parlarne da più punti di vista. Così, per essere espliciti, si è preteso di fare lavoro interdisciplinare scegliendo un periodo, il Seicento per esempio, lasciandovi parlare sopra il professore di italiano, quello di scienze, quello di storia dell’arte, l’insegnante di religione, e, ovviamente, il professore di filosofia (…). Questo tipo di lavoro pluriprospettivistico non è ancora ricerca interdisciplinare. In breve: la ricerca interdisciplinare non consiste e non è paragonabile ad un album fotografico (23)”. Poiché non esistono discipline a sé, ogni problema richiama gli altri e il metodo scientifico è interdisciplinare. L’interdisciplinarità non è qualcosa da aggiungere a diversi insegnamenti; non si realizza ricercando collegamenti più o meno esteriori, essa è pluralità unitaria. Antiseri, come Popper, difende pertanto il pluralismo che solo può garantire sia la logica della ricerca sia la libertà politica o culturale, sia un insegnamento aperto, critico e costruttivo.
Motivazione all’insegnamento e all’apprendimento
Le motivazioni all’insegnamento e all’apprendimento non possono essere estrinseche e cioè voti, premi, castighi e tutto l’armamentario di cui si è circondato a lungo l’insegnamento; le motivazioni vere ed autentiche sono quelle intrinseche. Tutto sta a saper partire bene. Se, come punto di partenza, si assume un libro di testo fatto di nozioni, cioè di princìpi, di esperienze, di idee da apprendere e da ricordare non ci possono essere motivazioni intrinseche. E’ solo partendo dai problemi che si realizza la motivazione intrinseca dell’apprendimento. I problemi possono essere posti anche da un libro di testo fatto bene, ma possono ancor meglio essere costruiti dentro la classe, attraverso la ricerca, sulla base delle esperienze e delle tradizioni, dai ragazzi stessi sotto la guida di docenti consapevoli che quello della problematizzazione è il metodo da seguire (24). Partire dai problemi è il primo passo ma non ci si può arrestare ad essi; occorre che si orientino e guidino i ragazzi a cercare teorie per la soluzione dei problemi stessi. Compito dei docenti è quello di saper fare inciampare i ragazzi nei problemi più profondi, più ampi, e cercare di offrire teorie per la risoluzione di tali problemi. Questo vuol dire procedere sulla base di una programmazione scientifica e interdisciplinare e non affidarsi allo spontaneismo, al caso, al pressappochismo.
Programmazione
Non volere la programmazione vuol dire correre il rischio di cadere nel ricerchiamo, nello spontaneismo irrilevante e dispersivo; la consapevolezza di questi due errori opposti e il fatto che l’epistemologia ci indica la via di un sistematico sfruttamento pedagogico dell’errore ci conducono a considerare la programmazione come un’ipotesi di lavoro, che prevede la consapevole scelta di certi problemi, quelli più rilevanti.
Fantasia creatrice di ipotesi
Una didattica fondata sui problemi, su quelli più significativi, coinvolgenti i ragazzi, scatena la loro fantasia creatrice di ipotesi, per cui essi divengono veramente attivi, perché si fanno artefici della ricerca per risolvere i problemi. E’ questa la via attraverso la quale si superano il disinteresse, il ricerchiamo, il nozionismo e il dogmatismo a tutti i livelli.
L’errore
Non bisogna aver paura di sbagliare, anzi occorre avere il coraggio di ricercare e affrontare l’errore (25). Per andare avanti sul serio, i ragazzi, come i docenti, debbono essere messi in condizione di avere il coraggio di sbagliare, di riconoscere gli errori per impegnarsi a costruire ipotesi sempre più nuove, valide e più significative. Se amiamo la libertà, dobbiamo amare di essere criticati e di criticare; la scoperta di un errore, in una comunità scolastica, dovrà essere salutata come un momento di gioia. Sulla base di queste considerazioni, esaminiamo i problemi più rilevanti della didattica su basi epistemologiche ed in prospettiva democratica. Prima fra tutti il problema dell’interdisciplinarità (26) che scaturisce dalla stessa impostazione razionale e critica del pensiero di Antiseri. Sul piano didattico quello dell’interdisciplinarità è, senza dubbio, il motivo centrale, più fecondo e di più viva attualità di Antiseri. Del resto tutta la didattica contemporanea si muove chiaramente in direzione dell’interdisciplinarità, perché si è assunta consapevolezza che solo essa può garantire al processo formativo la necessaria unità nella pluralità delle componenti in cui essa si articola. L’interdisciplinarità non si restringe al solo ambito dell’apprendimento e del processo formativo; essa è l’altra faccia della vita reale strutturata sulla divisione del lavoro nel processo produttivo e nell’organizzazione dei servizi. Pertanto vi è parallelismo ed interdipendenza tra la “scuola delle discipline” in cui queste sono una accanto all’altra, una dopo l’altra ed una senza l’altra ed “il mondo del lavoro”, in cui l’uno lavora accanto all’altro e senza l’altro. E come è mostruosa ed alienante la divisione del lavoro, altrettanto è mostruosa ed alienante la scuola delle discipline. La divisione alienante del lavoro è un fenomeno macroscopico, tale da attirare l’attenzione di tutti per cui tutte le società oggi si trovano a dover urgentemente affrontare tale problema; la scuola delle discipline separate è un fenomeno altrettanto macroscopico ma, forse per routine, forse per altri motivi essa non si è posta come problema in modo così netto ed in termini così drammatici. Ciò non toglie che non sia urgente allo stesso modo la soluzione del problema della divisione del lavoro quanto la soluzione del problema della divisione del lavoro quanto la soluzione del problema del superamento della divisione delle discipline; anzi Antiseri rileva, attraverso un’analisi puntuale e precisa, che non si può avviare a soluzione uno di questi problemi senza parallelamente avviare a soluzione anche l’altro; i due fenomeni e le due problematiche sono infatti interdipendenti (27). Antiseri affronta la problematica dell’interisciplinarità mettendo in evidenza che “l’interdisciplinarità presuppone la multidisciplinarità” e cioè le discipline o teorie nella loro autonomia e strutturazione linguistica. L’interdisciplinarità non è materia d’insegnamento; non esiste il professore di interdisciplinarità (28). L’interdisciplinarità non è prerogativa di nessuna disciplina; essa è piuttosto un modo di impostare i problemi, una mentalità, una maniera di condurre un insegnamento, che sfugga ai pericoli delle discipline una accanto all’altra, una senza l’altra. Il lavoro interdisciplinare scatta dovunque c’è da risolvere un problema non banale ed esso consiste nella cooperazione “competente” dei diversi esperti alla soluzione di questo problema. Alla spiegazione di un “fatto” storico contribuiscono il sociologo, l’economista, il politico, ecc.; la costruzione di un ospedale pediatrico non è certo affidata ad un solo competente, ma c’è il matematico che risolve i compiti che gli pone l’architetto e questi non può non ascoltare lo psicologo e l’urbanista, e costui non può certamente fare i suoi conti senza il contributo dell’economista, e di tutti quanti debbono dare una occhiata alle “significative” statistiche del sociologo; e, ancora, l’interpretazione, ad esempio, di un testo filosofico, non è funzione esclusiva del filosofo; accanto a costui, infatti, ci sarà il filologo, il sociologo, il linguista, lo psicologo, ecc. Dal punto di vista conoscitivo, l’interdisciplinarità effettua il recupero dell’unità nella comprensione del sapere, unità che si è frantumata nel corso della ricerca scientifica, la quale procede sulla via di una specializzazione progressiva. Il lavoro interdisciplinare, pertanto, non consiste nell’apprendere un po’ di tutto, ma nell’impostare il problema con tutta la competenza dello specialista che tiene conto dei problemi, delle difficoltà, delle spiegazioni e delle previsioni degli altri competenti. Questa impostazione del problema dell’interdisciplinarità conduce in modo corretto e coerente al lavoro di gruppo come via e metodo di lavoro interdisciplinare. L’interdisciplinarità che si realizza attraverso il lavoro di gruppo dei docenti e discenti, potrà essere uno dei fattori che contribuiscono allo sradicamento della competizione nella scuola, in quanto spinge a vedere nell’altro un collaboratore e non un rivale. L’interdisciplinarità è una lotta contro gli effetti alienanti della divisione del lavoro. Il lavoro interdisciplinare può prendere i suoi inizi da qualsiasi tema o problema che venga affrontato in una molteplicità di discipline. Esso può progredire, a livello epistemologico, allorché le strutture logiche e i procedimenti di verifica di una disciplina sono messi a confronto, o in correlazione, con quelli di un’altra disciplina. L’interdisciplinarità deve diventare l’imperativo capace di trasformare un insegnamento atomizzato in una scuola in grado di configurarsi come centro produttore e diffusore di grammatiche di lettura del mondo in cui viviamo. Tutti coloro che sono impegnati nell’opera educativa devono realizzare un effettivo lavoro di gruppo per costruire significative ipotesi di lavoro interdisciplinare. Potremmo dire che l’interdisciplinarità è collegialità ed è partecipazione in atto e, come tale, è democrazia. Antiseri, con precisa conoscenza della situazione della nostra scuola, coglie la valanga di difficoltà che si trova a dover affrontare chi intende realizzare il lavoro interdisciplinare. Scrive testualmente: “Orari, il giorno libero, interrogazioni, registro, programmi, una legislazione per molti aspetti inadeguata, mancanza o comunque insufficienza della biblioteca, scuola non a tempo pieno, spesso rivalità tra gli insegnanti – che a parità di funzioni – sono gerarchizzati secondo i criteri più strani, litigi tra il corpo insegnante e il preside, spessissimo mancanza di aule e locali (…), maldicenze e populismo a buon mercato sono alcuni dei fattori negativi che vietano il lavoro interdisciplinare, il quale lavoro se è vero che comporta competenze precise, implica, almeno in un primo momento, anche una buona dose di abnegazione e, diciamolo pure, di umiltà nei confronti delle altre competenze (29)”. Per un iter corretto e produttivo sul piano didattico, Antiseri prospetta come punto di partenza i “centri di interesse”, rilevando che gli alunni possono interessarsi ad un problema per i motivi più disparati. I motivi per cui si deve partire da centri di interesse sono da individuare nel fatto che questi rendono possibile l’aggancio ai problemi concreti della vita di oggi; partire dai centri di interesse significa non deludere le attese dei giovani e sollecitare i loro interrogativi. L’interdisciplinarità, quindi, non è un fatto, un dato, un punto di partenza, bensì è imperativo, un metodo di conquista dell’unità nella multidisciplinarità. Dato che l’interdisciplinarità richiede il superamento della competizione, del settorialismo, delle chiusure specialistiche, essa concorre a formare mentalità aperte a un progetto interdisciplinare. In questo modo tutti sono indotti a vedere nell’altro non un nemico, bensì un collaboratore da cui possono ricevere ed a cui possono dare. Il fatto, poi, di lavorare non uno accanto all’altro, ma uno con l’altro rende chi vi partecipa capace di confronto, di verifica, di autocontrollo, di solidarietà. Questo vuol dire far “scuola di democrazia”. A noi preme sviluppare soprattutto il discorso relativo alla didattica delle scienze. Antiseri sviluppa un ampio, fecondo e costruttivo discorso su epistemologia e didattica delle scienze (30). La didattica delle scienze deve formare il soggetto alla metodologia della scienza che è fatta di problemi, teorie e critiche. L’acquisizione di un metodo scientifico forma il soggetto in quanto lo rende capace di costruire i problemi, di formulare le ipotesi, di verificarle, cioè forma una mentalità concreta, razionale, critica. I problemi sono il punto di partenza dell’insegnamento della scienza come di ogni altro insegnamento e, come problemi veri, sono auto-motivanti, vale a dire che motivano intrinsecamente il soggetto al ricercare, progettare, al fare. La didattica delle scienze, procedendo dai problemi, dalle ipotesi alle verifiche, promuove una “creatività emotiva” e richiede che gli alunni, con la loro fantasia, costruiscano ipotesi significative. L’insegnamento delle scienze promuove la formazione di una mentalità rigorosa perché educa il soggetto all’osservazione, a costruire ipotesi, a riconoscere gli errori, a compiere verifiche. Tutto ciò vuol dire, in pratica, educare la mente al rigore logico e alla apertura democratica.
CREATIVITA’ ED EDUCAZIONE SCIENTIFICA
Qualunque cosa sia l’intelligenza, la creatività (31) ne è l’espressione più alta. Desideriamo che i nostri allievi non siano solo intelligenti, nel senso che capiscano quello che apprendono ma siano capaci di arrivare essi a nuove acquisizioni. Così ogni docente dovrebbe desiderare che i suoi allievi propongano altre ipotesi, idee, interpretazioni, rispetto a quelle da lui presentate. La creatività ha le sue leggi: non si sviluppa se non la stimoliamo. Un insegnamento trasmissivo, ripetitivo, fondato sulla trascrizione letterale, non spinge l’allievo a farsi proprie idee, proprie visioni. L’alunno “produttivo” è un alunno che stabilisce rapporti che propone sue ipotesi su quello che ha studiato, che scopre connessioni che il docente non gli ha indicato. Vygotsky parlò di “pensiero produttivo” facendo vedere come il pensiero possa andare oltre il mero dato, possa “vedere” quello che percettivamente non si vede: per esempio, noi non vediamo le spalle di una persona di fronte. L’adolescenza, rileva Piaget, vede un enorme sviluppo dell’immaginazione, della fantasia: in questo senso, l’adolescente è portato alle arti, all’immaginazione, a produrre mondi fantastici. E alla scuola spetta di saper costruire una didattica capace di far emergere queste capacità. Diremmo che una parte fondamentale della scienza e della pratica educativa è appunto quella di costruire modelli didattici capaci di far arrivare l’adolescente oltre il dato di fatto, oltre la realtà nella sua brutalità. Una didattica della creatività diventa educativa quando non solo permette di capire la realtà, ma anche gli strumenti per cambiarla. La creatività non è qualcosa che riguarda una disciplina specifica: erroneamente si può credere che riguardi essenzialmente l’arte. In realtà, gli epistemologi, oggi, rilevano che esiste una creatività e un’immaginazione nella scienza per esempio matematica, dove occorre appunto “immaginare” quale può essere la soluzione di un problema, l’esatta impostazione di un’equazione, etc., ma anche nel campo delle scienze naturali. In questo senso in tutti gli ordini della scuola l’insegnamento può mirare a far sorgere atteggiamenti creativi e ogni disciplina e ogni momento della vita scolastica, come nella vita familiare e sociale, può tendere a sviluppare la creatività. Puntiamo l’attenzione sull’evoluzione delle idee scientifiche. E’ chiaro che noi abbiamo bisogno di idee nuove e buone per la soluzione dei problemi che scoppiamo in ogni angolo della vita e della ricerca scientifica. Abbiamo bisogno di creatività nel lanciare ipotesi o congetture che riescano a risolvere i problemi che talvolta sono di difficoltà sorprendente. Per fronteggiare e risolvere questi problemi, non abbiamo un altro metodo che quello di inventare congetture o ipotesi e andare poi a vedere se queste sono o non sono valide. “Dobbiamo ipotizzare, congetturare, cioè teorizzare, vale a dire scatenare la nostra fantasia” (32). Ogni ipotesi è un sospetto; e, come tutti i sospetti, anch’essa va provata. Ma la prova, osservazioni ed esperimenti, presuppone sempre qualcosa da provare: questo qualcosa da provare sono appunto le ipotesi o congetture inventate come tentativi di soluzione dei problemi. Basta accostarsi appena un po’ alla storia delle idee e, particolarmente, alla storia della scienza e delle idee scientifiche per renderci conto dello sconfinato numero di ipotesi che, proposte per risolvere i problemi via via emergenti nella “polis” degli scienziati sono cadute contro l’urto dei fatti contrari. Dietro ad ogni problema che oggi consideriamo risolto c’è un cimitero di teorie sepolte, di tentativi falliti, “sciami di ipotesi si sono agitati attorno al problema del veleno delle vipere, attorno ai problemi della rabbia, del vaiolo, della peste bubbonica, del diabete, della tubercolosi e della difterite. Più di duemila anni e tentativi senza fine sono occorsi per risolvere il problema della febbre da parto, quello dell’origine dei fossili o per addentrarsi nell’enigma della costituzione della materia. E ipotesi proliferano attorno ai problemi oggi tuttora irrisolti come quello del cancro” (33). Quindi è fuori dubbio che, per risolvere i problemi, c’è bisogno di creatività, di creare e inventare le soluzioni di questi problemi. C’è bisogno di idee nuove, ma non tutte le idee nuove sono buone. Idee buone le abbiamo anche in sogno. Esistono idee gratuite, sogni ad occhi aperti, idee campate in aria. Un’idea buona è veramente rara. Esistono schiere di ricercatori che la storia della scienza ha dimenticato, proprio perché di nuovo e buono hanno lasciato niente o quasi niente. E i ricercatori ricordati dalla storia della scienza sono ricordati il più delle volte per una o due idee. Le idee vivono e muoiono, muoiono se sorgono nuovi problemi per i quali esse risultano inadeguate. Occorre creare nuove idee in grado di risolvere nuovi problemi via via emergenti. Psicologi, pedagogisti e storici anche della scienza hanno affermato e affrontano il problema della creatività. Spesso pare che siano alla ricerca di una teoria del pensiero che ha successo. “Si dice che, per essere creativi, occorre essere spiritualmente ribelli nei confronti del sapere precedente. Si dice che per riuscire bisogna essere tenaci, e questo talvolta è vero; ma come si fa, se non a posteriori, a distinguere la tenacia dalla testardaggine o dal dogmatismo? Si dice che occorre sapienza ed erudizione per essere creativi ma non è raro il caso che si è creativi proprio perché si è ignoranti in ambiti che invece conosciuti avrebbero bloccato la ricerca”(34). In realtà, il successo in una ricerca può dipendere da molti fattori; anche le metafisiche possono essere feconde di teorie nuove e buone; ed anche gli errori possono essere fecondi. Non esistono fonti privilegiate di conoscenza. Quel che occorre è la passione per un problema e la volontà di risolverlo, “provando e riprovando”, tentando e correggendoci. La creatività, forse non può essere appresa, ma può certamente essere incoraggiata e favorita. Possiamo avviarci verso le idee creative mediante la lettura e la discussione, guidati dal sano principio per il quale non si troverà mai una risposta a una domanda che non sia stata formulata nella mente. Quindi: passione per i problemi e volontà di risolverli, inventando congetture e criticandole, costruendo cioè mondi possibili e cercando tra questi quello che descrive il mondo reale. “Ma tutto ciò sarà possibile se impareremo a non vergognarci dei nostri errori. Il panico dell’errore, ebbe a dire Whitehead, è la morte del progresso; e anche della creatività. Non saremo creativi se avremo paura di sbagliare (35)”. Se, infatti, avremo paura di errare, non avremo nemmeno la soddisfazione di indovinare. La creatività non può essere insegnata, ma può essere favorita.
NOZIONISMO E RICERCHISMO
Si parla molto di creatività, di pensiero creativo, di fantasia creatrice, di ricerca dell’impossibile, di dirompenti alternative create dalla fantasia. Se ne parla tanto. Senza allargare troppo il nostro orizzonte, limitiamoci all’ambito della scuola e della pedagogia. Che senso potrà mai avere parlare di fantasia e di creatività nell’insegnamento? E più specificatamente: che senso ha parlare di creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento delle discipline scientifiche? Qui si tocca una delle diversità fondamentali tra le cosiddette “due culture”: quella umanistica e quella scientifica. In quella umanistica, infatti, la creatività sarebbe di casa; in quella scientifica essa sarebbe esclusa. Per molti, nel campo delle discipline scientifiche, la fantasia non c’entra. “Le cose si sanno o non si sanno; e le cose che si debbono sapere, le teorie valide, sono nel manuale; quindi io uso il manuale, procedo in base al manuale e il ragazzo sarà preparato quando saprà quel che c’è sul manuale; l’importante è scegliere un buon manuale (36)”. Ebbene, in genere l’esito scolastico di questa presa di posizione è il famigerato e deleterio nozionismo. Nozionismo in due sensi: laddove la disciplina è più altamente teorica, come la fisica, la chimica o la biologia, si ha un nozionismo fatto di teorie; laddove la disciplina è classificatoria, come nel caso dell’anatomia e della botanica, si ha un nozionismo fatto di nomi e classificazioni. Nel primo caso, l’insegnante ha offerto teorie, cioè risposte senza suscitare domande; nel secondo caso, l’insegnante ha dato nomi di cose che poco interessano e che bisogna studiare solo per l’esame. Così anche le teorie più belle possono diventare nozioni: in questo modo, i nomi, le classificazioni, i teoremi e le teorie non interessano poiché rispondono a domande in cui i ragazzi non sono stati fatti inciampare. Queste cose si affacciano appena sulla soglia della mente e l’amnesia successiva è molto rapida. C’è però un’altra risposta che viene data all’interrogativo che prima ci siamo posti sul senso della creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento delle scienze: quella data dal tipo di pratica in uso ormai nelle nostre scuole a partire già dalla scuola dell’infanzia e che consiste nel fare ricerche. E’ questa una cosa ammirevole: il bambino, il fanciullo, l’adolescente e poi il giovane sviluppano la loro personalità in un ambiente fisico e sociale e si pongono tanti perché, tanti problemi. E’ quindi giusto che tenendo ben conto sia della psicologia dell’età evolutiva, sia dell’epistemologia genetica, i ragazzi siano stimolati alla creatività, a proporre ipotesi e a discuterle, cioè ad osservare e a trovare materiale per smentirle o corroborarle. Tutto ciò è giusto. Le cosiddette ore di “osservazioni scientifiche” sono, in genere, ore di diseducazione alla osservazione: questo nella scuola media. Spesso si fa non ricerca, ma ricerchismo: “fai una ricerca sul Nilo; fai una ricerca sul passero; fai una ricerca sullo scopritore del motore a vapore. Ma ci potrebbero essere domande più interessanti. C’è la catena dei problemi dell’ecologia, c’è il problema degli effetti della caccia, e tanti infiniti altri problemi in cui far inciampare i ragazzi e su cui far esercitare, guidandola, la loro fantasia, e l’acume critico. E se non si fa così, si fa ricerchismo: e del ricerchismo non si avvantaggiano certamente né la scuola né la maturazione degli alunni. Gli unici ad avvantaggiarsi del ricerchismo sono i fabbricatori di enciclopedie (37)”. Antiseri, in un articolo sulla concezione pedagogica e didattica di G. Vailati, riporta alcune considerazioni degne di essere attentamente valutate (38). Uno dei motivi che attraversano la riflessione pedagogica di Vailati è la sua avversione a quello che noi oggi chiamiamo nozionismo. Anche per la Matematica la scuola continua, malgrado tutto, ad essere piuttosto una palestra mnemonica che non un istituto di cultura intellettuale: l’allievo è occupato troppo a imparare e troppo poco a capire. Vailati, nel raccomandare una stretta connessione tra lo studio dell’aritmetica e quello della geometria, aggiunge che anche per quest’ultima disciplina – come nel caso dell’aritmetica – è da raccomandare che le prove sia scritte sia orali, dirette ad accertare il profitto degli alunni e la sufficienza delle loro cognizioni, consistano piuttosto nell’esigere da essi l’esecuzione di determinate costruzioni o la soluzione di dati problemi speciali, che non la ripetizione o enunciazione di regole e di teoremi, indipendentemente da ogni loro applicazione. Solo quando l’alunno abbia mostrato di saper fare, lo si invita a dire, chiaramente ed esattamente, ciò che ha fatto. Proprio per questo, Vailati propone come drastica terapia del nozionismo l’attività, il fare, il risolvere problemi. Non nell’indottrinamento verbale, ma all’allenamento, all’esercizio: ecco dove vuol portare la scuola Vailati. Per lui, la scuola va vista non come una sala di conferenze, ma come laboratorio, come luogo dove all’allievo è dato il mezzo di addestrarsi, sotto la guida e il consiglio dell’insegnante, a sperimentare e a risolvere questioni, a misurare e soprattutto a “misurarsi” e a mettersi alla prova di fronte ad ostacoli e difficoltà atte a provocare la sua sagacia e a coltivare la sua iniziativa.
L’USO DEL MANUALE
La scienza è fattore di storia e di cultura. Di conseguenza, se vogliamo capire la storia economico- sociale e la storia della cultura, allora lo studio della storia della scienza diventa imprescindibile. Tuttavia, non bisogna passare sotto silenzio il fatto reale e massiccio per cui l’immagine della scienza che le singole generazioni apprendono è quella che esse traggono dai manuali che (pur nella loro insostituibile utilità) sono quasi sempre aproblematici, astorici e ametodologici. E, come ha detto Thomas S. Kuhn, “una concezione della scienza ricavata da essi non è verosimilmente più adeguata a rappresentare l’attività che li ha prodotti di quanto non lo sia l’immagine della cultura di una nazione, ricavata da un opuscolo turistico o da una grammatica della lingua (39)”. In effetti, il manuale riproduce le teorie assodate in un certo periodo, con i loro strumenti standard e le loro prove tipiche. E se muta qualche pezzo di scienza, muta anche il manuale. In tal maniera, ogni generazione esce dalla scuola con l’idea che la scienza sia un fatto certo, un tessuto di teorie assodate e invulnerabili, dietro alle quali c’è solo una preistoria di errori, e il cui futuro sarà dato forse soltanto da sempre migliori applicazioni. In sostanza: l’educazione manualistica distrugge l’idea che la scienza è una realtà storica, inculca l’immagine di una scienza dogmatica. La scienza, invece, è il frutto di discussioni e controversie, di fantasie ardite e critiche severe. Non possiamo confondere il linguaggio della scienza con quello dell’ideologia: “ma il crampo mentale – direbbe Wittgenstein – generato dalla confusione dei due giuochi di lingua, trova la sua scaturigine primaria nell’educazione manualistica che ad ogni generazione offre l’idea di una scienza senza futuro e con un passato di cui vergognarsi (40)”. Nella formazione di una mente critico-scientifica e nell’insegnamento della scienza, della storia della scienza come fatto essenzialmente storico, in cui la verità di oggi sarà verosimilmente l’errore di domani: mostrare che la scienza è frutto di tentativi ed errori, di congetture e confutazione, e che progredisce proprio perché apprende dai propri errori; far vedere che le teorie scientifiche sono smentibili, che sono umane e quindi non assolute, ma perfettibili. Bisogna tener presente che le teorie scientifiche si attuano in una tradizione. Il problema, in sostanza, è di sapere se l’educazione scientifica deve ridursi ad un addestramento o se, piuttosto, essa debba servire anche a fare dello scienziato un uomo dalla mente capace di giudicare il valore del suo lavoro in una tradizione, nella storia della cultura, nella storia di una società. La storia della scienza, inoltre, è necessaria per risolvere il grave problema della motivazione “psicologica” nell’insegnamento delle scienze. E le domande cui gli scienziati via via tentano di dare risposta emergono nel flusso della storia della scienza. A nessuno che abbia avuto occasione di trattare a scuola, davanti a dei giovani, qualunque soggetto che si riferisce alle parti astratte e teoriche della matematica, può essere sfuggito il rapido cambiamento di tono che subisce l’attenzione e l’interessamento degli studenti ogni qual volta l’esposizione, discostandosi per una circostanza qualsiasi dall’ordinario andamento dottrinale e deduttivo lascia luogo a delle considerazioni d’indole storica a considerazioni, per esempio, che si riferiscono alla natura dei problemi e delle difficoltà che hanno dato origine allo svolgimento di una teoria o alla introduzione di un metodo. Di questo appetito sano e caratteristico delle menti giovani per quella parte dei problemi loro presentati che istintivamente riconoscono come facilmente assimilabili, è certamente desiderabile trarre il maggior vantaggio possibile. Lo studio della storia della scienza è necessario per la comprensione della storia economico-sociale e per capire la storia della cultura ed è un possente strumento didattico per la motivazione ad apprendere. Paul K. Feyerabend è tornato sull’idea affermando che “l’intera storia di un argomento può essere utilizzata nell’intento di migliorare il suo stadio più recente e più avanzato (41)”.
INSEGNARE PER PROBLEMI
Insegnare per problemi significa stimolare l’educazione della mente critica, lo sviluppo delle facoltà di raziocinio, l’invenzione, l’esecuzione delle prove, la valutazione e la scienza delle teorie, le abilità nel manipolare strumenti, eseguire grafici, la capacità di risolvere problemi. La scuola dovrebbe spingere gli scolari a interrogare essi il loro maestro invece di essere interrogati da lui. “Credo che a tali risultati si riuscirebbe senza alcuna difficoltà se solo si avesse cura di distribuire la materia, che forma oggetto d’insegnamento, in modo che i giovani non dovranno mai imparare delle teorie prima di conoscere i fatti a cui essi si riferiscono, né sentire ripetere delle parole prima di essere in possesso degli elementi sensibili e concreti da cui per astrazione si può ottenere il loro significato (42)”. Non si dovrebbe temere di sminuire la dignità della scienza matematica col presentarla nella scuola sotto forme meno aride ricorrendo anche, se occorre, a problemi divertenti e capaci di stimolare la curiosità. La scuola è spesso stata – e talora lo è ancora – il luogo triste dove si danno risposte e domande non poste e a domande che non sempre l’allievo afferra. La scienza cresce passando da problemi a problemi più profondi. E così cresce la mente. E qui risulta fondamentale vedere la radicale differenza che corre tra problemi ed esercizi, e non scambiare nella teoria e nella pratica, gli uni con gli altri. Un problema è una domanda per la quale chi se la pone non ha ancora trovato una risposta. Un esercizio è, invece, una domanda per la quale chi se la pone ha già la teoria risolutiva che deve solo applicare. Da questa differenza discende che è sul problema che si innesca il processo di ricerca fatto di tentativi, prove, errori, mentre, in linea generale, chi deve risolvere un esercizio non ha bisogno di molta fantasia, non deve sbagliare, non deve, insomma, ricercare. Con tutto ciò non si vuole affatto sostenere che gli “esercizi”, vale a dire le “applicazioni” di scoperte siano sempre cose più semplici di una scoperta. Quel che, piuttosto si intende ribadire è che un problema non è un esercizio; una scoperta non è un’applicazione di una scoperta. E benché ci possano essere delle applicazioni geniali che somigliano tanto ad una scoperta, la scoperta è frutto di una creatività in genere non richiesta a chi applica la scoperta. Nella nostra scuola, dalle Elementari fino all’Università, specie per quanto riguarda le scienze e la matematica si espongono le teorie e poi si fanno i “problemi”: problemi di aritmetica, problemi di geometria, problemi di algebra e così via. Ma si tratta davvero di problemi o piuttosto abbiamo a che fare con esercizi? Non è difficile comprendere che i “problemi” con i quali ha a che vedere molta pratica scolastica non sono autentici problemi ma “esercizi”. “I problemi, come sappiamo, sono il primum della ricerca scientifica, ma dove sono i “problemi” in un libro di testo? Essi sono in fondo al testo, stampati in corpo minore. Stanno lì concepiti come banco di prova di quanto di teorico un allievo avrebbe dovuto apprendere (senza motivazione alcuna); stanno lì, appunto, come applicazioni delle teorie esposte, già confezionate, nelle pagine precedenti del testo (43)”. Essi, in realtà, non sono problemi ma esercizi. E, non essendo problemi, eliminano di un sol colpo “la logica della scoperta scientifica”: il giovane non deve scoprire proprio niente, giacché tutto è stato scoperto; non deve usare fantasia, non deve sbagliare. Egli non deve essere uno scopritore, ma solo un esecutore. L’aver scambiato l’esercizio per il problema è un grave errore. E questo errore rende minimo o quasi nullo il lavoro immaginativo nella soluzione di alcune specie di problemi. L’immaginazione di un alunno resta pressochè inoperosa nel risolvere qualsiasi problema una volta che è venuto in possesso della formula, o nel risolvere un problema quando ne ha risolti altri della stessa specie. In breve, la ricerca non è routine. E se la soluzione dei problemi richiede attività costruttrice, per gli esercizi ci vogliono memoria ed abitudine. L’abitudine, se facilita il lavoro, non ha forza perfezionatrice. Il suo carattere è la stabilità e l’immobilità; mentre il perfezionamento e il cambiamento continuo e graduato che ci avvicina a un ideale sempre più adulto. Dunque il problema non è un esercizio. Ed è un errore dannoso per la formazione degli allievi scambiare gli esercizi per problemi. Dobbiamo forse abolire nell’insegnamento delle scienze e della matematica gli esercizi? Non è forse vero che la scuola ha il compito di trasmettere agli alunni quello che la ricerca ha già ottenuto? Le teorie scoperte devono venire apprese e gli esercizi sono il banco di prova di quanto un allievo ha già appreso, sono anche un consolidamento, operato attraverso le applicazioni più svariate, delle teorie apprese. “Ebbene, di fronte a queste obiezioni occorre procedere punto per punto: 1] Non si tratta affatto di abolire gli esercizi; 2] non è compito specifico della Scuola, specie di quella Elementare, di quella Media e della Media superire quello di incrementare la scienza; 3] è fuori di ogni dubbio che la scuola, dalle Elementari sino all’Università, ha a che fare con un sapere già fatto” (44). Il problema vero qui è un altro: il sapere già fatto deve essere acquistato o conquistato? E’ questo il vero problema, giacché la diversa soluzione che ad esso si dà implica e coinvolge una differente concezione o idea di Scuola: se il sapere già fatto deve essere acquistato, la Scuola è una specie di mercato; se invece il sapere già fatto deve venire conquistato, allora la Scuola si trasforma in un laboratorio, in un centro vero e proprio di ricerca. Se il sapere deve essere acquistato, allora la mente umana è vista come un magazzino o un recipiente; se il sapere deve essere conquistato, la mente allora viene vista come risolutrice dei problemi, dotata di fantasia e di rigore, attiva e non passiva. L’importante, nella Scuola, è ri-fare il sapere già fatto, quel che davvero conta è ri-scoprire e ri-provare teorie già scoperte e provate. Un problema risolto per un uomo maturo non lo è ancora per il bambino. Occorre catturare i problemi degli allievi, esplorarne i presupposti cognitivi, e, in base a questi, far inciampare gli allievi in ulteriori problemi. E a questi problemi l’insegnante non deve dare la soluzione che l’allievo deve imparare a memoria. L’insegnante, piuttosto, si trasformerà in guida della ricerca; non inibirà la loro fantasia; faciliterà il confronto delle ipotesi; permetterà che i suoi allievi imbastiscano esperimenti per sottoporre a prova anche quelle ipotesi che lui, insegnante, sa già sbagliate, e in tal modo farà capire agli allievi che la scienza non solo è un prodotto sociale, un esito della collaborazione e della critica reciproca, ma anche, e soprattutto, che nella ricerca l’errore è inevitabile e che l’importante è apprendere dagli errori. In breve, all’allievo la scienza non va raccontata; l’allievo deve fare scienza: E deve ri-costruirla sotto lo stimolo dei problemi. Anche se, come scrive Mauro Laeng, “i nostri libri, per troppi decenni, sono stati invece repertori di risposte senza la scintilla di una domanda (45)”. In altri termini bisogna interessare l’allievo, stimolarlo alla ricerca e dargli di continuo la certezza che sia lui che scopra ciò che gli viene insegnato. Così l’alunno, mentre apprende e comprende meglio ciò che gli si insegna, fortifica il suo spirito d’iniziativa e si abitua alla ricerca. L’essenziale nell’insegnamento scientifico è il metodo stesso d’insegnamento. Insegniamo poco di scienze, ma insegniamolo scientificamente, vale a dire rifacendo le scienze e facendole rifare agli allievi. In tal modo i giovani, mentre elaborano la loro cultura, elaborano la loro mente, l’insegnamento così diviene, a un tempo, informativo e formativo. Se si trascura questo procedimento, se ciò non si insegna per problemi (sui quali far esercitare la fantasia costruttrice di ipotesi quali tentativi di soluzione di questi problemi), allora si può fare dell’alunno un recipiente pieno delle osservazioni altrui, ma non mai uno spirito originale, che sappia muoversi da sé anche nella sfera dell’investigare scientificamente. Occorre indurre l’allievo a porsi problemi; ogni problema è un’indagine proposta alla mente; la conoscenza di cento problemi risolti da altri non vale lo sforzo benefico compiuto da noi per la soluzione anche di pochi. In realtà, il difficile per lo scienziato sta nel sapere interrogare la psiche di colui a cui la scienza si vuole comunicare. In ogni caso, l’abile maestro saprà cogliere con intelligenza il momento in cui nel sapere di un singolo, di un gruppo o nell’intera scolaresca si aprono quelle crepe che sono i problemi: a volte il problema scoppierà a motivo di una lettura, a volte a causa di un racconto, a volte mentre si esegue un disegno, a volte quando si fa un esperimento; e poi ci sono gli infiniti eventi naturali a far sorgere domande urgenti e interessanti nella mente dei bambini; e brani di storia e di scienza catturano, quanto le favole, l’attenzione dei giovani. E le discussioni tra i ragazzi, a volte anche molto accese, crescono su problemi che l’insegnante non metterà a tacere. In una scolaresca, attraverso il fare e il discutere, i problemi di ogni singolo diventeranno i problemi di tutti, e su questo patrimonio comune si innescheranno altri problemi da risolvere, in una catena teoricamente senza fine. Ma, intanto, non dimenticheremo che un autentico problema non è un esercizio. Non è che gli esercizi (di aritmetica, di geometria, ecc.) non debbano essere fatti. Gli esercizi vanno fatti solo dopo che il problema è stato risolto. Soltanto dopo che si è ri-costruito un pezzo di sapere, soltanto dopo che si è capito perché la teoria è nata, per che cosa era necessaria, a cosa essa serve, solo allora è opportuno passare agli esercizi. Una teoria o formula o regola appresa a memoria proibisce il processo di ricerca e rende faticosi, quasi una tortura, gli esercizi. Una teoria o formula o regola riconquistata perché abbiamo inciampato nel problema che la richiedeva, invece, il prodotto di un genuino procedimento scientifico che scatena la fantasia, disciplinata dal rigore logico. E gli esercizi, dopo la ri-conquista della teoria, non saranno più una tortura, ma il più delle volte si trasformeranno in un piacevole gioco. Se si vuole davvero trasformare la Scuola delle nozioni (da imparare a memoria per poi dimenticarle) in Scuola della ricerca, l’attenzione ai problemi degli allievi, ai problemi per loro comprensibili, non è mai troppa. La scuola come centro di ricerca è un ambiente che cattura i problemi degli allievi, e li considera come primi anelli di una catena di ulteriori problemi che gli allievi, sotto la guida dell’insegnante, imparano a risolvere. Se invece è risolvere i problemi, allora imparare a risolvere problemi è anche imparare a vivere. Ma problemi e informazioni devono essere anche accessibili alla mente degli allievi, se vogliamo che nella Scuola non si parli a vanvera e si sprechi il tempo migliore. L’accessibilità di un problema, ossia il suo poter venire afferrato, il suo essere comprensibile alla mente degli allievi, comporta una previa e continua ispezione da effettuarsi, a seconda dell’età degli allievi e tenendo conto delle diverse situazioni, con i mezzi più vari: giochi, conversazioni, composizioni, discussioni, ecc., da parte dell’insegnante su quanto gli allievi già conoscono (e su come lo conoscono), sulle esperienze fatte, sul linguaggio posseduto. Senza questo basilare presupposto, la programmazione intesa in senso attuale e l’insegnamento tutto vengono vanificati.
NOTE
1) D.ANTISERI, Il pensiero di K.Popper: intervista ad Armando Armando, Servizio informativo Avio, n. 3-4, Armando, Roma, 1977, pag.123.
2) D.ANTISERI, L’interdisciplinarità, Servizio Informazioni Avio, n. 11-12, Armando, Roma, 1977, pp.418-419. Sullo stesso argomento si veda D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare, Armando, Roma, 1975.
3) K.R.POPPER, La ricerca non ha fine, Armando, Roma, 1978.
4) Cfr. di D.ANTISERI soprattutto: K.R.POPPER: Epistemologia e società aperta, Armando, Roma, 1972. Regole della democrazia e logica della ricerca, Armando, Roma, 1977. Teoria unificata del metodo, Liviana, Padova, 1981.
5) D.ANTISERI, Il pensiero di K.Popper: intervista ad Armando Armando, op.cit., pag.124.
6) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, Armando, Roma, 1977, pag.509.
7) M.BALDINI, Epistemologia e pedagogia dell’errore, La scuola, Brescia, 1986.
8) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op. cit., pag. 50-51.
9) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op.cit., pag.53.
10) La citazione è riportata in D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op.cit., pag.55.
11) D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici della interdisciplinarità, Armando, Roma, 1975, pp.31-32.
12) K.R.POPPER, Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 258-261.
13) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op.cit., pag:59.
14) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, Armando, Roma, 1977, pp. 83-84.
15) K.R.POPPER,Logica della ricerca e società aperta (antologia a cura di D.Antiseri), La Scuola, Brescia, 1989, pp. 8-9.
16) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, op.cit., pag. 7.
17) Su A.Einstein cfr. la raccolta di scritti: Come io vedo il mondo, Giachini, 1955.
18) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op.cit., pag.63.
19) D.ANTISERI, Regole della democrazia e logica della ricerca, op.cit., pp.65-65.
20) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, Armando, Roma, 1972.
21) D.ANTISERI, Epistemologia contemporanea e didattica della storia, Armando, Roma, 1974.
22) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, La Scuola, Brescia, 1985, pp.107-111.
23) D.ANTISERI, L’interdisciplinarità, Servizio Informazioni Avio, n. 11-12, Armando, Roma, 1977, pp.418.
24) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, La Scuola, Brescia, 1985, p.111.
25) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, La Scuola, Brescia, 1985, pp.55-58.
26) D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici della interdisciplinarità, Armando, Roma, 1975.
27) D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici della interdisciplinarità, op. cit., pp.10-15.
28) D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici della interdisciplinarità, op. cit., pag.70.
29) D.ANTISERI, I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare, Armando, Roma, 1975, pp.55-56.
30) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, op.cit.
31) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., Per il concetto di creatività si vedano soprattutto le pp.31-36.
32) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.31.
33) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.32.
34) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.35.
35) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.36.
36) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, op.cit., pag.157.
37) D.ANTISERI, Epistemologia e didattica delle scienze, op.cit., pag.158.
38) D.ANTISERI, Le concezioni pedagogiche-didattiche di G.Vailati, Motivi di attualità, in Pedagogia e vita, n.3, La Scuola, Brescia, 1988, pp.263-276.
39) TH.S.KUNH, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op.cit., pag.20.
40) D.ANTISERI, Le concezioni pedagogiche-didattiche di G.Vailati, Motivi di attualità, op.cit., pag.271.
41) P.K.FEYERABEND, Contro il metodo, op.cit., pag.40.
42) D.ANTISERI, Le concezioni pedagogiche-didattiche di G.Vailati, op. cit., pag.269.
43) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.187.
44) D.ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base, op. cit., pag.188.
45) M.Laeng, I programmi e la riforma, in AA.VV. I Nuovi Programmi della scuola elementare, Giunti e Lisciani, Teramo, 1984, pag.9.
DANIEL DENNET

Scheda di Astro Calisi – sito di riferimento: Il Diogene
VITA
Daniel Clement Dennet è nato a Boston nel 1942, si è laureato in filosofia ad Harvard nel 1963. Si è poi trasferito ad Oxford per lavorare con Gilbert Ryle, completando il dottorato in filosofia nel 1965. Dennet si è interessato di neuroscienze, linguistica, intelligenza artificiale, informatica e psicologia. Le sue ricerche hanno suscitato vasta eco nei settori delle scienze cognitive e i suoi scritti hanno avuto larghissima diffusione nel dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale. Dal 1971 insegna alla Tufts University di Medford (Massachusetts), dove è stato anche nominato direttore del Center for Cognitive Studies.
PENSIERO
L’intenzionalità
Dennet è approdato alla filosofia della mente passando attraverso un’accurata indagine sul concetto di intenzionalità, ovvero la peculiare caratteristica di alcune attività mentali (pensiero, coscienza, comprensione), messa in luce già da Brentano, di essere rivolte a un oggetto. La conclusione di Dennet è che l’intenzionalità si basa su nozioni che possono essere definite pseudospiegazioni, poiché le convinzioni, i desideri o gli atti volitivi a cui essa fa riferimento, non costituiscono la vera causa del comportamento umano, ma sono semplici etichette per descrivere ed, eventualmente, prevedere il comportamento stesso. L’intenzionalità, che deriva dalla psicologia del senso comune, non rappresenta un adeguato concetto esplicativo, dal momento che non può fare a meno di evocare una sorta di homunculus (eredità che ci deriva dalla concezione di Cartesio), posto alla base del nostro agire intenzionale e cosciente. L’unico modo per eliminare l’homunculus è quello di ignorare la soggettività dell’individuo, concentrando la nostra attenzione sulla struttura reale del cervello. In tal modo si può sostituire l’homunculus con tanti sottosistemi (folletti), ognuno dei quali svolge operazioni elementari: invece di parlare di fini o di intenzioni, analogamente a quanto avviene nei calcolatori, si può fare riferimento a subroutine di un programma a cui vengono assegnati compiti semplici e ben specifici.
Coscienza
Dennet ha successivamente affrontato il tema della coscienza, muovendosi in una prospettiva chiaramente funzionalistica. Egli non ritiene che ci sia una sostanziale differenza tra il modo di operare di un calcolatore e quello del cervello umano. In entrambi i casi si tratta di sistemi fisici (composti da un certo numero di sottosistemi). Non ha importanza il tipo di materiale con cui tali sistemi sono costruiti, bensì la funzione che essi svolgono. Dennet non nega l’utilità di attingere dati dalla soggettività individuale, ma nello stesso tempo ci invita a considerare con sospetto questi dati. L’evidenza con cui essi si presentano a un determinato soggetto non costituisce affatto una garanzia circa la loro veridicità. La capacità introspettiva della coscienza potrebbe addirittura essere frutto di un’illusione e noi non avremmo modo di smascherarla se ci affidassimo soltanto ad essa. Nella sua argomentazione, Dennet si richiama a Hume, all’analisi da questi condotta sul processo casuale. Prima di Hume, tutti i tentativi di spiegare perché si crede nella casualità muovevano dal presupposto che, quando si osserva una causa e poi un effetto, non si fa altro che vederne la necessaria connessione. Hume cercò di capovolgere questa impostazione osservando che essendo noi tutti stati condizionati ad aspettarci l’effetto allorché vediamo una causa, siamo irresistibilmente portati a trarre l’inferenza, e ciò fa sorgere l’illusione di vedere la connessione necessaria che lega il succedersi dei due eventi. Dennet propone una spiegazione analoga per la coscienza: «ci scopriamo a voler dire innumerevoli cose su ciò che sta accadendo in noi, e questo fa sorgere le varie teorie che spiegano come siamo capaci di dare resoconti introspettivi, tra le quali, ad esempio, quella ben nota ma semplicistica secondo la quale “percepiamo” questi avvenimenti con il nostro “occhio interiore”».
La questione dell’esistenza di un ente, od osservatore privilegiato, a cui farebbero riferimento i fenomeni dell’esperienza cosciente, torna prepotentemente in Coscienza. Che cos’è?. In quest’opera Dennet critica la tendenza diffusa tra i ricercatori a pensare che i sistemi percettivi forniscano “segnali in ingresso” a una qualche area centrale del cervello, la quale, a sua volta, utilizzi tali segnali per impartire comandi relativamente periferici che controllano i movimenti del corpo. Questo modello presuppone l’esistenza di un centro nel cervello verso il quale tutti i segnali convergono dando luogo al fenomeno della coscienza. Dennet chiama questa concezione Modello del Teatro Cartesiano poiché andrebbe appunto fatta risalire a Cartesio. Essa afferma l’esistenza di un ordine, di una linea d’arrivo in una parte definita del cervello, a seconda della quale l’ordine d’arrivo in quel punto corrisponde all’ordine con cui le esperienze “si presentano” al soggetto, poiché ciò che accade lì è precisamente ciò di cui diveniamo coscienti. Il fatto è che noi non abbiamo esperienza diretta di quanto avviene sulla nostra retina, nelle nostre orecchie, sulla superficie della nostra pelle. Nella nostra effettiva esperienza rientra soltanto il prodotto finito di questi diversi processi di interpretazione. Dennet riporta alcune situazioni sperimentali che mostrano come possiamo essere ingannati da ciò che appare. Ad esempio, dati due fenomeni collegati tra loro in rapida successione, in certi casi accade che nel nostro vissuto soggettivo il secondo influenzi il primo ancor prima di essersi verificato. Fenomeni del genere, osserva Dennet, sono piuttosto difficili da spiegare per mezzo della concezione che collega i contenuti di coscienza con l’arrivo di segnali in un determinato punto. Infatti, l’unica spiegazione razionalmente accettabile è che la percezione dei due eventi sia il risultato di una rielaborazione successiva. Le due esperienze distinte non fanno a tempo ad essere colte dalla coscienza come tali o, se ciò accade, esse vengono subito “spazzate via dalla memoria e sostituite da un documento falsificato” che ci presenta l’influenza del secondo evento sul primo come qualcosa di operante sin dall’inizio. Alla luce di questi indizi sperimentali, Dennet giunge a concludere che non esiste un luogo centrale, un Teatro Cartesiano dove “tutto converge” per essere esaminato da un osservatore privilegiato. La coscienza non sarebbe quindi una questione d’arrivo a un determinato luogo cerebrale, quanto piuttosto di attivazione che supera una certa soglia sull’intera corteccia o su larga parte di essa. Al posto della concezione del Teatro Cartesiano, in cui opera un flusso lineare di processi che si succedono in maniera ordinata e sequenziale, Dennet propone quella delle Molteplici Versioni, costituita da un certo numero di circuiti in stretta interconnessione tra loro, che operano in parallelo. Secondo tale concezione, l’unità dell’esperienza cosciente non viene ottenuta riconducendo l’attività dei diversi moduli in cui può essere idealmente suddivisa la corteccia cerebrale a un centro finale, che agisce da “collettore”, bensì deriva dal loro funzionamento strettamente integrato e interdipendente. In questa prospettiva, il Sé, l’Io a cui ciascuno di noi fa riferimento, si rivela essere soltanto una valida astrazione, una funzione teorica, piuttosto che un osservatore interno con il compito di raccogliere messaggi che provengono dalle varie zone del cervello. Detto questo, il passo successivo discende quasi come una logica conseguenza. Se il Sé – scrive Dennet – è soltanto il Centro di Gravità Narrativa, e se tutti i fenomeni della coscienza umana rappresentano soltanto i prodotti dell’attività di una macchina virtuale realizzata con connessioni variamente modificabili del cervello umano, allora, in linea di principio, un robot opportunamente “programmato” con un cervello costituito da un calcolatore al silicio, sarebbe cosciente, avrebbe un sé. Dennet osserva che molte persone trovano molto poco credibile che un robot possa essere cosciente; esse sono portate a considerare tale ipotesi come una pura e semplice assurdità. Effettivamente è piuttosto difficile immaginare come un calcolatore o una qualsiasi macchina cibernetica possa sviluppare la coscienza. Come potrebbe un complicato ammasso di circuiti che elaborano informazioni su chip al silicio equivalere alle esperienze coscienti? Ma, secondo Dennet, è altrettanto difficile immaginare come un cervello umano organico possa sostenere la coscienza. Come potrebbe un complicato ammasso di interazioni elettrochimiche tra miliardi di neuroni equivalere alle esperienze coscienti? Se non riusciamo a immaginare come un sistema complesso (biologico o artificiale) possa albergare al suo interno i fenomeni della coscienza, possa vivere le esperienze su di sé proprio come noi le viviamo, possa comprendere il senso di una frase allo stesso modo in cui noi lo comprendiamo, ciò dipende, secondo Dennet, dal fatto che ci limitiamo ad immaginare un caso troppo semplice. Per concludere, la qualità dell’essere coscienti, per Dennet deriva unicamente da un certo tipo di organizzazione funzionale, e non dal fatto che si abbia a che fare con un cervello organico piuttosto che con un cervello costituito da un calcolatore elettronico. Egli non trova una differenza sostanziale tra le due realizzazioni, essendo le loro attitudini legate all’insieme dei processi fisici che si svolgono in esse e non al materiale con cui sono costruiti. Non c’è altro da considerare, poiché le esperienze coscienti si identificano totalmente con gli eventi portatori di informazione al loro interno.
OSWALD SPENGLER

“Una cultura nasce nell’attimo in cui una grande anima si desta dallo stato psichico originario dell’eternità eternamente fanciulla e se ne distacca, come una forma da ciò che è privo di forma, come qualcosa di limitato e di perituro dall’illimitato e dal permanente. Essa fiorisce sulla base di un territorio delimitabile in modo preciso, al quale rimane vincolata come una pianta. Una cultura perisce quando quest’anima ha realizzato l’intera somma delle sue possibilità sotto forma di popoli, di lingue, di dottrine religiose, di arti, di stati e di scienze, ritornando quindi nel grembo della spiritualità originaria. ” (Il tramonto dell’Occidente)
L’antitesi ipotizzata da Dilthey tra “spiegazione naturale” e “comprensione storica” si traduce in Oswald Spengler (1880-1936) nella contrapposizione tra “mondo come natura” e “mondo come storia”. Spengler non fu tanto un filosofo nel senso rigoroso del termine, quanto piuttosto un ideologo, indubbiamente capace di cogliere certi orientamenti politico-spirituali del suo tempo, ma troppo proclive a sbrigative liquidazioni di determinati princìpi e valori (la libertà, la democrazia) e ad avventati appoggi agli orientamenti razzistici e totalitari approdati ad ultimo al nazismo. Egli, oltre ad altri scritti tra cui è bene ricordare Prussianesimo e socialismo (1919) e L’uomo e la tecnica (1931), è l’autore di una fortunata opera, Il tramonto dell’Occidente , pubblicata tra il 1918 e il 1922, cioè tra gli ultimi mesi della prima guerra mondiale e l’immediato dopoguerra, in un periodo in cui comincia ad accentuarsi (fino a diventare un elemento rilevante della cultura fra le due guerre mondiali) la consapevolezza di vivere in un periodo di crisi. Crisi sociale, economica e politica, in primis, ma anche crisi intellettuale e di valori, insomma delle certezze che l’inizio del secolo aveva ereditato dall’ottimismo ottocentesco (che con il Positivismo aveva raggiunto l’apice): ” quello che ci appare più chiaro nei suoi contorni è il ‘tramonto dell’antichità’, mentre già oggi avvertiamo chiaramente in noi e intorno a noi i primi indizi di un avvenimento ad esso del tutto analogo per corso e durata, che appartiene ai primi secoli del prossimo millennio: il ‘tramonto dell’Occidente’ “. L’opera di Spengler è emblematica già dal titolo: la crisi e il crollo della Germania vengono interpretati come il tramonto dell’intera civiltà occidentale; in un quadro concettuale che riprende temi della speculazione di Goethe e di Nietzsche, Spengler tenta di rispondere alla domanda pressante sul destino della civiltà europea. Respingendo ogni concezione unitaria dello sviluppo storico, egli afferma la necessità di intendere la storia dell’umanità come esplicazione di una molteplicità di forme differenti, cioè di diverse civiltà dotate ciascuna di una propria vita e di un proprio sviluppo autonomo. Ogni civiltà è un organismo appartenente alla medesima specie e ha quindi una nascita, una crescita, una decadenza e una morte; e come in tutti gli organismi biologici questo ciclo di sviluppo ha il carattere della ineluttabilità, risultando necessariamente determinato dal corredo di possibilità di cui dispone all’inizio del suo sviluppo. Questo è il fondamento di ciò che Spengler chiama ” logica organica della storia ” , che ha il suo principio nella necessità del destino; e dal dominio della categoria della necessità deriva anche il carattere della risposta che egli dà al problema del futuro della civiltà occidentale. Esso può essere previsto in maniera esatta perché la civiltà occidentale seguirà lo stesso cammino di tutte le altre: ” a noi non è data la libertà di realizzare una cosa anziché l’altra. Noi ci troviamo invece di fronte all’alternativa di fare il necessario e di non poter fare nulla. Un compito posto dalla necessità storica sarà in ogni caso realizzato, o col concorso dei singoli o ad onta di essi “. Spengler va quindi in cerca dei sintomi della decadenza dell’Occidente nell’analisi dei fenomeni economici e politici del mondo a lui contemporaneo, e li scorge nell’affermazione della borghesia, nel primato dell’economia sulla politica, nella democrazia, nella crisi dei princìpi religiosi e nella libertà di pensiero: ” non esiste una satira più tremenda della libertà di pensiero. Un tempo non si poteva osare di pensare liberamente; ora ciò è permesso, ma non è più possibile. Si può pensare soltanto ciò che si deve volere, e proprio questo viene percepito come libertà “. Se il ciclo evolutivo è lo stesso per tutte le civiltà, è tuttavia diverso il loro corredo di possibilità. Spengler sviluppa qui, in senso radicalmente relativistico , la dottrina di Dilthey dell’autocentralità delle epoche storiche: ogni civiltà rappresenta un mondo a sé, con un proprio linguaggio formale, un proprio simbolismo, una propria concezione della natura e della storia. E’ quindi possibile una comprensione effettiva solo nell’ambito di una stessa civiltà, che funge da orizzonte primario e intrascendibile; tra le civiltà non è possibile nessuna comunicazione, dal momento che ogni civiltà crea i propri valori e che tra di esse non vi sono valori comuni. Con l’opera di Spengler, lo storicismo tedesco dell’epoca approdava al relativismo: questo esito, già del resto implicito in Dilthey, spingerà verso tentativi di restaurazione dei valori che ne garantiscano la validità al di là delle singole epoche e culture. Non solo non può esistere una filosofia o una morale di tipo universale-assoluto, ma nessun principio teorico o pratico può pretendere di avere una validità non particolare e non contingente. Spengler riprende e irrigidisce il dualismo natura/storia : la natura è il regno dell’inerte e del “divenuto” , della cieca necessità causale e dell’anonima uniformità esprimibile nelle formule della scienza. La storia è, invece, il regno della vita e del vitale “divenire”, dell’intelligente necessità organica e delle particolarità individuali e irripetibili. Protagonista della storia non è tanto l’uomo, quanto la “cultura”: riprendendo (ma in modo per più versi unilaterale) un motivo dapprima caratteristico del Romanticismo, e poi da certi studiosi di fine Ottocento (ad esempio Burkhardt), Spengler interpreta la cultura come organismo . Ogni cultura/organismo ha una sua forma peculiare che ne caratterizza tutti gli aspetti costitutivi e che la distingue poi da tutte le altre. Essa ha inoltre una sua nascita, un suo sviluppo secondo un destino necessario e un non meno necessario tramonto. Tale tramonto si realizza appunto quando tutte le sue potenzialità si sono realizzate e a ciò segue un inesorabile processo di decadenza. I momenti estremi di tale vicenda (propria di tutte le culture in quanto tali) vengono indicati da Spengler coi due concetti di “Kultur” e di “Zivilisation”: due termini non nuovi (presenti già anche in Kant), ma che Spengler ha contribuito a popolarizzare. La Kultur è la cultura positiva, vitale, non priva di una sana barbarie; la Zivilisation (di cui non deve sfuggire la provenienza lessicale straniera) è invece la cultura raffinata ed estenuata della decadenza internazionale malata e votata alla consunzione. Per Spengler l’Occidente è oramai giunto alla Zivilisation e, dunque, alle soglie del suo inevitabile tramonto. L’unica speranza che si apre a questo punto è quella di un radicale sovvertimento di tutti gli pseudo-valori dell’epoca o dell’intero sistema socio-politico, in grado di ricondurre l’Occidente a un rinnovato stato primitivo.
MAX HORKHEIMER

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
Nel febbraio del 1923 viene aperto ufficialmente a Francoforte, grazie ad una donazione privata, l’ “Institut für Sozialforschung” (Istituto per la ricerca sociale), sotto la direzione dello storico marxista Karl Grünberg. Di esso fece parte anche Max Horkheimer (Stoccarda 1895 – Norimberga 1973), che nel 1931 ne diventa a sua volta direttore. Nato nei pressi di Stoccarda da ricca famiglia ebrea, dopo aver lavorato presso l’impresa paterna, si laurea con una tesi su Kant nel 1922 a Francoforte, dove nel 1929 diventa professore di Filosofia sociale. Nel 1932 iniziano le pubblicazioni della rivista dell’Istituto, la “Zeitschrift für Sozialforschung”, alla quale collaborano anche altri filosofi del calibro di Adorno, Fromm, Marcuse e sulla quale Horkheimer pubblica diversi articoli, che saranno successivamente raccolti dopo la guerra sotto il titolo di “Teoria critica” (1968). Nel 1933, con l’avvento del nazismo, Horkheimer è espulso dall’università, l’Istituto viene chiuso e trasferisce la propria sede in Svizzera e poi, nel 1934, a New York, mentre la rivista continua le sue pubblicazioni a Parigi, fino al 1940, e successivamente negli Stati Uniti. Horkheimer stesso si trasferisce a New York e dal 1941 in California, acquistando la cittadinanza americana. Durante il soggiorno statunitense, egli pubblica in inglese l’ “Eclisse della ragione” (1947) e in tedesco la “Dialettica dell’illuminismo”, composta in collaborazione con Adorno. Nel 1950 escono, sempre negli Stati Uniti, i risultati di una ricerca collettiva dell’Istituto, sotto il titolo “Studi sulla personalità autoritaria”, ma nel frattempo Horkheimer torna in Germania per insegnare Sociologia e Filosofia all’università di Francoforte, anche se conserva la cittadinanza americana; con lui torna anche l’Istituto, soprannominato dagli studenti “Caffè Max”. Nel 1951 è nominato rettore dell’università e nel 1954 si stabilisce sul lago di Lugano, dove conclude la propria esistenza nel 1973. In primo luogo, l’Istituto si propone il ripristino del marxismo , ma tenendo conto dei profondi mutamenti della situazione storico-sociale: soprattutto, dopo la grande crisi economica divampata nel 1929, il capitalismo sembra assumere un nuovo aspetto e trasformarsi, sia nelle democrazie occidentali, sia nelle dittature di Destra, sia nell’Unione Sovietica, in capitalismo di Stato. Ciò implica che non è più possibile parlare di una struttura economica autonoma rispetto alla politica: contrariamente alla teoria di Marx, lo Stato sembra riassumere il primato rispetto alla società civile e impedire, col suo intervento diretto nella sfera economica, l’impoverimento crescente del proletariato. In questa situazione, si assiste ad una graduale perdita di impulso rivoluzionario nella classe operaia, con la conseguente sfiducia, comune agli autori della Scuola di Francoforte, nel fatto che essa possa ancora essere il motore di una trasformazione radicale della società. Ostili alla socialdemocrazia, poiché traditrice degli obiettivi rivoluzionari, ma anche alla burocratizzazione e alla bancarotta, verificatasi anche sul piano teorico, del comunismo sovietico, essi si tengono per lo più lontani dall’attività politica diretta: l’organizzazione totale della società, comune ai paesi occidentali come a quelli orientali, non è spiegabile solo attraverso la coercizione materiale a cui sarebbero sottoposti gli individui. Si tratta, invece, di individuare anche le mediazioni psicologiche e culturali che rendono possibile la costituzione del dominio sociale e, dall’altra, l’accettazione passiva di esso. A questo scopo sono dedicate le ricerche collettive dell’Istituto sul problema dell’autorità. Non scorgendo più all’orizzonte un agente sociale della rivoluzione e ritenendo ormai impossibile su questa base una previsione scientifica del crollo del capitalismo, i pensatori della Scuola di Francoforte ritornano, in qualche modo, ad un’impostazione simile a quella della sinistra hegeliana dopo la scomparsa di Hegel: infatti, essi riconoscono la discrepanza tra la realtà storica e la razionalità e, quindi, il carattere irrazionale della società esistente, rispetto alla quale il compito primario da esercitare è la critica; si tratta pertanto, attraverso un lavoro di critica, di far diventare reale ciò che è razionale. Ecco perché i pensatori della Scuola di Francoforte vogliono elaborare una teoria critica della società , in cui occupa una posizione assolutamente centrale la dialettica , concepita (sulla scia del primo Lukàcs) come metodo per la trasformazione della realtà. A differenza di Lukàcs, però, la teoria critica non viene intesa come semplice espressione della coscienza di classe, senza per questo scivolare nell’illusione opposta che l’intellettuale sia al di sopra della mischia e della lotta di classe. L’intellettuale critico non è un ripetitore delle tendenze conformistiche del proletariato e la dialettica, di cui egli si serve, è orientata ad accertare le contraddizioni esistenti, ma senza la certezza di un superamento di esse in una sintesi finale. E poi, se Marx considerava la scienza, acquisibile mediante il metodo dialettico, diversa sia dall’ideologia, sia dall’utopia, per i pensatori della Scuola di Francoforte la scienza e la tecnica sono anch’esse causa ed espressione, al tempo stesso, del dominio totale della società e quindi forme di ideologia, non nel senso di essere semplici riflessi di interessi di classe, ma in quanto esprimono le contraddizioni della società. In questa prospettiva torna dunque ad aprirsi un nuovo spazio per l’ utopia , la quale però consiste, più che nella delineazione di un programma dai contenuti positivi da perseguire e nella definizione dei caratteri della società libera del futuro, nella denuncia di ciò che è falso nel presente e nel rifiuto di esso: e così nel pensiero dialettico assume grandissimo rilievo il momento della negazione .
IL PENSIERO
Secondo Horkheimer, non è possibile conoscere la totalità che è sempre incompiuta: nessun aspetto della realtà può essere compreso come definitivo. Questa è l’illusione del positivismo e della scienza stessa, che reputa che l’oggetto della conoscenza siano i fatti, nel senso letterale di entità ormai compiute e separate dai valori. Nel saggio “Teoria tradizionale e teoria critica” (1937), Horkheimer sostiene che gli scienziati sono inseriti nell’apparato sociale e contribuiscono alla continua riproduzione di esso. Il livello raggiunto dalla divisione sociale del lavoro conduce infatti ad una separazione fra teoria e prassi e ad attribuire al sapere una funzione sociale. Su questa base si costituiscono le forme tradizionali di teoria, le quali tendono soltanto a descrivere fatti e, per questa strada, a giustificare lo stato di cose esistente, mentre nei casi in cui sono orientate all’azione, ciò avviene soltanto in vista del dominio tecnologico della natura e degli uomini. Horkheimer ritiene infatti che sia impossibile una ricerca scientifica pienamente disinteressata, quando gli uomini non sono autonomi: gli scienziati e i ricercatori fanno parte della società che essi studiano e, giacchè tale società non è il frutto di una libera scelta razionale da parte degli uomini, essi non possono uscire da essa; nella migliore delle ipotesi, essi possono solamente ravvisare all’interno della società forze e tendenze negative, che rimandano ad una realtà diversa. Qui si innesta il compito della “teoria critica”, cosciente della scissione unilaterale fra teoria e prassi e orientata a superarla. Il suo strumento fondamentale è la ragione , che non va confusa con il senso comune o con l’intelletto, i quali sono incapaci di andare oltre l’immediatezza dei dati e di cogliere le contraddizioni e i nessi dialettici presenti nella realtà. La ragione deve invece riassumere il compito di tribunale critico della realtà: per essa è vero non un insieme di dati di fatto, ma tutto ciò che produce un cambiamento nella direzione di una società razionale. Le verità universali di cui si occupa la teoria critica non sono determinabili soltanto in relazione alla situazione esistente, ma implicano la possibilità di un diverso ordine delle cose. Questo non vuol dire appellarsi ad una presunta verità immutabile fuori dalla storia, dice Horkheimer: contrariamente alla fenomenologia e alle tesi di Scheler, egli non ritiene che esista una natura umana immutabile e che, pertanto, possa essere previsto e descritto una volta per tutte nei suoi tratti positivi il futuro regno della libertà: ” l’idea di una società futura come comunità di uomini liberi qual è possibile con i mezzi tecnici di cui si dispone, ha un contenuto al quale si deve rimanere fedeli comunque esso si modifichi ” (“Teoria tradizionale e teoria critica”). In una prospettiva del genere, la società buona può essere definita soltanto formalmente come la società in cui l’uomo è libero di agire come soggetto, senza subire alcuna strumentalizzazione. Nel quadro di questa antropologia negativa, ossia costruita attraverso la negazione dei caratteri dell’ordine esistente, il lavoro non occupa più la posizione centrale che aveva nel marxismo tradizionale. Porre il lavoro come la manifestazione suprema dell’attività umana equivale a ” professare un’ideologia ascetica ” tipicamente borghese, dice Horkheimer in pieno accordo con Benjamin e Adorno: essa mira a reprimere la felicità personale che per Horkheimer è in prima analisi legata alla sensibilità, sacrificandola a qualche bene superiore e sostituendola con palliativi di felicità illusoria, quali i divertimenti di massa. Contro quest’etica della negazione di sé, Horkheimer rivendica la dignità dell’egoista, che ha tuttavia il limite di respingere, come accade in Nietzsche, l’essenziale componente sociale della felicità. IL soggiorno statunitense pone Horkheimer di fronte alla realtà globale e monolitica di una società industriale all’avanguardia, caratterizzata, fra le altre cose, da uno straordinario sviluppo dell’industria culturale, che contribuisce anch’essa, ma in modo più sottile e meno brutale della costrizione fisica, a rendere gli individui uniformi e passivamente sottomessi al sistema sociale. Sorge allora il problema del perché l’umanità, nonostante gli straordinari progressi tecnici, ” anziché entrare in uno stato veramente umano, sprofondi in un nuovo genere di barbarie “: nel tentativo di trovare una risposta Horkheimer compone, insieme all’amico Adorno, la ” Dialettica dell’illuminismo ” : si tratta di chiarire come mai l’illuminismo, che ha come obiettivo la liberazione dell’umanità dalle paure e dalle superstizioni mediante la ragione, si sia capovolto dialetticamente nella sua negazione, ovvero nell’autodistruzione dell’illuminismo; si tratta cioè di spiegare come il progresso e la razionalità possano contenere elementi distruttivi. La via seguita dall’illuminismo per liberare gli esseri umani dalle paure consiste nel renderli padroni della natura mediante la scienza: il sapere si identifica, baconianamente, con il potere e la ragione si configura come strumento di dominio . In tal modo, tuttavia, l’illuminismo fa propri i contenuti dei miti che ha abbattuto, limitandosi a trasferire da Dio all’uomo il dominio sull’esistente: la differenza è che la natura non è più dominata assimilandosi ad essa attraverso la magia e l’imitazione, ma mediante il lavoro. L’accrescimento del potere degli uomini ha però il costo di una loro estraniazione dalla natura e dalle cose su cui lo esercitano, cioè di un distacco del soggetto dall’oggetto. Questa è la premessa su cui si costituisce l’ astrazione , che annienta le differenze individuali, rende compatibile ed equivalente ciò che è eterogeneo ed esercita un dominio livellatore su tutto, rendendo tutto ripetibile nella natura: così, essa prepara le cose affinchè possano essere manipolate nell’industria. In questo modo, ciò che appare come trionfo della razionalità scientifica, cioè la sottomissione di tutto quel che è al formalismo logico e matematico, viene secondo Horkheimer e Adorno pagato con la sottomissione della ragione a quel che è dato e il pensiero stesso viene reificato, cioè ridotto a cosa e a strumento, e soggiogato al modo di produzione dominante: ” l’animismo aveva vivificato le cose; l’industrialismo reifica le anime “. Attraverso la divisione del lavoro, il dominio della società viene ad estendersi anche sugli uomini, ma ciò che impedisce la realizzazione dell’illuminismo, come progetto di liberazione dal dominio, non è tanto la tecnica in quanto tale, la quale anzi fornisce abbondanza di prodotti, quanto la rinuncia al pensiero come apertura al nuovo. L’illuminismo viene così a rovesciarsi in una nuova mitologia, depurata da dèi e demoni, ma anch’essa fondata sull’accettazione passiva dei fatti; ciò conduce a legittimare l’ingiustizia sociale da cui i fatti stessi nascono: il mondo non è diventato più razionale. ” Nel mondo illuminato la mitologia è penetrata e trapassata nel profano. La realtà completamente epurata dai demoni e dai loro ultimi rampolli concettuali, assume, nella sua naturalezza tirata a lucido, il carattere numinoso che la preistoria assegnava ai demoni. […] Rinunciando al pensiero, che si vendica, nella sua forma reificata – come matematica, macchina, organizzazione – dell’uomo immemore di esso, l’illuminismo ha rinunciato alla sua stessa realizzazione ” (“Dialettica dell’illuminismo”, cap. 1). A differenza della tradizione marxiana, Horkheimer e Adorno non intendono per illuminismo l’ideologia della borghesia in ascesa; essi, anzi, includono lo stesso Marx, in quanto teorico del lavoro come autorealizzazione dell’uomo, nel solco dell’illuminismo. In realtà, per essi la storia dell’illuminismo coincide con l’intera storia della civiltà e del pensiero occidentale: al centro di esso vi è l’idea dell’uomo come padrone unico e assoluto del mondo. Essi scorgono la dialettica dell’illuminismo, incentrata sulla connessione tra mito, dominio e lavoro, già allegoricamente rappresentata dalle vicende di Ulisse narrate nell’Odissea omerica. Di fronte alle Sirene ammaliatrici, Ulisse si fa legare all’albero della nave dai suoi compagni per non perdere se stesso e la propria identità e in tal modo rinuncia al piacere immediato: gode, però, di un piacere a distanza udendo il loro conto. I suoi compagni, invece, hanno le orecchie tappate e quindi sono privati di ogni piacere, mentre remano, ossia lavorano obbedendo al comando di Ulisse, per portare lontana la nave: ciò simboleggia la separazione di godimento artistico e di lavoro manuale, la quale dà luogo ad una mutilazione e ad una regressione sia di Ulisse, che non partecipa al lavoro comune, sia dei compagni, che sono costretti a lavorare e hanno i sensi tarpati. La conclusione è che ” la maledizione del progresso incessante è l’incessante regressione “: oggi le macchine mutilano gli uomini, anche se li sostentano. In questo contesto, anche il pensiero è impoverito, destinato a compiti solamente organizzativi e amministrativi all’interno di un apparato di dominio che tende a produrre uniformità e conformismo. A ciò contribuisce l’ industria culturale , la quale trasforma la cultura in una merce oggetto di scambio come tutte le altre merci e, al contempo, esercita grande potere sul consumatore grazie alla mediazione del divertimento, che non deve essere, a sua volta, faticoso dopo il lavoro faticoso. Espressioni tipiche di essa sono, secondo Horkheimer e Adorno, la radio e il cinema, i quali, contrariamente a quanto pensava Benjamin, portano lo spettatore ad identificarsi con la realtà, ridotta ad una serie di personaggi stereotipati, che rappresentano l’ ” apoteosi del tipo medio “. In questo modo, essi tolgono spazio alla possibilità di pensare ciò che è inconsueto, conducono all’atrofia dell’immaginazione e riducono ogni capacità di resistenza di fronte alla realtà esistente. In questa situazione, la filosofia rappresenta ” lo sforzo di resistere alla suggestione, la decisione della libertà intellettuale e reale “, estranea all’esistente e insieme capace di comprenderlo, senza capitolare di fronte ad esso: essa è, secondo i filosofi della Scuola di Francoforte, ” la voce della contraddizione “. Horkheimer sviluppa temi affini a questi in un’opera pubblicata sempre nel 1947 e intitolata ” Eclisse della ragione “. Il termine “ragione” viene impiegato in una molteplicità di significati, dice Horkheimer: in senso oggettivo, essa indica, da Platone e Aristotele in poi, la ragione orientata a individuare un ordine oggettivo e gerarchico dei fini, mentre in senso soggettivo, dominante in età moderna e formulato con estrema chiarezza da Max Weber, la ragione ha il compito di determinare non quali siano i fini razionali, bensì quali siano i mezzi adeguati al raggiungimento degli scopi, che possono essere tantissimi. In quest’ultima accezione, la ragione ha rinunciato a definire gli scopi ultimi, ma in tal modo si è svuotata di precisi contenuti e si è formalizzata: come conseguenza, essa è diventata ragione strumentale , adattabile a qualunque scopo e, quindi, subordinata all’assetto sociale esistente. La situazione odierna è caratterizzata dal fatto che la vita tende ad essere assoggettata ad un processo crescente di razionalizzazione in questo senso, ma quanto più è cresciuta la libertà e l’abilità nel calcolare i mezzi opportuni, tanto più è aumentata la passività nella scelta dei fini, che si trovano di fatto imposti dalle esigenze di dominare la natura e controllare gli uomini in modo da renderli funzionali alla riproduzione del sistema. In questa situazione, le forze economiche e sociali si configurano come cieche forze naturali che l’uomo, se ci tiene a sopravvivere, deve dominare adattandosi ad esse, obbedendo a schemi generali di comportamento. Il risultato è una natura ridotta a pura materia da dominare e l’io stesso smarrisce ogni spontaneità nel suo agire, si trova svuotato e ridotto all’esercizio delle pure funzioni di dominio e di organizzazione: il dominio è l’idolo a cui tutto viene sacrificato. La malattia della ragione consiste nel fatto che, nata dall’esigenza umana di dominare la natura, essa è diventata strumento di dominio. Da ciò possono scaturire o la rassegnazione, che consiste nell’accettare l’identità di ragione e dominio come se si trattasse di una legge eterna, con la conseguente repressione degli impulsi naturali, o la rivolta, che richiede un’ autocritica da parte della ragione . Ciò vuol dire che la ragione può diventare ragionevole, solo riflettendo sul ” male del mondo “, così come è prodotto e riprodotto dall’uomo, cioè riconoscendo l’esistenza di un antagonista odierno tra soggetto e oggetto, io e natura, parola e cosa. In questo modo, la filosofia, acquistando questa consapevolezza, può contribuire a sovvertire il processo storico, ma senza regredire alle vecchie concezioni metafisiche della ragione oggettiva: per essa, infatti, ogni concetto deve essere visto come frammento di una verità più vasta, non ancora data, in cui esso trova il suo significato. Horkheimer è consapevole che la comprensione della negatività del presente e delle sue contraddizioni non sono di per sé il superamento della situazione storica, ma rifiuta di identificare la filosofia con forme di attivismo e propaganda, per quanto nobili possano esserne gli scopi: il compito fondamentale rimane quello di denunciare tutto quel che mutila l’uomo e ne impedisce il libero sviluppo. Nei suoi ultimi scritti, Horkheimer rivendica alla filosofia il compito di difendere l’individualità e la sua autonomia, che rischia oggi di volgere al tramonto, annegata nel conformismo. In questo senso, egli ribadisce la preferibilità della democrazia occidentale, con tutti i suoi limiti, ad ogni forma di dittatura e segnala i rischi, inerenti anche al movimento degli studenti del ’68, di applicare in modo troppo immediato la teoria critica alla prassi, con la violenza che ne può conseguire. Al centro della sua visione, rimane una concezione pessimistica della realtà e della fragilità dell’individuo, che egli fin dalla giovinezza aveva ereditato da Schopenhauer, Horkheimer riconosce però una funzione positiva alla religione , in quanto incarna un desiderio di felicità ed è mossa dall’aspirazione verso il totalmente altro, anche se tende a concepire questa trascendenza come rivelata e ipostatizzata in Dio e rischia, pertanto, di essere solamente un ulteriore strumento di controllo e di adattamento sociale. In “Teoria critica della società” (1968), Horkheimer indaga con gli strumenti della psicologia e della psicoanalisi i meccanismi del consenso e della formazione dell’opinione pubblica manipolata dai sistemi di propaganda. Il fascismo è indicato come forma implicita del capitalismo moderno e della civiltà tecnologica, che ha prodotto una società amministrativa, governata dalla burocrazia, senza autonomia per il singolo. Vedendo venir meno la possibilità di una reazione all’integrazione capitalistica nella società opulenta post-bellica, Horkheimer assume un atteggiamento di pessimismo metafisico, pur aprendo uno spazio critico al rinvio alla trascendenza ( “La nostalgia del totalmente altro”, 1970, e “La società di transizione”, 1972): egli arriva a coniugare il marxismo con lo schopenhauerismo.
LA DIALETTICA DELL’ILLUMINISMO
La Premessa degli autori all’edizione italiana Il testo tedesco della Dialettica del’Illuminismo è un frammento cominciato nel 1942 durante la seconda guerra mondiale. Doveva in realtà costituire l’introduzione alla teoria della società e della storia concepita dai due autori durante il dominio nazista. Il libro perciò risente molto, nella terminologia e nei problemi presi in esame, del contesto storico in cui è stato scritto. Il tema centrale del libro concerne le tendenze che trasformano il progresso culturale moderno e contemporaneo nel suo esatto contrario (cioè in un vero e proprio regresso). Ma è la stessa ragione illuministica a subire storicamente un vero e proprio rovesciamento, da cui principalmente dipende, secondo Horkheimer e Adorno, la trasformazione del progresso in regresso. Questo processo dialettico di ribaltamento del progresso nel suo contrario è illustrato da quell’insieme di fenomeni sociali contemporanei che si dispiegarono in America tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del ‘900. Gli autori affermano altresì di non aver voluto né potuto fornire una teoria sistematica di quegli eventi e di questa particolare ‘dialettica’ storica e sociale dal punto di vista economico e politico. Il frammento appare perciò come un testo essenzialmente filosofico. La Premessa alla prima edizione Lo scopo che gli autori si erano fin dall’inizio proposti accingendosi a scrivere questo testo-frammento era quello di capire perché l’umanità era sprofondata in un nuovo genere di barbarie: la società moderna si presentava certamente in progresso dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma in crescente decadenza dal punto di vista della cultura. I due autori riconoscono di aver inizialmente tentato di inserire la loro critica all’interno del quadro culturale e scientifico contemporaneo; anche criticando una particolare dottrina e rifacendosi piuttosto a un’altra. L’organizzazione della scienza in quanto tale – distinta in sociologia, psicologia e gnoseologia – non veniva da loro messa in discussione; il contributo che Adorno e Horkheimer intendevano dare con il loro scritto si sarebbe dovuto mantenere all’interno di questa “organizzazione” scientifica vigente. Il loro voleva essere sostanzialmente un intervento critico antipositivista; una riflessione sullo studio della tradizione scientifica, tale che ricostruisse le linee teoretiche fondamentali della scienza. Ma, iniziando il lavoro, ciò che immediatamente constatarono fu proprio la crisi della scienza in quanto tale; dell’organizzazione e del senso che la scienza deve avere in una società, che si vuole moderna e in costante progresso. Lo “sfacelo della civiltà borghese” è lo sfondo di questa crisi culturale e scientifica. La loro condanna del fascismo coincide allora con l’accusa mossa nei confronti di quella tendenza autodistruttrice che è l’Illuminismo . E la critica a questo stato di cose deve rifiutare di obbedire al pensiero filosofico attualmente vigente (all’organizzazione della scienza di cui sopra); esso si presenta né più né meno che come una “merce” e l’espressione che questa assume nella lingua non è altro che ideologia e mistificazione: un modo di rendere accettabile ciò che di per sé sarebbe umanamente da rifiutare . Il problema con cui ha a che fare la ‘critica’ non è tanto quello della “strumentalizzazione” della scienza da parte di alcune ideologie; piuttosto è il rischio che la critica stessa ricada nell’ideologia dominante della produzione di merci, la quale è un “processo globale” che tutto abbraccia, anche ciò che gli si oppone. Il riferimento storico è all’Illuminismo dell’Enciclopedia e all’”apologetica” di Comte, la quale trasformò la critica degli enciclopedisti in positiva accettazione della realtà vigente. C’è inoltre un riferimento polemico a tutto quanto il percorso della filosofia del diciottesimo secolo, la quale sembrò rivolgersi contro lo spirito ‘illiberale’ della sua età aderendo alla Rivoluzione Francese, salvo il fatto che poi, con l’avvento di Napoleone, “era già passata dalla sua parte” . Dal punto di vista strettamente teoretico si deve notare la tendenza nella filosofia moderna a trasformare la “critica” in “affermazione”; una tendenza che oggi è diventata la regola. In altri termini, la società contemporanea ha esautorato il pensiero scientifico-filosofico dalla possibilità di esercitare una libera critica del presente, oltreché una ricostruzione sensata di esso. La critica di Adorno e Horkheimer è rivolta contro gli attuali “meccanismi sociali” attraverso i quali la cultura viene prodotta (cinematografia, editoria, sistema educativo, etc.). Sembra vigere una forma di censura ‘spontanea’ anche in chi consuma il prodotto culturale; una autocensura in chi lo concepisce. Questa forma di proibizione al libero esercizio delle capacità teoretico-critiche dell’uomo, apre la strada alla “follia politica”; soprattutto all’incapacità umana di resistere ad essa. I due autori si rendono conto di trovarsi di fronte a un’aporia, a una difficoltà reale: l’autodistruzione dell’Illuminismo. “Non abbiano il minimo dubbio […] che la libertà nella società è inseparabile dal pensiero illuministico”. Ma esso è intrinsecamente unito a una forte e reale tendenza al regresso e alla distruzione della libertà stessa. Il progresso come tale non è garanzia di libertà; la mancanza di una adeguata critica all’Illuminismo e al progresso presi insieme, porta inesorabilmente ad un’accettazione passiva del “dispotismo”. Porta le “masse tecnicamente educate” alla “paranoia “popolare”. La debolezza del pensiero teoretico contemporaneo sta proprio nell’inconsapevolezza di questa aporia. L’Illuminismo è l’idea che la società borghese ha di sé; un’idea che però spesso si blocca, per paura, di fronte alla verità, non sempre rischiarata dal lume della ragione. Quando la realtà si fa intimamente contraddittoria e irrazionale, il pensiero illuministico-borghese non ha il coraggio di criticarla e smascherarla. Così il regresso dell’Illuminismo (“autentico rampollo della civiltà moderna”) a mitologia (irrazionalità) non va ricercato nelle moderne mitologie nazionalistiche, quanto piuttosto nella “paralisi” dell’Illuminismo stesso; una paralisi che condanna lo spirito moderno-contemporaneo alla cecità e all’incapacità di intervenire negativamente e criticamente sulla realtà. Spesso viene tacciato di “oscurità” quel pensiero che percorre vie non immediatamente visibili e chiare al senso comune; è “il lavoro del concetto” ciò che invece va incoraggiato, in tempi in cui il pensiero, scientifico e non, sembra soccombere sotto il peso di una condanna al regresso e all’autodistruzione. “La condanna naturale degli uomini è oggi inseparabile dal progresso sociale”. Le potenze economiche riducono all’inferiorità culturale, politica, ecc., gran parte della popolazione, annullando ogni potere decisionale del singolo. Allo stesso tempo portano a livelli finora mai raggiunti il dominio della società sulla natura; le masse e i singoli vengono svuotati da una parte e riempiti (di merci, di beni, di consumi, ecc.) dall’altra. Lo spirito (la cultura e il pensiero di un popolo) viene reificato; diventa una cosa (merce), perciò non è più spirito. “La valanga di informazioni minute e di divertimenti addomesticati scaltrisce e istupidisce nello stesso tempo”. Le condizioni storiche attuali sono tali che lo sviluppo materiale genera gruppi di potere che hanno preso totalmente il posto del “soggetto sociale” (popolo, massa, coscienza sociale diffusa), costituendo “la minaccia internazionale del fascismo” o, il che è lo stesso, il capovolgimento del progresso in regresso. Questi frammenti filosofici, dicono gli autori, hanno l’intento di smascherare il meccanismo perverso secondo cui, oggi, la “fabbrica igienica” (cioè la produzione di merci) si sostituisce al pensiero, allo spirito, alla metafisica. La Dialettica dell’Illuminismo è distinta in saggi diversi. Concetto di Illuminismo. Questo primo saggio è la base teoretica di quelli successivi; si incentra sull’intreccio di razionalità e realtà, tra natura e dominio della natura da parte dell’uomo. La critica mossa all’Illuminismo non vuole essere assoluta e senza appello. Ha, viceversa, una prospettiva di liberazione. Il primo saggio, scrivono gli autori, può riassumersi in questa formula chiasmatica: “il mito è già Illuminismo, e l’Illuminismo torna a rovesciarsi in mitologia”. Excursus . Seguono due excursus che vogliono illustrare questo intreccio dialettico mito-Illuminismo; il primo sull’Odissea, considerata come uno dei primissimi documenti rappresentativi della civiltà borghese occidentale; il secondo su Kant, Sade e Nietzsche, esecutori inflessibili dell’Illuminismo. In quest’ultimo viene rovesciato il rapporto di dominio del soggetto sull’oggettività, in cieco dominio di questa su quello. L’industria culturale . Il capitolo sull’industria culturale mostra la regressione concreta a cui l’Illuminismo è giunto attraverso la diffusione del cinema e della radio: l’ideologia feticistica della tecnica e della produzione si sostituisce alla consapevolezza critica e alla conoscenza in genere. Elementi dell’antisemitismo . Questa parte è dedicata al ritorno della civiltà illuminata alla barbarie. I due autori vi abbozzano una preistoria filosofica dell’antisemitismo, l’irrazionalità del quale viene ricondotta all’essenza stessa della ragione dominante. “Gli Elementi si ricollegano strettamente a ricerche empiriche dell’Institut für Sozialforschung, la fondazione creata e mantenuta in vita da Felix Weil, e senza la quale non solo i nostri studi, ma buona parte del lavoro teorico continuato, nonostante Hitler, da tedeschi emigrati, non sarebbe stato possibile”. Appunti e schizzi . L’ultima sezione è dedicata a schizzi, appunti, ecc., che hanno come quadro di riferimento una sorta di antropologia dialettica . Concetto di Illuminismo L’Illuminismo viene inteso da Adorno e Horkheimer come “pensiero in continuo progresso”, come razionalità propria dell’uomo capace di progredire e di far progredire la realtà. La storia di questo progresso abbraccia un lungo percorso, idealmente ricostruito dai due autori, che va dall’uscita del genere umano dallo stato di soggezione magica alla natura, fino allo sviluppo, in età moderna, della società industriale. L’Illuminismo, così inteso, è il rapporto che l’uomo instaura con la natura; un rapporto di dominio, nel quale o l’uno o l’altra debbono soccombere. E’ un processo di emancipazione dell’uomo dalla natura, nel quale egli si libera rendendo sottomessa l’altra. Il modo in cui si realizza la libertà dell’uomo (ossia il dominio sulla natura) è rappresentato dallo sviluppo della scienza, ma, prima di tutto, dalla critica e dall’abbandono del mito da parte della civiltà occidentale. Nella storia del pensiero filosofico è Bacone l’esempio a cui i due autori fanno fin da subito riferimento. L’Illuminismo o “rischiaramento” [Aufklärung] è la critica rivolta dalla ragione alla fede, alla superstizione, proprio così come Hegel ce l’ha presentata nella sua “Fenomenologia dello Spirito” descrivendoci la lotta dei ‘lumi’, nel diciottesimo secolo, contro l’irrazionalità della credenza ingenua e incolta. Horkheimer e Adorno, per Illuminismo, intendono certamente quello a cui Hegel fa riferimento, ma lo estendono nella storia dai primordi fino all’età contemporanea e ne dilatano il senso filosofico definendolo come l’inarrestabile “movimento stesso del pensiero”. L’Illuminismo contemporaneo si identifica, secondo gli autori, con la società stessa in cui viviamo. E’ la definitiva presa di possesso da parte dell’uomo del suo mondo naturale e umano. Una presa di possesso che però, a ben vedere, non realizza quella ragione da cui pure proviene; è un rischiaramento mancato quello a cui stiamo assistendo da millenni. Una lotta che certamente ha opposto il pensiero razionale a miti, illusioni, false credenze, idoli, feticci, ecc., ma che dialetticamente si è rovesciata nel suo opposto; la lotta intrapresa dall’Illuminismo ha inconsapevolmente restaurato, sotto altra forma, quella mancanza di razionalità contro cui si era rivolta. I nodi teoretici, intorno a cui ruota tutta l’argomentazione di questo primo capitolo della Dialettica dell’Iluminismo , possono essere racchiusi in queste nozioni fondamentali, più volte e in vario modo ripetute dagli autori: l’Illuminismo come sviluppo del pensiero razionale; l’Illuminismo come lotta contro il mito, la fede, la superstizione; come progressivo dominio dell’uomo sulla natura; come razionalizzazione della realtà in generale; come dialettica. Quest’ultima nozione è quella che ribalta e contraddice la positività e l’ottimismo su cui l’Illuminismo sembra reggersi, ovvero la certezza da parte della ragione illuministica di realizzare pienamente se stessa. Quest’ultima nozione è il centro stesso dell’argomentazione che Horkheimer e Adorno rivolgono contro la presunta linearità del progresso illuministico-occidentale . Argomentazioni 1. L’Illuminismo ha come scopo fondamentale quello di rendere gli uomini padroni di sé e della natura, togliendo loro la paura dell’ignoto, dell’irrazionale, riscattandoli dall’inconsapevolezza, dall’incapacità di dominare col pensiero la realtà. “Ma la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura.” Cioè all’insegna della sventura di essere caduta sotto una forma di pensiero che la rende cieca, inconsapevole, dominata dall’irrazionale, ecc. Vediamo perché. Gli autori prendono Bacone come primo esempio di questo ‘rovesciamento’ a cui è destinato l’Illuminismo, il pensiero filosofico moderno-occidentale. E’ un rovesciamento dialettico, nella misura in cui l’altro, l’opposto contro cui il progresso del pensiero si rivolge (il mito, l’irrazionalità, gli idoli, ecc.) diventa invece un termine posto (affermato) inconsapevolmente dallo stesso pensiero razionale. Ciò da cui l’Illuminismo prende consapevolmente le distanze, diventa ciò in cui viene inconsapevolmente ad identificarsi. La sventura illuministica però, proprio per questo suo carattere dialettico e autodistruttivo, può riscattarsi attraverso un’impietosa autocritica, prendendo finalmente consapevolezza di sé. L’interpretazione che i due autori danno di Bacone è, in sintesi, la seguente: se il linguaggio filosofico-scientifico di quest’ultimo non arriva certo ad usare la matematica, che con Galilei diventerà il linguaggio scientifico per eccellenza, il suo metodo sperimentale però coglie esattamente “l’animus della scienza successiva”. Bacone, in altri termini, pensa a un’identificazione piena fra intelletto umano e natura delle cose; li pone come differenti, per poi attribuire al sapere dell’intelletto la capacità di sottomettere a sé la natura. Il “potere” che l’intelletto ha nei confronti delle cose e dei “segreti” della natura è tale per cui riesce, nella visione baconiana, a distruggere non solo quei ‘fantasmi’ (gli idola) da cui la mente (del singolo uomo e del genere umano) è tradizionalmente affetta, ma compie una sorta di ‘epurazione’ di sé dalla tendenza alla magia e all’occultismo, che alla fine del ‘500 era fortemente presente in Europa . D’altra parte Bacone è il primo consapevole esponente del ‘sapere’ come ‘potere’; di quel potere che l’economia borghese stava, nell’Inghilterra del ‘600, mettendo in atto proprio a scapito della libertà della ricerca teorica; libera da fini pratici, materiali, utili alla società. “Ciò che gli uomini [baconianamente] vogliono apprendere dalla natura, è come utilizzarla ai fini del dominio integrale della natura e degli uomini.” Dunque, secondo Adorno e Horkheimer, l’emancipazione del pensiero dalla magia, dalla superstizione, dagli idoli della metafisica, ecc., tende in realtà – stando ai risultati storico-filosofici cui è giunta la scienza moderna – a instaurare, nella società, un “dominio” altrettanto opprimente, per la coscienza e la natura umana, di quello costituito dalla mancanza di pensiero razionale. Il pensiero scientifico, da Bacone in poi, si caratterizza per la sua totale mancanza di emancipazione dalla struttura sociale cui fa riferimento, e precisamente da quella borghese: “esso non tende […] a concetti e ad immagini, alla felicità della conoscenza, ma al metodo, allo sfruttamento del lavoro, al capitale privato o statale”. Il significato profondo e qualitativo delle cose cui dovrebbe tendere la scienza, viene sostituito dalla ricerca asettica, quantitativa della correttezza formale del procedimento; l’essenza di questo sapere si riduce a tecnica, a operation, procedimento efficace volto a conservare il dominio dell’economia borghese sulla coscienza, il dominio dell’uomo sulla natura. In questo quadro si distinguono anche i compiti propri della scienza da quelli della ricerca filosofica della verità, la quale diventa a sua volta un ostacolo per il moderno pensiero scientifico. La filosofia continua a sopravvivere, dicono gli autori, come idola theatri, come spettro metafisico, considerato dal pensiero scientifico né più né meno che una moderna mitologia. Il ‘lume’ della ragione, nella società borghese, perde totalmente la sua ‘autonomia’ dalle cose. Vediamo in che senso. Se la razionalità illuministica crede di liberarsi dal legame di sudditanza nei confronti della realtà, rendendola quantificabile e scientificamente dominabile, in verità, dicono gli autori, tanto più la conoscenza scientifica viene asservita alla struttura economica e sociale della borghesia, che si caratterizza, marxianamente, come condizione di essenziale alienazione dell’uomo da sé e dalla natura. Il dominio sulla natura da parte dell’uomo si rivela come domino dell’uomo sull’uomo, e più in generale come dominio della struttura sociale sulla coscienza: “Non c’è altro che tenga. Privo di riguardi verso se stesso, l’Illuminismo ha bruciato anche l’ultimo resto della propria autocoscienza.” Il rapporto scientifico di dominio dell’uomo sulla natura si rovescia in rapporto di dominio della società su quella forza del pensiero (l’Illuminismo stesso) che avrebbe dovuto emancipare l’uomo dall’inconsapevolezza, dalla mancanza di autonomia dalla natura, ecc.; la società borghese, il capitale, il lavoro sono il fine di quell’emancipazione umana, che non trova perciò in se stessa la sua ragion d’essere. Il rovesciamento del dominio dell’uomo sulla natura in dominio della società sull’uomo può essere presentato a partire da due punti di vista: da un lato attraverso un’analisi prettamente sociale (come alienazione, reificazione, mercificazione); dall’altro mostrando come l’Illuminismo contenga in se stesso, nella sua essenza, il suo destino, quindi come la ragione illuministica sia per definizione votata al suo ribaltamento 2. La critica dell’Illuminismo al mito e al mondo magico parte dal presupposto che si debba eliminare il rapporto paritario che l’antropomorfismo mitico e l’animismo magico instaurano fra l’uomo e la natura divinizzata. Il primo fu Senofane a criticare “gli dèi molteplici che somigliano ai loro creatori, gli uomini”, ma già le cosmologie presocratiche segnano, secondo Horkheimer e Adorno, un distacco fra la visione mitica del rapporto uomo-natura e la visione illuministica tesa al dominio dell’uno sull’altra. “Come le immagini della generazione dalla terra e dal fiume, giunte ai Greci dal Nilo, diventarono qui principi ilozoistici, elementi, così l’inesauribile ambiguità dei demoni mitici si spiritualizzò nella forma pura delle essenze ontologiche”. La genesi dell’Illuminismo, a ben vedere, affonda le sue radici proprio in ciò che intende criticare; in quella mitologia da cui, quasi spontaneamente, si genera il logos filosofico, la razionalizzazione dell’antropomorfismo mitico e la riduzione a elemento materiale dei principi naturali personificati o divinizzati. L’Illuminismo però, non pago della nascita dei concetti filosofici di ‘spirito’ e ‘materia’ – l’uno dalla mitologia, l’altro dalla cosmologia – si scaglia (in età moderna) anche contro le idee di Platone, la metafisica di Aristotele, la verità gli universali, l’ontologia, ecc. “Nell’autorità dei concetti generali esso crede ancora di scorgere la paura dei demoni […]. D’ora in poi la materia dev’essere dominata al di fuori di ogni illusione di forze ad essa superiori o in essa immanenti, di qualità occulte. Ciò che non si piega al criterio del calcolo e dell’utilità, è, agli occhi dell’Illuminismo, sospetto” . Adorno e Horkheimer individuano, a questo proposito, una precisa dialettica Illuminismo-mito che riferiscono sostanzialmente all’esposizione fenomenologica hegeliana dell’Aufklärung . La lotta dell’Illuminismo contro il mito non è, come si è visto, un’opposizione fra due termini assolutamente eterogenei; vi è una genesi storico-ideale della filosofia, del pensiero razionale (logos) e quindi dello stesso Illuminismo (inteso come ragione, pensiero in continuo progresso) che procede dal mito, quindi proprio dall’attribuzione indebita di caratteri divini all’uomo e alla natura o, il che è lo stesso, di caratteri umani al dio. La nascita della filosofia, in questi termini, fa nascere lo stesso atteggiamento illuministico della ragione, la quale ha buon gioco a criticare quelli che considera residui mitici (idealismo, metafisica, ontologia, ecc.), con l’intento di eliminarli del tutto. Anche le idee di Platone vengono tacciate di irrazionalismo, nella misura in cui non si attengono ai cosiddetti ‘dati di fatto’, neutralmente e lucidamente considerati da una ragione che non intende lasciare nulla, tra quello che cade sotto la sua considerazione, di inspiegato e non razionalizzato. Da parte sua, il mito-filosofia, nel momento stesso in cui prova a difendere la sua ragion d’essere, conferma la necessità di scendere a patti con l’Illuminismo e il suo modo di usare analiticamente la ragione. “L’Illuminismo è totalitario”, ingloba in sé anche il suo opposto. La lotta dell’Illuminismo contro l’antropomorfismo e contro la proiezione del soggettivo nella natura si concretizza da una parte nella fissazione dell’uomo come principio assoluto e dominatore del mondo naturale, dall’altra nella costruzione di un sistema teorico chiuso (razionalista o empirista che sia) nel quale sia tutto calcolabile e al quale tutto sia riducibile. La demitizzazione completa dell’universo arriva al suo apice, dicono gli autori, solo quando “il numero divenne il canone dell’Illuminismo.” La stessa società borghese sembra proprio reggersi sull’equivalente scambio di merci, che annulla ogni differenza qualitativa, riducendo a unità-quantità tutto ciò che le si presenta sotto mano. “L’essere si scinde d’ora in poi nel logos – che si riduce col progresso della filosofia, alla monade, al mero punto di riferimento -, e nella massa di tutte le cose e creature esterne. […] Senza riguardo alle differenze, il mondo viene sottomesso all’uomo” [corsivi nostri]. Questo doppio binario (numero e uomo, essere a-qualitativo e logos illuministico, massa di tutte le cose e dominio umano) sul quale l’Illuminismo, a detta degli autori, sembra viaggiare, approda alla costituzione del Sé, cioè alla identità della coscienza, della cultura e della ideologia della civiltà occidentale . Potrebbe non risultare chiaro al lettore il rapporto strettamente teoretico fra mito e Illuminismo, perché da un lato essi paiono allontanarsi in quanto il primo vive dell’identificazione uomo-natura e il secondo della loro separazione; allo stesso tempo però si afferma che entrambi perseguono il dominio sulla natura, anche se attraverso forme diverse; poi si dice che l’Illuminismo deriva direttamente dalla razionalizzazione del mito operata dalla filosofia (e quindi in questa ipotesi il mito è irrazionale), ma insieme che già il mito è Illuminismo in quanto spiegazione in termini razionali della realtà. Allora, ci si potrebbe chiedere, il mito è ‘già’ o ‘non ancora’ Illuminismo? La risposta, seguendo gli autori, è che il mito è al contempo ‘già’ e ‘non ancora’ Illuminismo. Il problema è dato dal fatto che Adorno e Horkheimer istituiscono questa dialettica ‘aporetica’ mito-Illuminismo/Illuminismo-mito; dunque, dicono, se la moderna razionalità intende separali, in realtà, non sa che essi sono ‘da sempre’ uniti, sebbene la loro unione sia profondamente contraddittoria. Ma è proprio questa contraddizione a costituire l’essenza della nostra moderna e borghese civiltà. Il problema che loro pongono è anche teorico, ma soprattutto etico. L’uomo (come genere e come civiltà occidentale) si è invischiato, in età moderna, in una difficoltà reale della quale, in tempi mitici, non era appieno consapevole (gli mancava la piena consapevolezza del ‘lume’ della ragione). Il trionfo dell’Illuminismo porta alle estreme conseguenze il contraddittorio rapporto dell’uomo con se stesso e con la natura. Gli dà una spiegazione scientifica, apparentemente emancipata dal mito, ma questa spiegazione non elimina, secondo gli autori, la contraddizione reale, la quale resta e anzi si fa più pesante in una condizione in cui, la ragione potrebbe (ma non lo fa), recuperare quel nesso originario che il mito ‘sembrava’ istituire fra il genere umano e la natura. Horkheimer e Adorno non forniscono soluzioni: vogliono al contrario che ad andare a fondo sia proprio ogni pretesa di ‘soluzione’. La ‘dialettica’ dell’Illuminismo (cioè a dire che anche l’Illuminismo ha una sua dialettica, può avere forti capacità critiche nei confronti di una realtà irrazionale, etc.) sta a significare che la ‘contraddizione reale’ va necessariamente esplicitata, in tutta la sua paradossalità, anche quando risulti insostenibile e fastidiosa a una ragione che desidera a tutti i costi ‘far quadrare i conti’. Ma, se i conti non quadrano, va detto ed evidenziato, senz’altro. Dunque si potrebbe dire che il rapporto mito-Illuminismo e Illuminismo-mito (l’uno rimanda a l’altro e viceversa) è rapporto dialettico nella misura in cui il mito è già il tentativo dell’uomo di venire a patti con le forze naturali, certo da una posizione ancora di ‘inferiorità’ e non pienamente razionale. L’Illuminismo perciò, criticando il mito, non fa altro che realizzarlo, completarlo, superarlo (nel senso hegeliano dell’aufheben). Ma questo superamento, la ‘falsa coscienza’ dell’Illuminismo lo presenta come annientamento del mito in quanto tale. L’Illuminismo assolutizza se stesso e così facendo si ripropone in veste ‘mitica’, non criticabile, non superabile a sua volta, come esso ha voluto invece fare con il mito. Questa assolutizzazione della ragione, in età moderna, è la “colpa” che Horkheimer e Adorno attribuiscono alla logica occidentale, alla scienza, al progresso, ecc. E’ un’assolutizzazione che passa sopra a tutto e fa terra bruciata; passa sopra la natura, ma – non si dimentichi il nazismo – anche sopra all’uomo. 3. Vediamo allora come Horkheimer e Adorno ci presentano questo cammino dell’Illuminismo verso la nascita della soggettività moderna-contemporanea. “L’emergere del soggetto [distinto dalla natura-oggetto] è pagato col riconoscimento del potere come principio di tutti i rapporti. […] La somiglianza dell’uomo con Dio consiste nella sovranità sull’esistente, nello sguardo padronale, nel comando. Il mito trapassa nell’Illuminismo e la natura in pura oggettività. Gli uomini pagano l’accrescimento del loro potere con l’estraniazione da ciò su cui lo esercitano.” Il progresso del pensiero è in realtà un regresso sociale e umano. La presa di consapevolezza da parte del soggetto (del singolo uomo e del genere umano) di essere capace di dominare razionalmente la realtà e soprattutto la natura (con la scienza), paga uno scotto senza precedenti, che nell’età moderna si concretizza non solo nel dominio dell’uomo sull’uomo, ma nel dominio delle cose (merci, lavoro, capitale) sugli uomini. Il rapporto mitico uomo-natura, nel quale l’uno e l’altra erano in simbiosi, viene sostituito da un rapporto di estraniazione dell’uomo dal mondo naturale. L’estraniazione segna negativamente quell’apparente positività con la quale l’Illuminismo crede di appropriarsi delle cose. Il possesso, il dominio, il comando, il potere esercitato dalla ragione sulle cose è in realtà un allontanamento, un distacco e, nella società borghese contemporanea, un rovesciamento del dominio: l’uomo socializzato controlla la natura, ma a sua volta è controllato dalla struttura economica della società. La consapevolezza con la quale egli diventa il soggetto assoluto del rapporto uomo-natura, viene annullata nell’inconsapevolezza con la quale è assoggettato al potere economico borghese. “Perché le pratiche localizzate dello stregone cedessero il posto alla tecnica industriale universalmente applicabile, era prima necessario che i pensieri si rendessero indipendenti dagli oggetti, come avviene nell’Io conforme alla realtà.” La nascita della società borghese, della scienza tecnologicamente applicata, del soggetto dominatore, sono tutti momenti che si costituiscono a partire dall’abbandono del rapporto ‘intersoggettivo’ uomo-natura. Ma – si chiedono gli autori – come è potuto accadere ciò? “Come totalità linguisticamente sviluppata, che mette in ombra, con la sua pretesa di verità, la fede mitica più antica, le religioni popolari, il mito solare, patriarcale, è già Illuminismo, con cui l’Illuminismo filosofico può misurarsi sullo stesso piano. […] La mitologia stessa ha avviato il processo senza fine dell’Illuminismo (…)” [corsivo nostro]. Allora possiamo vedere la precisa dialettica che viene fin da subito instaurata fra mito e Illuminismo nello stesso momento in cui il mito (vissuto e sentito nel mondo magico, pre-filosofico) diventa precisamente ‘mitologia’, cioè discorso, ragionamento, pensiero sul mito. La critica mossa dall’Illuminismo alla mitologia, non solo la obbliga a difendersi, scendendo sul piano logico, il piano dell’Illuminismo ( il riferimento è a Hegel e alla lotta dell’Illuminismo contro la fede che, per difendersi dalla critica deve ‘discutere’, articolare il linguaggio, fare del logos e cioè scendere sul piano logico-razionale a lei estraneo; allo stesso modo succede anche al mito criticato dall’Illuminismo), ma la riconosce in quanto discorso (logos) sul mito; in questo senso il mito è già Illuminismo, dal mito prende le mosse l’Illuminismo. Gli autori tendono a distinguere ‘mito’ da ‘mitologia’ (e lo si vedrà meglio più avanti): il mito in quanto tale è il rapporto originario uomo-natura, la mitologia invece è già sistemazione logica, pensata, articolata, di quel rapporto. L’originario rapporto di parità uomo-natura(divinizzata), nella mitologia, nell’ordinamento del mito e della tradizione mitica, è già andato perduto. Il soggetto teoretico, il filosofo, il logos e quindi il germe dell’Illuminismo ha già preso piede, iniziando un inarrestabile cammino che porterà l’umanità alla società moderna-contemporanea, all’estraniazione totale dell’uomo dalla natura pur da esso dominata. Il Sé a cui è pervenuta la civiltà europea, dicono gli autori, è in realtà schiacciato e non emancipato dall’irrazionalità, in una società che si presenta fondata sul rapporto di dominio del collettivo sull’individuale, della quantità indifferente sulle differenze qualitative, della giustizia livellatrice sulla libertà personale, ecc. “L’uomo si illude di essersi liberato dalla paura quando non c’è più nulla di ignoto. Ciò determina il corso della demitizzazione dell’Illuminismo […].” Ma la paura in realtà resta, nella misura in cui l’ignoto diventa per eccellenza il tabù della scienza positivistica (ultimo prodotto dell’Illuminismo). Non c’è un rapporto di inclusione fra la ragione e ciò che ragione non è, c’è al contrario un rapporto di esclusione messo in atto dalla ragione stessa, la quale così facendo espelle da sé il mito (il mana, come lo chiamano gli autori), riproponendolo come ciò che rimane fuori, ma che pur sempre rimane. Da una parte la civiltà occidentale si libera di ciò che non è conforme alla ragione, domina la natura, l’ignoto, ecc.; dall’altra però non elimina la paura stessa dell’ignoto, lasciandolo fuori della sua organizzazione sociale e scientifica, la quale viene a poggiare su criteri di ‘uguaglianza’, omologazione e dominio che, al dunque, annullano ogni libertà essenziale dell’individuo. 4. L’Illuminismo investe anche il campo dei rapporti fra le scienze e più precisamente fra la scienza e l’arte, fra il segno e l’immagine; oltre che il più complesso rapporto fra linguaggio e realtà. Viene inoltre tematizzato il rapporto fra Illuminismo e dialettica, intesa quest’ultima come capacità critica della ragione di negare l’esistente evitando accuratamente di assolutizzarlo. Ma vediamo meglio. La rottura dell’originario mana (unità di uomo e natura) fa sì che si distinguano anche, secondo Horkheimer e Adorno, il linguaggio (la parola come segno) dall’immagine (parola come imitazione della natura). “Come segno, la parola passa alla scienza; come suono, come immagine, come parola vera e propria, viene ripartita fra le varie arti […]. La separazione di segno e immagine è inevitabile.” In questa sorta di divisione del lavoro teorico fra scienza e arte, per cui l’una conosce la natura senza somigliarle, l’altra si limita ad essere solo copia della natura, il neopositivismo, la scienza contemporanea, abdica totalmente alla tensione conoscitiva e si riduce a “gioco” matematico, chiuso in se stesso, con le sue regole automatiche, le quali non sono riferite direttamente alla realtà, tanto meno al pensiero inteso classicamente: “L’Illuminismo ha accantonato l’esigenza classica di pensare il pensiero – di cui la filosofia di Fichte è lo svolgimento radicale […].” Questa divisione del lavoro serve, dicono gli autori, all’autoconservazione del dominio sociale, nella misura in cui non solo elimina la possibilità della critica (il pensiero a stretto rigore non pensa, il linguaggio scientifico è un segno separato dalla realtà, l’arte è copia acritica della natura), ma preclude ogni possibilità all’uomo di conoscere. “Il pensiero si reifica in un processo automatico che si svolge per conto proprio, gareggiando con la macchina che esso stesso produce perché lo possa finalmente sostituire.” L’apparato teorico così costituito (il positivismo scientifico) rende asservito il pensiero a meccanismi ad esso estranei; nei quali non solo il pensiero stenta a riconoscersi ma sui quali non esercita alcun potere. Questo è l’aspetto più contraddittorio e autodistruttivo dell’Illuminismo che, invece di realizzare il sapere, lo distrugge trasformandolo in mero calcolo utilitaristico, in formalismo logico, in un ambito separato dalla realtà, dalla natura, dall’essere delle cose. Il soggetto conoscente è incapace di conoscere; la realtà impenetrabile si riproduce meccanicamente secondo criteri e metodi alieni alla ragione. Se il ‘lume’ della ragione si presenta come progresso conoscitivo, in realtà sottomette il pensiero a regole estranee e opprimenti. “Non c’è essere al mondo che la scienza non possa penetrare, ma ciò che può essere penetrato dalla scienza non è l’essere” . Di fronte a questa estraneità del pensiero alla realtà, giace la realtà stessa, la quale viene risparmiata dalla critica: essa viene in fondo riprodotta e giustificata così come è. E’ una realtà ingiusta e brutale quella a cui stiamo assistendo, dicono gli autori, tale che richiederebbe un’impietosa critica. La negazione dialettica (o negazione determinata) del reale è ciò che solamente può scardinare la durezza impenetrabile della realtà. “Nel concetto di negazione determinata, Hegel ha indicato un elemento che distingue l’Illuminismo dalla corruzione positivistica a cui egli lo assegna. Ma finendo egli per elevare ad assoluto il risultato consaputo dell’intero processo della negazione: la totalità sistematica e storica, contravvenne al divieto e cadde a sua volta nella mitologia.” Vediamo allora a cosa esattamente si riferiscono i due autori. Il procedimento dialettico hegeliano, secondo Horkheimer e Adorno, riesce bene a utilizzare il carattere fondamentale del pensiero illuministico, cioè quello di negare, per superare e togliere, gli aspetti contraddittori e irrazionali del reale. Ma ricadendo nell’esigenza di affermare comunque la razionalità, di affermarla nonostante l’irrazionalità di una realtà poco prima negata, cede al carattere paradossale dell’Illuminismo: la critica dell’Illuminismo al mito (come l’esempio classico e originario di irrazionalità nella storia del pensiero occidentale) ristabilisce il mito stesso. Il mito di una realtà pienamente razionale. Gli autori utilizzano qui il termine ‘mito’ in un’accezione differente rispetto a quella usata finora. Il mito antico era l’immediata interpretazione umana della natura, superata la quale, da parte dell’Illuminismo, si instaura il ‘mito’ di una realtà pienamente razionale. Chiaramente il primo ‘mito’ è differente dal secondo, ma, nella sostanza, quello che vogliono sottolineare i due autori è che così come il mito originario si presentava resistente ad ogni intervento critico della ragione, anche il mito moderno (la ragione assolutizzata e incontestabile) si presenta impermeabile alla possibilità di essere a sua volta sottoposto a critica. 5. L’ultima argomentazione presentata dai due autori riguarda la formazione e l’autoconservazione del soggetto borghese (del Sé ideologico ma anche della struttura di potere vigente nella società contemporanea). Viene descritta un’allegoria particolarmente suggestiva fra il racconto omerico del dodicesimo canto dell’Odissea (il passaggio di Odisseo davanti alla Sirene) e la nascita della civiltà occidentale, che nella modernità culmina con l’instaurarsi di un controllo e dominio assoluto dell’uomo sulla natura e su una parte del genere umano. Odisseo rappresenta l’umanità che “ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso, perché nascesse e si consolidasse il Sé, il carattere identico, pratico, virile dell’uomo […].” Il canto delle Sirene cui Odisseo (l’io occidentale-borghese) deve resistere rappresenta il “passato; quel passato in cui l’uomo viveva in simbiosi con la natura, o meglio in cui non distingueva Sé dagli oggetti naturali. Lo sforzo di Odisseo di resistere al richiamo della natura-vita, rappresentata da quel canto, è necessario per conservare l’integrità dell’individualità personale dell’uomo borghese, ma soprattutto per mantenere quei rapporti di dominio dell’uomo sull’uomo, ben rappresentati, secondo gli autori, dal mito omerico. Sulla nave di Odisseo i suoi compagni hanno le orecchie tappate con la cera; il loro unico compito è quello di remare. “E’ ciò a cui la società ha provveduto da sempre. Freschi e concentrati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciar stare tutto ciò che è a lato. […] Essi diventano pratici. […] Odisseo, il signore terriero, che fa lavorare gli altri per sé […] ode, ma impotente, legato all’albero della nave […]. I compagni […] riproducono, con la propria vita, la vita dell’oppressore, che non può più uscire dal suo ruolo sociale”. L’analogia istituita da Horkheimer e Adorno fra il mito omerico e la struttura della società borghese è tale per cui la soggettività di chi domina (il proprietario della terra, dei mezzi di produzione), sebbene consapevole di rivestire un ruolo sociale che lo obbliga ad avere un rapporto di dolore ed estraniato con la natura (le Sirene), sa altresì di non poterne fare più a meno, pena la mancata autoconservazione di sé e della sua proprietà (fuori dei rapporti borghesi di produzione non è consentito sopravvivere). D’altra parte il lavoratori (compagni di Odisseo) mancano forzatamente di consapevolezza e coscienza sociale (hanno le orecchie tappate); la loro unica occupazione è materiale, volta alla riproduzione di sé e del padrone stesso. Essi sono quella parte del genere umano asservita (inconsapevolmente) al dominio borghese. Questo quadro assolutamente desolante e fortemente critico, viene però, secondo Horkheimer e Adorno, riscattato nella misura in cui la stessa ideologia borghese (l’Illuminismo della società contemporanea) rivela la sua interna paradossalità e inconsistenza teorica. “Misure come quelle prese sulla nave di Odisseo al passaggio davanti alle Sirene sono l’allegoria presaga della dialettica dell’Illuminismo”. Ciò che sembrava la realizzazione della libertà, dell’emancipazione dell’uomo (come singolo e come genere), il trionfo della ragione, si presenta al dunque come la realizzazione più cruda e irrazionale di un’oppressione e coercizione dell’uomo su se stesso oltre che sulla natura. Il mito poi (in questo caso quello di Odisseo) è ciò che, paradossalmente, rappresenta meglio la logica interna dell’Illuminismo; di quel pensiero razionale che intendeva invece dal mito liberarsi definitivamente. Excursus I. Odisseo, o Mito e Illuminismo 1- La dialettica dell’Illuminismo è testimoniata esemplarmente dall’Odissea nel suo complesso. Il nucleo originale è mitico, ma, organizzato dallo spirito omerico, si distacca da quella tradizione popolare da cui pure proviene. C’è una contraddizione, secondo gli autori, fra ‘mito’ e organizzazione mitologica nell’epos, cioè fra mito tramandato oralmente e mito raccontato, scritto, rielaborato razionalmente: “[…] cantare l’ira di Achille e le peripezie di Odisseo è già una stilizzazione nostalgica di ciò che non si può più cantare, e il soggetto delle avventure si rivela il prototipo dello stesso individuo borghese […].” Come sappiamo, c’è un rapporto dialettico fra mito e Illuminismo: da una parte la ragione organizzatrice (rappresentata in questo caso dalla mano di Omero) mette a punto una ricostruzione scritta del mito che emancipa l’uomo (la civiltà occidentale) dalla “preistoria”, dall’assenza di un rapporto razionale fra uomo e natura; d’altra parte però l’inizio dell’Illuminismo risale proprio alla tradizione mitica più remota. Il passaggio dal ‘mito’ all’approccio illuministico segna anche un passaggio a forme di ‘dominio’ dell’uomo sulla natura che – come ha ben compreso Nietzsche – si presentano fortemente ambivalenti: è il progresso umano e civile dell’uomo che distrugge la vitalità del suo rapporto con le forze naturali. E’ un progresso distruttivo quello a cui l’Illuminismo conduce. Non c’è opera che testimoni in modo più eloquente dell’intreccio di mito e Illuminismo di quella omerica, testo originale della civiltà europea.” Secondo Horkheimer e Adorno, l’itinerario di Odisseo è lo stesso itinerario del soggetto (del Sé) moderno-borghese, il quale, prima di prendere coscienza della sua razionalità, deve emanciparsi faticosamente da uno stadio di civiltà ancora legato a culti, forme di dominio e di vita mitiche. L’emancipazione dal mito, tuttavia, non annulla il mito in quanto tale, che anzi, proprio nell’Odissea, diventa metafora della struttura borghese della società e dell’individuo come tale. 2- L’astuzia di Odisseo rappresenta il ‘lume’ della ragione, contrapposto a una brutalità tutta naturale e mitica, comunque originaria, nella quale l’uomo si trova a dover combattere con forze ed istinti caratterizzati negativamente nell’epos omerico (Polifemo, la maga Circe, le Sirene, etc.). “L’organo con cui il Sé sostiene le avventure, e fa getto di sé per conservarsi, è l’astuzia.” L’astuzia di Odisseo rappresenta un ‘ordine’ (la patria, la famiglia a cui l’eroe tenta di ritornare attraverso il suo lungo viaggio); quell’ordine borghese che permette la riproduzione e l’autoconservazione dell’uomo entro schemi e rapporti da lui dominati e regolati. “Ecco il segreto del processo tra epos e mito: il Sé non costituisce la rigida antitesi all’avventura, ma si costituisce, nella sua rigidezza, solo in questa antitesi, unità solo nella molteplicità di ciò che quell’unità nega.” Il distacco dal mito, che nell’epos omerico viene descritto, porta l’uomo a irrigidirsi. Assistiamo, in altri termini, a una sorta di razionalizzazione (come irrigidimento) della vita e della coscienza umana, che si presenta come una conquista di civiltà, raggiunta attraverso un’avventura epico-mitica. Una conquista descritta mitologicamente e che al contempo emancipa (o crede di emancipare) definitivamente l’uomo dal mito. L’irrigidimento costitutivo del Sé (della coscienza umana moderno-borghese) sta proprio nella contraddittoria convinzione di essersi per sempre liberato del mito e nel credere che questa liberazione sia anche la realizzazione stessa del progresso. L’astuzia di Odisseo si manifesta anche come superamento del “sacrificio” (sacrificio dell’uomo al dio) e come consapevolezza da parte dell’eroe nell’usare il linguaggio. Ma vediamo in che senso. Notano gli autori che nell’epos omerico non vi sono descritti veri e propri sacrifici umani; vi è piuttosto la presa di coscienza, da parte di Odisseo, dell’inganno che il sacrificio in quanto tale rappresenta. Rendere, da parte dell’uomo, un sacrificio al dio vuol dire non solo ingraziarselo (e attraverso di lui ingraziarsi la natura), ma in qualche modo dominarlo, comunque controllarlo, sebbene da una posizione di inferiorità, e limitarne il potere. Ma l’uomo, in cuor suo, dicono Horkheimer e Adorno, non può non sapere che la divinità a cui ci si sacrifica in realtà viene in questo modo a far parte di uno scambio tutto umano, il cui valore ultimo certo non va al dio. “Se lo scambio è la secolarizzazione del sacrificio, il sacrificio stesso appare già come il modello magico dello scambio razionale, un espediente degli uomini per dominare gli dèi, che vengono rovesciati proprio dal sistema degli onori che loro si rendono.” Che cosa fa allora Odisseo di diverso dal sacrificio-scambio? Che cosa aggiunge a questa forma magico-mitica di inganno reso agli dèi? La vicenda a cui gli autori si riferiscono è quella descritta nell’Odissea a proposito del ‘falso’ sacrificio reso a Posidone; mentre il dio viene accontentato da ingenti sacrifici nella terra degli Etiopi, Odisseo può fuggire indisturbato e mettersi in salvo. L’uso ‘astuto’ e indiretto del sacrificio lo trasfigura e ne rovescia il senso originario; porta alla coscienza dell’uomo la possibilità di falsificare e dissimulare il rapporto con gli dèi, esclusivamente per il suo vantaggio personale. “Ma inganno, astuzia e razionalità non sono semplicemente opposti all’arcaismo del sacrificio. Odisseo non fa che elevare ad autocoscienza il momento dell’inganno nel sacrificio, che è forse la ragione più intima del carattere illusorio del mito.” Ecco allora che questa presa di coscienza è un passo oltre la magia del sacrificio, il quale, in questo modo, viene realizzato dall’uomo come consapevole inganno, come scambio moderno-borghese ante litteram, come dominio cosciente sulla natura divinizzata, come rovesciamento infine del rapporto di dominio del dio sull’uomo. Questo stacco illuministico dal mito è rappresentato bene anche dal modo in cui Odisseo usa il linguaggio e precisamente il suo nome. Udeis in greco vuol dire nessuno; con questo significato del proprio nome Odisseo si presentò a Polifemo il quale, reso cieco dall’eroe, pur chiedendo aiuto ai Ciclopi venne frainteso quando questi gli chiesero chi l’avesse ridotto a quel modo: “Nessuno!” rispose. “Nasce così la coscienza del significato: nelle sue angustie Odisseo si accorge del dualismo, in quanto apprende che la stessa parola può significare cose diverse.” Secondo gli autori, questa ulteriore presa di coscienza, da parte dell’eroe mitico, lo solleva dall’immediatezza del rapporto con le cose, con gli oggetti e la natura. L’immediatezza con cui le parole vengono attribuite alla realtà viene definitivamente rotta e mediata, da quel momento in poi, dal pensiero. La coscienza di Odisseo comincia appositamente a separare le parole dalle cose, a rendere problematico il riconoscimento dell’uomo nel proprio nome. Assistiamo, dicono gli autori, a un duplice sdoppiamento; da una parte il linguaggio si separa dalla cosa designata, potendo di per sé assumere significati anche opposti, che indicano opposte realtà, dall’altra è l’uomo stesso a sdoppiarsi nel proprio nome, ingannando la realtà al fine di autoconservarsi come individuo dotato di ragione e capace di dominare astutamente le circostanze esterne. Dall’astuzia di Odisseo “[…] emerge il nominalismo, il prototipo del pensiero borghese. L’astuzia dell’autoconservazione vive di questo processo in atto fra parola e cosa.[…] L’astuto pellegrino è già l’homo oeconomicus a cui somigliano tutti gli uomini dotati di ragione.” Excursus II. Juliette, Illuminismo e morale 1. Kant e la ragione strumentale: “L’Illuminismo è, per dirla con Kant, “l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro””. Secondo gli autori, Kant ha avuto il merito di cogliere il senso più profondo dell’Illuminismo, inteso come processo di conoscenza sistematica e scienza tout court; ha presentato però la ragione scientifica come uno “strumento” e cioè come un mezzo di conoscenza non dotato a sua volta di autocoscienza. Insomma, per dirla con Hegel, ciò che manca alla teoria della conoscenza di Kant è la capacità della ragione soggettiva di conoscere l’essenza delle cose e di riconoscerla come la propria essenza. Permane una distanza tra il soggetto e la realtà, non colmata dalla scienza, sebbene questa si presenti come l’unico modo di sistemare la verità delle cose. Certamente l’Illuminismo kantiano ha conquistato al soggetto la ‘libertà’ di agire indipendentemente da autorità esterne ed estranee alla sua logica, ma non ha risolto, in sede teorica e pratico-morale, la possibilità che quella libertà conquistata venga contraddetta e negata. “Alla base dell’ottimismo kantiano per cui l’agire morale sarebbe razionale anche là dove quello immorale ha buone probabilità di successo, è l’orrore di fronte al pericolo di una ricaduta nella barbarie.” Dunque, la possibilità che il percorso ‘lineare’ del progresso scientifico e morale dell’uomo moderno venga contraddetto, arrestato e al limite anche rovesciato, si dà nonostante quell’ottimismo kantiano-illuministico, che si rivela in realtà, secondo gli autori, come paura malcelata dell’irrompere nella ‘civiltà’ di elementi irrazionali. L’Illuminismo tende ad autoconservarsi come dominio borghese dell’uomo sulla natura; nel corso di questo assoggettamento dell’una all’altro intervengono distorsioni, contraddizioni reali, regressioni che coinvolgono la stessa scienza. Nella sua Critica della ragion pura, dicono gli autori, Kant ne ha dato conto; è l’Illuminismo ‘ideologico’ (cioè quello collegato direttamente al potere e alla struttura economico-borghese) che cela queste difficoltà “dietro l’apparente chiarezza dei suoi giudizi.” Dunque, il merito di Kant starebbe proprio nel suo tentativo (seppure non riuscito) di trovare all’interno della scienza un posto anche per la ‘contraddizione’; ossia di spiegare razionalmente l’irrazionalità, le difficoltà logiche e morali difronte a cui necessariamente si trova la moderna e illuministica coscienza umana. 2. Chi invece ha, certamente a suo modo, assolutizzato l’irrazionalità e l’immoralità dell’uomo moderno è Sade. L’Histoire de Juliette, secondo gli autori, è l’opera che meglio rappresenta il rovesciamento della morale illuministica e della società borghese. “La ragione è l’organo del calcolo, della pianificazione; neutrale verso i fini, il suo elemento è coordinazione. L’affinità di conoscenza e piano (fondata trascendentalmente da Kant), che dà all’esistenza borghese, razionalizzata fin nelle sue pause, un carattere, in tutti i particolari, di finalità ineluttabile, è stata esposta empiricamente da Sade un secolo prima dell’avvento dello sport. […] La peculiare struttura architettonica del sistema kantiano, come le piramidi ginniche delle orge di Sade e la gerarchia di principi delle prime logge borghesi […] preannuncia un’organizzazione di tutta la vita destituita di ogni scopo oggettivo.” L’ardito paragone istituito dai due autori fra lo schematismo trascendentale kantiano (cioè l’interna e autonoma struttura intellettuale del soggetto conoscente e immerso nell’esperienza), la ‘struttura’ delle orge sadiane, l’organizzazione sportiva del mondo contemporaneo e la struttura stessa della società borghese, ci fa ben comprendere il senso che Horkheimer e Adorno attribuiscono alla nozione di ‘dialettica’. I prodotti scientifici, culturali, artistici e sociali del mondo contemporaneo (nato dallo sviluppo dell’Illuminismo premoderno, che si è innanzitutto scagliato contro il mito, ecc.) sembrano, apparentemente e secondo il senso comune, realizzare appieno la razionalità dell’uomo, identificata con il suo alto grado di civilizzazione. Ma, a ben vedere, questi stessi risultati della cosiddetta civiltà si contraddicono reciprocamente e in se stessi. Da una parte, la ragione illuministico-kantiana viene ad assumere una funzione sociale distaccata dalla più intima coscienza umana, diviene “ragione strumentale”, organizzazione ‘neutrale’ di un materiale umano (l’esperienza in genere) che non riceve da questa ‘architettura razionale’ nessun accrescimento in termini di autocoscienza, consapevolezza, capacità di riconoscersi nelle cose e agire nel mondo come a casa propria e a casa propria come nel mondo. D’altra parte, questa struttura razionale, proprio a causa della sua pretesa ‘neutralità’ può essere applicata anche a ciò che razionale non è, anche a ciò che contraddice la moralità e i valori conquistati dalla ragione illuministica. La dialettica, cioè il rovesciamento nel suo opposto, che subisce la ragione strumentale, si manifesta anche nella società stessa come immoralità, come agire controllato e finalizzato dell’uomo verso scopi che prescindono dalla comprensione qualitativa dell’oggetto. C’è un totale “rovesciamento dei valori”, riprodotto sistematicamente in una società che ha come scopo ultimo e fine a se stesso, non l’innalzamento della coscienza umana, ma il dominio delle cose sugli uomini in forma di “potere economico”. “Sade e Nietzsche hanno eternato questa contraddizione, ma hanno contribuito così a recarla al concetto.” Ossia: sebbene questi due autori abbiano aderito alla dialettica dell’Illuminismo appena esposta, l’hanno proprio per ciò portata alla coscienza, l’hanno indagata, hanno contribuito a svelarne il carattere “distruttivo” della razionalità e moralità dell’uomo moderno-borghese. “Il fatto di non aver mascherato, ma proclamato ad alta voce l’impossibilità di produrre, in base alla ragione, un argomento di principio contro l’assassinio, ha alimentato l’odio di cui proprio i progressisti perseguitano ancora oggi Sade e Nietzsche. […] L’uno e l’altro hanno preso in parola la scienza. […] Proclamando l’identità di ragione e dominio, le dottrine spietate sono più pietose di quelle dei lacchè della borghesia. “Dove sono i tuoi massimi pericoli ? – si è chiesto una volta Nietzsche -: nella compassione”. Egli ha salvato, nella sua negazione, la fiducia incrollabile nell’uomo, che è tradita giorno per giorno da ogni assicurazione consolante.” Svelare criticamente e senza appello la “deformazione” in cui è caduta la pretesa civiltà occidentale; non concedere alcuna “compassione” a questo stato di cose, è ciò che, paradossalmente, riscatta l’uomo dalla “barbarie” borghese, dalla dialettica dell’Illuminismo, dall’ipocrita ideologia borghese di progresso. L’industria culturale. Quando l’illuminismo diventa mistificazione di massa 1. Nella società contemporanea e ‘di massa’ viene istituito un nesso inscindibile fra bisogni, sistema produttivo, tecnica, dominio. Di fronte a questo potente quadrinomio l’individuo si presenta piuttosto come “consumatore” passivo. La produzione di cultura non risponde a esigenze che soddisfino la qualità umana, la coscienza, la consapevolezza critica, e così via, ma la riproduzione del “capitale investito”. Il lavoratore stesso, dicono gli autori, è orientato dalla produzione anche nel suo tempo libero. “Il compito che lo schematismo kantiano aveva ancora assegnato ai soggetti, quello di riferire in anticipo la molteplicità sensibile ai concetti fondamentali, è levato al soggetto dall’industria.” In altri termini: la produzione industriale di ‘cultura’ toglie al soggetto la capacità di pensare autonomamente, in virtù di se stesso, ne annienta l’interna attività intellettiva, poiché semplicemente la sostituisce con l’automatismo, la ripetitività, già data al di fuori e a prescindere dalla coscienza. “Si può sempre capire subito, in un film, come andrà a finire, chi sarà ricompensato, punito o dimenticato; per non parlare della musica leggera, dove l’orecchio preparato può, fin dalle prime battute del motivo, indovinare la continuazione, e sentirsi felice quando arriva.” E’ questa una condizione di alienazione in cui l’uomo massa vive e si conserva, senza per altro averne l’esatta percezione. “I prodotti dell’industria culturale possono contare di essere consumati alacremente anche in stato di distrazione. Ma ciascuno di essi è un modello del gigantesco meccanismo economico che tiene tutti sotto pressione fin dall’inizio, nel lavoro e nel riposo che gli assomiglia.” La riproducibilità stereotipa di tutto determina l’annientamento di ogni differenza qualitativa e di ogni capacità creativa della ragione. Il prodotto contemporaneo dell’Illuminismo, il progresso dell’industria e la produzione capitalistica di cultura, si risolve in un annullamento della capacità intellettiva, del ‘lume’ della ragione umana. La cultura diventa “imitazione”, vuota di contenuto. 2. Questo processo di impoverimento culturale si presenta sotto gli occhi di tutti nei paesi industrializzati, tanto più in quelli nati politicamente dal “liberalismo”. “Non per nulla il sistema dell’industria culturale è sorto nei paesi industriali più liberali, come è là che hanno trionfato tutti i suoi mezzi caratteristici, il cinema, la radio, il jazz e i magazines.” Ma l’industria culturale più che avere caratteristiche politiche, nasce e si riproduce come sistema dell’amusement, del divertimento e dello svago. “Al processo lavorativo nella fabbrica e nell’ufficio si può sfuggire solo adeguandosi ad esso nell’ozio. Di ciò soffre inguaribilmente ogni amusement.” L’uomo diventa “cliente e impiegato”, rincorso dalla produzione culturale fin nella sua più intima coscienza; quanto più crede di emanciparsi dal processo lavorativo, tanto più ne riproduce e mantiene i presupposti, consumandone i prodotti culturali, la merce-cinema, la merce-TV, la merce-musica, etc. 3. La realtà non può più essere criticata; la libertà del pensiero a cui l’Illuminismo diceva di aver condotto la coscienza moderna si risolve in consumo acritico delle merci. “A dimostrazione della sua divinità il reale viene sempre e solo ripetuto cinicamente. […] La nuova ideologia ha per oggetto il mondo come tale.” Il cerchio si è chiuso: il progresso illuministico è approdato all’assoluta ‘positività’ della realtà estraniata dell’uomo; l’incontestabilità delle relazioni economiche e culturali instaurate dalla produzione capitalistica, diventa il ‘feticcio’ nei confronti del quale l’uomo singolo e il genere sono sottomessi come a un’autorità divina, che esce fuori del loro consapevole controllo. “Ciò serve a ribadire l’immutabilità dei rapporti. […] La libertà di ciascuno è garantita. Nessuno deve rendere conto ufficialmente di ciò che pensa. In cambio ognuno è racchiuso fin dall’inizio in un sistema di istituzioni e relazioni, che formano uno strumento ipersensibile di controllo sociale.” C’è però del tragico, secondo gli autori, al di sotto di quest’apparente impermeabilità delle coscienze alla ‘critica’ e all’autocritica. “La società è una società di disperati e quindi la preda di capi. […] Oggi il tragico si è dissolto nel nulla della falsa identità di società e soggetto, il cui orrore balena ancora fuggevolmente nella vuota apparenza di quello.” L’individuo è, per così dire, andato a fondo. Così come a fondo è andato ogni nesso etico-morale fra individui. “Tutto viene percepito solo sotto l’aspetto che può servire a qualche cosa d’altro, per quanto vaga possa essere l’idea di quest’altro. Tutto ha valore solo in quanto si può scambiare, non in quanto è di per sé qualcosa.” Assistiamo a un ‘nichilismo’ reale, del quale gli autori ci danno un quadro sociologico e antropologico molto ampio e articolato e per il quale, al momento, non forniscono soluzioni di sorta. Elementi dell’antisemitismo. Limiti dell’Illuminismo L’intero processo storico dell’occidente approda tragicamente nell’antisemitismo e nel nazismo-fascismo. Antisemitismo è innanzitutto odio e lotta da parte dei potenti-carnefici contro la natura umana in quanto tale. L’ebreo, il disadattato in generale, ricordano immediatamente le sofferenze a cui l’umanità è dovuta sottostare per dominare e autodominarsi. L’adattamento al dominio, da parte dell’uomo, non è completo, proprio nella misura in cui egli tenta l’eliminazione di chi gli ricorda di essere dominato. L’antisemitismo ha anche una precisa connotazione teologico-politica in quanto rappresenta la lotta del Dio cristiano con il Dio ebraico. Il Dio dei cristiani è costruito, secondo gli autori, a immagine e somiglianza della volontà di potenza dell’uomo; la volontà di innalzare all’assoluto ciò che si presenta come finito. Il Dio ebraico invece lascia la sua creatura nella finitezza, così come è, senza la pretesa di mediare, per superarla a forza, questa condizione naturale del vivere umano. L’antisemitismo non è un fenomeno storico e sociale ‘anormale’ ma tragicamente ‘normale’; è il prodotto più estremo dell’Illuminismo e del progresso borghese. E’ una profonda ferita etica che la ‘civiltà’ si è procurata da se stessa, e per la quale deve assumersi in pieno la colpa. L’antisemitismo può essere spiegato come un problema interno all’ideologia del borghese, il quale vuole fondare su elementi ‘di natura’ il suo dominio sociale; una natura deformata e violenta, quella “che si rivela nel genocidio.” Appunti e schizzi L’ultimo capitolo della Dialettica si intitola Appunti e schizzi ed è composto da una serie di brevi interventi su contenuti diversi, scritti in forma aforistica e fra loro disomogenea. Si passa dalla considerazione della figura di Hitler come “spirito antiumano” realizzato, alla critica nei confronti della teoria degli ‘spettri’ di Freud, fino al rapporto moderno-borghese fra filosofia e divisione del lavoro. L’ambiente americano in cui i due autori vivevano fa da sfondo a questa sorta di ‘carrellata’ di figure storico-sociali a loro contemporanee.
LUIGI PAREYSON

VITA E RIASSUNTO GENERALE
Nato a Piasco (Cuneo) il 4 febbraio 1918, Luigi Pareyson si laurea in filosofia all’università di Torino nel 1939 e segue i corsi di Karl Jaspers ad Heidelberg. Professore a Cuneo, durante la guerra partecipa alla Resistenza insieme a Pietro Chiodi. Nel 1950 diviene professore ordinario prima a Pavia e poi, dal 1952 al 1988 , a Torino, dove insegna Estetica e Filosofia teoretica, succedendo ad Augusto Guzzo . A Torino sono stati suoi allievi Valerio Verra, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Sergio Givone e numerosi altri studiosi italiani. E’ stato accademico dei Lincei, membro delll’Institut international de philosophie e direttore della Rivista di estetica. E’ morto a Rapallo l’8 settembre 1991. Pareyson è indubbiamente uno dei maggiori filosofi italiani del XX secolo: egli sviluppa l’ esistenzialismo in direzione personalistica, elaborando contemporaneamente un’estetica nella quale è centrale la considerazione del momento formativo della produzione artistica. Su questo presupposto, egli ha anche costruito una teoria dell’interpretazione come ” conoscenza di forme da parte di persone “, infinitamente molteplice nella molteplicità delle prospettive personali, ciascuna delle quali è in rapporto costitutivo con la verità. Egli è approdato infine ad una forma di pensiero “tragico”, preoccupato del problema del male, che ha le sue radici nella libertà che permea la stessa essenza di Dio. Che Pareyson fosse destinato a divenire un grande filosofo lo si comprese presto. Nel 1937, ad esempio, presentò una esercitazione scritta a un seminario universitario del suo maestro Augusto Guzzo, dal 1934 titolare della cattedra di filosofia morale all’Università di Torino. Questi, apprezzandola, la fece leggere a Giovani Gentile, in quanto all’epoca direttore della maggiore rivista italiana di filosofia, il “Giornale critico della filosofia italiana”. Stupito per la profondità e l’originalità del testo, Gentile chiese a Guzzo di quale filosofo torinese si trattasse, non pensando certo ad un diciannovenne. Nel 1938 uscì quindi sulla rivista di gentile la prima pubblicazione di Pareyson, le famose Note sulla filosofia dell’esperienza . E proprio del particolare rapporto di Pareyson con l’esistenzialismo è possibile avviare un tentativo di comprensione della sua originalità nell’ambito della filosofia novecentesca. Pareyson fu il primo filosofo a far conoscere in Italia la filosofia dell’esistenza, tedesca soprattutto, sviluppando egli stesso una forma personalistica ed ontologica di esistenzialismo. Con irruente purezza e semplicità giovanile Pareyson ruppe l’unico coro neo-idealista (rarissime eccezioni degli isolati, se non esiliati, quali Giuseppe Rensi, Piero Martinetti, Adriano Tilgher) – unente sino ad allora, nelle figure esemplari di Gentile, Croce e Gramsci, accademia soggetta al regime, pubblicistica liberale, opposizione politica incarcerata – presentando l’esistenzialismo non solo come filosofia capace di comprendere le tragiche problematiche contemporanee: fatte di guerra e sofferenza, di fallimento dei totalitarismi politici e intellettuali, dei falsi egualitarismi collettivi, nelle varie versioni borghesi, cameratesche, comuniste, ma anche come antidoto radicale alle filosofie e ideologie ottocentesche all’origine delle catastrofi novecentesche, cogliendo in Kierkegaard il padre dell’esistenzialismo e la vera alternativa a Hegel, così rinvigorendo per giunta le pure fonti religiose dello stesso ateismo esistenzialista novecentesco, nonché aprendo nuove prospettive di lettura e comprensione di profonde correnti di pensiero e filosofi tacitati dall’hegelismo imperante, quali l’idealismo e il romanticismo, Fichte e Schelling in particolare. Sin dalle sue prime opere: La filosofia dell’esistenza e Carlo Jaspers (1939, 1940), Studi sull’esistenzialismo (1943, 1950), Esistenza e persona (1950), Pareyson individua quello che sarà il nucleo incandescente alimentante perennemente il suo pensiero successivo, nei suoi continui approfondimenti ulteriori, ereditandolo dalla concezione di Kierkegaard dell’esistenza come coincidenza paradossale di autorelazione ed eterorelazione. Varco di accesso non solo alla mia vita personale, ma alla realtà in genere, è l’esistenza: l’esistenza di questo singolo che io sono. Tuttavia il singolo non è un separato individuo, soggetto assolutamente autonomo e autosussistente. L’esistenza è, in quanto tale, coincidenza di ciò che parrebbe non poter coincidere – e che è quindi coincidente in modo paradossale -, paradossale coincidenza cioè non necessaria articolazione o relazione – di autorelazione ed eterorelazione, della relazione con sé, autofondantesi, che ogni singola esistenza è, e della relazione con altro, che altrettanto imprescindibilmente, seppur coincidente in maniera paradossale, essa stessa è. L’esistenza è se stessa e comprende se stessa in quanto è in relazione con altro e comprende l’altro, e viceversa. Secondo questa profonda radice kierkegaardiana dell’esistenzialismo, Pareyson propone quindi la propria autentica versione di esso come esistenzialismo personalistico e ontologico . Personalistico perché è la singola persona vivente, non un astratto a priori trascendentale o esistenziale, a qualificare l’esistenza e la sua inaggirabilità, pena l’intransitabilità di qualsivoglia minimo senso della realtà e della vita umana. Ontologico perché è nell’apertura all’essere che ci trascende, che mi trascende, che io posso scegliere ed essere me stesso. Che l’esistenzialismo non possa che essere personalistico e che il personalismo non possa che essere ontologico ci dice allora che l’esistenza è quia talis apertura di trascendenza, quindi possibilità di esperienza religiosa. Infatti che l’esistenza sia paradossale coincidenza nel tempo di autorelazione e di eterorelazione mostra quanto la relazione con sé, nell’apertura alla relazione con altro, che ogni singolo è non possa esistere se non in quanto posta, istituita, donata a se stessa e al suo aprirsi all’alterità da una trascendenza che è tale non in quanto posta dalla autorelazione coincidente con la eterorelazione, ma perché trascendente la stessa relazione, e nel momento stesso in cui istituisca tale relazione, cioè perché è l’irrelativo che pone la relazione fra il relativo e l’irrelativo stesso, quindi senza cessare di essere irrelativo nell’istituire liberamente il relativo come possibile relazione con l’irrelativo. Grazie a questo ritorno a Kierkegaard Pareyson può risalire la nefasta storia degli effetti hegeliana. Leggendo la filosofia e la storia contemporanea come dissoluzione dell’hegelismo , Pareyson ne individua due correnti, quella risalente a Kierkegaard, che conduce all’esistenzialismo, e quella che attraverso Feuerbach giunge sino al marxismo e all’attualismo. Kierkegaard dissolve il sistema hegeliano negando l’identità fra pensiero e realtà, la conciliazione dialettica fra storia ed eternità, ancorando ogni possibile verità alla soggettività del singolo, incoercibile a qualsivoglia sistema assoluto del sapere. Tuttavia, a detta di Pareyson, mantenendo la concezione negativa del finito, tipicamente luterana, già propria a Hegel. Feuerbach risolve invece la filosofia di Hegel antropomorfizzandone gli aspetti più ideali, riducendo a ciò che è reale il razionale e il reale a ciò che è sensibilmente percepibile o desiderabile. Tuttavia la posizione atea di Feuerbach e dei suoi epigoni è ricomprendibile, in un orizzonte più ampio, nella kierkegaardiana, nella concezione dell’esistenza come innanzi tutto autorelazione, che se inospitale giunge alla disperazione, malattia mortale, e se invece aperta nella eterorelazione alla trascendenza, ed eventualmente all’esperienza religiosa, possibile nella sua stessa misura finita e temporale, corrisponde alle questioni stesse dell’ateismo, assumendolo in sé e vincendone tuttavia l’egoismo mortale. Ecco che ritornare a Kierkegaard e all’origine teorica delle vicende contemporanee significa per Pareyson porsi nuovamente e più consapevolmente ancora di fronte al dilemma: pro o contro il cristianesimo? E per Pareyson si tratta di scegliere un cristianesimo tragico , dialettico, paradossale, esso soltanto capace di dare risposta alla deriva atea del pensiero e della storia contemporanea, vivendo e vincendo l’ateismo in sé, sino alla morte in croce per rivelare nella abissale libertà dell’uomo la eterna libertà che è Dio. L’ontologicità dell’esistenzialismo, la apertura alla trascendenza dell’essere, prima ancora che alla libertà di Dio, dell’autocomprendersi dell’esistenza umana, conduce inevitabilmente Pareyson, come già Heidegger prima di lui, ad approfondire il proprio esistenzialismo in filosofia ermeneutica , che intenda l’esistenza in quanto tale come comprensione dell’essere trascendente. Prima che Gadamer e Ricoeur, i due più noti filosofi ermeneutici dopo Heidegger, Pareyson elaborò negli anni quaranta e cinquanta una propria filosofia dell’interpretazione o ermeneutica. Oltre che in Esistenza e persona (1950) e in articoli precedenti, i risultati maturi di tale elaborazione sono contenuti in Estetica. Teoria della formatività (1954) e infine in Verità e interpretazione (1971), opera che chiude questo secondo periodo ermeneutico nel cammino di pensiero di Pareyson. Se la realtà è accessibile solo e sempre singolarmente, attraverso l’esistenza personale che io sono, ogni mio atto o pensiero o esserci è interpretazione, personale incarnazione dell’essere che trascende la mia situazione. Non che l’interpretazione sia parziale attingimento dell’essere, bensì ogni vera e autentica interpretazione è il darsi stesso dell’essere in essa: essere che non sta quindi come un oggetto intangibile al di là delle proprie interpretazioni, e che tuttavia non si riduce alle interpretazioni, non ne è esaurito, ma mantiene la propria differenza ontologica. Qui sta lo specifico della posizione di Pareyson rispetto a gran parte delle restanti filosofie ermeneutiche: il mantenimento, anzi la sottolineatura della imprescindibilità della verità per una concezione interpretativa della realtà. L’ermeneutica non solo non mette in crisi, ma cerca di comprendere ed esige ancora più fortemente di ogni altra filosofia la verità. Perché la verità trascendente e assieme immanente alle sue esistenziali e personali interpretazioni non si riduca a ideologia, a mera espressione della condizionatezza storica dell’interprete, anziché mostrarsi simultaneamente a ciò anche rivelazione di inesauribile e inoggettivabile ulteriorità, essa non può tuttavia esser semplicemente intesa come fonte incessante eppure imperscrutabile suscitatrice di infinite interpretazioni proprio approfondendo la concezione ermeneutica della verità attraverso un riattingimento delle proprie origini esistenzialistiche, Pareyson nell’ultima tappa del suo pensiero si dedica all’elaborazione di una ontologia della libertà , un discorso sull’essere che lo intenda come libertà. Libertà quindi non solo in quanto primaria essenza della esistenza umana, ma anche nel suo significato originario, metafisico, ontologico: l’essere stesso come libertà. Infatti solo comprendendo l’essere come libertà se ne potrà rivelare pienamente la trascendenza veritativa: una necessità logica o semplicemente eventuale, quale l’inesauribile e inesorabile imperscrutabile darsi dell’essere, ne legherebbe circolarmente al finito ogni possibilità di eccedenza significativa. Solo se l’essere trascendente è libero di darsi o di non darsi in una forma finita, solo se l’irrelativo è libero di porsi o di non porsi nella relazione che esso stesso istituisce, e in un istituirla che non sia un vincolarvisi necessitante, la verità non è fagocitata dall’interpretazione né l’infinito reso vuoto prodotto del finito. Si raccolgono in estrema concentrazione, lungo tutta l’ultima tappa del cammino filosofico di Pareyson, il suo esistenzialismo personalistico, la sua ermeneutica veritativa e la sua ontologia della libertà (originaria e finita, indivisibilmente), capaci assieme della forza per affrontare la scoscesa realtà della sofferenza e del male. In opere uscite, nella loro complessività, postume, come Dostoevskij (1993), Ontologia della libertà (1995), Essere libertà ambiguità (1998), Pareyson ripropone quindi una coraggiosa teoria dell’essere, una ontologia, ma non nel comune senso necessitaristico della cosa, bensì un’ontologia della libertà, che comprenda l’essere originario stesso come libertà. Libertà assolutamente iniziale, arbitraria, imperscrutabile, eppure ontologica, propria all’essere stesso nella sua eterna positività, indiscutibile e immemorabilmente attuale. Pareyson concepisce paradossalmente e dialetticamente la libertà come inizio e assieme come scelta, unità originaria irrevocabile in Dio di inizio e scelta, di eternità e unicità nell’iniziare, se stessa e ogni altro ente o creatura, e di assolutezza e arbitrio positivo nello scegliere: nel decidere quindi di essere il bene e l’essere dall’eternità e per l’eternità, significante simultaneamente e retroproiettivamente l’esclusione e la vittoria sul male e il nonessere, posti nell’atto di sconfiggerli e senza che alcuna alternativa precedesse tale eterna e irrevocabilmente positiva autooriginazione divina. Ma in quanto ontologica, caratterizzante essenzialmente l’essere stesso, la libertà implica allora l’indivisibilità della libertà umana e divina. E se in Dio la libertà (originaria) è unità eterna e indissolubile e positiva di inizio e scelta: sconfitta del male e vittoria sul nonessere solo in quanto autoposizione nello scegliersi come bene ed essere, tuttavia nell’uomo la libertà (finita) è solo coincidenza di inizio e scelta, paradossale coincidenza nella finitezza esistenziale di tempo ed eternità, autorelazione ed eterorelazione. Cosicché quel male eternamente vinto in Dio, senza che ne precedesse temporalmente o ontologicamente l’eterna autopositività, nell’uomo dallo stato latente può essere riattivato, essendo l’eterna e irrevocabile unità divina nell’uomo solo coincidenza temporale sempre faticosamente da realizzare. Da qui la sofferenza quale creaturale schiavitù alla caducità, il male come realtà pienamente umana, frutto di esistenziale libertà: non corrodente l’essere divino stesso, al punto da farne fallire il progetto di autooriginazione come positività, irrevocabile anche nel suo estendersi alla creazione dell’altro da Dio facendo kenotico spazio in sé, dell’universo creato con a suo radicalmente libero vertice l’uomo, tuttavia capace di sospenderne indefinitivamente la compiuta realizzazione. Eppure, elaborando intrecciata alla propria esistenza una ermeneutica filosofica dell’esperienza religiosa cristiana, Pareyson riesce con estremo e umile atto esistenzialmente speculativo ad ascoltare la tacita presenza del Cristo sulla terra come rivelazione, attraverso la sofferenza, dell’unione cosmoteandrica che vincola uomini, creature, Dio in un’unica vicenda segnata sì tragicamente dall’abissalità della morte e del male, ma anche riscattabile mediante l’energia e la scommessa del balzo della libertà.
IL PENSIERO
Personalismo ontologico, espressione e rivelazione, interpretazione : Il panorama filosofico in cui si muove Luigi Pareyson (Piasco 1918, Milano 1991) è l’ esistenzialismo (o, forse più propriamente, la filosofia dell’esistenza); non però un esistenzialismo vittimistico, né materialistico o immanentistico, né spiritualistico, né nichilistico. Pareyson adotta il termine di personalismo ontologico : l’uomo, da un lato, è costitutivamente apertura verso l’essere, rapporto ontologico; dall’altro, non è né individuo singolo né funzione della società, bensì propriamente persona, ovvero fusione di apertura ontologica (aspetto universale) e di carattere storico (aspetto particolare). Non unicamente trascendenza (perderemmo la ricchezza e l’unicità della singola esistenza concreta), non unicamente storicità (perderemmo la speranza del dialogo alla luce di un qualche principio universale). L’uomo è persona, e la persona è rapporto verso l’essere, ed ha storia (non ha l’essere, non lo possiede interamente; non è storia, non si riduce alla storicità dell’esistenza). La stessa filosofia non può essere semplice pensiero espressivo , portavoce unicamente dell’aspetto storico e particolare dell’esistenza umana, ma deve essere invece pensiero rivelativo , al tempo stesso ascolto dell’essere e considerazione della storicità umana. Dimentico della verità dell’essere, il pensiero espressivo distorce la natura dell’uomo e diviene pensiero strumentale, vuota ideologia, occasione per la volontà di potenza. Come può essere conosciuta la verità ? Non la si può possedere interamente, in quanto trascendente; ma non siamo neppure condannati all’assoluto silenzio, poiché è la verità stessa che si offre al nostro ascolto. D’altro canto, non è che la conoscenza della verità sia talmente ardua da divenire sostanzialmente vana ed impossibile: nel conoscerla, la possediamo davvero, per quanto non la esauriamo, così come ad una sorgente inesauribile ci si abbevera davvero, ma non la si finisce. La verità si dona a noi, ma nessuno può dire di possederla del tutto, né di essere l’unico a possederla; la verità si nasconde, ma nessuno deve scoraggiarsi dal cercarla ponendosi in ascolto. Una tale forma di conoscenza è l’ interpretazione . E’ interpretazione della verità, non arbitraria espressione del soggetto; è sempre personale, cioè accompagna l’aspetto rivelativo con quello espressivo, per cui la storicità del soggetto, lungi dal corrompere la conoscenza o dal farci cadere nel relativismo, è piuttosto lo strumento prezioso con cui possiamo penetrare la verità; è dialettica di presenza e nascondimento della verità; è rispettosa delle altrui interpretazioni, essendo il dialogo possibile (unica è la verità) e necessario (come strumento della sociabilità umana); è testimonianza personale, richiedendo che il soggetto scelga, scommetta, metta in gioco se stesso, senza sufficienza, presunzione, scetticismo. Una siffatta conoscenza interpretativa mette capo ad una teoria ermeneutica dal carattere insieme ontologico e personalistico (sulla quale Pareyson ha modellato anche una originale teoria estetica della formatività , su cui non ci soffermiamo). Probabilmente, il rischio costante di tale impostazione è quello del relativismo; ma non si deve chiedere alla filosofia di essere ricetta univoca e sistematica per risolvere le controversie, altrimenti cadremmo di nuovo in un pensiero strumentale, tecnico, ideologico. Ogni interpretazione è un impegno personale, e il dialogo fra gli uomini è cosa ardua senza soluzioni precostituite, con il costante rischio della sconfitta. La risposta va cercata di continuo, questa è la responsabilità dell’esistenza.
Filosofia della libertà ed ermeneutica dell’esperienza religiosa : Ora, alla luce di quanto detto a proposito di personalismo ontologico, di pensiero rivelativo e di ermeneutica, qual è la filosofia possibile? Innanzitutto una filosofia che sia universalizzante e rivelativa, e non solo storicistica ed espressiva dei tempi che cambiano; e ciò è possibile, ammettendo la presenza non muta della verità. In secondo luogo, la filosofia non può più ambire ad essere oggettivante, assolutamente razionalistica, astratta. Non oggettivante perché l’essere e la verità non possono venire rinchiusi nelle definizioni e nelle categorie umane; l’uomo partecipa dell’essere, è rapporto con l’essere, benché non sia l’essere, da cui invece è sempre trasceso, e incommensurabilmente distanziato. Non razionalistica, in senso assoluto ad acritico, perché di nuovo l’essere non può essere limitato negli angusti recinti della ragione umana; e non si può muovere a tal proposito l’accusa di irrazionalismo o superstizione, giacché è semmai il razionalismo acritico a peccare irrimediabilmente di cecità, nel momento in cui non vuole, anzi non può riconoscere la premessa gratuita e non razionale che ne sta alla base, ovvero il principio che tutto sia conoscibile razionalmente (se non ora, in futuro). Non astratta, poiché la filosofia deve in primo luogo rendere conto dell’esistenza concreta dell’uomo, senza perdersi in fantasiosi sistemi totalizzanti che pretendono di spiegare l’universo e Dio, mentre finiscono per dimenticare chi è l’uomo, con le sue speranze e i suoi drammi. Soprattutto, per poter sperare di capire la natura delle vicende dell’intero universo e della storia umana in particolare, la filosofia non può più essere necessitaristica. La necessità è uno strumento comodo per imbrigliare la realtà e l’essere stesso in un qualche principio di ragione, per alleggerire la coscienza morale affidandosi all’inevitabilità del fato, per eludere l’incombente problema del male, per giustificare azioni prepotenti. E’ un peso legato al collo di Dio, del cosmo e dell’uomo. Ciò che invece va riscoperta – e Pareyson lo fa rileggendo e correggendo l’ultimo Schelling e Heidegger – è la libertà . Libero è l’agire di Dio, le cui azioni arbitrarie l’uomo non è degno di giudicare; libertà è l’essenza di Dio, che fu libero di scegliere il suo stesso essere, senza essere vincolato da alcuna legge di necessità; libertà è il cuore del reale, senza alcun fondamento metafisico, a cui si oppone semmai il nulla, non in senso nichilistico, ma come abisso assoluto che precede il primo atto libero di Dio, la sua autooriginazione (così come dire che Dio è il nostro nulla, cioè è totalmente altro dall’uomo, non implica alcuna caduta nichilistica); libera è la caduta dell’uomo, e tutta dell’uomo la responsabilità del peccato e del male reale; libero è il sacrificio di Cristo per assumere su di sè il peccato e la sofferenza dell’uomo e per redimerli; libero è ogni atto umano, nella scelta per l’essere o contro l’essere; libero è ogni evento, e cioè irruzione nella realtà, non prevista da alcuna possibilità e non schiava di alcuna necessità; la stessa situazione storica in cui l’uomo vive va pensata non tanto come prigione ed impedimento, quanto come occasione, spunto, suggerimento, appello alla libertà, punto di partenza e non di arrivo; la realtà non è com’è perché così deve essere, ma deve essere com’è perché così è. Naturalmente è evidente la natura tragica della libertà, della costante scelta fra le alternative, dell’inevitabile responsabilità delle proprie azioni, dell’incombente rischio del fallimento. E la stessa rinuncia alla libertà, è già una presa di posizione, una scelta, un atto di libertà. Siamo allora non in una ontologia della necessità, e nemmeno in una ontologia del nulla, ma in una ontologia della libertà , più agile e più fedele alla tragicità dell’esistenza umana del necessitarismo, più costruttiva del nichilismo. Se la libertà è il cuore del reale, allora la filosofia non può essere dimostrativa, non deve cercare leggi necessarie che spieghino alcun determinismo. La realtà, divina ed umana, è costituita di fatti, di eventi, è una storia libera di cui non si può teorizzare, ma di cui invece si deve narrare. E quando ci si avvicina all’agire divino e alla sua relazione con l’uomo, il compito di narrare gli eventi è affidato al mito . Mito non inteso come espressione irrazionale, arbitraria, superstiziosa: invece come unico modo di parlare di fatti che sfuggono alla ragione umana, senza però disperderne la carica rivelativa. Come nell’interpretazione, il mito fonde armonicamente la verità rivelata e l’espressione storica, artistica, fantastica. Il mito non fa violenza alla ragione, ma diventa l’unica via di accesso ad una verità che non può essere dimostrata, pena fare violenza alla verità. E senza ancora uscire dalla filosofia, che resta pensiero razionale e rigoroso, possiamo indagare la rivelatività del mito cercando di interpretarlo, cercando di attingere alla verità non già per trasformarla in dimostrazione scientifica, bensì per problematizzarla, interrogarla, universalizzarla. Questo è quanto si propone di fare Pareyson negli ultimi scritti, attraverso l’ ermeneutica dell’esperienza religiosa (del cristianesimo in particolare).
Il problema del male in Dio, nell’uomo e nel mondo : Questa filosofia, che chiaramente si contrappone alla tradizione metafisica culminata in Hegel, porta in dote la capacità di ammettere l’esistenza del male, di comprenderlo, di darne ragione. Finché il pensiero è ancorato all’idea della necessità, e dell’essere come qualcosa di oggettivo a cui affibbiare le varie idee umane di perfezione, il male non può esistere: tutto è razionale, tutto è previsto, tutto è necessario alla storia, tutto è giustificato, tutto è com’è perché così deve essere. Al più il male è semplice sofferenza, al più è privazione dell’essere. Ma il male che si presenta nel mondo quale forza negativa e distruttrice, che non dovrebbe essere ma è, non viene e non può venire ammesso. Ciò che avviene invece nell’ontologia della libertà: ogni atto è atto di libertà, è scelta, e la scelta può avvenire per l’essere, o contro l’essere. Ecco il male reale : non come semplice privazione dell’essere, ma come consapevole rivolta contro l’essere. Il male compare a livello di pura possibilità già nell’autooriginazione divina: scegliendo di esistere Dio sceglie il bene, e scarta il male (non esistere); Dio esclude per sempre la possibilità del male che gli si presenta; Dio vince per sempre il male. Ma questo male possibile è come un’ombra in Dio, nel senso che è una possibilità sopita pronta ad essere ridestata (Pareyson usa l’espressione efficace ma ambigua di “male in Dio”, rischiando di far credere in un Dio demonizzato). Sarà l’uomo, liberamente, a cogliere questa possibilità, a ribellarsi a Dio, a realizzare realmente il male, finora solo possibile; e con la caduta dell’uomo fallisce la creazione, subentrano la storia e la morte, il male si insedia nel cuore della realtà. Il male si accumula sempre più, travolgendo il mondo, e l’umanità intera ne è responsabile, è solidale nel peccato. Ma il male può essere vinto. Da parte dell’uomo, l’unica opposizione al male è data dalla sofferenza : che non è solo punizione per il peccato commesso, ma diviene strumento di espiazione, al di là della logica retributiva per cui ogni uomo dovrebbe soffrire solo per le colpe individuali e determinate commesse da lui stesso. Invece nessuno è innocente, e ciascuno deve soffrire per lavare la colpa dell’umanità intera. Ma l’uomo da solo non potrebbe compensare il male commesso ed accumulato con la sofferenza patita; occorre che addirittura Dio si faccia carico del male destato dall’uomo, assuma su di sè il peccato, divenga sofferente, si faccia mortale e patisca sulla croce; e qui, al culmine del sacrificio divino, il Cristo grida, chiede ragione al Padre, e ottiene solo silenzio: Dio abbandonato da Dio , Dio contro Dio. E’ qui che la sofferenza, di per sè negativa, viene completamente ribaltata e diventa strumento per fare il bene, per riscattare il male, per tornare all’essere. E’ la sofferenza di Dio stesso, è la passione di Cristo a rendere sopportabile la sofferenza umana, altrimenti disperata e vana. Così, il solo modo per dare ragione del male e della tragedia umana (e divina) è nel cristianesimo (altre filosofie negano il male; altre religioni negano non solo il male ma l’intera realtà, che sarebbe illusoria); e il cristianesimo trova una vera risposta positiva al problema del male, e pure un autentico rapporto con Dio, solo attraverso la cristologia , e non tramite una metafisica oggettivante. Il cristianesimo indicato da Pareyson è quello arricchito dalle meditazioni di Pascal e Kierkegaard e dalla sensibilità di Dostoevskij; è un cristianesimo attuale e problematico, che deve capire i problemi dell’uomo moderno per dare loro la risposta più convincente; è un cristianesimo della sofferenza, ma non masochistico o lamentoso, in contrapposizione a certo spiritualismo annacquato; è un cristianesimo consapevole della tragicità dell’esistenza, in contrapposizione a certo facile ed ingenuo ottimismo; è un cristianesimo che si rende conto della scelta sofferta e continua che richiede la testimonianza di fede, in contrapposizione ai molti cristiani nominali per abitudine; è un cristianesimo dialettico, non nel senso hegeliano, per cui ci sarebbe sempre una sintesi pronta a dissolvere lo scontro dei contrari, ma nel senso del dualismo pascaliano, per cui permane la tensione dei contrari, ciascuno dei quali è veritativo solo se accostato al proprio opposto (così la sofferenza e il sacrificio di Cristo sono inseparabili dalla redenzione e dalla resurrezione); è un cristianesimo non fatalistico, e quindi necessitaristico, ma consapevole della libertà di Dio e dell’uomo, e delle conseguenze che derivano dalle libere scelte (Dio ha vinto il male per sempre, l’uomo ha scelto il male); è un cristianesimo che si oppone con forza al tentativo di essere secolarizzato e ridotto ad una morale e ad una espressione storica.
Cristianesimo e pensiero tragico : Siamo quindi all’interno di un pensiero tragico , nel senso che non risolve le contraddizioni radicate nella realtà (anzi si ispira al paradosso kierkegaardiano come categoria logica della verità rivelata), ammette l’esistenza sia di Dio sia del male, e vede nella sofferenza, umana e divina, il solo modo per riscattare e vincere il male. Questo pensiero tragico si oppone alla teodicea, sistema filosofico tradizionale che cerca di conciliare l’onnipotenza di Dio con la sua infinita bontà, tramite la concezione del male come semplice privazione dell’essere; la teodicea ha un duro avversario in quell’ateismo che arriva a negare Dio in forza dell’esistenza del male, un male reale, che sarebbe incompatibile con l’esistenza di Dio. Ma il fatto è che l’esistenza di Dio non è incompatibile con quella del male, anzi ne è imprescindibile: il male reale esiste in quanto rivolta contro Dio; e il Dio-libertà e non necessario, il Dio vivente, prevede la possibilità (scartata da lui, accolta dall’uomo) della trasgressione e quindi del male. Allora, combinando i termini “esistenza di Dio” ed “esistenza del male” nelle varie possibilità, otteniamo quattro tipiche correnti di pensiero: nel cristianesimo esiste Dio ed esiste il male; nella teodicea esiste Dio ma non esiste il male (reale); nel nichilismo classico esiste il male ma non esiste Dio (termini che come visto sopra sono in realtà inseparabili); infine, c’e’ la possibilità dell’inesistenza tanto di Dio quanto del male. Quest’ultima è la via del nichilismo consolatorio, dell’ateismo confortevole: non più tragicità, non più sofferenza, non più negatività. Resta da vedere quanto questa visione del mondo possa realmente essere compatibile con l’esperienza concreta dell’uomo. A meno di invocare l’illusorietà del dolore e infine della realtà stessa, come in molte religioni orientali; o di degradare il peccato a semplice senso di colpa, come nello psicologismo; o di sostituire la responsabilità con la necessità del fato, come nel paganesimo; o di dissolvere la tragicità in un disincantato naturalismo secondo cui la morte e il dolore sono eventi semplicemente naturali e necessari. Non così nel cristianesimo, il quale non nega la realtà tragica, ma la accetta, e le offre una soluzione grazie alla salvezza in Cristo; e non rifiuta la sofferenza, ma la assume, senza evitarla, e senza tentare di annullarla in una rassegnazione stoica in fondo più facile della sopportazione e della accettazione della propria condizione di peccatori sofferenti.
LE LEZIONI DI NAPOLI
Schema riassuntivo delle Lezioni tenute da Pareyson presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici dal 26 al 30 aprile 1988, sul tema “Filosofia della libertà”. Queste lezioni sono significative in quanto costituiscono un denso ma chiaro compendio del principale nucleo speculativo del pensiero pareysoniano, quello facente capo all’ontologia della libertà.
Questi miei appunti sono evidentemente alquanto schematici, ed hanno appunto la funzione di evidenziare in maniera immediata le principali considerazioni avanzate da Pareyson. Per una lettura più piacevole e completa, rimando naturalmente alla fonte originaria, in particolare alla versione che appare in Ontologia della libertà (versione a sua volta basata sulle registrazioni delle Lezioni, sugli appunti utilizzati da Pareyson durante l’esposizione e su quelli manoscritti da A. Magris e F. Tomatis: le uniche tracce di quel convegno, altrimenti inedito).
Nella I lezione si discute dell’esistenza umana fra attività e passività, dono e consenso, e come rapporto verso l’essere, e quindi di essere e libertà; nella II lezione si tratta di libertà originaria, in Dio e nell’uomo; nella III lezione invece la libertà è vista in quanto scelta, da Dio e dall’uomo; infine la IV lezione affronta il problema della dialettica fra eternità e storia, chiarendo il ruolo della sofferenza.
Alcune note.
Le considerazioni antropologiche della I lezione risalgono ad Esistenza e Persona; invece le argomentazioni che riguardano più specificamente l’ontologia della libertà e il problema del male sono state approfondite durante gli anni 80. Considerazioni ulteriori sull’escatologia sono riportate come “frammenti” in Ontologia della libertà.
L’ermeneutica religiosa specificamente affrontata da Pareyson riguarda Ebraismo e Cristianesimo. Altrove (La filosofia e il problema del male, in Ontologia della libertà, pag. 165-66) l’autore osserva:
“… qui non si tratta d’un’indagine di storia della cultura, ma d’un’ermeneutica esistenziale … se fossimo in Asia cominceremmo col non parlare di fallimento della filosofia e di necessario ricorso al mito, perché queste due operazioni sono pensabili solo all’interno della nostra tradizione cristiana né avrebbero alcun senso all’interno dell’induismo o del buddismo … l’ermeneutica della coscienza religiosa qui proposta suppone che la riflessione sia portata non su una scena culturale oggettivabile e astratta, ma su un’esperienza esistenziale, concreta e personalmente vissuta … fa parte dell’essenza stessa della religione il suo nesso esistenziale con chi la professa. Per prospettarla nella sua vera natura bisogna vederla come assunta all’interno d’una tradizione storica e d’una situazione personale, come adottata con una scelta esistenziale inseparabile dalla nostra sostanza personale e storica …”.
I riferimenti di sapore gnostico che hanno fatto pensare a Pareyson quale pensatore non molto ortodosso (rispetto al Cattolicesimo in particolare) sono quelli del male in Dio (vedi lezione III; mi pare che sia evidente la limitazione del male in Dio a mera possibilità, come dire che il male in Dio è banalmente l’opportunità data all’uomo di rivoltarsi a Dio, di non sceglierlo: una cosa inevitabile, direi, solo per il fatto dell’esistenza di Dio, e per la libertà donata all’uomo; se Dio non fosse, non si parlerebbe di male poiché tutto sarebbe indistintamente male; quindi il male come possibilità è figlio dell’esistenza di Dio e della libertà dell’uomo) e dell’apocatastasi (vedi lezione IV; personalmente non vedo l’esigenza teorica dell’introduzione di questo argomento da parte di Pareyson; mi pare anzi che l’annientamento del male possa essere una violazione alla libertà umana di non scegliere Dio, contraria allo spirito che accompagna le riflessioni fin lì fatte; naturalmente Pareyson stesso se ne avvede, ma insiste nel ritenere incompleta la redenzione senza questo ulteriore passo).
Lezione I : Libertà e Situazione
La filosofia della libertà inizia con Cartesio, restando però legata ad idee necessitaristiche (meccanicistiche, oppure razionalistiche e monistiche, ad esempio con Spinoza ed Hegel). Dopo Hegel, la filosofia della libertà segue le orme dei prehegeliani Kant e Fichte da un lato, e dei dissolutori dell’hegelismo Kierkegaard e Feuerbach dall’altro; Schelling riassume entrambe le posizioni.
Uomo vs Essere:
- l’essere è irrelativo, pone il rapporto con l’uomo
- l’uomo è relativo, è rapporto con l’essere
(non conosco mai l’essere direttamente, ma sempre attraverso l’uomo: per Jaspers conosco la trascendenza solo attraverso la mia esistenza; per Marcel l’essere non è “problema” ma “mistero” che mette in questione noi stessi)
- quindi abbiamo coincidenza di autorelazione ed eterorelazione
Due interpretazioni:
- Attività vs Passività
- c’è passività nella situazione, ma pure nella libertà (a cui siamo costretti)
- questa passività, se vista come appello alla libertà, apertura ontologica, diventa attività
- quindi nell’uomo c’è sintesi di recettività e attività
- Dono vs Consenso
- la libertà è ad un tempo iniziata (data all’uomo) e iniziativa (dell’uomo), e ciò accade all’unisono, non l’una prima dell’altra: dono e consenso insieme (dono di me a me)
- di nuovo, abbiamo sintesi di recettività e attività
Ma la passività è solo un diaframma tra l’atto di libertà come donazione e l’appello alla libertà donata: c’è comunque solo libertà nell’esistenza, non necessità.
Libertà ed Essere:
- inseparabili
(la libertà non è puro agire abbandonato a se stesso, ma è legata all’essere: suo consenso o suo rifiuto; l’essere si affida alla libertà, non perché le si abbandoni, ma perché le fa appello per essere accettato o rifiutato; ma questa libertà è sempre illimitata, è rischio costante di negarsi: non c’è alcuna legge o garanzia razionalistica; solo la libertà precede la libertà)
- anzi convertibili fra loro
Fin qui giunge la filosofia. Per andare oltre si deve ricorrere all’ermeneutica del mito, ovvero alla riflessione sull’esperienza religiosa, per trarne non contenuti, ma significati da universalizzare; non sostituendo il logos al mito: il mito dice cose che solo così si possono dire, cose di cui si può solo narrare; la filosofia ne trae solo spunto per problematizzare.
Lezione II : Libertà e Trascendenza
Esperienza religiosa:
è tutta una vicenda di libertà, umana e divina, indivisibili
Libertà (in Dio e nell’uomo):
- come inizio originario (questa lez.)
- come scelta (v. lez. III)
Libertà originaria:
- nell’uomo:
- ogni evento è imprevedibile, preceduto solo dal nulla della libertà; non esistono né la “possibilità né la “necessità”, ma solo la “realtà” dirompente
- ogni evento è irrevocabile: ciò che è stato non può non essere; ma di nuovo questa non è necessità
- in Dio:
- autogenesi di Dio come primo atto libero
- “Ego sum qui sum”: va letto non come identità di un essere statico, ma come libertà di essere come Dio stesso vuole (Plotino, Schelling: libertà rispetto al proprio essere; Dio non è “libero”, ma è libertà!)
- abissalità di Dio = abissalità del nulla (solo Dio prima di Dio, non c’è un prima senza Dio, ma c’è comunque un inizio in Dio: abisso!)
- uomo e Dio:
- le loro libertà non sono in contrasto, non si limitano a vicenda
- non c’è nemmeno prescienza divina (determinismo teologico): Dio lascia la scelta all’uomo, sa contemporaneamente alla scelta umana; non ha nemmeno bisogno di sapere in anticipo; al limite sa nella sua dimensione eterna il nucleo in cui si riduce la dimensione temporale dell’uomo
Lezione III : Libertà e Negazione
Libertà (in Dio e nell’uomo):
- come inizio originario (lez. II)
- come scelta (questa lez.)
Libertà come scelta:
- è libertà positiva (scelta per l’essere) o negativa (scelta per il non essere: il male)
- libertà negativa:
- all’origine è possibilità di non essere, scartata da Dio
- dopo l’origine è l’uomo che sceglie il non essere quando che già esiste l’essere, e quindi c’è anche un aspetto distruttivo; in realtà l’uomo distrugge solo se stesso, autonegandosi; non manicheismo: la libertà negativa non è equipollente alla libertà positiva; non pessimismo, ma pensiero tragico, ambiguità dell’esistenza, coesistenza di bene e male nell’uomo
- libertà positiva: Dio sceglie il bene, che non è a lui preesistente, come neppure lo è il male: entrambi cominciano ad essere con l’atto stesso della scelta
- in Dio:
- Dio sceglie la libertà positiva, non perché gli sia necessario, ma per suo libero volere
- la sua scelta istituisce: il bene come realtà, vincitore ab aeterno, e il male cone possibilità non scelta
- sia pure come possibilità, il male resta un’ombra inquietante, un’ambiguità in Dio, pronto ad essere risvegliato (dall’uomo)
- non esiste la possibilità di un Dio cattivo: se Dio avesse scelto il male, avrebbe scelto il non essere, e non esisterebbe; invece il bene scelto è la sua stessa esistenza
- nell’uomo:
- l’uomo sceglie la libertà negativa, non per necessità, ma per suo libero volere; storicamente, è l’uomo ad aver scelto il male (peccato originale, caduta, nascita della storia)
- la sua scelta istituisce: il male come realtà, da mera possibilità che era in Dio la sua scelta non è irrimediabile, però è progressiva: il male ingrandisce per atti negativi che si accumulano
- il male, il peccato non è tanto negare Dio, quanto volersi mettere al suo posto (Dio come rivale); è peccato di orgoglio e di invidia (questo è il peccato più diabolico, mentre c’è poi il peccato dell’uomo mediocre: mediocre sia nel bene, che non riesce ad essere bene, sia nel male, che non riesce ad esser male; alla mediocrità si contrappone la forza morale del santo e dell’uomo diabolico, ed è la forza della libertà piena; queste due figure finiscono per rasentarsi; è più facile la conversione del grande peccatore che nell’uomo mediocre)
- diverso è il caso della sofferenza: è negatività che riesce a mutarsi in positività (v. lez. IV)
Lezione IV : Libertà e Dialettica
Problema: come conciliare eternità e tempo storico?
Tempo storico:
- dalla caduta dell’uomo alla sua morte
- lotta incerta fra bene e male
- elemento eterno: è storia della salvezza, intervento divino che impedisce di rientrare nel nulla
Eternità:
- si divide in protologia (prima della caduta) ed escatologia (dopo la fine dei tempi)
- il male è vinto fin dall’inizio: l’escatologia non fa che confermare la protologia, non c’è dialettica in Dio verso la perfezione
- elemento temporale: non è intemporalità o totalità puntuale, ma è una storia con i suoi tempi, le sue epoche (un “Dio vivente”)
Dialettica eterna:
Dio è dialettico nel senso della libera scelta, della opposizione bene-male
Dialettica temporale:
tensione, lotta fra bene e male, non distinti ma confusi fra loro (non la dialettica triadica hegeliana della conciliazione, bensì la dialettica diadica pascaliana della contraddizione)
Legame fra le due dialettiche:
- la storia della salvezza (ripristinare escatologicamente la situazione protologica, vincendo la lotta tramite l’espiazione e la redenzione)
- Hegel:
- confonde e unisce storia eterna e storia temporale (la vittoria escatologica è storica);
- propone una dialettica della necessità (negatività necessaria, non libera scelta)
- sofferenza:
- è ciò che capovolge, nella storia umana, il male in bene
- non è solo espiazione, ma pure redenzione e riscatto: unica forza che può vincere il male
- non è fato, ma conseguenza della colpa originaria (che accomuna tutti: solidarietà nella colpa, responsabilità reciproca)
- è sopportabile solo in quanto anche Dio condivide la sofferenza umana (culmine nel grido di Cristo in croce, “momento ateo” della divinità)
- tragicità: solo nella sofferenza c’è collaborazione fra uomo e Dio
Epoche eterne:
- protologia:
- autooriginazione divina
- creazione (libertà come liberalità)
- caduta dell’uomo
- escatologia:
- morte (essenzializzazione dell’uomo, della sua personalità storica)
- giudizio (separazione di bene e male, personalità umana eventualmente arricchita dalla misericordia divina)
- apocatastasi (annientamento del male, ripristino ultimativo dell’origine)
- apocatastasi: contradditoria, impensabile (sorta di incarnazione nell’intera natura, panteismo, totalità, immanenza: cose normalmente inconciliabili con libertà e trascendenza)
- escatologia: indicibile, non solo per il linguaggio razionale, ma pure per quello fantastico; apice di filosofia e teologia, sorgente di problemi fondamentali, quali i seguenti
- non può esserci intervallo temporale fra creazione e caduta, né fra morte e giudizio (“illusione ottica” che nasce solo dalla prospettiva umana che guarda l’eternità dalla storia)
- dal punto di vista dell’uomo, immerso nella storia, il centro dell’universo non può che sbilanciarsi verso l’uomo stesso: non può essere direttamente Dio, ma il rapporto uomo-Dio (teandria, Cristo)
Conclusioni:
- “Dio esiste” significa “l’uomo è peccatore; il mondo ha un senso; il male finirà”
- Dio è presenza scomoda, assillante, angosciante: “è terribile cadere nelle mani del Dio vivente”
WILHELM REICH

Il pensiero di Wilhelm Reich si presenta in bilico tra freudismo e marxismo, dei quali tenta una sapiente quanto ardita sintesi, proiettandosi in tal senso verso un filone della psicoanalisi che potremmo definire “ereticale”: ne nacque un freudo/marxismo a cui aderì a pieno titolo lo stesso Marcuse. Reich nasce nel 1897 a Dobrzcynica – in Galizia – in una famiglia di agricoltori di lingua tedesca; quando nel 1920 era ancora studente di medicina, già era socio attivo nella Società psicoanalitica di Vienna, sperimentando la terapia delle nevrosi non nella separatezza del rapporto privato analista/cliente (quest’ultimo solitamente appartenente alla borghesia), bensì a contatto con gente ampia e proveniente dalle classi sociali più disparate. Nel 1927, poi, aderisce ufficialmente al Partito comunista: e il frutto di tale adesione, oltreché del contatto con gente delle più diverse (e basse) classi sociali, fa affiorare in lui la convinzione dell’improponibilità della psicoterapia individuale, così prolungata nel tempo e accessibile solo ad un ristretto numero di pazienti privilegiati 8delle classi sociali superiori), per la cura di disturbi nevrotici largamente diffusi presso tutte le fasce sociali. In secondo luogo, comincia ad affiorare in Reich la convinzione dell’esistenza di un nesso tra repressione sociale e logica del potere, da una parte, e repressione della sessualità, dall’altra (nesso su cui insisterà tantissimo Marcuse). Soprattutto la militanza nelle file del partito comunista permette a Reich di scoprire, grazie all’istituzione di appositi centri popolarfi di igiene sessuale, quella che egli avrebbe più tardi definito la “materia sessuale di massa” (nevrosi, aborti in clandestinità, disinformazione sessuale, perversioni, nevrosi, angosce giovanili, impossibilità di una sana e soddisfacente vita sessuale, e così via). Da questa esperienza medico/sociale/politica Reich trae gli elementi per fare i conti con la teoria e la pratica terapeutica freudiana, cosa che lo conduce rapidamente verso posizioni di aperta dissidenza con Freud, di cui sono fulgida testimonianza alcuni scritti risalenti a quegli anni: La funzione dell’orgasmo (1927) e Materialismo dialettico e psicoanalisi (1929). Nel 1930 Reich si trasferisce a Berlino per sottrarsi alla diffidenza e ai sospetti che su di lui gravavano da parte dei freudiani ortodossi: a Berlino milita in prima linea nel partito comunista tedesco e pubblica le sue opere più importanti, quali L’irruzione della morale sessuale coercitiva (1932), La lotta sessuale dei giovani (1932), Analisi del carattere (1933), La psicologia di massa del fascismo (1933) e, infine, La rivoluzione sessuale (1936). In rotta con il partito fin dal 1932 a causa della sua propaganda tra i giovani iscritti e per le posizioni propugnate nel saggio La psicologia di massa del fascismo (dove individua nel fascismo “l’espressione politicamente organizzata della struttura caratteriale umana media” in quanto costituisce “l’atteggiamento fondamentale dell’uomo autoritariamente represso dalla civiltà delle macchine“), Reich è anche bandito – nel 1934 – dalla “Società psicoanalitica internazionale”, mentre già si trova a vagabondare per l’Europa per sottrarsi al nazismo oramai dilagante. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti, dove inaugura una nuova fase della sua vita e della sua riflessione. In sintonia con Freud per quel che concerne l’eziologia sessuale dei disturbi nevrotici, ed in particolar modo con gli orientamenti del primo Freud (quello del saggio su La morale sessuale ‘civile’ e il nervosismo moderno, del 1908), Reich esprime il suo totale dissenso nei confronti della svolta – da lui definita “idealistica” – operata da Freud in Al di là del principio di piacere e Il disagio della civiltà. Muovendo da un presupposto di remota ascendenza rousseauiana, secondo il quale la natura umana sarebbe in origine integra, pura, incontaminata negli istinti e genuinamente rivolta alla felicità (in primis a quella sessuale), egli nega che si possa parlare di un impulso distruttivo originario come quello freudiano di Thanatos che, al contrario, sarebbe un derivato della repressione degli istinti, soprattutto della repressione sessuale cui gli uomini sono sottoposti dal condizionamento sociale. Per quel che riguarda le tesi frudiane disvelantisi in Disagio della civiltà, Reich obietta che il discorso di Freud è viziato da un concetto destoricizzato di civiltà, cosicchè il sacrificio della pulsione sessuale, che viene inteso come inevitabile per garantire gli interessi della civiltà in generale, è in realtà richiesto da un determinato tipo di civiltà, ossia quella particolare civiltà caratterizzata dai rapporti sociali e dal sistema economico capitalistico. Il principio di realtà – da Freud assunto senza chiarire di qual realtà si tratti – si configura allora come una bieca mistificazione aberrante: per non parlare poi del fatto che la sublimazione, proposta da Freud come modo di risolvere il conflitto libido/civiltà, è in effetti praticabile esclusivamente dai privilegiati (ovvero i borghesi) che frequentano il salotto dello psicanalista, mentre il proletariato (a cui Reich rivolge la propria attenzione) ne resta inevitabilmente escluso in partenza, non potendosi economicamente permettere tale lusso. Del resto anche il primo Freud, condizionato com’era dall’assenza di una preparazione sociologica e da idee politiche piuttosto conservatrici (e caotiche), non avrebbe condotto alle sue ultime necessarie conseguenze la teoria dell’origine sessuale della nevrosi, accontentandosi di ottenere – grazie al trattamento terapeutico – la liberazione del paziente dalla rimozione inconscio delle pulsioni, e di sostituirla con la rinuncia consapevole delle passioni stesse. Un tale esito è da Reich rigettato: egli si convince che la nevrosi sorga, per l’appunto, dalla rinuncia alla soddisfazione della sessualità genitale, tanto da fare – già in La funzione dell’orgasmo (1927) – delle “nevrosi attuali“, provocate non dai conflitti rimossi dell’infanzia bensì da un inappagamento sessuale nel presente, l’origine anche delle psiconevrosi approfondite da Freud. Siffatta origine viene ricercata nell’ “impotenza orgastica“, ovvero nell’incapacità – indotta dalle resistenze antipulsionali – di donarsi interamente nell’amplesso genitale, attraverso un completo abbandono, con la conseguente scarica completa dell’eccitazione. L’energia vitale non liberata provocherebbe un ingorgo nell’organismo – la “stasi sessuale” – responsabile di fornire ai sintomi nevrotici una sorgente continua di energie. E così la guarigione della nevrosi richiede secondo Reich una vita sessuale caratterizzata dal recupero della pienezza della potenza orgastica. Ma all’origine delle difficoltà della sessualità genitale – cui Reich riconosce freudianamente un primato incontrastato nella vita sessuale umana – si nasconde la repressione sociale della sessualità.La miseria sessuale delle masse, inestricabilmente intrecciata com’è alla miseria sociale, ne è una prova inappellabile; negli stessi anni in cui prendono avvio – grazie alla Scuola di Francoforte – gli studi sull’autorità, la famiglia, i condizionamenti culturali, Reich è fra i primi a mettere in evidenza la funzione repressiva della sessualità cui assolve la famiglia, attraverso l’educazione sessuofobica dei bambini e dei giovani, la proibizione dei rapporti sessuali prima e al di fuori del matrimonio, il forte condizionamento di istituzioni come il matrimonio monogamico. La lettura dello scritto di Engels sull’Origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, la critica serrata condotta da Malinowski contro la pretesa universalità del complesso edipico, agevolano Reich nel consolidare questi suoi orientamenti. In linea generale, egli conclude che la funzione repressiva svolta dalla famiglia si inserisce in un ordinamento sociale come quello capitalistico, interessato a imporre alle classi subalterne non soltanto il dominio materiale ed economico della classe egemonica, ma anche la propria ideologia, quale puntello essenziale di quello stesso dominio. L’introiezione di massa dell’ideologia sessuofobica favorisce infatti la formazione di individui passivi, acritici, disposti ad essere piegati e sottomessi senza opporre resistenza: questo è quanto si può ricavare dalla teoria di Reich sul carattere, quale viene tratteggiata nell’opera Analisi del carattere, in cui Reich sostiene che ogni individui possiede una sorta di natura caratteriale mediante la quale si difende dagli stimoli provenienti dal mondo esterno o dal proprio inconscio. Essa, indotta dalla struttura sociale in cui una persona si trova a vivere, ne limita più o meno gravemente la mobilità psichica: l’arduo compito della terapia analitica sarà allora quello di aprirvi dei varchi, onde liberarne le energie imprigionate dell’uomo. L’armatura caratteriale è formata da più strati, fungenti da linee di difesa inconsce nei confronti degli impulsi non tollerati dalla società, e che irrigidiscono entro modelli stereotipati la condotta della persona: uno superficiale, che rende disponibile l’individuo nei confronti del ruolo e della responsabilità che riveste nella vita sociale, un secondo sottostante, corrispondente al rimosso freudiano, costituito dagli impulsi aggressivi e perversi conseguenti all’azione repressiva della società. Nel profondo si nasconde il nucleo biologico costitutivo della natura originaria dell’uomo, soffocato dalle strutture sovrastanti. Con questa impalcatura teorica, Reich conduce a Vienna e, soprattutto, a Berlino la sua battaglia per la liberazione sessuale: nel 1931 promuove Sexpol, l’Associazione per una politica sessuale proletaria che finisce per coinvolgere quasi cinquantamila giovani nella prospettiva di una lotta anticapitalistica, il cui esito vittorioso soltanto può creare i presupposti per un’autentica liberazione sessuale. Per il Sexpol Reich scrive La lotta sessuale dei giovani (1931), in cui sviluppa la sua tesi sull’origine sociale dei disturbi sessuali dei giovani: l’autoritarismo e la repressione sessuale all’interno della famiglia impediscono lo sviluppo della volontà di lottare negli individui, per questo Reich si propone con la sua associazione di aiutare i giovani a liberare la propria sessualità come presupposto per un pieno sviluppo della loro capacità critica, dell’attività intellettuale e della lotta politica. Il grande merito di Reich è stato quello di aver atteso per primo al progetto teorico di conciliar fra loro psicoanalisi e marxismo, salvaguardando la prima dalla deriva idealistica avviata con l’abbandono da parte di Freud del panedonismo originario (istanza accentuatasi in Jung e Adler) e liberando il secondo dai suoi limiti economicistici. Psicoanalisi e marxismo sono da Reich concepiti prospettive parziali e insufficienti se non incollate fra loro, efficaci solo e soltanto se integrati, in modo tale da penetrare la dialettica psicosociale dell’uomo. Alla psicoanalisi il marxismo può offrire il contesto sociologico che le manca per esprimere le potenzialità di contestazione radicale dell’assetto sociale che pure essa racchiude in sé, ma che il suo rapporto di convivenza con la cultura e la società borghesi le ha sempre fatto sacrificare. La psicoanalisi, sull’altro versante, è capace di colmare il deficit di psicologia sociale che impedisce al materialismo storico di liberarsi da interpretazioni meramente economicistiche della realtà sociale. Non è ad esempio sufficiente che i comunisti spieghino il fenomeno di massa del fascismo con la tesi (che pure presenta una sua parziale verità) secondo cui esso costituirebbe la reazione di classe del capitalismo contro l’ascesa del proletariato e sarebbe la conseguenza del fallimento della politica socialdemocratica; arrestarsi a queste spiegazioni vuol dire non poter spiegare come sia stato possibile al nazifascismo ottenere il consenso delle masse popolari, in un’epoca in cui (stando a Reich) vi sarebbero tutti i presupposti economici per la crisi del capitalismo e il suo violento tramonto attraverso la rivoluzione socialista. A tal proposito, così scrive Reich in Psicologia di massa del fascismo: “non sarebbe più logico chiedersi che cos’è, nelle masse e dentro le masse, a render loro impossibile di riconoscere la vera funzione del fascismo? Le solite formule: ‘i lavoratori debbono rendersi conto…’, o le autocritiche del tipo ‘noi non abbiamo capito che…’ non servono a nulla. ‘Perché’ i lavoratori non si rendono conto e ‘perché’ noi non abbiamo capito?“. Ed è qui che la psicoanalisi giunge in soccorso: essa è infatti capace di spiegare comportamenti politici delle masse che non sarebbero mai derivabili dagli interessi economici: l’analisi del carattere, lo studio della famiglia patriarcale e piccolo-borghese e della sua funzione altamente repressiva, permettono di capire la struttura caratteriale di tipo autoritario, indotta dal potere dominante tra le masse, che le ha portate a interiorizzare il rispetto e l’accettazione del capo, estremo esito di quella castrazione dell’individuo iniziata dalla famiglia, nel rapporto del figlio con l’autorità del padre. Già Freud aveva notato che il fantomatico “imperativo categorico” di Kant altro non era se non l’interiorizzazione di leggi imposte dalla società; ora Reich arriva a dire, in maniera piuttosto simile, che l’autorità sviluppantesi nella famiglia viene introiettata dall’individuo e da questi sentita come legge morale. Siffatti orientamenti di Reich incontrarono profonde ostilità tanto nella Società psicoanalitica quanto all’interno del partito comunista tedesco, il quale restava dogmaticamente fermo all’economicismo della tradizione marxista e non disponibile – per la sua stessa struttura autoritaria – ad accettare la linea politica della Sexpol, in un’epoca in cui anche in Urss erano tornati in auge – con quella feroce dittatura che fu lo stalinismo – il culto dell’autorità (Stalin era visto quasi come un Dio in terra) e della famiglia, nonché il sospetto nei confronti della sessualità. Il periodo americano di Reich – periodo che va dal 1939 fino alla morte del filosofo – segna il suo distacco dal marxismo e il prevalere di quella tendenza alla radicale biologizzazione della libido, denudata da ogni segno culturale, i cui inizi erano già avvertibili nella teoria del nucleo biologico del carattere. Egli converte gradualmente il trattamento analitico della nevrosi in medicina psicosomatica e vegetoterapia (una specie di manipolazione del corpo del paziente, volta alla soluzione delle rigidità muscolari responsabili della corazza caratteriale), e soprattutto va alla ricerca dell’orgone, l’ipotetica energia cosmica bioelettrica primordiale imprigionabile in speciali accumulatori organici, di cui una manifestazione sarebbe anche l’energia sessuale. Si tratta – è evidente – di aspetti deliranti che contrassegneranno sempre più queste fantasiose e suggestive (nonché bizzarre) ricerche, fino alla morte di Reich – avvenuta nel 1957 in carcere, dopo che era stato condannato per ciarlataneria da un tribunale degli Stati Uniti (presunti) liberali e democratici.
Capitalismo e repressione sessuale
Quali rapporti esistono tra l’ordinamento sociale capitalistico, le sue norme sessuali ed il modo in cui viene trattata la sessualità dei giovani? Che significato ha la repressione sessuale giovanile?
La maggior parte dei giovani, ad eccezione di quelli proletari che hanno una notevole coscienza di classe, assumono la repressione della loro vita sessuale da parte della società capitalistica come qualcosa di ovvio, che è cosí e non potrebbe essere altrimenti.
Cominciamo a fare un paragone fra i pochi giovani che conducono una vita sessuale soddisfacente e gli altri che non sono riusciti a liberarsi dall’influsso della famiglia borghese, della scuola e della Chiesa, e vivono perciò in astinenza, si masturbano oppure cadono occasionalmente nel cosiddetto “amore platonico”, immergendosi nei loro sogni ad occhi aperti. Dovremo senz’altro constatare che i giovani che hanno le idee chiare in materia sessuale (e questi sono quasi sempre figli di proletari) si ribellano apertamente contro la loro famiglia, la scuola e la Chiesa, mentre quelli sessualmente inibiti (prevalentemente di origine piccolo-borghese) sono nella maggioranza dei casi dei “bravi ragazzi”.
Famiglia e scuola infatti sono oggigiorno, da un punto di vista politico, nient’altro che officine dell’ordinamento sociale borghese dalle quali vengono sfornati continuamente servi bravi ed ubbidienti. Il padre, nel suo ruolo abituale, è il rappresentante dell’autorità statale all’interno della famiglia. Lo stesso atteggiamento ubbidiente e servile che il padre esige dai figli quando sono ancora piccoli oppure giovani, lo Stato lo pretende dagli adulti. La mancanza di senso critico, l’impossibilità di protestare, il non-avere-nessuna-opinione-personale caratterizzano tanto il rapporto di fedeltà familiare che i figli hanno con i genitori, quanto quello degli impiegati fedeli con lo Stato, e quello degli operai non ancora coscienti a livello di classe con il loro direttore di fabbrica o col padrone.
Nella misura in cui si sviluppa all’interno della famiglia proletaria la coscienza di classe, si modifica anche l’atteggiamento dei genitori verso i figli, anche se tale trasformazione avviene per ultima e con maggiore difficoltà di tutte le altre. La meccanica della repressione sessuale si può sintetizzare cosí: per ottenere una efficace repressione dei desideri sessuali è necessario impiegare una notevole quantità di energia psichica; ciò si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell’attività, dell’intelligenza e della critica. Al contrario, piú la vita sessuale si svolge in modo sano e vigoroso, tanto piú libero, attivo e critico diventa l’individuo. Ma è proprio questo che il capitalismo non vuole che avvenga. La limitazione della libertà spirituale e critica per mezzo della repressione sessuale è uno degli scopi fondamentali dell’ordinamento sessuale borghese. È assai significativo il fatto che la borghesia con tutti i mezzi che ha a disposizione si impegna per il mantenimento e il rafforzamento della morale familiare: la famiglia borghese è infatti, come abbiamo detto precedentemente, la sua principale fabbrica di servi.
La morale dell’astinenza viene fatta valere in modo particolarmente rigido nell’epoca della maturità sessuale perché normalmente la gioventú comincia a ribellarsi proprio in quel periodo contro i genitori; gli interessi e le energie sessuali di ognuno si ribellano contro i loro oppressori.
L’epoca della maturità sessuale è proprio quella in cui, quasi senza eccezione, in tutte le famiglie avvengono i piú duri conflitti fra genitori e figli.
Se il giovane non è stato completamente condizionato (e questo è il caso dei figli di impiegati e piccoli commercianti) comincia a rifiutarsi di passare i giorni di festa in compagnia di adulti (come vorrebbero i genitori) prima o poi, piú o meno chiaramente intuisce che il suo posto è altrove, in mezzo agli altri giovani, si accorge che si annoia con gli adulti, che desidera aria aperta, sole, movimento e rapporti sessuali.
Se il nostro lavoro rivoluzionario di informazione non raggiunge questi giovani, essi ricadranno, dopo un breve ed inutile periodo di lotta contro i genitori, nella malinconica atmosfera familiare che li terrà lontani dalla vita politica, e li sottoporrà ad un tale indottrinamento borghese, che poi andranno a finire nel movimento giovanile borghese o addirittura in quello nazista. Non dobbiamo dimenticare il fatto che il movimento nazionalsocialista recluta i suoi appartenenti prevalentemente fra i giovani piccolo-borghesi e si schiera insieme alla Chiesa e al capitale per “tener alto l’onore” della famiglia borghese e per la castità nei giovani. È significativo inoltre che il movimento nazionalsocialista, accanto a slogan rivoluzionari, collochi parole d’ordine che implicano la totale schiavitú della donna (aumento della pena detentiva per l’aborto, “la donna appartiene al focolare domestico”, rifiuto di una parificazione delle donne nelle associazioni politiche) e ne risulta che l’ideologia nazionalsocialista va perfettamente d’accordo con l’ideologia familiare borghese-capitalistica.
Il compito principale della gioventú rivoluzionaria è quello di chiarire le idee agli altri giovani su questi punti.
In questa lotta per la liberazione di tutti i giovani non emancipati dai legami con la famiglia, dobbiamo essere preparati a fronteggiare enormi difficoltà.
La famiglia borghese ha dunque il compito di educare dei servi, di rendere la gioventú disposta al matrimonio. Siccome la vita sessuale e la sussistenza materiale al di fuori della famiglia (che può godere della protezione delle leggi) è ancora assai difficile per la donna ed i bambini, anzi, spesso incredibilmente pericolosa per chiunque non goda di questa protezione, la famiglia e la casa dei genitori hanno pur sempre un ruolo importante nella società capitalistica come istituzioni protettive per le donne oppresse ed i loro figli.
Proprio per questa ragione le donne proletarie difendono cosí appassionatamente il matrimonio. In ogni caso l’istituzione familiare rappresenta, sia negli strati borghesi che piccolo-borghesi, fino al proletariato, nient’altro che miseria e squallore per tutti i suoi componenti.
Nell’istituzione familiare vi è una contraddizione che contribuisce a rafforzarla e nello stesso tempo a distruggerla: da una parte la famiglia è una delle piú importanti istituzioni dell’economia privata, dall’altra la stessa economia capitalistica, la disoccupazione di massa, l’impoverimento del proletariato provocato dall’abbassamento continuo dei salari, distruggono le famiglie della popolazione lavoratrice; le donne e i giovani proletari devono scegliere fra l’andare a lavorare, per guadagnarsi il minimo necessario per vivere, o vivere con il sussidio di disoccupazione (ed in tal caso la lunga disoccupazione provoca in loro un tale scoraggiamento che le tensioni già presenti normalmente in ogni famiglia raggiungono a volte il livello di un odio insopportabile). In tal modo molte famiglie proletarie si spezzano tanto per difficoltà interne che per la pressione economica che incalza dall’esterno.
Nella piccola borghesia il quadro non è molto diverso (a parte la crisi del matrimonio piccolo-borghese). Piú la miseria economica in cui versano le masse investe la famiglia piccolo-borghese, piú rapidamente cadono le frasi ipocrite piú chiaramente la situazione si rivela per quella che è. Intere generazioni di giovani vengono moralmente rovinate dai violenti litigi che scoppiano fra i loro genitori; se non riusciranno ad inserirsi nel movimento della gioventú proletaria, questo giovani consumeranno inutilmente le loro forze migliori in una inutile lotta personale contro la propria famiglia.
Questa lotta dei giovani contro i propri genitori retrogradi non ci deve tuttavia far trascurare il fatto che sono ancora profondamente legati, sia interiormente che materialmente alla loro famiglia; forse nei giovani proletari questa dipendenza è meno accentuata a causa della loro autonomia economica. La dipendenza dalla custodia dei genitori e dalla loro autorità sono proprio i due argomenti principali per i quali la Chiesa scende in campo contro i suoi nemici, con tutto il suo arsenale di idiozie, di discorsi su Dio, la sua eterna volontà, la sua saggia previdenza, quando cerca di sollevare in cielo, ben lontano da qualsiasi valutazione critica, il matrimonio e la famiglia; perché infatti l’attuale figura del padre, mettiamocelo bene in testa cos’altro è se non il rappresentante dell’ordine costituito e della morale nei confronti dei figli e della donna all’interno della famiglia? E siccome il Papa approva questo ordine costituito è solo per un fatto di coerenza che ammonisce il suo gregge a seguire il comandamento divino che dice che la donna ed i figli devono essere sottoposti ed obbedienti al capo della famiglia come al buon Dio.
Se avessimo l’occasione di visitare il museo antireligioso di Mosca in cui sono esposte immagini di santi del tempo degli Zar, nelle quali viene raffigurato o Gesú con gli abiti dello Zar, o lo Zar con il volto di Gesú, capiremmo subito il nesso: Dio e Gesú sono immagini ultraterrene del Kaiser e dell’autorità per gli adulti, e del padre per i bambini.
Il Kaiser e le autorità successivamente assumono lo stesso ruolo nella vita sentimentale dell’adulto, lo inducono allo stesso atteggiamento di sudditanza e sottomissione acritica che caratterizzava i rapporti fra padre e figlio.
Naturalmente il ruolo politico della famiglia non si esaurisce in questo: in nessuna istituzione della società borghese risalta cosí chiaramente l’oppressione autoritaria della gioventú, in nessuna istituzione comincia cosí presto ad agire sulla struttura psichica del ragazzo come nella famiglia. Perciò ci rendiamo conto sempre di piú, che la subordinazione familiare nella maggior parte dei casi, và di pari passo con un forte legame all’ordine costituito, e che la ribellione contro i genitori è spesso nei giovani solo un primo passo verso una lotta cosciente a livello di classe contro l’ordinamento sociale capitalistico. Non è un caso che i giovani proletari rivoluzionari, per la maggior parte, proprio per il fatto di aver partecipato al processo produttivo quando erano ancora molto giovani, si allontanano molto presto dalla casa paterna, mentre d’altra parte la gioventú reazionaria è molto legata ai genitori.
È anche significativo il fatto che in uno Stato socialista come l’Unione Sovietica venga data tanta importanza all’indipendenza ed all’autonomia dei giovani dai genitori, e persino ad un atteggiamento critico nei loro confronti.
La famiglia rappresenta nella maggior parte dei casi un baluardo del capitale e della reazione all’interno della stessa classe oppressa. Dentro le quattro squallide mura della sua casa il padre che in altre occasioni dimostra di essere consapevole a livello di classe, dimentica spesso il suo ideale rivoluzionario: in casa si trasforma nel patriarca brutale che domina la moglie ed i figli, e, cosí facendo non fà altro che aiutare, anche se inconsapevolmente, la reazione politica, perché una famiglia di questo genere impedisce ai giovani di sviluppare quella gioia della lotta e quell’energia rivoluzionaria di cui hanno cosí urgentemente bisogno.
Osserviamo dunque in che ambito sopravvive piú fortemente l’autorità dei genitori: quello della vita sessuale dei loro figli. Intimidire ed inibire sessualmente i propri figli, creare in loro un’angoscia autoritaria nei confronti dei loro desideri, pensieri e atti sessuali, costituisce il nucleo di quell’apparato ideologico con l’aiuto del quale la famiglia rende i giovani dei soggetti malleabili per l’ordinamento sociale capitalistico.
A determinare il successo di questa repressione ed assoggettamento dei giovani, poco importa che sia la severità o la dolcezza: ambedue contribuiscono a stabilire un forte legame e sono di solito persino mescolate l’una con l’altra, cioè, uno dei genitori può essere brutale, mentre l’altro si comporta con estrema dolcezza: il risultato e sempre la mancanza di autonomia che caratterizza tutti i giovani. Quando gli educatori borghesi ci vengono a dire che la libertà sessuale rende i giovani incapaci di essere educati, noi rispondiamo: incapaci di essere educati per scopi capitalistici. La miseria psichica e sessuale dei bambini dipende direttamente da questi scopi, che la società capitalista riesce ad affermare facendo opprimere i figli per mezzo dei loro genitori, usando la repressione intellettuale nella scuola, l’abbrutimento spirituale della Chiesa, ed infine la repressione e lo sfruttamento materiale nella fabbrica.
La gioventú proletaria è naturalmente portata verso la lotta di classe dalla propria miseria materiale, mentre larghi settori sociali di grande peso politico, non riescono ancora a raggiungere una piena capacità di lotta di classe per la loro dipendenza emotiva da genitori retrogradi e reazionari. Questo fattore è senz’altro molto piú importante per il giovane piccolo-borghese che per quello proletario.
Purtroppo oggi c’è un numero molto limitato di genitori comunisti che mettono in pratica le proprie convinzioni rivoluzionarie anche nei rapporti con i propri figli. Questi genitori sono per noi l’esempio di come tutti i genitori dovrebbero essere.
Per riuscire a schierare questi giovani nel fronte di lotta di classe è necessario fare i conti con i loro legami familiari.
Occorre passare attraverso questo legame, se si vuol giungere al fronte unito di classe, attraverso la lotta contro la famiglia, attraverso l’opera di convincimento sui genitori proletari che li porti a prendere coscienza del ruolo reazionario della famiglia borghese. Siccome l’angoscia di fronte al sesso rappresenta lo strumento fondamentale per creare uno stato di asservimento e di subordinazione, nessuna presa di coscienza del ruolo autoritario dei genitori e dello Stato classista può essere efficace, senza l’affermazione della fondamentale verità che nei giovani la sessualità è qualcosa di ovvio e di naturale per la quale devono entrare in lotta e combattere contro qualsiasi tipo di repressione.
Prima di passare al problema se il capitalismo dia una possibilità al suo interno di eliminare o almeno di diminuire la miseria sessuale della gioventú dobbiamo chiarire un punto che fino ad ora è stato troppo trascurato nella lotta proletaria contro la religione.
Mentre la scuola prende il posto della famiglia nel portare avanti l’oppressione autoritaria e intellettuale dei giovani, è la Chiesa a perpetuare la repressione puramente sessuale che, – non lo ripeteremo mai abbastanza – rappresenta il piú importante fondamento individuale dell’ottundimento della ragione e della capacità critica. Non è un caso – ed anzi, è particolarmente significativo – che la celebrazione della “cresima”, per i ragazzi cattolici, viene a coincidere proprio con l’inizio della maturità sessuale.
Tutti sanno che nella confessione religiosa non è tanto importante se uno abbia – per esempio – rubato, ma è invece di capitale importanza se uno sia stato troppo libidinoso, se si sia masturbato o abbia avuto rapporti sessuali fuori dell’ordinario. Confessarsi, in altri termini, significa rinfrescare continuamente il senso di colpa sessuale che i genitori, fin dalla piú tenera età, hanno inculcato nei loro figli per reprimere le loro curiosità sessuali. Nella confessione il ragazzo si sente sempre ripetere che l’attività sessuale è un grave peccato e che la piú alta autorità divina vede tutto e punisce tutti i “peccati”, che i ragazzi compiono in questo ambito. Se la società umana oggi non fosse nelle mani dei capitalisti e dei preti che sono cosí esperti nel servirsi della religione per i loro interessi, se la sessuologia non stesse al servizio del capitale, ma utilizzasse la propria esperienza scientifica per una critica coerente della società, si dovrebbe giungere alla ovvia conclusione che la Chiesa, per la sua influenza negativa sulla sessualità dei giovani, (per non parlare del suo influsso direttamente reazionario su coloro che subiscono lo sfruttamento piú intenso) rappresenta una delle istituzioni piú dannose per la salute fisica e psichica dell’individuo che lo Stato classista possieda, e che nessuna punizione è troppo grande per coloro che continuamente, in piena coscienza e consapevolezza dell’infelicità che provocano, compiono incredibili misfatti contro l’umanità non solo impuniti, ma addirittura ben ricompensati. Questi legami fra reazione clericale e repressione sessuale non sono fatti di poca importanza: si tratta di sottrarre all’influenza della Chiesa la gioventú cattolica e di portarla nei nostri ranghi contro la Chiesa stessa, la famiglia borghese, la scuola reazionaria e l’ordine sociale capitalistico, perché, anche se sono cattolici, sono figli di operai sfruttati, di impiegati e di contadini. È nostro dovere, tuttavia, dimostrare a questi giovani con dati alla mano, la nostra tesi che la Chiesa è esclusivamente al servizio del capitale.
Quando ultimamente il Papa (dicembre 1930) nella sua Enciclica Del matrimonio cristiano, venendo in soccorso al capitalismo, si è pronunciato per un rafforzamento della “moralità” cristiana e per il matrimonio ha scritto:
“L’ordinamento dell’amore implica la superiorità dell’uomo sulla donna e sui figli e la volenterosa e generosa ubbidienza da parte della donna (e dei figli) come fu descritta dall’apostolo: Le donne (ed i bambini) devono essere sottoposti ai loro uomini (e padri) come al Signore, perché l’uomo è il signore della donna (ed il padre dei figli) come Cristo è il signore della Chiesa”.
In seguito il Papa raccomanda, contro la miseria materiale delle masse “esercizi religiosi” e ammonisce i ricchi in questo modo:
“Coloro che vivono nell’abbondanza non devono utilizzare il danaro per spese superflue o addirittura sperperarlo, ma per il mantenimento ed il bene di coloro a cui manca persino il minimo necessario per sopravvivere”.
Se alle associazioni giovanili cristiane dicessimo che sono in contrasto persino con la loro Chiesa, perché i loro appartenenti si comportano dal punto di vista sessuale, nello stesso modo dei giovani atei (forse con manifestazioni patologiche piú gravi), ci risponderebbero che con l’aiuto dello spirito santo e della Chiesa riusciranno a crearsi le forze necessarie per resistere all’onanismo e per reprimere la loro sessualità; perciò bisogna parlare non solo dei pericoli che incombono sulla salute, ma anche dello sporco gioco che avviene alle loro spalle, dire e dimostrare chiaramente tutta la verità riguardo alla Chiesa; per esempio questo: mentre, nell’anno di depressione economica 1930, il bilancio statale prevedeva solo 1693 milioni di marchi per l’assistenza ad invalidi, disoccupati, bambini, mentre le scuole e gli ospedali erano chiusi, la gente si trascinava affamata per le strade, il numero dei suicidi fra i giovani aumentava enormemente, la Chiesa aumentò le sue entrate, attraverso le tasse statali, dai 40 milioni del 1923 (71 nel 1928) agli 86 milioni del 1929. Questi giovani delle associazioni cattoliche dovrebbero cercare di chiarire a se stessi come mai la Chiesa, in periodi di grave necessità, non segue nemmeno i propri precetti, ma, al contrario riesce ad assicurarsi entrate sempre maggiori alle spese dei poveri, perché tutti sanno che queste entrate provengono dalle tasse che gravano maggiormente sui poveri cioè gli oppressi pagano, senza saperlo, allo Stato il mantenimento dei mezzi che servono alla loro oppressione.
Come dimostra questo esempio (purtroppo non possiamo portare in questa sede l’intera documentazione che sarebbe necessaria) è necessario sviluppare tutto il retroterra clericale e capitalistico in una discussione sui bisogni sessuali della gioventú, altrimenti non raggiungeremo mai il nucleo della questione; corriamo il pericolo di non dare una risposta corretta ai giovani che ci chiedono una soluzione alla loro miseria sessuale.
Il nostro problema fondamentale era dunque: può la borghesia, nel proprio ambito, risolvere il problema sessuale dei giovani? A questa domanda rispondiamo decisamente di no: in ambito capitalistico, finché regneranno incontrastate l’economia e l’educazione borghese, non c’è nessuna soluzione al problema.
Nei circoli liberali della borghesia si parla molto spesso della miseria dei giovani, ma è necessario rendersi conto piú esattamente di come pensano (o meglio, pretendono di pensare) e di come agiscono in realtà. Sono forse veramente pronti a concedere ai giovani una completa facoltà di autodeterminazione e quindi una vita sessuale adeguata alla loro età?
Sono veramente pronti a riconoscere e approvare il rapporto sessuale quando è necessario, e quando la sua mancanza si rivela dannosa per la salute? Sono veramente pronti a smetterla di riempire di angoscia i giovani con i loro film di informazione sessuale che sono cosí dannosi da rendere impotenti alcuni ragazzi che assistono alla loro proiezione? Il 98% di questi film ha lo scopo di creare il panico e diffondere l’ideologia dell’astinenza nella gioventú, solo il 2% descrive le possibilità di cura delle malattie veneree che sono oggi a disposizione e nessuno di essi si occupa della loro prevenzione. Sono dunque pronti a sopprimere ufficialmente la doppia morale sessuale, in modo tale che i giovani della piccola borghesia possano avere rapporti sessuali con ragazze della loro classe e non con delle prostitute? Sono pronti, – cioè – il loro sistema sociale permette loro di mettere a disposizione della gioventú, in centri di consultazione sessuale che dovrebbero essere immediatamente costituiti, tutti gli anticoncezionali, gratuitamente e senza alcuna limitazione?
Cancellerà la borghesia il paragrafo sull’aborto, e permetterà che venga procurato gratuitamente in cliniche pubbliche anche alle ragazze minorenni, nel caso che gli anticoncezionali non abbiano avuto effetto?
Può la borghesia risolvere il problema dell’abitazione per i giovani in modo che non siano piú costretti a vivere una grottesca imitazione di una sana vita sessuale, a fare l’amore nei portoni e dietro i muri, dando cioè a ciascuno la possibilità di stare solo con il proprio partner?
Sono pronti ad educare sessualmente i bambini in modo tale da renderli capaci, quando diventeranno adulti, di avere una vita sessuale sana?
Una statistica di un centro di consultazione sessuale di Berlino ha stabilito che il 44% di tutti quelli che sono venuti a chiedere consigli, abitano in un appartamento formato da una camera e una cucina.
327 abitano in 3
354 abitano in 4
187 abitano in 5
81 abitano in 6
47 abitano in 7
Il 20% di questi ha solo una stanza con uso di cucina, in cui vivono: 240 in tre, 76 in quattro. Il 5% di quelli che frequentano i consultori pubblici vivono in una unica stanza che fa anche da cucina in tre, fino a cinque persone.
No, la borghesia, a causa del suo sistema economico che si basa sullo sfruttamento da parte di una minoranza che vive bene, non può risolvere il problema sessuale dei giovani. Non è neanche capace di sfamare i giovani proletari, e quello della fame è naturalmente il primo presupposto per la soluzione del problema sessuale in generale.
Secondo i dati dell’”Annuario statistico tedesco” del 1930, nel 1918 sono morti per suicidio 11239 uomini e 4797 donne; fra questi 3563 uomini e 1440 donne in età dai 15 ai 30 anni. Senz’altro sono stati tutti delle vittime dell’abbrutimento materiale e sessuale: ogni giorno circa 47 persone. Da allora il numero è enormemente cresciuto. Questa è l’immagine offerta dal “pacifismo” dei democratici dal cuore tenero, che non sopportano la vista del sangue.
Non vogliamo qui fare lunghe discussioni sul perché la borghesia non può e non potrà mai trasformare il proprio ordinamento sessuale; abbiamo svolto questo argomento in altra sede. Nella misura in cui la sessualità, nella società borghese riesce a liberarsi degli antichi vincoli, questo succede contro la volontà della borghesia. Questo non solo è un segno della decadenza della morale borghese ma del sistema borghese in generale.
Alcuni giovani non ancora coscienti a livello di classe, come sono i giovani socialdemocratici, affermano di solito, a questo punto, alludendo a quel poco di libertà sessuale che la gioventú ha raggiunto fino ad oggi, che la liberazione sessuale senza rivoluzione sociale è ancora possibile nella società capitalistica: queste “libertà” secondo loro, dovrebbero essere la miglior prova a conforto della loro tesi. Bisogna dimostrare chiaramente a questi giovani che si sbagliano: non si tratta infatti di una libertà sessuale. È senz’altro vero che oggigiorno i giovani hanno una vita sessuale diversa da quella che avrebbero potuto avere, per esempio, trent’anni fa, che la famiglia e la Chiesa hanno perduto molta della loro influenza di una volta su gran parte dei ragazzi, ma ciò è avvenuto solo grazie al lavoro rivoluzionario svolto dalle nostre organizzazioni.
Tuttavia è necessario non scambiare la confusione odierna per “liberazione sessuale”. Che aspetto ha? A quale tipo di struttura psichica porterà questa maggiore libertà sessuale? Non sono forse aumentate le difficoltà dei giovani per il fatto che vivendo in famiglia prima nella infanzia e piú tardi nella scuola, la loro sessualità è stata cosí disturbata che essi, per la maggior parte, sono divenuti interiormente incapaci di avere una vita sessuale soddisfacente?
E dall’altro lato il piú frequente unirsi dei giovani in associazioni, pur stabilendosi fra compagni un corretto atteggiamento di solidarietà, e portando un certo sollievo, non produce nello stesso tempo, a causa della insolita situazione, un acutizzarsi del problema?
L’assistenza sociale nella sua forma di volgarizzazione scientifica, aiuto sociale, non è forse aumentata solo nella stessa misura in cui la morale borghese si è andata disgregando e la gioventú ha cominciato ad entrare nelle associazioni spinta da una oscura e istintiva consapevolezza del fatto che la lotta contro la casa paterna non avrebbe avuto nessun risultato positivo? Non sono forse enormemente aumentati i disturbi sessuali ed i suicidi per motivi sessuali negli ultimi anni?
I giovani socialdemocratici possono dirci in che modo autoritario e repressivo il loro partito si comporta. Il borghese e il prete diranno: “Certo, la miseria sessuale dei giovani deriva dal fatto che la loro moralità si è disgregata e la colpa di ciò deve essere attribuita ai bolscevichi”. Noi rispondiamo, (e lo possiamo dimostrare fino nel piú piccolo dettaglio), che è stata invece proprio la repressione sessuale e materiale della gioventú che ha sotterrato questa morale. Si tratta come ha giustamente constatato il giudice borghese Lindsay in America, di una irreversibile ribellione sessuale della gioventú che oggi però non sempre porta ad un atteggiamento chiaramente rivoluzionario, perché noi non siamo riusciti a trasformare questa sterile rivolta sessuale in una feconda lotta rivoluzionaria, che avrebbe dato un senso al tutto.
Lo sviluppo economico della società, l’incapacità del capitalismo di regolare in modo soddisfacente i rapporti economici fra gli uomini, il suo progressivo disgregarsi, garantiscono da soli anche senza il nostro aiuto, che la morale borghese si sta putrefacendo in modo irreversibile.
Non l’abbiamo seppellita noi questa morale, non le abbiamo provocate noi le crisi economiche, né abbiamo distrutto la famiglia: lo ha fatto il sistema capitalistico stesso. Noi svolgeremo il nostro compito di organizzazione giovanile e di partito rivoluzionario solo se riusciremo ad accelerare questo doloroso processo di immiserimento delle masse uccidendo ciò che è già in agonia dovunque si presenti, per costruire una nuova società, che la faccia finita una volta per tutte con i privilegi di classe, lo sfruttamento economico, l’asservimento intellettuale e sessuale, e soddisfi finalmente l’aspirazione dell’uomo alla socializzazione assicurando la soddisfazione delle esigenze fondamentali delle masse: il cibo, l’amore, le attività culturali.
[La lotta sessuale dei giovani]
Il fascismo come espressione della struttura caratteriale umana media
Da quando la primitiva organizzazione democratico-lavorativa è definitivamente tramontata, il nucleo biologico non ha piú trovato un’espressione sul piano sociale. Ciò che è a naturale” ed “elevato” nell’uomo, ciò che lo lega al suo cosmo, ha trovato soltanto nell’arte, soprattutto nella musica e nella pittura, un’autentica espressione. Ma finora non ha esercitato alcuna sostanziale influenza sulla formazione della società umana, se per società si intende non la cultura di un ristretto gruppo di persone ricche appartenenti alla classe dominante, ma la comunità di tutti gli uomini.
Negli ideali etici e sociali del liberalismo si possono riconoscere i tratti dello strato caratteriale superficiale, caratterizzato dall’autocontrollo e dalla tolleranza. Questo liberalismo accentua la propria etica al fine di soffocare “il mostro nell’uomo”, il secondo strato delle “pulsioni secondarie”, “l’inconscio” di Freud. La naturale socialità del terzo e piú profondo strato, dello strato in cui ha sede il nucleo biologico dell’uomo, è sconosciuta al liberale. Egli deplora e combatte il pervertimento caratteriale umano con norme etiche, ma le catastrofi del XX secolo hanno insegnato che non ha combinato gran che.
Tutto ciò che è veramente rivoluzionario, qualsiasi arte e scienza autentiche, nasce dal nucleo biologico naturale dell’uomo. Né il vero rivoluzionario né l’artista o lo scienziato finora sono riusciti a conquistare le masse e a guidarle, e semmai vi sono riusciti, non sono stati capaci di tenerle in modo duraturo nel campo degli interessi vitali.
Le cose stanno diversamente, rispetto al liberalismo e alla vera rivoluzione, per quanto riguarda il fascismo. Sostanzialmente il fascismo non rappresenta né lo strato superficiale né quello piú profondo, ma il secondo strato caratteriale intermedio delle pulsioni secondarie.
Nel periodo in cui ero occupato con la prima stesura di questo libro, il fascismo veniva generalmente considerato un “partito politico” che come altri “raggruppamenti sociali” esprimeva in modo organizzato un’”idea politica”. Di conseguenza “il partito fascista introduceva il fascismo o con la forza o con “manovre politiche””.
Contrariamente a tutto ciò, le mie esperienze mediche fatte con molte persone appartenenti ai piú disparati strati sociali, razze, nazioni, religioni ecc. mi avevano insegnato che il “fascismo” non è altro che l’espressione politicamente organizzata della struttura, caratteriale umana media, di una struttura che non è vincolata né a determinate razze o nazioni né a determinati partiti, ma che è generale ed internazionale. Secondo il significato caratteriale “il fascismo” è l’atteggiamento emozionale fondamentale dell’uomo autoritariamente represso dalla civiltà delle macchine e dalla sua concezione meccanicistico-mistica della vita.
Il carattere meccanicistico-mistico degli uomini del nostro tempo crea i partiti fascisti e non viceversa.
Ancor oggi, in seguito a un errato pensiero politico, il fascismo viene considerato una specifica caratteristica nazionale dei tedeschi o dei giapponesi. Da questa prima concezione sbagliata conseguono tutte le altre interpretazioni erronee.
Il fascismo è stato e continuerà ad essere considerato, a danno degli autentici sforzi per raggiungere la libertà, la dittatura di una piccola cricca reazionaria. L’ostinazione con cui si continua a sostenere questo errore è da attribuire alla paura di rendersi conto di come stanno veramente le cose: il fascismo è un fenomeno internazionale che corrode tutti i gruppi della società umana di tutte le nazioni. Questa conclusione trova la sua conferma negli avvenimenti internazionali degli ultimi quindici anni.
Le mie esperienze analitico-caratteriali mi convinsero invece che oggi non esiste assolutamente nessuno che non porti in sé gli elementi del modo di pensare e sentire fascista. Il fascismo come movimento politico si differenzia da altri partiti reazionari per il fatto che viene sostenuto e diffuso dalle masse umane.
Mi rendo perfettamente conto dell’enorme responsabilità che deriva da simili affermazioni. Augurerei, nell’interesse del nostro mondo tormentato, che le masse lavoratrici si rendessero conto con altrettanta chiarezza della loro responsabilità per quanto riguarda il fascismo.
Bisogna distinguere rigorosamente fra normale militarismo e fascismo. La Germania guglielmina era militarista, ma non fascista.
Poiché il fascismo si manifesta sempre e ovunque come un movimento sorretto dalle masse umane, tradisce tutti i tratti e tutte le contraddizioni della struttura caratteriale delle masse umane: non è, come si crede generalmente, un movimento puramente reazionario, ma costituisce un amalgama tra emozioni ribelli e idee sociali reazionarie.
Se per rivoluzione si intende la ribellione razionale contro condizioni insopportabili nella società umana, la volontà razionale di “andare a fondo a tutte le cose” (“radicale” – “radix” – “radice”) e di migliorarle, allora il fascismo non è mai rivoluzionario. Non vi è dubbio che esso può fare la sua comparsa ammantato di sentimenti rivoluzionari. Ma non si chiamerà rivoluzionario quel medico che combatte con sfrenate imprecazioni una malattia, ma al contrario quello che con calma, coraggiosamente e coscienziosamente, cerca e combatte le cause della malattia. La ribellione fascista nasce sempre laddove una emozione rivoluzionaria viene trasformata in illusione per paura della verità.
Il fascismo, nella sua forma piú pura, è la somma di tutte le reazioni irrazionali del carattere umano medio. Il sociologo ottuso, a cui manca il coraggio di riconoscere il ruolo predominante della irrazionalità nella storia dell’umanità, considera la teoria fascista della razza soltanto un interesse imperialistico, per dirla con parole piú blande, un “pregiudizio”. Lo stesso dicasi per il politico irresponsabile e retorico. L’intensità e la vasta diffusione di questi “pregiudizi razziali” sono la prova che essi affondano le loro radici nella parte irrazionale del carattere umano. La teoria della razza non è una creazione del fascismo. Al contrario: il fascismo è una creazione dell’odio razziale e la sua espressione politicamente organizzata. Di conseguenza esiste un fascismo tedesco, italiano, spagnolo, anglosassone, ebreo ed arabo. L’ideologia razziale è una tipica espressione caratteriale biopatica dell’uomo orgasticamente impotente.
Il carattere sadico-pervertito dell’ideologia razziale tradisce la sua natura anche nel suo atteggiamento di fronte alla religione. Si dice che il fascismo sarebbe un ritorno al paganesimo e il nemico mortale della religione. Ben lungi da ciò, il fascismo è l’estrema espressione del misticismo religioso. Come tale si manifesta sotto una particolare forma sociale. Il fascismo appoggia quella religiosità che nasce dal pervertimento sessuale, e trasforma il carattere masochista della religione della sofferenza dell’antico patriarcato in una religione sadica. Di conseguenza traspone la religione dall’aldilà della filosofia della sofferenza nell’aldiqua dell’omicidio sadico.
La mentalità fascista è la mentalità dell’”uomo della strada” mediocre, soggiogato, smanioso di sottomettersi ad un’autorità e allo stesso tempo ribelle. Non è casuale che tutti i dittatori fascisti escano dalla sfera sociale del piccolo uomo della strada reazionario. Il grande industriale e il militarista feudale approfittano di questa circostanza sociale per i propri scopi, dopo che questi si sono sviluppati nell’ambito della generale repressione vitale. La civiltà meccanicistica ed autoritaria raccoglie, sotto la forma di fascismo, solo dal piccolo borghese represso ciò che da secoli ha seminato, come mistica mentalità del caporale di giornata e automatismo fra le masse degli uomini mediocri e repressi. Questo piccolo borghese ha copiato fin troppo bene il comportamento del grande e lo riproduce in modo deformato e ingigantito. Il fascista è il sergente del gigantesco esercito della nostra civiltà profondamente malata e altamente industrializzata. Non si può far vedere impunemente all’uomo comune il grande tam tam dell’alta politica: il piccolo sergente ha superato il generale imperialista in tutto: nella musica di marcia, nel passo dell’oca, nel comandare e nell’obbedire, nella mortale paura di dover pensare, nella diplomazia, nella strategia e nella tattica, nelle divise e nelle parate, nelle decorazioni e nelle medaglie. Un uomo come l’imperatore Guglielmo si rivelò in tutte queste cose un miserabile dilettante rispetto a Hitler figlio di un funzionario e morto di fame. Quando un generale “proletario” si copre il petto da ambo le parti con medaglie, e perché no, dalla gola fino all’ombelico, dimostra cosí al piccolo uomo comune che non intende essere da meno del “vero” e grande generale.
Solo dopo aver studiato a fondo e per anni il carattere del piccolo uomo comune represso, e le cose come si svolgono realmente dietro le quinte, è possibile comprendere su quali forze poggia il fascismo.
Nella ribellione delle masse di animali umani maltrattati contro le insignificanti cortesie del falso liberalismo (non intendo il vero liberalismo e la vera tolleranza) apparve lo strato caratteriale delle pulsioni secondarie.
Non è possibile rendere inoffensivo l’energumeno fascista se lo si cerca, a seconda della congiuntura politica, soltanto nel tedesco o nell’italiano e non anche nell’americano o nel cinese; se non lo si rintraccia nel proprio essere; se non si conoscono le istituzioni sociali che lo covano ogni giorno.
Si può battere il fascismo soltanto se lo si affronta obiettivamente e praticamente con una approfondita conoscenza dei processi vitali. Nessuno è capace di imitarlo in fatto di manovre politiche, abilità nel destreggiarsi nei rapporti diplomatici, e organizzazione delle parate. Ma non sa rispondere a questioni vitali pratiche, perché vede tutto nell’immagine riflessa dell’ideologia e sotto forma della divisa dello stato.
Quando un carattere fascista di qualsiasi colorazione si mette a predicare “l’onore della nazione” (anziché l’onore dell’uomo) o a la salvezza della sacra famiglia e della razza” (anziché la comunità dell’umanità che lavora); quando monta in superbia e quando dalla sua bocca non escono che slogans, allora gli si chieda pubblicamente, e con la massima calma e semplicità:
“Che cosa fai praticamente per dar da mangiare alla nazione senza assassinare altre nazioni? Che cosa fai come medico contro le malattie croniche, che cosa fai come educatore per favorire la gioia di vivere dei bambini, che cosa fai come economista contro la miseria, che cosa fai come assistente sociale contro il logoramento delle madri con tanti figli, che cosa fai come costruttore per sviluppare l’igiene delle abitazioni? Ora, cerca di non parlare a vanvera e cerca di dare una risposta concreta e pratica, altrimenti tieni chiuso il becco!”
Da ciò consegue che il fascismo internazionale non potrà mai essere battuto con manovre politiche. Soccomberà alla naturale organizzazione del lavoro, dell’amore e del sapere su scala internazionale.
Il lavoro, l’amore e il sapere della nostra società non hanno ancora il potere di determinare l’esistenza umana. Piú ancora, queste grandi forze del principio vitale positivo non sono consapevoli della loro immensità, della loro insostituibilità e della loro determinante importanza per l’esistenza sociale. Per questo motivo la società umana si trova oggi, un anno dopo la vittoria militare sui partiti fascisti, ancora piú vicina all’orlo dell’abisso. Il crollo della nostra civiltà sarà inarrestabile se i responsabili del lavoro, gli scienziati di tutte le ramificazioni vitali (e non mortali) e i donatori e i beneficiari dell’amore naturale tarderanno a rendersi conto della loro gigantesca responsabilità.
Ciò che è vivo può esistere senza il fascismo, ma il fascismo non può vivere senza ciò che è vivo. Il fascismo è il vampiro avvinghiato al corpo dei viventi che sfoga i suoi impulsi omicidi quando l’amore si ridesta in primavera invocando la naturale realizzazione.
“La libertà umana e sociale, l’autogoverno della nostra vita e della vita dei nostri discendenti si realizzerà in modo pacifico o violento?”. Nessuno è in grado di dare una risposta a questa angosciosa domanda.
Ma chi conosce le funzioni vitali nell’animale, nel neonato, nel lavoratore dedito alla propria attività, sia che si tratti di un meccanico, di un ricercatore o di un artista, cessa di pensare servendosi di concetti che sono stati creati dalle malefatte dei partiti. Ciò che è vivo non può “prendere il potere con la violenza” perché non saprebbe che farsene del potere. Forse questa conclusione significa che la vita sarà per sempre vittima e martire del gangsterismo politico e che il politicante continuerà a succhiare per sempre il suo sangue? Questa conclusione sarebbe errata.
In quanto medico il mio compito è quello di guarire le malattie. In quanto ricercatore devo svelare processi naturali sconosciuti. Se mi si presentasse un cialtrone politico per costringermi ad abbandonare i miei malati e il mio microscopio, non mi farei disturbare, ma lo butterei fuori dalla porta, qualora non se ne andasse di sua spontanea volontà. Il fatto di dover ricorrere alla violenza per difendere il mio lavoro e i miei studi sulla vita umana dagli intrusi non dipende da me o dal mio lavoro, ma dal grado di impudenza dell’intruso. Proviamo a immaginare ora che tutti quelli che svolgono una attività che investe la vita umana riconoscano in tempo utile il cialtrone politico. Non agirebbero diversamente. Forse questo esempio semplificato può dare una risposta parziale alla domanda sul modo con cui prima o poi dovrà essere difesa la vita contro gli intrusi e i distruttori.
[La psicologia di massa del fascismo, Prefazione alla III edizione del 1932]
MARIA ZAMBRANO

A cura di Agnese Galotti e Diego Fusaro
“Solo nella penombra, tra le ombre, annida la liberazione anche per il sole: la liberazione dal suo proprio regno che con il suo potere imprigiona anche lui.”
Allieva di Ortega y Gasset e di Xavier Zubiri, Maria Zambrano (Vélez-Malaga, 1904 – Madrid 1991), interprete molto attenta e sensibile dell’opera di Miguel de Unamuno e della poesia di Antonio Machado, fu tra le prime donne spagnole ad intraprendere le carriera universitaria in un contesto in cui “una filosofa, nella Spagna degli anni Trenta, era quasi `una donna barbuta’, un’eresia, una curiosità da circo“. La sua caratteristica più affascinante consiste in uno sforzo intellettuale e viscerale insieme di dar voce a ciò che resta silente, di celebrare l’oscurità, l’altro lato dell’esistenza, quello esiliato, muto, nascosto ma profondamente `sentito’, che solo libera dalla tendenza assolutizzante ed impone l’umiltà, compagna necessaria di ogni cammino di conoscenza. La filosofia fu il suo prioritario impegno e la sua irrinunciabile passione: una sfida costante al pensiero oggettivante che tende a negare l’anima stessa da cui trae origine. Non amò quindi mai alcun `sistema filosofico’, che vedeva come “castello di ragioni, muraglia chiusa del pensiero di fronte al vuoto“. Aspirò sempre ad una verità al di fuori di criteri e stereotipi, fedele nell’intento di attuare una “filosofia vivente”, disposta a confrontarsi con l’essere umano nella sua interezza, ad esplorare “il logos che scorre nelle viscere“. “Il pensiero, a quanto sembra, tende a farsi sangue. Per questo pensare è cosa tanto grave. O forse è che il sangue deve rispondere al pensiero… come se l’atto più puro, libero, disinteressato compiuto dall’uomo dovesse essere pagato, o quanto meno legittimato, da quella `materia’ preziosa tra tutte, essenza della vita, vita stessa che scorre nascosta“. Il suo scrivere è caratterizzato da una vena poetica, spesso ironica, da cui emerge una figura trasgressiva ed originale, profondamente vitale nella sua riflessività. La sua vita ha conosciuto varie e profonde crisi, di cui troviamo testimonianza nel saggio autobiografico “Delirio e destino”. Prima vi fu la “malattia creativa” (1928-29), che per lunghi mesi la costrinse all’isolamento ed all’immobilità oltre, naturalmente, all’interruzione degli studi. Fu, forse, la risposta del suo essere all’impatto con un mondo accademico in cui l’egemonia del discorso maschile non ammetteva apertura. Poi vi fu l’esilio, durato quarant’anni, per sfuggire al regime franchista: aveva partecipato alla guerra civile e nel gennaio 1939 era nella colonna di profughi che abbandonava la Spagna ormai in mano all’esercito franchista. Infatti, all’avvento del franchismo al potere, per lei si apre un lunghissimo periodo di peregrinazioni che la porteranno in Cile, in Messico, a Parigi, ove, in momenti diversi, conosce Sartre, Camus ed Emile Cioran, a Cuba e a Portorico. Nel 1953 si trasferisce a Roma con la sorella; qui stringe significativi rapporti con Alberto Moravia, Carlo Emilio Gadda, Elena Croce, Elemire Zolla e Cristina Campo. Lasciata Roma, si sposta nel Giura francese e poi a Ginevra, finché, dai primi Anni ’80 sino alla morte, risiede a Madrid. La Zambrano coniugò costantemente l’attività di insegnamento a quella della scrittura, pubblicando numerose opere che la fecero via via apprezzare da un numero sempre maggiore di estimatori e che le fruttarono pure ambiti riconoscimenti (sarà la prima donna a ottenere, nel 1989, il premio della letteratura in lingua castigliana “Miguel de Cervantes”). Maria Zambrano visse l’esilio come esperienza limite, come “oggetto di rivelazione, che è come dire di scandalo” per chi è potuto restare “nella propria casa, nella propria geografia, nella propria storia“. Sperimentò l’abisso della perdita del senso, lo spaesamento, l’estraneità a se stessi che prelude all’apertura ad un ignoto prima inconcepibile. Tornò sempre al suo compito di testimoniare, con il suo essere donna che pensa e scrive, le infinite potenzialità della vita che restano nell’ombra, nel desiderio inespresso, al di sotto della coscienza. “Il pensiero filosofico ci permette di osare sentire quello che sentiremmo in ogni caso ma senza osare, e che resterebbe per questo sospeso a metà nascita, come quasi sempre succede al nostro sentire. E’ per questo che la vita di tanta gente non va oltre il conato, un conato di vita. E questo è grave, perché la vita deve essere piena in qualche modo, in questo conato di essere che siamo” Poi vi fu la inevitabile e dolorosa divergenza da Ortega y Gasset: nel saggio “Per un sapere dell’anima”, l’autrice affermò come, per essere realmente `vivente’, la filosofia debba rompere con un atteggiamento di unilaterale egemonia della mente per farsi carico dell’essere umano nella sua interezza, riconoscendo non solo l’anima ma anche il corpo quale fonte di creatività e trascendenza, quale luogo pulsante che media il contatto con le forze sacre della materia vivente, con “i residui della matrice originaria da cui l’uomo si è strappato per vivere come un essere indipendente“. Ciò le costò un’accusa di “mancanza di obiettività” da parte di quello che fino ad allora era stato per lei maestro e riferimento. Prese gradualmente corpo l’intuizione di quella che in “Filosofia y Poesia”, (1939), l’autrice chiamò “ragione poetica”, ovvero un metodo di pensiero che, ispirato alla poesia ed alla mistica, apriva un mondo di conoscenza alternativo a quello della filosofia occidentale. “E tutti questi mondi, prima ancora che di leggi, di ragioni o di altre cose pratiche, hanno bisogno della poesia, che sa capire le cose schiave, ascoltare la loro voce e avvicinare la loro immagine fuggevole“. Ad una presunta oggettività neutra e distaccata, predicata dall’epistemologia dei suoi tempi, ella contrappose un’apertura fiduciosa al reale, una posizione filosofica che era ad un tempo una scelta di vita, “uno stile di vedere la vita e quindi di viverla, un modo di star piantato nell’esistenza”, e ancora “un modo di stare nel mondo ammirati, senza pretendere di ridurlo a niente“. Negli anni dell’esilio a Cuba, la Zambrano denuncia spesso la preoccupazione per l’esclusione delle donne dai luoghi del dire e del sapere ufficiale, il dolore per la mancanza di una parola femminile che restava muta, sottomessa, priva di riconoscimento e di voce. Tuttavia la sua analisi va oltre i riduttivi termini della “questione femminile”, pur così urgente: ella riconosce come la negazione della donna reale sia sempre stata il riflesso dell’incapacità della vita umana di albergare l’amore in tutta la sua forza vitale e rivoluzionaria. Troppo spesso addomesticato e ridotto in limiti angusti di regole sociali, l’amore tende ad essere svuotato della sua potenza “capace di generare metamorfosi, di indurre trasformazione, di far germogliare il nuovo in ogni essere“. La crescente emancipazione delle donne, portatrici potenziali di tale forza trasformatrice, si rivela troppo spesso ambivalente nel subire il fascino dei modelli maschili: “mai diremo che la donna debba diventare uguale all’uomo; per certi aspetti dovrebbe essere il contrario“. Il tema centrale della riflessione filosofica della Zambrano verte intorno alla necessità di `coniunctio’ tra il mondo femminile e quello maschile, tra mente che crea e anima che sente e vive. Il suo atteggiamento intellettuale, così come tutta la sua vita, rincorre il sogno di un’unione di opposti, capace di realizzare “il prodigio di vivere tra i due, conseguendo il nous senza perdere l’anima; addentrandosi per quanto è possibile nella libertà senza annientare né umiliare la vita delle viscere“. Si tratta di un’impresa divina, che all’umano è concesso tentare se si astiene dalla presunzione ed impara la misericordia: “questo è misericordia: che con la nostra speranza e il nostro amore arriviamo a partecipare della creazione, anticipando la verità nei sogni, sognando verità che non sono ancora vere, dando il nostro aiuto perché dal mistero la verità si sprigioni“. La filosofia di Maria Zambrano si ispira quindi a quelle figure di donna che, come Antigone, Eloisa e Diotima, hanno conosciuto la misericordia in quanto “hanno fatto dell’amore una filosofia di vita e della propria vita un’opera filosofica“. In modo estremamente evocativo e poetico, nel saggio “All’ombra del dio sconosciuto”, l’autrice ne traccia i personaggi che definisce “aurorali” in quanto, a differenza di tanti eroi maschili, furono donne capaci di quell’offerta consapevole di sé che prelude l’atto creatore. “Prima di raggiungere l’indipendenza bisogna offrirsi, come se qualcosa di quello che la vita è in forma spontanea dovesse essere assimilato e trasformato“. Al sole della coscienza, che spesso scivola nella ragione unilaterale, l’autrice preferisce la figura mitica di Aurora, sorella della notte, promessa di luce che emerge dalle tenebre di cui mantiene in sè intima traccia. “Si dimenticherà sempre la lacerazione e il patimento dell’Aurora, il suo parto, se non si tiene conto della Notte, se la si vede unicamente come l’annuncio del giorno“. Scrive Maria Teresa Russo: “quello di Maria Zambrano si può, in effetti, definire un “pensiero appassionato’, che aspira ad una sintesi tra ragione e cuore, e dunque anche tra poesia e filosofia… Maria Zambrano fa senz’altro filosofia, ma in cerca di una modalità espressiva che concilii in sè il rigore e la passione, per un’adesione più profonda del pensiero alla vita. In lei la filosofia non è mai puro esercizio speculativo, ma esigenza profonda dell’essere alla ricerca di risposte vitali”. Per la pensatrice spagnola, dunque, la filosofia fa un tutt’uno con la vita, significa trovare se stessi, giungere finalmente a possedersi, e la verità di cui essa va alla ricerca non è qualcosa di astratto, ma assume piuttosto i caratteri della concretezza esistenziale. In questo contesto, la Zambrano elabora un antropologia secondo la quale l’uomo possiede una chiara coscienza della propria finitezza, che alimenta in lui nostalgia e speranza a un tempo: è per questo che il futuro dell’uomo (la speranza) coincide con una sua rinascita (la nostalgia), realtà, queste, che hanno la loro sede naturale nel cuore di ciascun essere umano. Afferma a questo proposito ancora Maria Teresa Russo: “di fronte al ‘cogito’, cifra dell’umanesimo cartesiano, Zambrano oppone il cuore, categoria dichiaratamente agostiniana. Proprio a sant’Agostino la pensatrice si riconduce esplicitamente, quando tratta della necessità che il cuore si ricomponga, che riconquisti la perduta armonia con la ragione. È un cuore – prosegue la Russo – che ha bisogno, contemporaneamente di ritrovarsi nella confessione e di esprimersi nella compassione”. Non casualmente la Zambrano ha dedicato uno dei suoi scritti più notevoli proprio al tema della confessione, intesa come possibilità di ricostruire la propria identità attraverso il raccontarsi a un interlocutore privilegiato: a questo riguardo si possono leggere cose molto interessanti nel volumetto Antigone e il sapere femminile dell’anima, curato da Maria Inversi per le Edizioni Lavoro, nel quale si trova questa bella suggestione: “la confessione – secondo Zambrano – è dunque un metodo per trovare questo chi, il soggetto a cui accadono le cose, e in quanto soggetto, colui che resta al di sopra, libero da quanto gli accade”. In “Chiari del bosco”, Zambrano ci parla del risveglio dell’anima e del suo incamminarsi per boschi oscuri, dove opprime l’angoscia del vuoto fino al compiersi quasi miracoloso della liberazione; ritrovandosi, l’anima infine nei chiari del bosco (qualche influsso dei “Sentieri interrotti” di Heidegger è presente), piccole radure di luce che appaiono all’improvviso e senza ragione, ridando ordine all’essere che vagava perso a se stesso. La Zambrano opera un movimento del tutto inusuale nel campo dell’investigazione filosofica che si è sempre servita del logos per trovare la realtà, o meglio per trovare quegli assunti logici che della realtà erano l’archè, la causa prima da cui poi la materia poliedrica si generava, squadernando per l’universo quel caos che, tuttavia, era solo apparente. Pure questo logos per spiegare il caos ha dovuto flettere la materia caotica e sottrarla di forza al suo campo uniforme ed indistinto, e distillarlo da quelle contraddizioni che pure sono l’humus del divenire, ed elevarlo alle astrazioni disseccate e filtrate del pensiero, non trovando in questo processo nessuna incoerenza. La filosofia ha sempre smussato gli angoli, cancellato le sbavature, teso alla perfezione, è stata arrogante, tiranna, investigatrice, teorizzando realtà inconfutabili ha tagliato tutto ciò che era brutto, malfermo, incerto, abnorme, codificando in tal modo le linee del potere e dando alla storia dell’occidente le coordinate sulle quali poter muovere il gioco della vita. In una parola ha mistificato. Questa mistificazione si è andata operando grazie all’asservimento del pensiero e della parola ai dogmi logici di una razionalità che si dava come presunta unica sapiente e conoscente. Perché come può questo maldestro, iniquo e strampalato essere che vive di logos come di caos, che si lascia irretire dalle facili seduzioni della sua natura, come può piegarsi alle strettoie di un pensiero che lo vuole certo, unico, mitico e fermo? Esso, l’essere si ribella, sfuma, vaneggia e non si lascia comprimere. La sua rivolta è l’inconoscibilità. Dove si conosce si pongono limiti, nel momento in cui comprendo classifico, elimino dunque, faccio rientrare un fatto in una categoria piuttosto che in un’altra, opero scelte, cioè taglio sulla realtà, sulle possibilità. Se tutto ciò che l’essere fa è dovuto a qualcosa, dove finisce la sua libertà? Esso non può più sorprendere. Molto di un certo pensiero moderno derivato anche da tanta psicanalisi, nel tentativo di dare soluzioni alla sofferenza sta operando l’ennesima mutilazione, creando i dogmi di una nuova religione, quella del benessere a tutti i costi, di cui è facile prevedere come un futuro potere potrà appropriarsi per rendere l’individuo ancora una volta omologato agli altri. Classificando si pone ordine, si mette in fila e nasce il superiore e l’inferiore, la normalità e la diversità, il ghetto, la violenza e tutto il sistema di controllo e repressione di cui la prigione, il manicomio, l’ospedale e la scuola sono stati e sono per l’occidente gli strumenti per coercizzare e piegare la diversità, la malattia, l’innocenza all’interno di un codice morale penalizzante, del quale è stato supremo indagatore il filosofo francese Michel Foucault. Pare di vedere che oggi più che mai la rivolta dell’essere debba compiersi secondo una riappropriazione del proprio diritto alla sofferenza, a un dolore che è mistero, ricerca, tentativo individuale di spiegazione, che sempre si cerca, si trova un attimo solo per tornare a perdersi. Tale è la realtà che la Zambrano ci descrive nella sua dolentissima umanità, nel suo dignitosissimo modo, tutto umanistico, di accostarsi all’essere, senza violentarlo, con la compassione di chi sa qualcosa perché l’ha vissuta e preferisce tacere. Non dà spiegazioni, la filosofia della Zambrano, si accontenta di seguire l’uomo, la sua stupidità, la sua tragedia, il fuoco improvviso della sua gioia che in un attimo, per miracolo, ritrova tutto chiaro in sè, ma già è oltre, di nuovo nel bosco, viandante, solo, alla ricerca di sè. Il pensare è per la Zambrano non tanto un analizzare quanto un osservare, un restare testimone, un’accettazione di cui lei costruisce una religione del silenzio e della dignità. E’ invece il coraggio di restarsene ai margini con un’umiltà molto solenne, senza voler per forza piegare la realtà nelle strettoie del bene/male, vero/falso, morale/immorale. E infatti la fedeltà alla vita è un’infedeltà alla morale, “un segno di fedeltà, d’accettazione del tempo e della relatività che non rinuncia all’assoluto“. Ma quella della Zambrano è parola poetica, umile e povera. “Generatrice di musicalità e abissi di silenzio, la parola che non è concetto perché è lei che fa concepire, la fonte del concepire, che probabilmente si colloca oltre ciò che si chiama pensare“. Come se nel dormiveglia la realtà si svelasse, dono profetico, cibo per iniziati, capriccioso rito che conserva leggi sue proprie. Perché non è il logos che la realtà dell’essere ricerca, vagando esso come più gli piace, e tuttavia nel suo gioire e soffrire esiste un logos, certamente, ma che è misura contenente gli opposti. “Illimitata, (la parola) traccia, come un geometra, limiti, le necessarie separazioni fra i verbi e fra le diverse manifestazioni del tempo; nel quale apre solchi, paralleli o meno. sostenendo addirittura il loro divergere, perché nella relatività della vita il divergere, quando è sorretto dalla parola depositaria del senso indiviso, dell’unico, è garanzia di unità“. Lo si cerchi dunque, questo logos, e lo si trovi nel mosaico integro e non filtrando quelle sedimentazioni perturbatrici che sono la trama in cui sempre va a dibattersi l’essere, se esso è, com’è, realtà incarnata, immersa nel tempo e nel divenire. La filosofia della Zambrano ci porta alle soglie del silenzio, come già certa poesia. se poetare significa non tanto fantasticare, quanto indagare la frase, la logica, forzando i significati, i limiti della sintassi, sfibrare la parola, decomporla, ucciderla e risorgerla diversa, obliqua finché ci sveli qualcosa d’imprendibile: il mistero. Come dice la Zambrano magnificamente. “E in seguito l’essere una volta destatosi, di mattina o nel centro della notte, a questa luce che si accende senza che si sappia come nell’oscurità, se ne ricade…Soffrirà, anzi, senza dubbio di sete e di oscurità. Ma il vivere umanamente sembra che sia proprio questo, che consista in questo, in un aspirare e un desiderare appagati, nell’oblio di se stessi, da istanti di pienezza che in seguito li ravviano, che li riaccendono. E continuerà cosí, per quanto è da intuire, interminabilmente“. “Scrivere – come dice in un suo testodel’61- è difendere la solitudine in cui ci si trova è un’azione che scaturisce unicamente dall’isolamento effettivo, non comunicabile, nel quale proprio per la lontananza da tutte le cose concrete, si rende possibile una scoperta dei rapporti tra di esse“. Girovaga, “pensatrice errante”, Maria Zambrano ha fatto del “pensare ” un’esperienza capace di coniugare “parola poetica” e rigore geometrico. Sulle figure di Edipo e Antigone, la Zambrano ha scritto pagine fondamentali, non prive però di qualche forzatura della tragedia greca. “El ombre y lo divino” (“L ‘uomo e il divino”) è sicuramente la sua opera filosoficamente più pregnante e suggestiva, in cui ci si addentra in quella “ingens sylva” che unisce appunto l’uomo e il Divino, sapendo che compito dell’uomo è “custodire” il mistero, sì per “conoscerlo come tale, come mistero – senza pretendere di svelarlo”.
ROGER PENROSE

Scheda di Astro Calisi – sito di riferimento: Il Diogene
VITA
Roger Penrose è nato a Colchester (Gran Bretagna) nel 1931. Ha studiato all’University College School di Londra e al St. John’s College di Cambridge. Si è laureato in fisica a Cambridge nel 1957. Dal 1973 insegna matematica presso l’Università di Oxford. Penrose è stato inoltre, nel 1975, Fellow all’University College di Londra, Visiting Professor Yeshiva a Princeton e alla Cornell Univerity nel 1966-67 e nel 1969, Lovett Professor Rice all’Università di Houston dal 1983 al 1987. Nel 1998, per i suoi studi sulla struttura dell’universo ha ricevuto il premio Wolf, il maggior riconoscimento mondiale per la matematica.
PENSIERO
Oltre a interessarsi a vari problemi della geometria, Penrose si è dedicato allo studio dei cristalli, ma soprattutto alla teoria della relatività generale, dimostrando che nel collasso gravitazionale di una stella di massa sufficientemente elevata si generano buchi neri. Da questo lavoro presero il via delle ricerche, condotte insieme a Stephen Hawking, che portarono, nel 1974, ad un celebre teorema, secondo il quale, se la relatività generale è valida in tutti i punti dell’universo, in ogni buco nero deve esistere una singolarità in cui le ordinarie leggi della fisica non sono più valide. Penrose ha anche affrontato il problema dello spazio-tempo all’interno della meccanica quantistica. Se tutte le grandezze fisiche fondamentali variano in maniera discontinua – argomenta il fisico inglese – forse anche lo spazio-tempo non è caratterizzato da una struttura continua come descritto dalla fisica classica, ma è in qualche modo “quantizzato”. Da tale premessa, egli perviene alla teoria dei “twistori”, nella quale è prevista una struttura geometrica non continua, bensì discreta, posta in relazione allo spin delle particelle elementari. Questa teoria, nelle intenzioni del suo autore, costituisce un tentativo di unificare la meccanica quantistica con la relatività generale.
La concezione della mente umana
Successivamente Penrose ha rivolto la propria attenzione alla mente umana, utilizzando alcuni concetti della meccanica quantistica per giungere a un’ipotesi che lo pone in netta antitesi con le posizioni funzionaliste e, più in generale, con coloro che considerano la mente umana qualcosa di molto simile a un sofisticato computer. Il punto di partenza di Penrose è l’osservazione che i computer portano a termine i compiti assegnati utilizzando procedure e algoritmi predefiniti: la loro attività consiste unicamente nell’esecuzione di operazioni logiche e di calcoli, sulla base di specifiche regole fornite dalla programmazione. L’attività della mente umana, benché in grado di svolgere anche operazioni di questo tipo, si mostra capace di giungere a conclusioni che non sono riconducibili alla mera computazione. A sostegno della sua tesi, Penrose ci propone i seguenti argomenti:
1. Argomento di Gödel
Il teorema di incompletezza di Gödel può essere utilizzato per dimostrare che l’intuizione matematica di cui si servono i matematici per ideare i loro teoremi è una capacità non algoritmica (e quindi non simulabile dalla computazione). Infatti, qualsiasi proceduta algoritmica un matematico usi per giungere a una verità matematica, ci saranno inevitabilmente delle proposizioni matematiche che la sua procedura non sarà in grado di risolvere. Ipotizzando che la mente del matematico funzioni in modo interamente algoritmico, l’insieme degli algoritmi da lui utilizzati non gli permetterebbe di giudicare la validità del sistema usato e quindi dei risultati raggiunti.
2. Problema dell’arresto
E’ il problema per cui, posto di fronte a particolari compiti da svolgere, un sistema puramente computazionale (macchina di Turing), non è in grado di arrestarsi e prosegue indefinitamente la propria attività. Penrose fornisce diversi esempi di problemi matematici a cui una procedura algoritmica appare incapace di dare risposta. Il più semplice di questi è costituito dalla domanda se esista un numero dispari che sia la somma di due numeri pari. Gli esseri umani riescono abbastanza facilmente a giungere alla soluzione, e cioè che non si può mai ottenere un numero dispari dalla somma di due o più numeri pari. Ma come perveniamo a questa conclusione? Non certo effettuando tutte le possibili prove, dal momento che esse sono infinite, bensì ricorrendo alle nostre facoltà intuitive, che ci consentono in qualche modo di “vedere” la verità senza utilizzare procedure algoritmiche. Un computer programmato in funzione di tale compito, invece, continuerebbe ad eseguire operazioni per un tempo illimitato, sulla base degli algoritmi forniti, perché non saprebbe quando fermarsi.
Secondo Penrose, la comprensione matematica (che poi non è altro che un caso particolare della più generale capacità di comprensione della mente umana) non è in alcun modo sovrapponibile a un processo puramente computazionale, basato sull’esecuzione di algoritmi. Lo stesso si può dire della coscienza, della creatività e anche della volontà, che presuppongono attività che non hanno nulla a che vedere con la computazione. I fenomeni che hanno luogo all’interno dei neuroni cerebrali rispondono a leggi ben definite e sono quindi assimilabili a processi computazionali. Pertanto essi non possono essere utilizzati per giungere a una spiegazione adeguata dei fenomeni mentali. Neppure la fisica quantistica ci è di molto aiuto, in quanto aggiunge al determinismo della fisica ordinaria una componente di casualità che si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo. Penrose si dichiara convinto che sia necessaria una nuova teoria fisica prima di compiere autentici progressi nella spiegazione dei fenomeni mentali come la comprensione o la coscienza: “Perché la fisica sia in grado di contenere qualcosa di così estraneo al presente quadro scientifico come il fenomeno della coscienza, ci dobbiamo attendere un mutamento profondo – che alteri le fondamenta stesse delle nostre opinioni filosofiche sulla natura della realtà”. Secondo Penrose, il candidato più probabile per produrre il cambiamento auspicato sembrerebbe essere una teoria quantistica della gravità, ancora da scoprire, che potrebbe gettare nuova luce su fenomeni come la coerenza quantistica o la non località. Detti fenomeni potrebbero essere implicati in comportamenti non computabili che interesserebbero i microtuboli, strutture interne dei neuroni, capaci di favorire le particolari condizioni richieste per il verificarsi di questo tipo di fenomeni.
KARL BARTH

Negli anni della prima guerra mondiale cominciò a delinearsi un’irresistibile crisi della teologia liberale. I drammatici eventi bellici e il correlativo crollo di tutto un preciso mondo spirituale sollecitarono anche teologi e uomini di chiesa a prendere coscienza della problematicità di tante “sicurezze” di ieri: la fede nella ragione, il privilegiamento della prospettiva umanistico-storicistica, l’esistenza di valori etici universali e oggettivi. Nell’ambito più precisamente religioso, questa fase di profonda crisi indusse molti a considerare per più versi superficiale e ottimistica la teologia liberale e a riproporre con nuova drammaticità la limitatezza e la peccaminosità del mondo terreno, l’irriducibilità della trascendenza all’immanenza, la distanza tra l’umano il divino. Alcuni “nuovi” teologi che orientarono la loro riflessione su questi temi vollero definire il loro pensiero “dialettico”, non nel senso hegeliano di un superamento e inveramento degli opposti, ma in quello kierkegaardiano della presenza di una tensione costitutiva e irresolubile tra essi. Un importante centro di riunione e di propaganda della teologia “dialettica” fu la celebre rivista Tra i tempi , il cui titolo voleva alludere al destino di una generazione che sentiva di appartenere allo spazio situato tra un passato ormai morto e un futuro non ancora definibile con certezza. I principali esponenti del gruppo raccoltosi intorno a tale rivista furono: Karl Barth, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen, Emil Brunne. La personalità di maggior rilievo tra i nuovi teologi “dialettici” è indubbiamente Karl Barth (1886-1968). Nato in Svizzera ma formatosi nelle università tedesche, fu allievo tra l’altro di Harnack. Nel secondo decennio del Novecento si allontanò dalle posizioni della teologia liberale. Nel 1919 pubblicò uno scritto sull’ Epistola ai Romani (poi rimaneggiato nel 1922), che nonostante la forma esteriore di semplice commento al celebre testo biblico fu subito considerato un’opera rivoluzionaria per la radicalità delle tesi che vi erano contenute. Il presupposto di fondo dell’ Epistola ai Romani è la duplice convinzione barthiana dell’esistenza di un’insuperabile differenza ontologica tra la creatura e il creatore e della necessità di ridimensionare radicalmente le pretese esplicative del razionalismo filosofico-teologico, ricollocando al centro dell’esperienza umana la dimensione religiosa: anzi, propriamente, la fede. Asserisce Barth: ” Dio è in cielo e tu sei in terra e ciò significa che la linea codificata dalla teologia liberale per unire finito e infinito, uomo e Dio presenta una soluzione di continuità. Quanto alla filosofia, se tende a uccidere (magari per “incerarlo”) l’atteggiamento religioso, e se costituisce la più peculiare forma di riflessione mondana dell’uomo bisognerà saperla mettere, all’occorrenza, risolutamente da parte. ” Già in queste prime tesi è percepibile la ripresa da parte di Barth del pensiero kierkegaardiano, di cui il teologo svizzero fu uno dei principali riscopritori primo-novecenteschi; si è a tal proposito parlato di una “rinascita” di Kierkegaard, a sottolineare che dopo mezzo secolo di oblìo, il filosofo danese torna finalmente sulla scena filosofica. Vicino a Kierkegaard Barth lo è anche nella sua intensa riflessione sull’umano, la sua peccaminosità e la sua finitudine. E’ proprio per tale riflessione che l’opera barthiana è stata considerata una delle più significative sorgenti dell’esistenzialismo europeo ed è stata accostata al pensiero di Heiddeger. Tale interpretazione è giustificata purchè si tengano ben presenti le differenze degli esistenzialisti tedeschi e francesi. E’ ben vero, infatti, che alcune tra le più stimolanti pagine barthiane sono quelle dedicate all’esistenza umana e ai suoi limiti: ma è anche vero che al centro di quelle stesse pagine sta non tanto l’essere umano quanto l’essere divino – o meglio il loro drammatico rapporto. Dio è, in effetti, la “figura” che attraverso la meditazione barthiana torna ad assumere – con tratti di potente originalità – un rilievo assolutamente centrale e predominante nella teologia primo-novecentesca. Dio è, per Barth, lo “sconosciuto”, il ” totalmente Altro “. Dio è alterità assoluta e incolmabile differenza nei confronti di tutto ciò che è umano, e non può pertanto essere conosciuto né come potenza naturale né come forza che sta al di sopra della natura: ogni pretesa di questo tipo è un ” equivoco ” religioso, se non una superstizione, e si adatta a compromessi mondani. Bisogna rinunciare alla religione, la cui funzione consolatoria ha solo aiutato l’uomo a mettere fra parentesi la sua drammatica situazione, segnata dal ‘no’ che Dio rivolge a lui e al mondo. Ciò implica che l’unica possibilità è riscoprire la fede, mantenendosi aperti alla speranza dialettica che proprio l’estremo della negazione si converta nel ‘sì’ divino: ” Dio è il Dio sconosciuto. Come tale egli dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Perciò la sua potenza non è né una forza naturale né una forza dell’anima, né alcuna delle più alte o altissime forze che noi conosciamo o che potremmo eventualmente conoscere, né la suprema di esse, né la loro fonte, ma la crisi di tutte le forze, il totalmente Altro, commisurate al quale esse sono qualche cosa e nulla, nulla e qualche cosa, il loro primo motore e la loro ultima quiete, l’origine che tutte le annulla, il fine che tutte le fonda.[…] L’uomo si trova in questo mondo in prigione. Una riflessione alquanto profonda non può concedersi nessuna incertezza sulla limitazione delle nostre possibilità che sono qui e ora a nostra disposizione. Ma noi siamo più lontani da Dio, la nostra decezione da lui è più grande e le sue conseguenze sono sempre ancora più vaste di quante ci permettiamo di pensare. L’uomo è signore di se stesso (Letteraai romani). Dio non costituisce, come per la metafisica classica, la genesi e il fondamento delle cose. Il suo essere sta infatti “al di là” di tutte le forze, le origini e i fini. La sua “potenza” è ” autosufficiente, incondizionata e in sé vera “: essa è ” l’assolutamente nuovo “. Cercare Dio nelle sue creazioni, presumere di salire a lui lungo gli “itinerari” descritti dalla teologia e dalla morale antica e moderna è pura follia: anche perché ” concepire questo mondo nella sua unità con Dio è colpevole di arroganza religiosa “. Dinanzi a questo Dio “totalmente Altro”, l’uomo non può per Barth affidare le sue possibilità di salvezza né alla conoscenza razionale, né al progresso storico, bensì solo alla fede, sulla quale Barth ha scritto alcune delle pagine più intense del Novecento: ” La fede è questo: il rispetto dell’incognito divino, l’amore di Dio nella coscienza della differenza tra Dio e l’Uomo, tra Dio e il mondo, l’affermazione del ‘No’ divino in Cristo, il fermarsi, turbati, davanti a Dio […]. La fede è la conversione, il radicale nuovo orientamento dell’uomo che sta nudo davanti a Dio, che per acquistare la perla di gran prezzo è diventato povero e che per amore di Cristo è pronto a perdere la sua anima […]. La fede non è mai compiuta, mai data, mai assicurata, è sempre e sempre di nuovo, dal punto di vista della psicologia, il salto nell’incerto, nell’oscuro, nel vuoto […]. Non vi è nessuna presupposizione umana (pedagogica, intellettuale, economica, psicologica, ecc..) che debba essere adempiuta come preliminare della fede […]. La fede è sempre l’inizio, la presupposizione, il fondamento. Si può credere come Galileo e come Greco, come fanciullo e come vegliardo, come uomo colto o come ignorante, come uomo semplice e complicato, si può credere nella tempesta e nella bonaccia, si può credere a tutti i gradini di tutte le immaginabili scale umane. L’energia della fede interseca trasversalmente tutte le differenze della religione, della morale, delle condotta e dell’esperienze della vita, della penetrazione spirituale e della posizione sociale. La fede è per tutti altrettanto facile e altrettanto difficile. ” Negli anni seguenti Barth tempererà in certa misura le proprie posizioni. Pur non rinunciando al principio della trascendenza divina e della condanna di ogni antropocentrismo in campo filosofico-teologico, egli vorrà aprire qualche strada nuova all’impegno storico-razionale dell’uomo e dell’azione della Chiesa. Vorrà, soprattutto, istituire qualche mediazione tra l’umano e il divino, il peccato e la grazia, la finitudine e l’infinito. Tale orientamento è accertabile nella Dogmatica ecclesiale , il cui primo volume uscì nel 1932 e che ha esercitato una profonda influenza nell’intero mondo cristiano. Significativi in questa stessa prospettiva i saggi Comunità cristiana e comunità civile (1946), Umanesimo (1950), L’umanità di Dio (1956) e Introduzione alla teologia evangelica (1962). Il testo più suggestivo di Barth resta peraltro proprio l’ Epistola ai Romani , che ha continuato ad affascinare intere generazioni di lettori. La radicale messa in questione di certezze secolari, la drammatica accentuazione della limitatezza e della costitutiva colpa dell’uomo, e soprattutto l’interpretazione della fede come senso del limite dell’oltre, come contestazione di tutti i valori e le opere terrene, come continuo scandalo e paradosso per le coscienze quiete e le anime belle, come imprevista e sconvolgente possibilità di rigenerazione spirituale per ogni essere umano, indipendentemente dalla sua razza, ceto e convinzioni: questo sono le principali componenti di un messaggio tra i più alti della meditazione religiosa del Novecento.
RUDOLF BULTMANN

Vicino in un primo tempo alle posizioni di Karl Barth, il tedesco Rudolf Bultmann (1884-1976), autore di ” Credere e comprendere ” (in quattro volumi, 1933-1965), si discosta ben presto dalla teologia dialettica nell’intento di ripensare quanto di positivo aveva comunque espresso quella liberale. Egli muove dal fondamentale postulato barthiano, quello dell’assoluta trascendenza di Dio rispetto al mondo e all’uomo, ma la domanda che regge tutta la sua riflessione teologica verte su come, in tale condizione, l’uomo possa recepire e far propria la parola di Dio donatagli nella rivelazione. La risposta di Bultmann poggia sugli strumenti concettuali tratti dall’esistenzialismo e, soprattutto, dall’analitica esistenziale di Heidegger: l’uomo può comprendere la parola di Dio poiché vi è in lui una ” precomprensione dell’esistenza ” che costituisce la base della sua apertura al Dio che lo interpella e, quindi, all’esperienza di fede. Però, affinchè ciò sia possibile, è necessario, secondo Bultmann, che la parola di Dio sia liberata dalle concezioni mitologiche risalenti all’epoca in cui essa è stata fissata per iscritto, in modo da poter essere presentata nella sua genuinità all’uomo di oggi, per il quale l’elemento mitologico è divenuto estraneo e incomprensibile. E’ questo il metodo della demitizzazione , che intende liberare il messaggio cristiano dalle forme di cui è esteriormente rivestito nelle Sacre Scritture, non per smentire queste ultime, ma per far emergere il significato universale che sottende le rappresentazioni contingenti e relative alla determinata civiltà che le ha espresse. Si tratta di recuperare la dimensione autentica ed essenziale della Scrittura, accessibile ad ogni uomo nella chiarificazione della sua esistenza, in modo da poter accedere a una fede criticamente depurata e indipendente dalla sua particolare collocazione spazio-temporale. Occorre perciò, in primo luogo, operare una distinzione tra il vero contenuto della fede e i simboli attraverso cui essa è stata tramandata, sia nelle prime comunità cristiane (con i relativi influssi di marca ellenistica), sia nelle epoche successive, come durante il Medioevo; si deve cioè riconoscere come mitica (e quindi spuria) ogni rappresentazione che costringa il divino in categorie umane e mondane immanentizzando la trascendenza e abbassando a fatto puramente umano la redenzione di Cristo. Lo stesso vale per la tradizionale concezione del miracolo come azione del sovrannaturale nella storia, per le visioni apocalittiche della fine del mondo o del giudizio finale (comuni, del resto, a molte religioni non cristiane), o anche per molte verità dogmatiche espresse in forme che ne velano il genuino contenuto di fede. Per cogliere quest’ultimo è necessario che l’uomo, rivolgendosi ai testi sacri, sia animato da un’attiva precomprensione del problema di Dio, la cui mancanza rende muto il rapporto e impossibile la relazione tra la domanda dell’uomo e la risposta dei testi: ” la demitizzazione vuol mettere in risalto l’autentica intenzione del mito, cioè quella di parlare dell’esistenza umana, del suo essere fondata e limitata da una potenza dell’aldilà non mondana, una potenza che non è percepibile dal pensiero oggettivamente. In senso negativo, quindi, la demitizzazione è una critica dell’immagine del mondo propria del mito, nella misura in cui essa nasconde la vera intenzione del mito stesso. In senso positivo è un’interpretazione esistenziale, con cui si vuol chiarificare l’intenzione del mito, che è precisamente quella di parlare dell’esistenza dell’uomo ” (“Nuovo Testamento e mitologia”, app. I). Ciò riporta in piena luce il legame tra teologia e filosofia, nelle norme che Bultmann considera più atta a illuminare il problema della precomprensione, cioè l’esistenzialismo di Heidegger, soprattutto laddove egli esamina le nozioni di “esistenza inautentica” e “esistenza autentica”: la prima è per Bultmann la via del peccato, giacchè in essa l’uomo si appiattisce sull’oggettività e sulla manipolazione dell’essere, e non è aperto a una realtà suprema che lo interpella; mentre nella seconda si dà l’apertura all’inoggettivabile, all’appello dell’Altro, all’evento dell’incontro con Dio. E così l’esistenza autentica può accedere al significato più proprio (e quindi autentico) della predicazione di Gesù, che è appunto un richiamo a mantenersi aperti alla rivelazione di Dio in ciascuno. Ma perché l’uomo possa passare dall’esistenza inautentica a quella autentica (ed è questo ciò che la teologia aggiunge alla semplice analitica esistenziale) la filosofia non è sufficiente e le forze umane non bastano, dal momento che si tratta di una ” conversione ” che può essere operata soltanto dall’amore di Dio attraverso Cristo. La piena realizzazione dell’esistenza autentica è dunque l’incontro con Cristo, che non avviene sulla base di una conoscenza meramente storica, che è sempre di tipo oggettivante, bensì solamente nell’esperienza esistenziale della fede. Il “Gesù storico” è infinitamente meno importante del “Cristo della fede”, che non ha alcun bisogno di essere “ricostruito” nella sua realtà mondana e temporale, giacchè si rivela nell’interiorità di ciascuno a cui voglia manifestarsi. Sulla base di tutto questo si comprende la netta preferenza di Bultmann per il quarto Vangelo, quello più libero da elementi mitologici e più aperto ad una comprensione universalmente filosofica della figura di Cristo: la dottrina del Logos ” che brilla nelle tenebre ” può fruttuosamente incontrarsi con l’idea della precomprensione del divino, con l’istanza esistenziale della decisione di accoglierlo o negarlo, e quindi di accettare o di rifiutare il senso della nostra esistenza.
THOMAS KUHN

IL PENSIERO
L’ impostazione fornita da Popper al problema della conoscenza scientifica ha portato l’ attenzione sul suo processo di crescita attraverso la dinamica della formulazione e della critica delle teorie. Dal che è emersa la consapevolezza che per comprendere la natura della conoscenza scientifica non è sufficiente esaminare la struttura logica interna delle teorie, ma bisogna investigare anche il modo in cui esse si sono affermate o sono state abbandonate nel corso della storia: di qui la necessità di intrecciare la considerazione epistemologica con la storia della scienza. Questa impostazione ha avuto risonanza soprattutto grazie all’ opera del filosofo statunitense Thomas Kuhn (nato a Cincinnati nel 1922 e morto nel 1996), intitolata La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962). Professore di storia della scienza all’ università di Princeton, e autore di un volume su La rivoluzione copernicana (1957), Kuhn si è reso conto che il cammino della scienza procede non per accumulazioni, secondo una crescita continua, ma attraverso rivoluzioni . Le rivoluzioni, però, rappresentano soltanto momenti di eccezione rispetto a quella che egli chiama scienza normale , ossia una pratica di ricerca ” stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costruire il fondamento della sua prassi ulteriore “. La scienza normale è, dunque, caratterizzata da un consenso sulla validità di questi risultati, i quali vengono ad assumere la veste di paradigmi , ossia di modelli che determinano quali sono i problemi e i metodi legittimi e danno, quindi, origine e tradizioni di ricerca scientifica: tali sono, per esempio, l’ astronomia tolemaica o quella copernicana o la meccanica newtoniana. I paradigmi non sono regole rigide, ma devono avere due caratteristiche: devono essere abbastanza nuovi da attrarre un gruppo stabile e sufficientemente ampio di seguaci, distogliendoli da forme di attività scientifica che contrastino con essi e devono essere abbastanza aperti da consentire di risolvere altri problemi. La scienza normale, che si costituisce su questa base, più che mirare a produrre novità, cerca di risolvere rompicapo (puzzles) entro le procedure riconosciute. Essa è opera collettiva e cumulativa: estende la conoscenza dei fatti che il paradigma indica come particolarmente rivelatori, confrontando i fatti con la teoria , e procede ad articolare ulteriormente il paradigma mediante esperimenti. Contrariamente a quanto sostiene Popper, gli scienziati, stando a Kuhn, normalmente non si dedicano a controlli severi delle teorie. Questo può cominciare quando sorgono novità insospettate, che si presentano come anomalie rispetto al paradigma: tale per esempio è stata la scoperta dell’ ossigeno. Kuhn considera un luogo comune, privo di consistenza storica, l’ idea che una teoria sia invalidata mediante un suo confronto diretto con fatti o osservazioni e che questo conduca al suo abbandono. In realtà, i mutamenti di più vasta portata emergono soltanto con l’ invenzione di nuove teorie, in quanto una teoria che ha raggiunto lo stato di paradigma viene riconosciuta invalida soltanto se esiste un’ alternativa disponibile. Così è avvenuto, per esempio, per il sistema tolemaico con la nascita di quello copernicano. Solo in questi momenti avviene una crisi e una rivoluzione, ossia la sostituzione di un paradigma con uno nuovo. In tal modo, Kuhn respinge ogni concezione della storia come processo continuo di assorbimento e ampliamento dei risultati precedenti; egli considera, pertanto, la teoria della relatività di Einstein e il sistema di Newton incompatibili, in quanto paradigmi che ” dicono cose differenti sugli oggetti che popolano l’ universo e sul comportamento di tali oggetti “. Il che significa che il mutamento di paradigmi non riguarda soltanto singoli settori, ma comporta una trasformazione dell’ intera struttura concettuale, con la quale gli scienziati guardano il mondo. Questa transizione non è istantanea; in analogia con le rivoluzioni politiche, Kuhn mette in rilievo che tra i paradigmi s’ ingaggia una lotta e che la scelta di uno di essi non è mai risolvibile soltanto facendo ricorso alle argomentazioni logiche e all’ esperimento. Essa comporta, infatti, una decisione su quali problemi sia più importante risolvere e questo implica un riferimento a valori. La vittoria di un paradigma dipenderà, allora, dalla sua forza persuasiva nell’ ottenere il consenso della comunità scientifica. All’ opera di Kuhn sono state mosse accuse di relativismo e irrazionalismo, in quanto elimina la verità e la discussione razionale come criteri determinanti nella scelta tra le teorie. Da esse, Kuhn ha tentato di difendersi in vari saggi raccolti in La tensione essenziale (1977). Egli ha continuato a ribadire l’ incommensurabilità fra le teorie, che guardano il mondo diversamente e usano le stesse parole in modo diverso, ma indicano vari criteri non arbitrari di scelta fra le teorie, quali l’ accuratezza, la coerenza, la semplicità, la fruttuosità. Su questa base, egli ha riconosciuto la legittimità di parlare di progresso scientifico , ma con l’ avvertenza che, come avviene nella teoria darwiniana dell’ evoluzione, tale progresso deve essere misurato non rispetto a un fine prefissato, ma rispetto a quel che precede: il progresso consiste nell’ allontanamento da stadi più primitivi, meno ricchi e meno complessi, di ricerca. Dopo La struttura delle rivoluzioni scientifiche , che è stato uno dei libri più recensiti e più discussi nella filosofia del Novecento, Kuhn non solo ha scritto altri libri importanti ma in un dialogo serrato con i maggiori filosofi della scienza, ha approfondito e modificato i suoi iniziali punti di vista. Kuhn, fino dal 1957, pose mano all’ambizioso progetto di introdurre nella filosofia e nella cultura del secondo Novecento una nuova immagine della scienza. Se la storia della scienza, scriveva allora, non fosse più considerata un deposito di aneddoti, potrebbe produrre una trasformazione decisiva nell’immagine della scienza dalla quale siamo dominati. La storia alla quale pensava Kuhn non doveva più ” rispondere a domande formulate in base agli stereotipi antistorici ricavati da manuali scientifici “, doveva richiamarsi allo stile e al tipo di approccio ai problemi presenti in grandi storici come Alexandre Koyré e Arthur Lovejoy. I concetti scientifici – troviamo scritto ne La rivoluzione copernicana – ” sono idee e come tali sono oggetto della storia del pensiero “. Lo storico, affermava ancora Kuhn, ” deve acquisire un lessico che in alcuni punti differisce sistematicamente da quello corrente al suo tempo “. Come il suo fratello-nemico Paul K. Feyerabend, Thomas Kuhn era una mente libera. A entrambi la storia apparve come ” una realtà più ricca di contenuto, più varia, multilaterale, viva, astuta di quanto anche il migliore storico e il migliore epistemologo non riescano a immaginare “. Nel caso di Kuhn, è la storia della scienza ad offrirsi come luogo di confronto delle tesi epistemologiche: la storia doveva essere considerata “come qualcosa di più che un deposito di aneddoti o una cronologia”, si diceva in La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), non poteva ridursi a serbatoio di esempi che confermassero l’immagine del progredire del sapere per congetture e confutazioni (del resto, proprio Popper ci ha spiegato che chi cerca conferme le trova sempre). La scienza dimentica facilmente il proprio passato, tende ad interpretarlo alla luce del presente, sulla base del “paradigma” del giorno; si finisce così per veicolare l’idea che la scienza proceda in modo lineare e cumulativo, da antichi precursori a futuri eredi. Ma, se proviamo a leggere gli scritti scientifici del passato inseguendone la coerenza interna e nel loro contesto culturale, scopriamo che non sempre gli antichi concetti si riferivano alle stesse realtà a cui si rivolgono oggi. E’ come se, prima di Copernico o di Einstein, si guardasse il mondo in modo diverso da oggi, si vedesse un’anatra là dove noi vediamo un coniglio, per riprendere la figura ambigua, resa nota dagli studiosi della Gestalt e ripresa nelle Ricerche filosofiche di Wittgenstein. Proprio questi mutamenti percettivi, questi slittamenti di significato, ci impongono di riconoscere l’esistenza di rivoluzioni scientifiche: la storia delle scienze è percorsa da fratture, da discontinuità, e la variazione di un paradigma trasforma i fatti stessi presi in considerazione (l’energia e la materia non sono più la stessa cosa dopo Einstein). Non esiste dunque una base comune, un identico mondo osservabile, che possa fungere da terreno di confronto fra le teorie; dall’attenzione filologica alla storia delle scienze emergeva così quella nozione di incommensurabilità fra teorie o paradigmi, a cui negli stessi anni giungeva Feyerabend. Gran parte della riflessione successiva di Kuhn, fino alla morte nel 1996, cercherà di chiarire tale nozione, come attestano i saggi raccolti in Dogma contro critica, due dei quali risalgono ai primi anni Sessanta, gli altri agli anni Ottanta e Novanta. Il libro (con prefazione di Paul Hoyningen-Huene, a cura di Stefano Gattei, edito da Cortina) comprende anche due lettere in cui un Feyerabend ancora popperiano commenta le bozze della Struttura delle rivoluzioni scientifiche: ci viene così restituito il dialogo che avrebbe dovuto svolgersi al Bedford Colloquium del 1965 (il convegno da cui avrà origine il volume ormai classico Critica e crescita della conoscenza Feltrinelli), in cui all’intervento di Kuhn, “Dogma contro critica”, avrebbe dovuto seguire quello di Feyerabend (assente per motivi di salute), dal titolo rovesciato, “Critica contro dogma”. Le obiezioni di Feyerabend scivolano spesso dall’ambito teorico a quello in senso lato politico, anche col ricorso alla nozione marxiana di ideologia; da esse emerge l’immagine di Kuhn come indagatore della “scienza normale” più che di teorico delle rivoluzioni, un’immagine che le opere successive (si veda in particolare il saggio che dà il titolo alla raccolta La tensione essenziale, Einaudi) finiranno per confermare. Il “necessario preliminare” alla rivoluzione kuhniana è il dogmatico rispetto delle norme accolte dalla comunità, l’osservanza rigorosa di un paradigma che caratterizza la scienza normale: “lo scienziato produttivo, per essere un innovatore …, deve essere un tradizionalista cui piace giocare complicati giochi secondo regole prestabilite”. La garanzia del successo delle comunità scientifiche è la resistenza al nuovo, l’adesione al “pensiero convergente”: la spregiudicata ricerca della verità, il “pensiero divergente”, flessibile e critico, assolve la sua funzione nella fase rivoluzionaria, ma solo l’accettazione di quanto appreso nel corso dell’addestramento professionale consente di scorgere quali anomalie intaccano le teorie dominanti. Le discontinuità che spezzano la linearità apparente del cammino delle scienze sorgono solo sullo sfondo di una tradizione di ricerca consolidata; come nel lessico della teoria delle catastrofi di Thom, è la stabilità strutturale a preparare il terreno della morfogenesi. Per Kuhn, è l’abbandono del discorso critico a segnare la transizione alla scienza matura, nella quale si è formata una ortodossia indiscussa; per Feyerabend, solo disponendo di paradigmi alternativi le anomalie diventano avvertibili. Meglio dunque la proliferazione di teorie che possano reciprocamente criticarsi piuttosto della “normalità” di un consenso dogmatico; “rivoluzione permanente” è lo slogan con cui Feyerabend, radicalizzando l’ideale dei controlli critici di Popper, si avviava a far scivolare il criterio liberal della proliferazione di concezioni verso l’anarchismo del “tutto va bene”. La “società chiusa” degli scienziati normali appare incompatibile con la società libera (o aperta), che dovrebbe fare della città della scienza il modello della democrazia; per il Feyerabend popperiano di quegli anni la falsificabilità o controllabilità resta comunque il criterio per distinguere fra scienza e follia, fra adesione critica e dogmatismo. I saggi raccolti in Dogma contro critica permettono inoltre di apprezzare un significativo mutamento nella scatola degli attrezzi kuhniani: il lessico della psicologia (gestaltica o piagetiana) e della sociologia cede il passo a quello della linguistica e della critica letteraria (anche per la vicinanza con Noam Chomsky, al Mit di Boston, dove Kuhn insegna dal ’79). Se i paradigmi forniscono i filtri, gli a priori della conoscenza (era proprio Kuhn a proclamarsi “un kantiano con categorie mobili”), l’incommensurabilità non è più conseguenza dei modi diversi di percepire il mondo, ma dell’adozione di differenti vocabolari concettuali: diviene una sorta di intraducibilità. Le rivoluzioni mutano la struttura lessicale, e dunque cambiano i sistemi di classificazione, la tassonomia utilizzata dagli scienziati; gli oggetti vengono ridistribuiti secondo categorie differenti, la Terra e la Luna entrano in nuove relazioni di somiglianza dopo Copernico, la caduta dei gravi entra in nuovi insiemi di fenomeni dopo Galileo. Pur non esistendo una possibilità completa di traduzione, la comunicazione fra paradigmi resta garantita da una condizione analoga al bilinguismo: “lo storico diventa bilingue”, consapevole che per alcuni termini non si dà traduzione ottimale, che bisogna ricorrere a perifrasi, ad imperfette corrispondenze. Dalla storia delle scienze Kuhn entra così in un labirinto teorico su cui la filosofia, in particolare di tradizione analitica, si è a lungo soffermata negli ultimi decenni, basti pensare a Putnam e a Quine. Lo storico delle scienze è un narratore che deve dare inizio al suo racconto preparando la scena, cioè descrivendo le convinzioni e specificando il vocabolario degli attori del passato; “come gli altri insegnanti di lingue”, lo storico deve affrontare problemi di traduzione, nella consapevolezza che nelle scienze, come in letteratura, le difficoltà di traduzione hanno la stessa causa, cioè l’incapacità del linguaggi di conservare le relazioni strutturali fra le parole. Cambiando lingua, mutano anche le relazioni fra le cose. Era Kuhn stesso a proclamarsi sostenitore di un “kantismo postdarwiniano”. Popper utilizzava la metaforica darwiniana della competizione e della selezione per spiegare l’evoluzione delle teorie scientifiche. Il Kuhn degli anni ottanta appare contemporaneo della teoria degli equilibri punteggiati: sviluppo scientifico ed evoluzione biologica condividono lo stesso modello, uno schema di ramificazione ad albero, dove l’aspetto rilevante non è il processo di mutazione, ma quello di speciazione. Gli episodi rivoluzionari sono spesso associati ad un incremento delle specializzazioni nella scienza; i fatti sono interpretati secondo una grana via via più fine, grazie ad una struttura lessicale più minuziosa, ma il rischio è di rinchiudersi in nicchie sempre più isolate. Il progresso nella scienza è sempre accompagnato da una perdita, da un restringimento di settori e competenze, che limita la comunicazione; ma tale progresso non è un cammino verso la verità, un crescente approssimarsi alla corrispondenza con la realtà. Possiamo dire soltanto a partire da che cosa procediamo; la kantiana cosa in sé resta inconoscibile.
LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE
In La struttura delle rivoluzioni scientifiche Kuhn scrive:
La transizione da un paradigma in crisi ad uno nuovo, dal quale possa emergere una nuova tradizione di scienza normale, è tutt’altro che un processo cumulativo, che si attui attraverso un’articolazione o un’estensione del vecchio paradigma. […]Questi esempi ci guidano verso il terzo e più fondamentale aspetto dell’incommensurabilità tra paradigmi in competizione. In una maniera che sono incapace di spiegare ulteriormente, i sostenitori di paradigmi opposti praticano i loro affari in mondi differenti. […] I due gruppi di scienziati vedono cose differenti quando guardano dallo stesso punto nella stessa direzione. Ciò però, vale la pena ripeterlo, non significa che essi possano vedere qualunque cosa piaccia loro. Entrambi guardano il mondo, e ciò che guardano non cambia. Ma in alcune aree essi vedono cose differenti, e le vedono in differenti relazioni tra loro. […].Per la stessa ragione, prima che possano sperare di comunicare completamente, uno dei due gruppi deve far l’esperienza di quella conversione che abbiamo chiamato spostamento di paradigma. Proprio perché è un passaggio tra incommensurabili, il passaggio da un paradigma ad uno opposto non può essere realizzato con un passo alla volta, né imposto dalla logica o da un’esperienza neutrale. Come il riordinamento gestaltico, esso deve compiersi tutto in una volta (sebbene non necessariamente in un istante), oppure non si compirà affatto. […] Il trasferimento della fiducia da un paradigma a un altro è un’esperienza di conversione che non può essere imposta con la forza.
LA SCIENZA NORMALE E IL PARADIGMA
In La struttura delle rivoluzioni scientifiche Kuhn scrive:
In questo saggio, ‘scienza normale’ significa una ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua prassi ulteriore. […] La Fisica di Aristotele, l’Almagesto di Tolomeo, i Principia e l’Ottica di Newton, l’Elettricità di Franklin, la Chimica di Lavoisier e la Geologia di Lyell e molte altre opere servirono per un certo periodo di tempo a definire implicitamente i problemi e i metodi legittimi in un determinato campo di ricerca per numerose generazioni di scienziati. […] D’ora in avanti, per indicare i risultati che hanno in comune queste due caratteristiche, userò il termine ‘paradigmi’, che ha una precisa relazione col termine ‘scienza normale’. […] Coloro la cui ricerca si basa sui paradigmi condivisi dalla comunità scientifica si impegnano ad osservare le stesse regole e gli stessi modelli nella loro attività scientifica.
LA CRISI E L’EMERGERE DI NUOVE TEORIE
In La struttura delle rivoluzioni scientifiche Kuhn scrive:
Si consideri innanzitutto un caso particolarmente famoso di mutamento di paradigma: la nascita dell’astronomia copernicana. Quando la teoria precedente, il sistema tolemaico, fu sviluppata per la prima volta nel corso degli ultimi due secoli prima di Cristo e dei primi due dopo Cristo, esso riusciva meravigliosamente a prevedere le mutevoli posizioni sia delle stelle che dei pianeti..[…] Fin dall’inizio del XVI secolo, i migliori astronomi d’Europa in numero sempre crescente riconoscevano che il paradigma dell’astronomia non era riuscito a risolvere i suoi problemi tradizionali. Questo riconoscimento preparò il terreno sul quale fu possibile a Copernico abbandonare il paradigma tolemaico ed elaborarne uno nuovo. La sua famosa prefazione costituisce ancor oggi una descrizione classica di uno stato di crisi. […] In una scienza matura […] dei fattori esterni come quelli citati sopra sono importanti soprattutto nel determinare il momento in cui scoppierà la crisi, la facilità con cui essa può venire riconosciuta e l’area in cui si manifesterà per la prima volta l’insuccesso, data la particolare attenzione che essa riceve.
NIKOS KAZANTZAKIS (ΝΊΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΆΚΗΣ)

A cura di Haris Papoulis
“Veniamo da un abisso oscuro; ritorniamo in un abisso oscuro. Lo spazio luminoso che intercorre tra di loro lo chiamiamo vita. Appena nati inizia il nostro ritorno; contempora-neamente l’inizio e il ritorno; ogni attimo moriamo. Per questo molti hanno protestato: lo Scopo della vita è la morte. “
I PARTE
L’ interesse degli studiosi, delle case editrici europee, e in particolare di quelle italiane, intorno agli autori greci, si esaurisce – per la maggior parte – nell’ antichità. Una strana, e certamente errata, separazione voluta da una tradizione prettamente anti-ortodossa (e non anti-greca in generale) vuole che si veda nella Grecia antica il culmine della civiltà occidentale, mentre la cultura della Grecia moderna viene considerata un frutto tipicamente orientale. La Grecia moderna, e in particolare la sua letteratura, paga un debito per la sua “resistenza” linguistica all’ omogeneità delle lingue latine. Ci sono mille fattori che possono farci comprendere a pieno perchè un grande autore come Kazantzakis (1883-1957) rimanga sconosciuto in Italia, paese da lui amato così tanto da portare il suo patrimonio letterario in Grecia. Infatti tradusse nel 1932 la Divina Commedia in soli 45 giorni nella metrica greca della “terza rima”. Inoltre scrisse “Il poverello di Dio” in cui presenta il suo grande ideale San Francesco come il simbolo dell’ uomo. Nel suo ultimo libro autobiografico (“Riferimento al Greco”) effettuò una particolareggiata descrizione del suo amore per Assisi e per l’ Italia. Ultima menzione di testi riguardanti questo paese e da rivolgere ai testi “Viaggiando in Italia”, “Questa sera si recita a soggetto”, traduzione dell’ opera di Pirandello e “Il Principe” di Machiavelli. Ma nulla può giustificare l’ abbandono nell’ oblio delle sue, ormai rare, edizioni italiane, come la sua fedeltà alla sua lingua madre. E parlo di fedeltà perchè avrebbe potuto scrivere agevolmente anche in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano o Russo. E, quando i suoi scritti furono vietati dal potere della chiesa ortodossa negli anni ’50 (ma anche prima), lo fece con la circolazione del suo libro – che più tardi ispirerà Martin Scorsese per l’ omonimo film – L’ ultima tentazione del Cristo. Nonostante tutto egli continuò a scrivere in Greco, probabilmente portando con sè questo vecchio consiglio dei suoi -e di tutti gli anziani che vedevano i loro figli emigrare in Europa- “stai attento figlio mio, dovunque andrai, non diventare Franco”. Ed egli è stato EllhnaV fino alla sua morte. EllhnaV vero perchè ha offerto la sua mente, “l’ unico laboratorio che aveva per trasformare le tenebre in luce”, alla sua missione : trovare un punto d’incontro tra il “Franco” Nietzsche e il Buddha, tra il “Franco” S.Francesco e Alessandro Magno. Di questo splendido greco, che ha scritto su tutto e di tutto, che dovrebbe essere onorato dal paese che lui onora con le sue “terze rime”, ora non si ha neanche a disposizione una copia dei suoi innumerevoli libri. Io posso soltanto scrivere questo piccolo, ma spero significativo, saggio per presentare il suo pensiero. Pensiero che, grazie alla sua pregnanza di significato, può divenire un punto di riferimento per tutti noi, anche se impossibilitati nella lettura diretta dei suoi scritti.
II PARTE
Nel 1954 il Pontefice della Chiesa Cattolica mise “L’ultima tentazione” nell’ Index Dei Libri Vietati. In risposta soltanto una frase telegrafata da Kazantza-kis, ripresa dall’ apologetico Tertulliano : “ Ad tuum, Domine, tribunal appello”. Come dice Luciano Canfora, “la storia del libro è soprattutto la storia della sua distruzione”. In questo senso si possono leggere i divieti o i rifiuti di pubblicazione dei suoi scritti, il fatto che per due voti non entrò nell’ Accademia Greca, la perdita del premio Nobel nel ‘56 e il gesto, sintomo di odio o di stupidità, della chiesa ortodossa, che non ha permesso l’ esposizione della sua salma ad Atene. Tutto ciò va a edificare il mito di un intellettuale che ha dedicato la sua intera vita allo scrivere. Ma in fondo non è il rifiuto che lo rende grande ma le sue stesse opere. Ha scritto, con ardore e costanza, saggi, opere teatrali, traduzioni, racconti storici e qualsiasi altro genere letterario. Alcuni anni fà ho letto in un articolo di giornale che un gruppo di filologi, volendo pubblicare le sue opere complete, si sono resi conto che il suo corpus letterario oltrepassa i cento volumi (!). I suoi libri sono tradotti in quarantacinque lingue. Intorno alle sue opere si è svolta anche una intensa produzione di film. “L’ ultima tentazione del Cristo” di M.Scorsese, “Zorba il Greco”, con l’ interpretazione di Anthony Quinn, e “Il Cristo di nuovo in Croce” (Celui qui doit mourir-Colui che deve morire), realizzato per il festival di Cannes in lingua Francese. Ma quale è il significato più profondo della sua opera? Ecco cosa scrive nel suo diario : “Tutta la mia opera Devise e questo scopo ha: “Come l’ uom s’ etterna” (Inferno, Dante, XV,85)”. Tante volte mi è capitato di essermi stupito di fronte alle opere grandiose dei grandi spiriti umani. Nessuna di queste è però paragonabile alla meraviglia che ho provato prendendo in mano la sua “Odissea” e leggendo mille volte la sua “Ascetica” . E da discutere chi sia più geniale tra lui e Omero. Questo perchè la fama e il lavoro di Omero sono giunti fino a noi con la proteziene dell’autorità della tradizione. Guardando le idee di Eraclito, i palazzi di Knosos, l’Acropoli o l’oracolo di Delfi non mi sembra affatto strano che un uomo abbia cantato queste opere uniche. Ma lo spirito di un uomo che nel ’38 scrive 33.333 rime per celebrare un Ulisse che, annoiato dalla quiete familiare e dalla patria, parte di nuovo, mi fa dubitare delle ragioni della fama dell’ autore antico. Riguardo all’ “Ascetica” posso affermare che è l’espressione lampante dell’acume di Kazantzakis. E’ costituita da sole 100 pagine ma rachiude la sapienza di 100 libri. E’ veramente una guida preziosa all’ esercizio filosofico. Vi è riassunto tutto il percorso dello spirito umano, unificando il materialismo estremo all’idealismo romantico, favorendo il progresso dell’uomo, la vita come lotta contro la finitezza che non può accettare etichette nè limitazioni, tipiche di ogni corrente filosofico. E’ un manuale di Guerra in senso Eracliteo, e un manuale di Pace in senso Bubbhista. Mio proposito è di presentare questo libro tentando di avvicinarmi alle intenzioni che muovevano lo stesso Kazantzakis, di far sì che, grazie alla letteratura, i popoli si avvicinino e testi come questo divengano armi contro l’ignoranza, l’indifferenza, l’obbedienza e ogni forma di malattia culturale.
III PARTE
“Veniamo da un abisso oscuro; ritorniamo in un abisso oscuro. Lo spazio luminoso che intercorre tra di loro lo chiamiamo vita. Appena nati inizia il nostro ritorno; contempora-neamente l’inizio e il ritorno; ogni attimo moriamo. Per questo molti hanno protestato: lo Scopo della vita è la morte.” Così Kazantzakis apre la sua “Ascetica” (Esercizio Mistico), facendoci immediatamente capire il suo modo di filosofare: astratto e contemporaneamente concreto, come concreta è la vita stessa nella sua astrattezza. E’ questo il suo operato: mettere insieme gli opposti; vincere le diversità e arrivare al punto esatto in cui inizio e fine si uniscono, in cui il ciclo si compie, cambiando e rimanendo sempre uguale a se stesso. “Ma appena nati inizia lo sforzo di creare, di comporre, di plasmare la materia vita; ogni attimo nasciamo. Per questo molti hanno protestato: lo Scopo della nostra effimera vita è l’immortalità.” Questo è lo schema antitetico, tipico dell’autore, capace di racchiudere in sé entrambe le tendenze del nostro pensiero, o, se vogliamo, entrambe le manifestazioni del Divenire. Il suo parlare prima di morte e poi di immortalità non ha un significato particolare. Non vuole lasciare la parola immortalità a risuonare come fosse un’eco. Potrebbe valere in ogni caso anche il contrario. Questo ragionamento non è privo di importanza. La duplicità delle idee non è uno schema letterario per lasciar “vincitrice” l’Immortalità; infatti l’equivalenza dei due termini nel divenire si manifesta subito dopo, con l’inversione conseguente-mente necessaria delle posizioni delle due parole: “Negli esseri viventi contingenti queste due tendenze configgono: A) la salita verso la composizione, la vita , l’immortalità; B) la discesa verso il disfacimento, la materia, la morte. ” Tutto torna al suo posto, il ciclo sembra conclusosi. Proseguendo la lettura, Kazantzakis si domanda quale sia la nostra posizione, con la morte o con l’immortalità? Definisce tutte e due le correnti “Sante”. Quindi termina il suo prologo in questa maniera: “E’ nostro dovere concepire una visione che contenga armonizzati questi due impulsi privi di ordine e incessanti. E, seguendo tale visione, disciplinare la nostra visione e Prassi.” “E combattiamo tutti – piante, animali, uomini e idee – in questo breve frangente, che è la nostra vita personale, per ordinare il Caos dentro di noi, per quietare l’abisso, per rielaborare la totale oscurità che c’è nei nostri corpi, rendendola luce.” In tutta la sua opera è centrale il tema della salvezza. E a nessuno di noi, figli di una tradizione filosofica nichilista o esistenzialista, piacciono questi concetti. Tuttavia, alcune volte, la verità è nascosta tra le righe, dietro le parole, dietro le tematiche, nella nostra mente, che non è capace di esprimere (cioè di oggettivare) il suo soggettivismo innato. Ecco quindi cosa afferma Kazantzakis a proposito della salvezza: “non che il Dio ci salverà, ma: Noi salveremo Dio, combattendo, creando, trasformando la materia in spirito ”. Quello che risulta dal pensiero del filosofo, che ad una prima occhiata può apparire mistico e spirituale, non è altro che una esatta identificazione con il mio “principio” di materialista: “Ci dobbiamo salvare dalla salvezza e dai salvatori ”. Infatti, tutta la sua opera esprime un significato Umano, dove uomo è colui che compie un salto, oltrepassa i propri limiti. Ciò vuol dire che la trascendenza di Kazantzakis, ovunque si trovi, è una trascendenza esistenziale proprio dell’uomo che, per comprendere il mondo e se stesso, deve chiamarsi Dio. Un uomo al quale sia data la partecipazione alla possibilità eterna, e così si spieghino i modi umani, il dolore, l’amore e la negazione. Nel suo libro “Il poverello di Dio”, da me chiamato “Manuale di un cristianesimo cristiano”, c’è un continuo dialogare fra l’uomo accecato e l’uomo nietzschiano, che rappresenta il Cristo vivente contro i “cristiani”. Questo accostamento è ritrancciabile nello schema dello stesso Nietzsche, secondo il quale: “Cosa nega Cristo? Tutto ciò che ora porta il nome di cristiano”. Ma vediamo come lo descrive lo stesso Kazantzakis: [parla il Despote a Francesco]
“- Fai il bravo Francesco, sei andato oltre…
– E’ proprio lì che si trova Dio, mio Despote; risponde Francesco.
Il Despote dice, muovendo la testa:
– E la virtù richiede limiti; altrimenti rischia di diventare impudenza.
– Nei limiti si trova l’uomo; oltre i limiti Dio. Verso ciò comincio ad andare, mio Despote, afferma Francesco, camminando verso la porta – aveva fretta.”
E cosa importa se, dopo aver accettato un tale modo di pensare (perché queste scene denotano una certa mentalità, o meglio, un certo stile di vita), ti chiameranno idealista, o se, non chiamando questo arrivo Dio, ma Uomo, ti chiameranno ateo, ecc., ecc.? Non importa nulla! Ma ancora voglio scrivere le bellissime parole fatte pronunciare ancora a Francesco da Kazantzakis: [ parla frate Elias a Francesco ]
– “Fratello Francesco, perdonami e, con tutto rispetto, fammi parlare: andare seguendo il tempo in cui vivi, questo è il dovere dell’uomo vivo.
Andare contro il tempo in cui vivi, replica Francesco, questo è il dovere dell’uomo libero!”
E io, uomo che vive quarantacinque anni dopo la morte di Kazantzakis, uomo pienamente cosciente delle estreme conseguenze del proprio materialismo, non temo di aprire la mia visione e di illuminarla, accogliendo il suo particolare misticismo. Misticismo che non ha niente a che fare con quello disumano, proprio delle religioni semitiche, né con quello ipocrita, tipico della cultura occidentale, che ha bisogno della scienza per edificare qualcosa di obiettivo. L’abitudine propria degli spiriti deboli è quella di mettere etichette e categorizzare tutto ciò che è pensiero, per chiudersi nel proprio campo e non permettere alcuna espansione. Perché l’espansione delle idee, provocata da qualsiasi intellettuale, rappresenta una minaccia all’ordine degli Stati e delle società, che devono rimanere addormentate, ipnotizzate dall’abbondanza, dalla conformità e dalle informazioni. Quest’abitudine, quindi, tipica degli ignoranti formati da “profeti” come Cohelo, etichetta il filosofo come un idealista, che non ha posto nel pensiero… moderno, o come materialista, che non può insegnare nulla di nuovo sullo spirito umano. Ma è da prendere in considerazione, che molte volte, un intellettuale abbraccia il materialismo solo per contrapporsi all’idealismo. Questo è capitato a molti filosofi moderni e contemporanei. Seguendo il pensiero di Kazantzakis, possiamo giungere a un raggruppamento di idee apparentemente contrapposte: “Perché il nostro Dio non è una riflessione astratta, né una necessità logica, un edificio alto e armonioso costituito da sillogismi e fantasie.”Non è una purissima, neutra, ermafrodita, inodore, distillata invenzione della nostra mente. E’ uomo e donna, mortale e immortale, sterco e spirito. Fa nascere, feconda e uccide, è l’amore unito alla morte, e che da di nuovo la vita e nuovamente uccide, danzando dolcemente al di là dei confini della logica, poiché in essa non sono contenute le antinomie. “Il mio Dio non è onnipotente, lotta, rischia ogni momento, freme, vacilla su ogni ente, grida. Incessantemente è sconfitto e di nuovo si erge, sporco di sangue e di fango, e ricomincia la lotta.” Inoltre afferma: “Sii dissidente, inquieto, insoddisfatto… Quando un’abitudine degenera in conformismo, distruggila!” Questo è il grande paradigma del cammino dell’uomo. Se avete letto Nietzsche, vi avrete trovato la figura di un Superuomo pronto, già creato, cui non si può aggiungere nulla, pensato in modo tale da far sorgere la domanda se ci sia una differenza fra lui e un ideale teologico. Invece in Kazantzakis è palesato il cammino dell’uomo in lotta per salire, per diventare Zaratustra, che “godette del suo spirito e della sua solitudine, né per dieci anni se ne stancò” già dalla prima pagina dell’opera. Ma per l’uomo reale non è così semplice. A mio parere è questa la grande, ma anche sottile, differenza tra il Nietzsche “tedesco” e quello “greco”. Cioè che mentre l’uno chiama Dio l’uomo, l’altro chiama Dio il percorso verso l’uomo.
IV PARTE
“L’essenza del nostro Dio è la LOTTA. In questa lotta si manifestano e operano eternamente il dolore, la gioia e la speranza. Il salire e la guerra controcorrente ge-nerano in noi il dolore. Ma il Dolore non è il monarca asso-luto. Ogni vittoria, ogni equili-brio è solamente un momento della scalata, che riempie con gioia ogni ente vivente, che respira, cresce, si innamora e genera. Ma all’interno della gioia e del dolore c’è la speranza eterna di sfuggire alla sofferenza, di moltiplicare la felicità. E’ così che ricomincia la salita, il dolore, rinasce la gioia e ricompare di nuovo la speranza. Il Ciclo non ha mai termine. ”
La storia dello spirito umano non è la storia della filosofia, ma quella delle interpretazioni filosofiche. L’interpretazione è tanto implicita nella nostra mente, quanto lo è il nostro io, la nostra soggettività. Una volta superata l’ angoscia primitiva esistenziale, non ci chiediamo se il Dio esiste; il perché non c’ interessa. Non è la migliore cosa possibile neanche donare la nostra mente alle illusioni, come ha fatto Pascal, e negare all’umanità la possibilità di avanzare. Non importano le figure storiche, ma soltanto la chiarezza con cui interpretiamo le loro parole. E questa chiarezza ha a che fare con il ‘come’, vale a dire con la prassi. Questo nostro modo di agire, in ultima analisi, ci farà comprendere propriamente chi siamo. Anche se all’imperativo “conosci te stesso” noi rispondessimo che siamo figli di Dio o gli eletti dello spirito, comunque la nostra esistenza rimarrebbe senza scopo, senza essenza. Prescindendo da una risposta negativa, o positiva riguardo l’esistenza di Dio, nel momento stesso in cui mi interrogo sulla possibilità della sua esistenza, mi interrogo sulla possibilità di trascendere me stesso e di accettare l’apparenza della cosa in sé. Il film di Pasolini “120 giorni a Sodomia”, se con la capacità interpretativa non lo si collega alla vita politica, è solamente un film perverso. Quindi agiamo seguendo le rappresentazioni dettate dall’interpretazione, che non può esserci fornita da nulla di esterno a noi. Ne siamo i soli responsabili, e, di conseguenza, lo siamo anche delle nostre azioni. E poiché il nostro agire caratterizza il nostro essere, è evidente che dalle nostre interpretazioni si determina la nostra essenza. Ecco perché il Santo, il vero Santo guarda con bontà anche i dannati. Kazantzakis lo spiega nel “Poverello di Dio”, attraverso le parole di Francesco, che si rivolge a Chiara: “Cosa vuol dire Paradiso? La felicità perfetta. E come potresti essere pienamente felice quando, sporgendoti dal Paradiso, vedi i tuoi fratelli e le tue sorelle che si dannano nell’Ade? Com’è possibile che ci sia il Paradiso, se c’è anche l’Inferno?”. Se una persona sceglie di essere cattiva, interpreta tutto secondo la categoria del male. Se uno sceglie l’esclusione, tutto ciò che interpreta lo porta a questa. Per questo non vi è distinzione alcuna tra intenzione moralmente buona e azione accidentalmente cattiva. Anche se la conseguenza di una nostra intenzione buona fosse negativa, porterebbe sempre con sé la bontà del soggetto che agisce. Se Dio non esistesse, l’avremmo capito tutti una volta per tutte. Se Dio esistesse, l’avrebbe fatto sapere oggettivamente una volta per tutte. Cosa ci rimane escludendo la logica (che, volenti o nolenti, è propriamente umana, e quindi non possiamo evitarla)? Ci rimane un Nulla da riempire con la nostra responsabilità. Ed ecco il primo dovere del filosofo: mettere in discussione tutti i valori e, se nessuno rappresenta i bisogni reali dell’uomo, crearne dei nuovi. Forse è proprio questo il punto di vista di Kazantzakis che, davanti al potere ecclesiastico e alla degenerazione dell’interpretazione delle parole di Cristo da parte della folla accomodata, fa esplodere, grazie alla sua penna, il grido di Dio:
“Io, l’Urlo, sono il tuo Signore, il tuo Dio! Non sono un rifugio. Non sono una Casa, neanche la speranza. Non sono Padre, né Figlio, né Spirito. Sono il tuo Generale! Tu non sei uno schiavo, né un giocattolo nelle mie mani. Non sei mio amico, non sei mio figlio. Sei il mio compagno nella battaglia. Difendere coraggiosamente gli stretti che ti ho affidato; non tradirli! Hai il dovere e le possibilità per diventare un eroe nel tuo ambito. Amare il pericolo. Qual è la cosa più difficile? Questa pretendo! Qual è la strada da seguire? La salita più ardua. Questa strada ho intrapreso anch’io; seguimi! Impara ad obbedire. Solo quello che obbedisce ad un ritmo superiore a se stesso è libero. Impara a comandare. Solo colui che sa comandare è il mio rappresentante su questa terra. Amare la responsabilità. Dire: io, soltanto io ho il dovere di salvare il mondo. Se non si salverà sarà soltanto colpa mia. ”
Queste frasi aiutano la descrizione dell’ interpretazione della nozione metafisica di Kazantzakis, che sentiamo più o meno tutti, ma che alcuni rifiutano, altri l’accettano così com’è, altri ancora la trovano nelle Sacre Scritture. Necessariamente, però, sono riduttive nel presentare un filosofo complesso, geniale e così grande nel comunicare con i dotti e con il popolo, usando sempre lo stesso linguaggio. Ho comunque cercato di trovare qual è il suo messaggio ultimo, la sua lezione fondamentale al posto vostro, di voi italiani, che siete impossibilitati nel leggere direttamente le sue opere. Credo che si possa rintracciare in due momenti fondamentali della vita di ogni uomo, la sua nascita e la sua morte. In particolare in Kazantzakis questi due istanti sembrano armonizzati con il ritmo di tutta la sua vita: quando nacque, a Creta, la sua isola si trovava in una condizione di schiavitù, sotto l’occupazione dell’Impero Ottomano. Quando morì lo seppellirono su una montagna, sempre a Creta, incidendo un’epigrafe, sotto sua richiesta, con tre frasi di contenuto politico, ontologico, teologico e filosofico, che chiudono in maniera eroica il ciclo infinitamente continuo da lui sempre sostenuto:
NON TEMO NIENTE
NON SPERO NIENTE
SONO LIBERO
NPANTALEO CARABELLESE

A cura di Lorenzo Marras
“Del mio vivere ho poco da dire. Sono nato a Molfetta il 6 luglio 1877; ho sempre tratto i mezzi del mio sostentamento dalla mia opera di insegnante: della scuola ho percorso tutti i gradi: l’insegnare mi è stato di aiuto a filosofare: credo di non aver tradito le esigenze dell’uno e dell’altro, e non le ho trovate incompatibili tra loro“. “Del mio vivere ho poco da dire…” in fondo qualsiasi biografia di Pantaleo Carabellese si potrebbe arrestare a questo punto. Queste scarne parole tradiscono, forse meglio di ogni cronologia, l’inestricabile nesso che cinge in un unicum il pensiero e la vita di questo autore così austero,sicuramente uno dei pensatori più austeri dello scorso secolo, e così totalmente immerso nel lavoro del filosofare che il chiasmo “la sua vita sono le opere e il lavoro filosofico è la sua biografia” forse trova nella sua figura una reale autenticità. Aggiungendo alla frase citata in esergo la data del decesso, avvenuto il 19 settembre del 1948, il resto della biografia di Carabellese potrebbe essere scandita da poche altre date significative e quasi sempre legate alla pubblicazione delle sue opere oppure al suo insegnamento. Nel 1901 Carabellese consegue a Napoli la laurea in Storia (pubblicata nel 1910), Sulla vetta ierocratica del Papato e nel 1906 a Roma la laurea in Filosofia con una tesi sulla Teoria della percezione intellettiva in A. Rosmini pubblicata nel 1907 con una presentazione di Bernardino Varisco. La libera docenza in Filosofia Teoretica viene conseguita per titoli nel 1917 mentre si trova al fronte. Nel 1921 Carabellese pubblica la Critica del concreto, certamente la sua opera più famosa, che avrà due ristampe (1940;1948) e una traduzione di alcune parti, insieme a quelle di altri testi, in francese, ma che dalla morte dell’autore non troverà più una riedizione ed è tuttora praticamente introvabile. Di particolare interesse risultano le vicende redazionali delle riedizioni che vanno al di là della semplice ristampa e questo perché in alcune parti si tratta di una completa rielaborazione e in molti punti le aggiunte e le correzioni sono sostanziali; tali aggiunte e rielaborazioni costituiscono forse lo specchio, un po’ come i romanzi per Jacobi, di un vero e proprio filosofare in divenire il cui studio analitico ancora attende di essere svolto. Negli anni tra il ’22 e il ’29 Carabellese tiene corsi di Filosofia Teoretica a Palermo i quali, nell’approfondimento dell’amatissimo Kant e del pensiero dell’aetas kantiana, contribuiranno costitutivamente all’elaborazione dei fondamentali ed originali studi, rispetto ad una lettura oramai stereotipata, proprio su Kant e sul pensiero postkantiano fino a Fichte (La filosofia di Kant. Vol.I L’idea teologica, 1927; Il problema della filosofia da Kant a Fichte, 1929), ma porteranno anche alla pubblicazione di importanti traduzioni di opere kantiane, Scritti minori/precritici (1923) e Prolegomeni ad ogni metafisica futura (1925). Traduzioni, queste, la prima delle quali per molti versi tradisce già nella scelta la posizione fortemente critica di Carabellese verso l’attualismo di Giovanni Gentile, con cui tra l’altro era legato da cordialissimi rapporti, mentre la seconda ci tramanda un commento letterale, oggi si direbbe filologico, che oltre ad essere per diversi aspetti ancora insuperato costituisce una vera e propria opera nell’opera. Il 1931 è l’anno della pubblicazione del testo Il problema teologico come filosofia, forse l’opera organicamente più complessa e, per dir così, matura del pensiero di Carabellese, vero spartiacque del pensiero, crinale di un approfondimento incessante il quale permetterà nei seguenti anni, più che un’evoluzione, proprio un approfondimento, nel senso di scavo ed esplicitazione lungo la stessa via, della “cosa stessa” carabellesiana “complicata” in queste opere palermitane; approfondimento che peraltro coincide con gli anni (1929-1948) dell’insegnamento all’Università di Roma prima come ordinario di Storia della Filosofia (1929-44) e poi (dal 1944 al 1948) come ordinario di Filosofia Teoretica. Nel 1936, unico avvenimento rilevante insieme con gli anni trascorsi al fronte nel rigido monismo speculativo di una vita dedita al pensiero, si sposa con Irene Gentile. Di questi anni sono gli studi sull’ontologismo e l’idealismo italiano (L’idealismo italiano, 1938, 19462); il serrato confronto con Cartesio e con il problema dell’argomento ontologico (Le obbiezioni al cartesianesimo, 3 voll., 1946; Il circolo vizioso in Cartesio, 1938), e la loro sintesi storica nel volume dal titolo programmatico Da Cartesio a Rosmini. Fondazione storica dell’ontologismo critico (1946). Tutti questi lavori non denotano certo un allentamento della tensione “kantiana” bensì una sua maggiore problematizzazione, evidente sia nella traduzione della Fondazione della metafisica dei costumi del 1936, e nell’opera Il problema della filosofia in Kant. Guida allo studio dei Prolegomeni (1938), sia nei corsi universitari degli anni quaranta sul problema dell’esistenza in Kant (1940-1943) e pubblicati postumi nel 1969 con il titolo La filosofia dell’esistenza di Kant (1969). Proprio gli anni quaranta segnano un periodo di forte “ripiegamento” su se stesso dell’Autore, di messa in discussione ed esplicitazione della propria posizione filosofica, si potrebbe dire di “sistemazione”, se questo non implicasse l’utilizzo di un sostantivo che tradirebbe lo spirito sempre “aperto” del filosofare di Carabellese e che peraltro fu da lui sempre, esplicitamente o no, avversato. Testimoni di questa “messa in discussione” sono le dispense litografate dei corsi universitari dal 1943 al 1947 (L’essere e la manifestazione parte I e parte II; L’attività spirituale umana. Prime linee di una logica dell’essere; Disegno storico della filosofia come oggettiva riflessione pura) nonché quasi tutti gli articoli pubblicati negli anni quaranta (ad esempio La nuova critica e il suo principio, 1940; La coscienza, 1944; L’essere, 1948). Purtroppo ancora non esiste una edizione di queste dispense litografate, senza le quali qualsiasi giudizio su Carabellese sarebbe menomato (per esempio nella comprensione delle variazioni della Critica del concreto del 1948). Ne sono in circolazione soltanto poche copie, alcune delle quali sono presenti nella Biblioteca di Filosofia dell’Università la Sapienza a Roma ed in quella dell’Università di Bari. Insieme a queste opere un’importanza rilevante assumono le diverse voci che l’autore ha composto per l’Enciclopedia Italiana che, tutt’altro che estrinseche, già alla semplice elencazione descrivono e racchiudono un orizzonte chiaro e ben definito il quale riflette un tessuto concettuale che anche da solo lascia trasparire la complessa personalità intellettuale di Pantaleo Carabellese: Appercezione, Astratto, Certezza, Concreto, Cosa in sé, Errore, Fichte, Jacobi, Kant, Varisco. Carabellese generalmente amava definire la sua filosofia “ontologismo critico”, definizione con la quale essa viene per lo più ricordata, ma che non ne esaurisce certo la complessità e peraltro potrebbe creare alcune confusioni con la posizione per esempio di Rosmini, la filosofia del quale viene spesso denominata proprio “ontologia critica”. In questo senso, nel senso cioè di una irriducibilità della filosofia di Carabellese alla sola definizione di ontologismo critico, ci si trova di fronte ad un’elaborazione che potrebbe con il medesimo diritto chiamarsi metafisica critica, teologia critica, ontocoscienzialismo, critica della concretezza, spiritualismo dell’essere. Pensatore difficile, talvolta astruso, che pochi conoscono e quasi nessuno, anche in Italia, conosce a fondo, Carabellese non è mai stato un pensatore famoso neanche all’apice della sua carriera (anni trenta-quaranta). Non ha fondato alcuna scuola e praticamente non ha avuto “allievi”. Si racconta che alcuni corsi, gli ultimi in particolare, erano seguiti al massimo da tre o quattro studenti. Eppure la dimenticanza e le incomprensioni che lo hanno avvolto non rendono giustizia alla vastità e alla complessità delle sue opere, alla rigorosità estrema e alla logica implacabile del suo argomentare e del suo pensare che non concedevano nulla alle “immagini”, né alla serietà dei suoi lavori storiografici e alla profondità di un pensiero in continua sfida con gli acritici “luoghi comuni” di una certa filosofia dell’epoca e con l’adesione dogmatica a formule e stilemi stereotipati. Sfida questa che lo ha portato ad assumere posizioni controcorrente, a battere sentieri all’epoca considerati impraticabili se non folli e a cambiare direzione rispetto alle mode passeggere, a ritornare su problemi antichi e considerati già da tempo superati e risolti definitivamente se non addirittura inutili (una delle accuse più frequenti è stata quella di “arcaismo filosofico”, come se in filosofia ci fossero problemi nuovi o vecchi e ad ogni problema una risposta). Tutto ciò si è riflettuto nell’impresa di una elaborazione personale che non solo si ergeva solitaria (o con pochi altri: Varisco e/o Castelli il quale però solo più tardi avrebbe dato una fisionomia “forte”, o “debole” che dir si voglia, al proprio pensiero) al di là dello storicismo e dell’attualismo, ma persino li combatteva a viso aperto su tutti i fronti. Ed ecco quindi che Carabellese diviene l’autore che riscopre come fondamentali gli scritti precritici kantiani, che propone fin dai primi anni venti un’interpretazione metafisica di Kant e una nuova interpretazione della “cosa in sé” al di là dei travisamenti postkantiani e di quello che si suol chiamare idealismo. Su questi presupposti Carabellese diventa uno dei pochi autori, se non l’unico almeno in campo laico, che tenta una elaborazione in grande stile di una ontologia e sopratutto una metafisica critica nelle quali le categorie di soggettività ed oggettività vengono ridefinite rispetto al classico dualismo (oggetto come essere e soggetto come conoscente che essendo altro dall’essere propriamente “non è”) al fine di evitare l’errore di assolutizzare la loro contrapposizione, il loro fronteggiarsi irriducibile, ed ogni loro esteriorità (infatti per Carabellese “l’esterno non esiste“) per ricomprenderli in quel “circolo solido” della concretezza dove l’Oggetto – come essere di coscienza puro(Dio) – e i Soggetti – come esistenti “testimoni dell’Oggetto/Essere” a loro immanente e allo stesso tempo trascendente nel preciso senso di una sua irriducibile alterità (come alterità dell’essere) ed inesauribiltà – divengono costitutivi, in un’interdipendenza ontologica, di questa “originaria organicità divisa in se stessa”. Battere questa strada ha condotto Carabellese, quasi necessariamente, verso un’”inaudita” riformulazione e rivalutazione dell’argomento ontologico in campo critico e all’elaborazione di una vera e propria teologia apersonalistica se non, come in alcune occasioni egli ha tranquillamente affermato, di un vero e proprio panteismo seppur passato attraverso la mediazione della critica kantiana. Un brunismo formato Kant potremmo ironicamente dire, ma con un’ironia che trova la sua serietà nell’importanza che Carabellese attribuiva al pensiero di Giordano Bruno non soltanto in chiave di attualità storiografica ma, questo sì singolare, anche in quella teoretica, importanza evidente anche nei numerosi motivi e debiti bruniani che ricorrono continuamente nelle sua opere (si veda anche il non certo casuale lavoro di tesi di una sua allieva, Maria Saracista, su La filosofia di Giordano Bruno nei suoi motivi plotiniani, pubblicata nel 1935 con una sua prefazione). Inoltre, la continua ricerca di un concetto di religione, nella sua inscindibile differenza e quindi nel suo rapporto costitutivo con la filosofia, che prescinda dai presupposti realistici come da quelli dogmatici rappresenta una costante del filosofare carabellesiano: la convinzione che soggiace le chef-d’œuvre del ‘31 è proprio quella che il carattere fondamentale del problema oggettivo della filosofia sia eminentemente teologico, ma, naturalmente, di una teologia acentrica. E non solo, ecco in Carabellese l’autore che abbozza un teoria della costituzione e della relazione di una pluralità di soggetti che il termine ultrahusserliano intersoggettività non farebbe altro che confondere, vista l’eterogeneità delle prospettive in questione (in quel periodo in Italia tra i pochi che erano soliti parlare di intersoggettività c’era Gioele Solari). Ma soprattutto ecco l’autore che tenta, pur di non adagiarsi sul “noto”, una revisione critica di tutto un determinato lessico filosofico oramai consueto e perfino consunto, revisione nel senso proprio di una decostruzione delle “sedimentazioni filosofiche” che i concetti hanno subito nel corso della storia della filosofia e che li ha resi “irriconoscibili”. Teoria, pratica, essere, Io, critica, sapere, cosa in sé, trascendenza, immanenza, implicito, esplicito, idealismo, realismo, spiritualità, esigenza, certezza, concretezza, oggetto, soggetti, coscienza, alterità e relazione sono tutti termini che in Carabellese parlano diversamente. Proprio tale riscrittura di un gergo ormai consolidato ha reso la sua ricezione ardua se non impervia, facendola dipendere da una previa e meticolosa conoscenza di tutte le sue opere e della particolare flessione data ai vari termini, in assenza della quale le incomprensioni si sprecherebbero, e quindi dalla richiesta di un costante sforzo di ascolto e di attenzione alle rigorose sequenze logiche del suo pensiero. Attenzione questa che, per dirla insieme con George Steiner, in un periodo in cui i saltimbanchi del pensiero e del linguaggio venivano,vengono e verranno incoronati d’alloro, oggigiorno viene considerata un tributo troppo alto da versare alla serietà del pensiero.
A cura di Giuseppe Tortora
Carabellese afferma che solo la coscienza è realtà concreta; coscienza in quanto consapevolezza che il soggetto umano possiede dell'”essere”; l’essere quindi non è esterno ed estraneo alla coscienza, ma immanente in essa; fuori della coscienza ci sono solo le esistenze particolari degli oggetti sensibili; l’essere che è nella coscienza è invece “essere universale”, la “cosa in sé” che è il fondamento della “cosa reale”, empirica. Nella coscienza c’è l’assoluto essere; fuori di essa c’è solo l’esistente relativo e diveniente, la cui essenza e la cui ragione d’esistenza stanno dunque proprio nella coscienza. L’essere – aggiunge poi Carabellese -, quello che è oggetto puro di coscienza, è lo stesso Dio; l’essere infatti non può essere se non unico e assoluto, e questi sono i caratteri della realtà divina; pertanto di Dio si può dire che “è”, non che “esiste”, perché l’esistenza è caratteristica degli enti finiti; e non si può dire neppure che esiste come “soggetto”, perché in senso proprio “soggetti” sono gli uomini, in cui I essere – cioè Dio – “si frange”. Acquista cosí credito anche la fede; l’intuizione di fede, come il pensiero concettuale del filosofo, è pensiero dell’oggetto puro in sé, di Dio che sta a fondamento della coscienza credente o pensante. Fondamento della coscienza, non coscienza, perché Dio è l’idea pura della ragione e l’oggetto assoluto della fede. Dati questi presupposti Carabellese rivaluta, rivedendola, la prova ontologica. E d’altra parte ridimensiona il ruolo delle religioni positive, che sono fondate sulla coscienza approssimata e imperfetta della realtà divina. In ogni caso pone un fondamento al rapporto intersoggettivo: se l’oggetto della coscienza, Dio, è immanente ad essa, e se la realtà empirica è estranea ad essa, solo l’altra coscienza, l’altro soggetto, è veramente “altro da essa”; essa lo riconosce “altro”, e ciò è possibile perché ne riconosce insieme l’omogeneità con sé; cosí nella coscienza stessa è fondata la molteplicità dei soggetti e la possibilità di autentiche relazioni intersoggettive. Ma soprattutto Carabellese esalta il ruolo della filosofia, anche a fronte della religione: la filosofia è sforzo di raggiungere l’essere in sé, anzi è il supremo sforzo dello spirito; il suo compito, però, è solo teoretico non pratico; per il suo statuto non deve “servire” alla vita; non offre norme e regole per la vita, perché in tal caso sarebbe subordinata alla vita e dipendente da essa, mentre, in realtà, la vita è subordinata ad essa, che sola può scoprirne il fondamento ontologico; la filosofia è dunque “inutile”, ma la sua inutilità è “divina”.
SYED HOSSEIN NASR
A cura di Mari Iaria
Syed Hossein Nasr è nato a Tehran nel 1933. Dopo aver compiuto i primi studi in Iran, Nasr ha studiato matematica e fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed a conseguito il dottorato ad Harvard nel 1958,specializzandosi in scienze e cosmologia islamica.Dal ’58 al ’79 è stato docente di Storia delle scienze e della filosofia all’università di Tehran doce, per alcuni anni, è stato anche preside della Facoltà di Lettere. Ha inoltre ricoperto la carica di rettore dell’Università di Aryamehr in Iran. Dal ’62 al ’65 è stato professore aggiunto ad Harvard e nel biennio ’64-’65 primo docente di Studi Islamici nell’università Americana di Beirut.è stato il fondatore ed il primo presidente dell’Accademia Iranica di Filosofia.Nel 1979,è emigrato negli Stati Uniti ed ha prestato servizio presso diverse Università prima di stabilirsi presso la Gorge Washington University nell’84,dove è tuttora docente di Studi Islamici.
Nasr ha scritto un considerevole numero di libri ed articoli circa il nesso generale tra scienza e religione ed in particolare su quello tra Islam e scienza.La sua tesi per il dottorato, che fu pubblicata nel ’64 col titolo Introduzione alla cosmologia islamica è la prima opera dell’epoca moderna dedicato allo studio della cosmologia islamica. Nell’Introduzione, Nasr tratta tre figure preminenti della scienza islamica ed il loro approccio allo studio della natura. Il suo scritto successivo, Scienza e Civiltà nell’ Islam, pubblicato per la prima volta nel ’68,portò alla ribalta il concetto di ‘scienza islamica’.In questo scritto, Nasr considera il concetto di scienza nell’ottica della visione teocentrica propria del mondo islamico ed analizza le conquiste della tradizione scientifica Islamica in campi come la medicina, la fisica, la geografia e la storia naturale. La sua opera si basa sui frammenti di uno dei migliori compendi di scienze della civiltà islamica.
Il successivo lavori di Nasr nel campo della scienze islamiche è un’opera erudita di vasto respiro che è però rimasta incompiuta : Bibliografia commentata di Scienza Islamica, scritta in tre volumi con l’ausilio di William Chittick.Si tratta di una grandiosa presentazione di tutto il materiale disponibile nelle lingue occidentali riguardo alla scienza Islamica. Il primo volume uscì nel 1975, il terzo nel 1991.L’opra più celebre di Nasr sulla scienza Islamica è Trattato Illustrato di Scienza Islamica(1976).è il primo nel suo genere che tratta la scienza islamica,la sua soria,le sue premesse filosofiche ed il suo sviluppo col supporto di stupende immagini e grafici. Nasr si è inoltre occupato del rapporto tra Islam e scienza anche in altri suoi scritti come Vita e pensiero Islamico(1981),Guida del giovane musulmano al mondo moderno(1993),Storia degli intellettuali islamici in Persia(1994).
Nasr è stato anche un pioniere per quanto riguarda il nesso tra scienza religione e crisi ambientale. Il suo lavoro Incontro tra la Natura e l’Uomo: La crisi spirituale dell’uomo moderno, pubblicato per la prima volta nel 1968,è stato uno dei primi libri a predire le nefaste conseguenze della crisi ambientale. L’opera è una critica filosofica della concezione della natura come ente inerte che si presta alla spoliazione da parte della scienza moderna e della tecnologia. La seconda opera importante che si pone su questa scia è Religione ed Ordine naturale, pubblicata nel 1996, in cui si occupa della nascita della scienza moderna e critica le filosofie della natura tradizionali e riduzioniste. L’opera si pone anche l’ambizioso obbiettivo di riportare alla ribalta la concezione divina della natura e la cosmologia tradizionale, di cui Nasr si è occupato lungo tutto l’arco della sua carriera intellettuale.
Durante il suo iter intellettuale,Nasr si è occupato di tutti gli aspetti più rilevanti della relazione intercorrente tra scienza e religione. I risultati della sua ricerca possono essere analizzati seguendo due direttive principali,vale a dire il concetto di Scienza Islamica,sul quale si è concentrato fin dal ’60, e la critica della scienza Occidentale contemporanea.NASR chiama Scienza Islamica lo studio dei fenomeni natuali entro le coordinate dell’intuizione del mondo Islamica,nel cuore del quale pulsa la dottrina del Tawhid,la Divina unità.Secondo Nasr,il tawhid ha radici di significato in questioni spirituali,filosofiche,e teologiche proprio come in quelle della coltivazione delle scienze naturali. La sottesa unità dei fenomeni naturali ed umanità è considerata una premessa metafisica a priori poiché tutto trae origine da un’unica fonte ,ossia dall’atto creatore di Dio.Le scienze naturali Islamiche,proprio come le loro corrispondenti Cristiane o Hindu ,guardano all’ordine naturale come vesitigia Dei (Ayat Allah),insistendo sull’origine divina delle cose. Da ciò deriva che l’ordine della natura ha un intrinseco telos, che la rende sacra e necessariamente significante. Queste le premesse, deriva che l’ordine naturale è costituito in modo tale da possedere un’ intrinseca intelligibilità che può essere scoperta e compresa dall’intelletto. La funzione analitica del ragionamento logico è supportata da potere sintetico dell’intelletto. I fenomeni naturali, sviscerati dalla ragione nei loro elementi costitutivi,vengono integrati grazie all’intelletto in un insieme organico che ha un’importanza epistemologica maggiore per la sua capacità intuitiva e sintetica. Quindi Nasr propone una visione olistica dell’universo ed anche un’epistemologia solistica per la sua indagine scientifica.
La natura teleologica delle scienze Islamiche prevede anche un ordine ieratico della natura. Per spiegare ciò, Nasr il linguaggio metafisico tipico della filosofia Islamica, la cui prima premessa è quella di sancire una netta frattura tra il Principio (Dio) e la manifestazione di esso(le creature). Proprio come la teoria della creazione della molteplicità dall’Unità implica una gerarchia ontologica,anche i vari gradi di esistenza sono strutturati in unità gerarchiche,essendo il cosmo ,da questo punto di vista, un caso particolare . Poichè ogni grado di esistenza ha il proprio posto ed il proprio significato nell’economia generale della creazione Divina,nessuno di questi può essere ridotto ad un singolo elemento,e cioè alle cosiddette unità elementari delle cose. Secondo Nasr, è stata proprio questa visione teologica e gerarchica dell’universo che ha fatto sì che le scienze Islamiche non cadessero nelle insidie del riduzionismo e del materialismo.
Allo stesso modo,gli scienziati musulmani, molti dei quali raggiunsero per sapienza i filosofi, svilupparono complessi modi di sperimentazione scientifica senza ricadere nel fiscalismo ovvero nello scientismo. Per Nasr la più grande e rilevante conquista della tradizione scientifica Islamica risiede non solamente nella sua capacità di seguire la direzione della Kacbah ma nel fatto che questa possiede una prospettiva totalizzante basata sui principi metafisici dell’Islam. Sotto quest’ottica,la scienza Islamica non è semplicemente scienza sviluppata e coltivata da scienziati Musulmani ma, piuttosto, si tratta dello studio scientifico dei fenomeni compreso all’interno della visione del mondo di matrice Islamica.
Il secondo aspetto dello studio di Nasr sulla religione e la scienza è pertinente alla critica della scienza moderna. Nasr è stato infatti uno dei critici più accaniti della scienza secolare Occidentale e dei suoi effetti sul mondo non-Occidentale.In un gran numero dei suoi scritti,egli ha dimostrato che le radici della scienza moderna affondano in un insieme di assunti filosofici che sancirebbero la demarcazione tra il Medioevo Cristiano e l’Occidente moderno.
Considerando la rivoluzione scientifica dei secoli XVII e XVIII come un punto cruciale nella storia d’Europa, Nasr si concentra sul processo che ha lentamente portato alla decadenza del pensiero Cristiano spianando la strada all’affermarsi di una visione secolare del mondo. A tal proposito egli sostiene che la nascita della scienza moderna non sia stata la conseguenza di una scoperta sensazionale ma semplicemente dalla visione rinnovata che l’uomo aveva del mondo dopo il XVII secolo. Per argomentare questa tesi ,Nasr si rifà ai sei tratti caratteristici della scienza moderna.
Il primo è la visione secolare dell’universo che rifiuta ogni impronta Divina nell’ordine naturale da una parte,mentre dall’altra nega ogni finalismo all’universo.
Il secondo è la visione meccanicistica del mondo,basata sul modello delle macchine e degli orologi – l’immagine preferita dei deisti del XVII e XIX secolo. Poiché la scienza moderna e la filosofia pretendono di spiegare tutto di analisi scientifica e razionale, l’universo doveva acquistare la struttura di una macchina per prestarsi perfettamente ai precisi metodi di analisi e misurazione della fisica moderna.
Il terzo si identifica con la tesi che solo il razionalismo e l’empirismo siano gli strumenti adatti per giungere alla verità .A dispetto delle forti contraddizioni che vigono tra entrambi, sono comuni a queste due scuole i metodi di analisi secolari e riduzionismi.
Il quarto è il retaggio del dualismo Cartesiano,che presuppone una netta distinzione tra res cogitans e res extensa.Una delle conseguenze maggiori di questa scissione è l’alienazione epistemologica e spirituale dell’uomo dal suo ambiente naturale e,di fatti, da tutto ciò che potrebbe potenzialmente essere oggetto di conoscenza.
Il quinto è ciò che Nasr definisce la “visione Prometeica dell’uomo”, che consacra l’uomo come misura di tutte le cose ed a cui Nasr oppone a quella che egli chiama visione Pontificale dell’uomo, visto come trait d’union tra cielo e terra
L’ultima caratteristica distintiva della scienza moderna è lo sfruttamento della natura come fonte di potere e dominio, che è stato alla base della Rivoluzione Industriale ed alla nascita del capitalismo. Messi assieme,questi sei postulati costituiscono la cornice filosofica della scienza moderna, che ha portato allo scientismo ed al declino della visione sacra del cosmo da una parte,mentre dall’altra ha prodotto disastri quali la crisi ambientale e la guerra
Per quanto concerne la relazione tra religione e scienze, Nasr viene contrapposto alla visione modernistico-puritana secondo cui una dimensione etica congiunta alla pratica scientifica annullerebbe le malfunzioni della scienza stessa. Invece di relegare l’etica e la religione alla linea di condotta , Nasr propone un profondo decostruzione dei fondamenti filosofici della scienza moderna e tenta di riportare in vita la visione divina dell’universo. La radice metafisica su cui sono innestate tutte le religioni e, secondo Nasr, a sine qua non per un’autentica e genuina relazione tra religione e scienze.
HENRI BERGSON
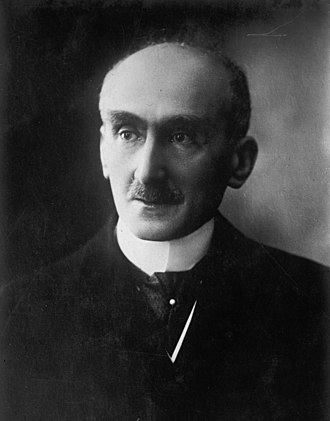
Tutti gli esseri viventi sono congiunti insieme, e tutti obbediscono al medesimo formidabile impulso. L’animale ha il suo punto d’appoggio nella pianta, l’uomo nella animalità, e l’umanità intera, nello spazio e nel tempo, è come uno sterminato esercito che galoppa al fianco di ciascuno di noi, avanti e dietro a noi, in una carica travolgente capace di rovesciare tutte le resistenze e di superare moltissimi ostacoli, forse anche la morte. (L’evoluzione creatrice)
“Il mio stato d’animo, avanzando sulla via del tempo, si arricchisce continuamente della propria durata: forma, per così dire, valanga con se medesimo. Se la nostra esistenza fosse costituita di stati separati, di cui un Io impassibile dovesse far la sintesi, non ci sarebbe per noi durata: poiché un Io che non muti non si svolge, come non si svolge uno stato psichico che resti identico a se stesso finchè non venga sostituito dallo stato successivo. Infatti, la nostra durata non è il susseguirsi di un istante ad un altro istante: in tal caso esisterebbe solo il presente, il passato non si perpetuerebbe nel presente e non ci sarebbe evoluzione né durata concreta. La durata è l’incessante progredire del passato che intacca l’avvenire e che, progredendo, si accresce. E poichè si accresce continuamente, il passato si conserva indefinitamente. ” (L’evoluzione creatrice)
i Bergson nasce da famiglia ebrea e resterà ebreo fino alla fine, anche se meditò spesso di convertirsi al cristianesimo, senza mai però farlo, perché in quegli anni, in cui la Germania nazista stava sterminando milioni di ebrei, convertirsi al cristianesimo avrebbe voluto dire abiurare e la gente avrebbe facilmente creduto che il vero motivo di tale gesto fosse appunto di evitare le persecuzioni. Una delle prime opere che egli scrive, dal titolo anonimo ma dai contenuti dirompenti, è il Saggio sui dati immediati della coscienza ” (1889): si tratta di un’opera di remota ascendenza cartesiana, in quanto l’uomo viene inteso come luogo in cui convivono lo spirito e l’anima, ma, nonostante quest’analogia con il celebre pensatore francese del Seicento, la soluzione che Bergson prospetta al problema del rapporto spirito/anima è tutta in favore dell’anima, a dispetto dell’equilibrio ipotizzato da Cartesio stesso. Ad un periodo più maturo risale l’opera più famosa di Bergson, intitolata L’evoluzione creatrice (1907): in essa, il pensatore francese dà un’immagine vitalistica dell’evoluzionismo di stampo darwiniano, riconoscendo l’evoluzione delle specie, ma respingendo la tesi canonica secondo cui essa avviene deterministicamente in base alla selezione naturale: l’evoluzione di cui si fa portavoce Bergson è, piuttosto, un’evoluzione vitale, spirituale e creatrice di novità (sullo sfondo troviamo le concezioni “congentistiche” di Boutroux) ed è in quest’opera che il filosofo si allontana maggiormente dalle tesi cartesiane, arrivando addirittura a negare che la materia esista autonomamente. La formazione di Bergson è, in origine, scientifica: ed egli si allontanerà, dunque, dalla scienza non perché impreparato in quel campo, ma, al contrario, perché preparatissimo e consapevole dei limiti propri della scienza. Nel 1928 gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura: fu uno dei pochi filosofi a riceverlo, proprio perché, tradizionalmente, lo scopo della filosofia è di esprimere concetti, non di dilettare i lettori; la vittoria di Bergson del premio Nobel è particolarmente significativa perché legata, in qualche misura, all’impostazione del suo pensiero: fin dalla sua prima opera (il Saggio sui dati immediati della coscienza ), egli sostiene che, per una conoscenza del mondo spirituale, l’atteggiamento proprio della scienza è del tutto inadeguato. In essa, però, Bergson vede ancora lo strumento migliore per indagare il mondo fisico: in opere successive, le negherà anche questa funzione, dichiarandola pertanto incapace di cogliere l’essenza profonda che permea la realtà. Ai tempi del Saggio sui dati immediati della coscienza , egli non ha ancora chiuso con la scienza e le riconosce la capacità di investigare sulla realtà fisica, quasi ritagliandola, per meglio analizzarla: tuttavia, ad essa è preclusa la facoltà di proiettare la propria indagine nel mondo spirituale, poiché per Bergson la coscienza è un flusso continuo che non può essere né colto né analizzato da una scienza che separa e ritaglia. Sarà invece molto più portata per quest’indagine la letteratura, la quale in effetti riesce a seguire il flusso della coscienza: tutt’al più, ci si potrà avvalere di una filosofia che si serva dello stile ampio e piacevole proprio della letteratura, non di quell’argomentare impassibile e arido impiegato da Kant e da Hegel. E non è un caso che Bergson fosse parente di Proust: quest’ultimo, intriso delle concezioni filosofiche di Bergson, propone (soprattutto in Alla ricerca del tempo perduto ) una letteratura intesa come forma per indagare il flusso della coscienza; e se Proust fa uso di una letteratura che assume gli obiettivi della filosofia, Bergson si serve invece di una filosofia che assume lo stile della letteratura e in virtù di ciò gli viene conferito il premio Nobel. Il Saggio sui dati immediati della coscienza ha come argomento centrale, proprio come Alla ricerca del tempo perduto di Proust, il tempo e si configura pertanto come una ricerca di esso; in altri termini, Bergson si propone di andare alla ricerca dei dati immediati della coscienza, depurandoli da tutto ciò che ad essi si sovrappone, per poterli così cogliere nella loro immediatezza. La grande scoperta che fa Bergson in quest’opera è l’eterogeneità qualitativa dei dati di coscienza rispetto alla realtà esteriore e, in questa fase del suo pensiero, egli non fa altro che riproporre quella netta contrapposizione, di sapore cartesiano, tra mondo esteriore e mondo interiore: mentre il mondo esteriore viene interpretato attraverso lo spazio, quello interiore ha come sua dimensione il tempo e da ciò si capisce bene che cosa intenda dire Bergson quando parla di “immediatezza dei dati della coscienza”. Egli, infatti, sottolinea come troppo spesso interpretiamo erroneamente anche l’interiorità in forma spaziale, ovvero come commettiamo l’errore di sovrapporre il concetto di tempo a quello di spazio: si tratta pertanto, dice Bergson, di ritornare ai dati immediati della coscienza per coglierli nella loro purezza, cioè nella dimensione temporale, depurandoli dagli elementi spaziali a cui ci siamo erroneamente abituati per via del rapporto che abbiamo con il mondo esterno. E’ ormai nostra abitudine, infatti, ” spazializzare il tempo ” , inquinando in tal modo la conoscenza interiore: si tratterà dunque di cogliere nuovamente l’interiorità nella sua dimensione genuinamente temporale. Ed è a questo punto che Bergson contrappone il “tempo spazializzato” a quella che lui definisce ” durata reale ” , che altro non è se non il tempo che scorre nella nostra coscienza, il tempo autentico; e per fare un’analisi dell’interiorità, non è possibile impiegare il linguaggio rigoroso della scienza e così Bergson si distacca dalla tradizione cartesiana che cercava di emulare in tutto e per tutto il linguaggio e la conoscenza scientifica: infatti, egli osserva, i concetti scientifici e quelli filosofici ad imitazione della scienza, tendono a ritagliare la realtà, sono strumenti adottati per inquadrarla in modo rigoroso, ma questo procedimento è possibile solo per il mondo esterno, proprio perché esso si colloca nello spazio e solo ciò che si colloca nello spazio può essere ritagliato, cioè diviso in parti ciascuna delle quali sia rigorosamente separata dalle altre. Ma per il tempo e per ciò che si colloca in esso (ossia l’interiorità della coscienza) ciò è inattuabile e per questo motivo Bergson ricorre ad un linguaggio scintillante di immagini, convinto che i concetti non siano del tutto in grado di tratteggiare una realtà indivisibile quale è appunto quella interiore: dove non arrivano i concetti, ci potranno aiutare le immagini e così si spiega il linguaggio letterario che è valso il Nobel a Bergson. Le immagini a cui egli ricorre sono quella della valanga e quella del gomitolo: arrotolando il filo di lana su se stesso, cresce il gomitolo e, man mano che cresce, c’è sempre nuovo filo che si aggiunge, senza però che quello che c’era già sparisca: resta nascosto, anzi racchiuso dal filo che si aggiunge e il gomitolo nella sua interezza non potrebbe esistere senza il filo racchiuso in precedenza. In modo analogo, la valanga nasce nel momento in cui si stacca della neve e comincia a rotolare accumulando sempre più neve, senza che quella presente in origine venga persa. Secondo Bergson, la memoria, la coscienza e il tempo autentico (“durata reale”) assomigliano al gomitolo e alla valanga, poiché nel tempo reale (cioè quello della coscienza) non vi è nulla che si perda mai veramente. E infatti, se il termine “reale” viene impiegato per sottolineare la contrapposizione con il tempo “falso” dello spazio, il vocabolo “durata” suggerisce il concetto di tempo, ma anche l’idea del permanere; ed è esattamente ciò che accade al gomitolo e alla valanga, che ” concrescono ” senza perdere i pezzi iniziali. Si tratta pertanto, fuor di metafora, di uno scorrere del tempo in cui il passato viene continuamente accumulato, il che fa sì che nel vero tempo i tempi successivi non siano mai propriamente omogenei tra loro e proprio in questo si distinguono dallo spazio. Le parti dello spazio, infatti, sono assolutamente omogenee tra loro, uno spazio non si distingue qualitativamente da un altro; invece col tempo tutto è diverso: e Bergson ci chiede di fare un esperimento mentale per renderci conto. Immaginiamo di essere chiusi in una stanza priva di finestre e di osservare un oggetto posto su un tavolo per un minuto e poi per un altro minuto: le osservazioni, intese oggettivamente, sono tra loro uguali, visto che non è cambiato nulla dal primo al secondo minuto; potremmo perfino dire che, dal punto di vista oggettivo del mondo esterno, sono omogenee come le porzioni di spazio; tuttavia, se riflettiamo meglio sull’esperienza, ci accorgiamo che se scrutiamo l’oggetto per un minuto e poi per un altro succede magari che, avendo colto nel primo minuto gli aspetti superficiali dell’oggetto, nel secondo possiamo cogliere i dettagli, oppure nel primo minuto eravamo animati da curiosità, nel secondo eravamo invece annoiati. Tutto ciò significa che il secondo minuto dell’esperienza è qualitativamente diverso rispetto al primo e lo è perché il primo c’è già stato, perché cioè il primo minuto è presente anche nel secondo. Pertanto, se gli spazi diversi si escludono a vicenda, i tempi successivi, invece, non escludono quelli precedenti, ma li recuperano come con il gomitolo o con la valanga, tutto resta presente e si arricchisce continuamente, sicchè il secondo momento è ricco di tutto quello precedente. E così nell’esteriorità sembrava non essere successo nulla, mentre nell’interiorità è avvenuto eccome qualcosa: ogni istante successivo è ricco di tutti gli istanti precedenti e la “durata” implica il permanere e dunque sembrerebbe che per Bergson sia centrale il passato, ma in realtà non è così. E’ vero che da un lato egli mette in luce come nella durata reale in ogni istante successivo sia presente il tempo passato, ma è anche vero che ogni fase del tempo è come se spingesse e penetrasse in quella successiva, come se ogni momento si sforzasse per entrare in quello successivo, cosicchè il passato è conservato nella sua interezza ma è come se spingesse verso il futuro, il che suggerisce a Bergson l’idea di “spontaneità”. E’ curioso come egli, in origine, volesse intitolare il Saggio sui dati immediati della coscienza in un altro modo, più precisamente “Problema della libertà”: il problema della libertà, strettamente connesso con quello della spontaneità, è infatti centrale nell’opera. L’idea del passato che spinge verso il futuro suggerisce infatti che nulla sia determinato rigorosamente, ma che sussista quello che Bergson chiamerà, in opere successive, “slancio vitale”, una sorta di forza creatrice sempre in grado di produrre qualcosa di nuovo. Per meglio distinguere il tempo reale da quello spazializzato, egli ricorre ad un’altra immagine: immaginiamo di sciogliere una zolletta di zucchero in un bicchier d’acqua; mentre il tempo trascorre, vi sarà un’attesa interiore, ovvero il tempo verrà vissuto interiormente, mentre, nota Bergson, il tempo spazializzato è quello impiegato dalla scienza: egli, con un esempio calzante, fa l’esempio dell’astronomo che fa calcoli per prevedere un’eclissi che si verificherà dopo un sacco di anni: nella testa dell’astronomo, ciò che l’astro farà da quel momento per i prossimi cinquecento anni viene compattato e compresso in poche frazioni di secondi; il tempo con cui l’astronomo sta lavorando non è reale, poiché il tempo reale (quello con cui attendiamo che la zolletta si sciolga) non è comprimibile, ha bisogno di una durata per svolgersi, un’attesa che si attua inevitabilmente nella coscienza. Per capire meglio può essere utile fare ricorso ad un’altra immagine, di sapore cartesiano: immaginiamo che vi sia un genio maligno che comprime al contempo tutti gli eventi della natura, cosicchè tutti gli eventi accelerano contemporaneamente e nella stessa misura. In questo caso, noi non saremmo più in grado di misurare il tempo, o meglio, non ci accorgeremmo di nessun cambiamento, dato che lo misuriamo in base ad una serie di coincidenze: per dire che sono lo 9 e 20 dico che sul mio orologio le lancette sono in una determinata posizione, poi le vedo in ‘altra posizione e dico che sono le 9 e 30 e avrò constatato in due momenti diversi la corrispondenza tra due situazioni spaziali (le lancette), non temporali. Ora, se tutto accelerasse contemporaneamente, io farei la stessa misurazione e otterrei il medesimo risultato, però, dice Bergson, questo vale solo per il tempo spazializzato, in quanto, in qualche modo non concettualmente analizzabile, nella mia coscienza percepirei che il tempo è cambiato, che c’è stato bisogno di meno tempo perché avvenisse quella cosa a me nota. Da ciò si evince benissimo la distinzione tra il tempo “falso” dello spazio e quello “reale” della coscienza, in cui vige la spontaneità , cioè lo spingere per penetrare nel futuro, quasi una specie di slancio vitale che sfugge ad ogni determinismo e comporta appunto la spontaneità, sinonimo di libertà. E sotto questo profilo, è curioso notare come Bergson respinga la contrapposizione tradizionale tra meccanicismo e finalismo, da sempre considerati antitetici: il pensatore francese si pone da un punto di vista nuovo e afferma espressamente che il meccanicismo e il finalismo sono le due facce della stessa medaglia e tale medaglia è il determinismo. Il meccanicismo è, naturalmente, una forma di determinismo in quanto prescrive che tutto avvenga in modo deterministicamente prevedibile attraverso rapporti di causa/effetto; il finalismo, dal canto suo, prevede che l’azione sia orientata verso un fine, per cui l’architetto che progetta la casa mira ad un disegno preciso fin dall’inizio; ne consegue che anche nel finalismo, come nel meccanicismo, tutto è già rigorosamente determinato fin dall’inizio. Caduta la contrapposizione tra i due, Bergson afferma che la maniera corretta per interpretare la realtà interiore non è né il finalismo né il meccanicismo, bensì la spontaneità: la si deve cioè intendere come un flusso di coscienza in cui non si possono ritagliare pezzi (dal momento che ogni momento è presente anche in quello successivo) e in cui nulla è già determinato e tutto spinge e, quindi, crea continuamente in una forma che schizza via da ogni determinazione (e da ciò traspare l’influenza contingentista di Boutroux). E la nostra vita, dice Bergson, è come una frase, con le sue virgole, le sue parentesi e i suoi due punti: il punto finale è costituito dalla morte; e proprio come in una frase, anche nella vita basta inserire una virgola per far cambiare non solo ciò che viene dopo, ma anche tutto ciò che c’era prima. A questo punto del discorso di Bergson, abbiamo l’individuazione di due ambiti diversi della realtà, uno esterno, costituito da cose materiali che si collocano nello spazio, l’altro interno e che si colloca nel tempo; il primo è oggetto di studio da parte della scienza e, più in generale, dell’intelligenza che, lavorando nello spazio, tende a ritagliare le cose (il che è più che legittimo, se fatto solo ed esclusivamente nello spazio) e anche quando pare che sia presente il tempo, in realtà hanno sempre e solo a che fare con lo spazio: e non è un caso che la scienza tenda a rappresentare graficamente il tempo come linea retta, ma è una rappresentazione imprecisa, giacchè le parti di una linea sono contemporanee e i vari punti che la costituiscono sono staccati dagli altri, mentre nella durata reale ogni istante è presente anche in quello successivo. Nella coscienza, la scienza e l’intelligenza cedono il passo alla metafisica e all’intuizione: l’intuizione ci permette di cogliere direttamente i dati immediati della coscienza, la durata reale, il flusso della coscienza, e addirittura la spontaneità (e quindi la libertà) di ciò che avviene all’interno, in antitesi al determinismo che impera all’esterno. E Bergson fin qui è ancora molto cartesiano, poiché ammette la distinzione, propria di Cartesio, tra mondo materiale e mondo spirituale e riconosce l’esistenza di una facoltà (l’intuizione) che consente di creare una disciplina particolare (la metafisica) che studia l’interiorità; ad essa Bergson contrappone il mondo materiale, collocato nello spazio e inquadrabile dall’intelligenza e dalla scienza: in sostanza, Bergson ammette l’esistenza di due mondi diversi con due scienze diverse. Poi, però, in ” Materia e memoria ” (1896) si pone il problema del rapporto tra questi due mondi (il sottotitolo dell’opera recita in modo significativo: “Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito”) e, infine, in ” L’evoluzione creatrice “, si sbarazza di uno dei due mondi, più precisamente, sulle orme di Leibniz, di quello materiale, e arriva a dire che al di sotto della realtà materiale vi è un principio spirituale e vitalistico simile a quello dell’interiorità. ” Materia e memoria ” parte dal concetto di “immagine”: Bergson, rispetto alle tradizionali alternative dell’idealismo e del materialismo, sceglie una via intermedia, dal momento che lui è partito dai dati immediati della coscienza ed essi non suggeriscono né l’ipotesi idealistica né quella materialistica. Infatti, per gli idealisti non vi sono realtà indipendenti dal nostro atto di percepirle e per i materialisti, invece, ad esistere sono propriamente solo le cose materiali: ma la nostra coscienza, nota Bergson, ci dice che esiste qualcosa di indipendente da noi (a dispetto della tesi idealista), che vediamo e percepiamo, però (e qui affiora l’influenza di Cartesio) non ci dice che quel qualcosa che esiste indipendentemente dall’essere da noi percepito esista materialmente (checchè ne dicano i materialisti); in altri termini, abbiamo sensazioni di colore, di sapore, ecc, e siamo convinti che esse siano dotate di esistenza autonoma, ma il dato di coscienza non ci testimonia affatto che siano entità materiali, sicchè sia l’idealismo sia il materialismo si spingono al di là di quel che ci è testimoniato dalla coscienza. Essa, infatti, si limita a dirci che c’è qualcosa fuori di noi, senza tuttavia darci altre informazioni in merito. Questa realtà intermedia fra il non-esistere autonomamente e l’esistere come realtà materiale Bergson la chiama ” immagine “: noi abbiamo immagini della realtà che esistono autonomamente, cosicchè quando vedo un libro ho la certezza (perché è la coscienza a dirmelo) che esso sia dotato di esistenza effettiva, ma che sia costituito da materia è una dottrina filosofica che esula dalla testimonianza della coscienza: ” per immagine intendiamo una determinata esistenza che è più di ciò che l’idealista chiama una rappresentazione, ma meno di ciò che il realista chiama una cosa- un’esistenza che si trova a metà strada tra la cosa e la rappresentazione ” (“Materia e memoria”, Prefazione alla VII edizione). E Bergson, con una considerazione fortemente schopenhaueriana, fa notare che la prima immagine che abbiamo è l’immagine del nostro corpo, la cui funzione è di selezionare le altre immagini; e con quest’affermazione si perviene al nucleo di “Materia e memoria”, nel tentativo di risolvere l’annoso problema del rapporto che intercorre tra l’anima e il corpo. Bergson conduce, a tal proposito, un’analisi clinica di alcuni casi di amnesia dovuti ad incidenti: all’epoca, si cominciava a notare che a determinati danni fisici riportati da certe parti del cervello corrisponde la perdita della memoria di determinate “aree”; ovviamente, ciò accreditava l’ipotesi che vi fosse uno stretto legame tra il cervello come base materiale e le funzioni psichiche, ipotesi che suggeriva la validità della psicofisiologia. E Bergson, nella sua indagine, si rivela un pensatore poliedrico, pronto a concentrare la sua attenzione su saperi anche non propriamente filosofici: dalla sua indagine tecnica egli evince che la funzione del cervello non è di essere un magazzino della memoria, per cui è scorretto dire che ad un danno materiale del cervello corrisponde un danneggiamento anche del contenuto; viceversa, il contenuto della memoria resta integro, e ad essere danneggiata è la capacità del cervello di fare da filtro nei confronti del materiale della memoria. Ne consegue che per Bergson la memoria in quanto tale è indipendente dal cervello , sicchè il cervello, alla stregua del corpo, seleziona le altre immagini, fa da filtro tra mondo interiore della coscienza e mondo esteriore: immaginiamo di avere un piano e un cono rovesciato la cui punta poggia su tale piano. Il cono rappresenta la coscienza umana, il piano la realtà: la mente (che si identifica con la memoria, in quanto è somma di ricordi) ha un contenuto vastissimo, ma, per così dire, tocca la realtà in un solo punto: ad esempio, mentre sto parlando chiudo tutti i molteplici passaggi che mettono in contatto la mente (il cono) e la realtà (il piano) e lascio solo una fessura, attraverso la quale la mia coscienza entra in contatto con la realtà. Tutto il resto della mente viene invece nascosto, fatta eccezione, appunto, per ciò di cui parlo in quel momento, e ad avvalorare il discorso bergsoniano (in cui serpeggiano le concezioni freudiane) è l’esistenza di alcune patologie che fanno sì che la mente non riesca più a controllare i ricordi. E’ infatti necessario che la mente, in entrata e in uscita, sia a contatto con la realtà solo in un punto e spetta appunto al cervello tenere nascosto tutto il restante contenuto mentale e Bergson è convinto di essere riuscito a dimostrare questa tesi dall’analisi dei casi di amnesia. E se ciò è vero, egli nota, allora la memoria non è riducibile al cervello, ma ha una sua dimensione autonoma e spirituale, mentre il cervello è un puro e semplice meccanismo che filtra: e i casi di amnesia non fanno altro che mettere in luce come sia stato danneggiato tale meccanismo con cui la nostra mente si rapporta col mondo esterno. A questo punto può essere interessante riprendere il rapporto bergsoniano con Proust: per entrambi i pensatori, nella memoria non vi è nulla che si perda, a patto che si faccia una distinzione tra l’avere memoria e il rammemorare. Infatti, se è vero che abbiamo sempre memoria di tutto, a tal punto che non è scorretto affermare che la mente è memoria e che tutte le nostre esperienze sono custodite in essa (come il filo nel gomitolo), è anche vero che per rammemorare si deve far sì che la punta del cono tocchi il piano, ovvero che la mente entri in relazione con la realtà: ma anche se a toccare il piano è solo la punta del cono, ciononostante il resto del cono non sparisce e da ciò deriva la convinzione bergsoniana e proustiana che debbano esistere modi per far emergere anche ciò che sembra scivolato nell’oblìo, sparito dalla memoria. Celebri, a tal proposito, sono le pagine in cui Proust racconta di quando gli viene offerto del the con dei biscotti caratteristici e comincia a provare sensazioni particolarissime, in quanto, attraverso i sapori e gli odori, gli torna alla memoria di quando li aveva già mangiati in passato; ora, secondo Bergson e Proust, questo ricordo era presente nella memoria, ma non poteva emergere finchè non fosse stato sollecitato: e non è certo lo sforzo razionale che può far sì che i ricordi vengano a galla, visto che la memoria, come abbiam visto, ha a che fare con quelle realtà fluide e volatili che sono le sensazioni, coglibili dall’ intuizione . E infatti Bergson, fin dal “Saggio sui dati immediati della coscienza”, contrappone l’intelligenza, riguardante il mondo esterno, propria della scienza e cristallizzata nel linguaggio, all’intuizione, sulla quale si costruisce la metafisica, capace invece di attingere al flusso della coscienza, di cogliere l’essenza dall’interno della vita psichica; tuttavia Bergson, nelle ultime fasi del suo viaggio filosofico (soprattutto in “L’evoluzione creatrice”) tenderà sempre più a vedere qualcosa di analogo alla coscienza nell’intero cosmo, più precisamente arriverà a ravvisare un principio comune, uno slancio vitale che governa l’evoluzione del mondo vivente. E con queste considerazioni egli, da dualista, diverrà monista: nel “Saggio sui dati immediati della coscienza” aveva riscontrato un’insanabile frattura tra mondo spirituale e mondo fisico; ora, con “Memoria e materia”, ha ridotto il corpo ad un’ “immagine” e, infine, con “L’evoluzione creatrice”, arriverà ad ammettere un unico principio valido per l’intera realtà, superando così il dualismo anima/corpo e pervenendo ad una forma di monismo, cioè alla convinzione che la realtà sia, in fin dei conti, una sola. Pertanto non avrà più senso parlare di due realtà differenti (anima e corpo) e di due strumenti diversi per conoscerli (l’intelligenza e l’intuizione): essendo respinta l’esistenza della materialità, la distinzione tra intelligenza e intuizione viene stravolta nel suo significato, sicchè non indagano più due realtà diverse, bensì indagano in due modi diversi l’unica realtà esistente. L’intelligenza (e quindi la scienza) non avrà alcuna funzione conoscitiva, come già aveva prospettato Schopenhauer, giacchè non è in grado di cogliere la realtà nella sua vitalità, ma, ciononostante, le verrà riconosciuta una valenza pratica, in quanto permette di dominare concettualmente la realtà, facendocela vedere come un insieme di “cose” immerse nello spazio e, in tal modo, permettendoci di manipolarla. Sarà invece l’intuizione a fornire una conoscenza valida e metafisica, penetrando nel profondo della realtà. L’intuizione, dice Bergson in “L’evoluzione creatrice”, nasce da una sintesi di intelligenza ed istinto, una sintesi cioè degli aspetti migliori dell’umanità e dell’animalità. ” L’evoluzione creatrice ” è un testo il cui tema portante è ben riassunto nel titolo: l’argomento centrale è l’evoluzione del mondo animale, ma non è darwinianamente intesa in modo meccanicistico, bensì viene letta come il frutto di uno slancio vitale ed è proprio in questa prospettiva che Bergson respinge la tradizionale contrapposizione tra meccanicismo e finalismo, intendendoli come due facce della stessa medaglia deterministica. L’intera realtà è, invece, il frutto di uno slancio vitale, creativo e spontaneo, che sfugge ad ogni forma di determinabilità: nell’interiorità scopriamo un flusso, dice Bergson, e, attraverso un processo quasi analogico di ascendenza schopenhaueriana, possiamo tranquillamente affermare che questo processo investe non solo la coscienza (come si credeva nel “Saggio sui dati immediati della coscienza”), ma tutta quanta la realtà; in particolare, osserva il filosofo francese, la durata reale ha come caratteristica il fatto che il passato spinge nel presente e nell’avvenire con il risultato che nella durata reale non si può immaginare di capovolgere il tempo. Infatti, una volta che il tempo si è sviluppato, si è arricchito di nuovi momenti, sicchè non è più possibile smontare e tornare indietro, dal momento che non si tratta di semplici pezzi aggregati insieme, ma, come si capiva dall’esempio del gomitolo, ogni istante ha in sé tutti quelli precedenti. E Bergson, in “L’evoluzione creatrice”, fa notare che tutto ciò è anche vero per il mondo vivente, non solo per la coscienza: se una certa tradizione ha letto gli animali (e La Mettrie perfino gli uomini) come macchine, Bergson afferma ora che è impensabile smontare e rimontare un animale come se fosse una macchina, proprio perché, come il tempo della coscienza, così anche quello della vita appare irreversibile, non si può giocare su di esso. Poi, esaminando ulteriormente il mondo fisico, con un processo analogico di matrice schopenhaueriana, Bergson ritiene di poter estendere il discorso a tutto il cosmo: la durata reale, scoperta nel “Saggio sui dati immediati della coscienza” e inizialmente ravvisata solo nella coscienza, viene ora concepita come chiave di lettura del mondo vivente e, in ultima analisi, dell’intero universo, cosicchè in Bergson il dualismo cede definitivamente il passo al monismo. Infatti, la coscienza e la materia, coi loro due tempi (la durata reale e il tempo spazializzato) e con i loro due strumenti (l’intuizione e l’intelligenza), non vengono più contrapposte, in quanto anche la materia è permeata da quell’unico principio vitale che Bergson chiama ” slancio vitale “. Esso corrisponde in parte alla volontà di Schopenhauer: è anch’esso un principio unico che soggiace all’intera realtà, e con esso Bergson spiega l’evoluzione del mondo vivente. Tuttavia, ancor prima di addentrarsi in questo problema, ne sorge un altro: se ammettiamo un unico principio ed esso è spirituale, come si spiega la materia? Per capirlo può essere utile far riferimento a due immagini bergsoniane che si richiamano e si chiarificano a vicenda: immaginiamo di affondare la mano in un recipiente pieno di limatura di ferro; le nostra dita si allargano e spingono le varie particelle fino ad un certo punto, finchè la resistenza della limatura blocca la mano. La mano rappresenta lo slancio vitale, la limatura, invece, la materia: l’immagine sta a significare che lo slancio vitale, penetrando nella materia, la spinge in direzioni diverse finchè esso non si esaurisce di fronte alla resistenza fatta dalla materia stessa: secondo Bergson è esattamente in questo modo che procede l’evoluzione; gli esseri viventi, cioè, contengono in sé lo slancio vitale, ma sono pur sempre esseri animali incarnati nella materia, e così si può dire che ogni essere vivente è il risultato della spinta data in una certa direzione dall’unico slancio vitale, che di fronte alla materia si divide e in qualche caso spinge più in là, in qualche altro caso si ferma prima. E ogni specie vivente è il risultato di una spinta dello slancio vitale che si è spinto fin dove ha potuto e poi si è arenato. Ovviamente, si tratta di un’interpretazione dell’evoluzionismo assai diversa rispetto a quella di Darwin, in quanto è carica di spiritualismo e presuppone quasi una lotta perenne tra slancio vitale e materia inerte che lo frena: e Bergson stesso si distacca da Spencer e dalla sua concezione evoluzionistica perché, ai suoi occhi, eccessivamente meccanica. Oltre a giustificare il fatto che le specie animali sono tra loro diverse (in alcune lo slancio vitale si è spinto più in là, in altre si è arrestato prima), l’immagine della mano e della limatura spiega anche la differenza tra individuo e individuo: più lo slancio vitale va in alto e più riesce ad emergere nella sua natura più propriamente spirituale. E così nelle forme vegetali l’identità spirituale è quasi ingabbiata, come se lo slancio vitale non fosse riuscito a penetrare molto nella materia: negli animali e ancora di più nell’uomo, esso si è spinto oltre qualitativamente e quantitativamente. L’immagine della mano e della limatura, però, lascia irrisolto un problema non da poco: spiega come avviene l’evoluzione senza però giustificare la materia. Occorre pertanto fare riferimento ad un’altra immagine bergsoniana: quella dei fuochi d’artificio. Lo slancio vitale è un fuoco d’artificio che sale verso l’alto ma prima o poi esaurisce la sua spinta e tende a ricadere al suolo; ad esaurirsi, però, non è lo slancio (poiché è infinito), bensì sono i singoli frammenti che si spengono e che nel momento in cui tendono a ricadere vengono ancora tenuti su per un po’ dal flusso che continua a giungere dal basso. La materia, in questa nuova prospettiva, non è più un qualcosa di esterno e autonomo dentro cui lo slancio vitale deve farsi strada, come sembrava nell’immagine della limatura: viceversa, è lo stesso slancio vitale che, spirituale nella sua essenza, nel momento in cui esaurisce la sua forza tende a manifestarsi come materia. Essa è pertanto l’insieme dei resti dello slancio vitale e con questa concezione Bergson si avvicina in modo impressionante alla teoria leibniziana secondo cui le “monadi” più passive si estrinsecano materialmente; l’antico Plotino in persona, del resto, aveva detto che dove l’essere si esaurisce, lì c’è la materia. Ritornando ai fuochi d’artificio di Bergson, l’istante in cui le scintille sono tenute ancora un po’ in aria dalle altre, questa è la vita dei singoli individui e delle specie: ciascuno di noi è, in altri termini, un corpo vivificato dallo slancio vitale e l’esistenza altro non è se non un brandello lasciato per strada dallo slancio, cosicchè noi siamo un corpo materiale che piano piano si spegne. La vita, così, è, secondo la definizione pirandelliana, un flusso continuo che cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili. E la vitalità affiora anche nella risata, sulla quale Bergson conduce un’analisi nel saggio Il riso : in questo saggio sul significato del comico, egli si concentra su tre aspetti della comicità: 1) è legata a un fattore umano (se cado faccio ridere; se vedo un paesaggio non mi suscita ilarità, un animale può essere comico se vi ravviso somiglianze con una caricatura dell’uomo); 2) è legata all’insensibilità (non si può ridere di una persona che genera pietà; il comico non si rivolge al cuore ma all’intelligenza pura); 3) ridere ha natura sociale (è sempre il riso di un gruppo o si immagina di condividerlo con altri magari immaginari). La cosa curiosa, sottolinea Bergson, è che lo slancio vitale si articola in ramificazioni fondamentali: una prima ramificazione può essere scorta tra il mondo vegetale e quello animale e in quest’ultimo, a sua volta, troviamo un nuovo bivio tra due grandi percorsi evolutivi caratterizzati, rispettivamente, da due modi molto raffinati, anche se diversi, di manifestazione dello slancio vitale. Si tratta della ramificazione tra vertebrati e artropodi (insetti, crostacei, ecc): la differenza tra i due percorsi evolutivi risiede nel fatto che il percorso dei vertebrati spinge sempre più verso l’emergere della coscienza e dell’intelligenza e culmina nell’uomo, mentre il percorso degli artropodi non è orientato verso lo sviluppo della coscienza, bensì verso quello dell’istinto, uno strumento altrettanto raffinato per risolvere i problemi. L’istinto, però, non è caratterizzato dalla coscienza: gli insetti, infatti, fanno cose complicatissime (pensiamo alle ragnatele) ma le fanno istintivamente, senza averne coscienza. Questi due strumenti, l’istinto e l’intelligenza, hanno i loro pregi e i loro difetti: il pregio dell’intelligenza consiste nell’essere cosciente e, proprio in quanto cosciente, essa è anche più duttile, riflette dall’esterno sui problemi e adatta ad essi le soluzioni; l’istinto, invece, non è cosciente, ma è immediato, governa le cose dall’interno, e infatti il ragno non progetta coscientemente la tela, ha una sorta di certezza interiore che lo induce ad agire in quel modo e Bergson nota come l’istinto può portare a grandi cose, ma anche a grandi errori. Questa distinzione tra intelligenza e istinto è particolarmente rilevante perché nell’uomo, che costituisce il vertice dei vertebrati, l’origine comune diversificatasi tra vertebrati e artropodi si ricongiunge, dato che l’uomo è dotato di intelligenza ma, se lo desidera, può recuperare la dimensione dell’istinto e fonderla con quella dell’intelligenza, dando vita all’intuizione, una specie di intelligenza istintiva che fa sì che si abbia la certezza immediata e interiore dell’istinto e la coscienza propria dell’intelligenza. ” Le due fonti della morale e della religione ” (1932) è l’opera che conclude il discorso bergsoniano sull’evoluzione creatrice: l’evoluzionismo, dopo aver prodotto l’uomo, non si ferma, ma procede nelle realizzazioni culturali umane e, proprio come nelle evoluzioni dei viventi, anche in questo nuovo ambito troviamo elementi più evoluti e altri più “arenati”. In altre parole, all’uomo è dato scegliere se far proseguire nel suo corso lo slancio vitale o se bloccarlo dentro di sé: ciò traspare dalla contrapposizione (che sarà ripresa da Popper) tra “società chiuse” e “società aperte”. La società chiusa è quella autoritaria, in cui l’uomo è spinto con forza ad identificarsi nella società e nei suoi rigidi valori; quella aperta, invece, è la società in cui ci si apre all’umanità e si promuove la libertà degli individui, creando (un po’ come aveva detto Nietzsche) dei nuovi valori da anteporre ai vecchi. Dalle società chiuse si sviluppano le “religioni statiche”, quelle cioè istituzionalizzate, che tendono a favorire un atteggiamento dogmatico e chiuso degli individui; in seno alle società aperte, invece, nascono le “religioni dinamiche” (che Bergson di gran lunga preferisce rispetto a quelle statiche): esse, in sostanza, si identificano con il misticismo che, per sua natura, sfugge all’istituzionalizzazione. Non c’è da stupirsi che Bergson nutra simpatia per il misticismo, soprattutto se teniamo presente che, fin dal “Saggio sui dati immediati della coscienza”, egli cercava di scorgere nell’uomo una vivace spontaneità, tentativo proseguito in “L’evoluzione creatrice”, quando trovava in un unico principio la chiave di lettura dell’intera realtà: è naturale che la religione che più lo affascina sia il misticismo, che esprime l’essenza libera dell’uomo e lo metto in contatto diretto con quel flusso vitale che scorre in profondità. E, con un’immagine stupenda, in “L’evoluzione creatrice”, Bergson sostiene che “ l’umanità intera, nello spazio e nel tempo, è come uno sterminato esercito che galoppa al fianco di ciascuno di noi, avanti e dietro a noi, in una carica travolgente capace di rovesciare tutte le resistenze e di superare moltissimi ostacoli, forse anche la morte “. Anch’egli si pone, come molti suoi contemporanei, il problema della tecnica e la concepisce come un prolungamento del corpo umano, in quanto grazie ad essa l’uomo è agevolato nelle sue attività: e in un’epoca in cui il corpo si è gonfiato a dismisura, si rende necessario anche un ” supplemento di anima “, espressione con la quale Bergson sottolinea come le responsabilità siano infinitamente cresciute, come a dire che, aumentato il corpo, anche l’anima deve adeguarsi. In precedenza abbiamo riscontrato analogie tra il pensiero di Bergson e quello di Schopenhauer, in particolare abbiamo intravisto una notevole vicinanza tra lo slancio vitale e la volontà schopenhaueriana: tuttavia, è bene notarlo, se il discorso di Schopenhauer è fortemente venato di pessimismo, tant’è che egli arriva a proporre l’annullamento della volontà, quello di Bergson, invece, è vivacemente colorato di ottimismo e può essere inquadrato in quel filone vitalistico, sorto in opposizione al Positivismo e al suo culto della ragione e dei dati di fatto, in cui rientra anche quello di Nietzsche. La prospettiva di Nietzsche, però, era una sorta di ottimismo tragico, poiché il sostanziale ottimismo che la informava nasceva dal nichilismo e dalla tragicità dell’esistenza; tutto questo in Bergson manca. Egli, al contrario, è un ottimista nel vero senso della parola e, non a caso, pensò anche di convertirsi al cattolicesimo, che, fra tutte le religioni, è forse quella più conciliante con il mondo.
IL RISO
IL COMICO SECONDO BERGSON
1. Le fonti. Le riflessioni di Bergson sulla natura della comicità sono racchiuse in un breve libro, intitolato Il riso. Saggio sul significato del comico (1900), destinato ad un successo travolgente: ebbe infatti più di sessanta edizioni in poco più di quarant’anni, grazie anche alla leggerezza dello stile che rende tanto più piacevolmente leggibile un’opera che è peraltro assai più impegnativa e ricca di quanto non sembri.
Quest’opera si situa in una fase importante dell’evoluzione del pensiero bergsoniano: si colloca infatti negli anni in cui da interessi prevalentemente psicologico-filosofici Bergson muove verso una filosofia della vita orientata metafisicamente. Il saggio sul riso accomuna dunque, come vedremo, queste due tendenze della speculazione di Bergson e rappresenta quindi una possibile introduzione al suo pensiero.
1. Un’idea antica: il riso ha una funzione sociale. Nelle pagine di questo suo libro, Bergson muove innanzitutto da una constatazione di natura generale: se il riso è un gesto che appartiene a pieno titolo al comportamento umano, allora deve essere lecito domandarsi qual è il fine che lo anima. Ora, per comprendere il fine cui mira un comportamento si deve in primo luogo far luce sulle occasioni in cui accade. E per Bergson vi sono almeno tre punti che debbono essere a questo proposito sottolineati:
- “Non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano” (ivi, p.4). Questa affermazione può lasciarci di primo acchito perplessi: si può ridere infatti anche di un cappello o di un burattino di legno. E tuttavia, se non ci si ferma a questa constatazione in sé ovvia, si deve riconoscere che in questi casi il rimando a ciò che è umano gioca un ruolo prevalente e comunque ineliminabile: di un cappello ridiamo perché vi vediamo espresso un qualche capriccio estetico dell’uomo, così come nella marionetta l’immaginazione scorge i gesti impacciati di un uomo sgraziato. Alla massima antica secondo la quale l’uomo È l’animale che ride si deve affiancarne dunque una moderna: l’uomo È un animale che fa ridere.
- Il riso scaturisce solo di fronte a ciò che appartiene direttamente o indirettamente all’ambito propriamente umano; perché possa tuttavia scaturire è necessario che chi ride non si lasci coinvolgere emotivamente dalla scena che lo diverte. Per ridere di una piccola disgrazia altrui dobbiamo far tacere per un attimo la pietà e la simpatia, e porci come semplici spettatori o – per esprimerci come Bergson – come intelligenze pure: “il comico esige dunque, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa come un’anestesia momentanea del cuore” (ivi, pp. 5-6).
- Il riso – abbiamo osservato – chiede una sorta di sospensione del legame di simpatia che ci lega a colui di cui ridiamo. E tuttavia tutti sappiamo che il riso È un’esperienza corale: ridiamo meglio quando siamo insieme ad altri, ed il riso È spesso il cemento che tiene unito un gruppo di persone. “Il riso, – commenta Bergson – […] cela sempre un pensiero nascosto di intesa, direi quasi di complicità, con altre persone che ridono, reali o immaginarie che siano” (ivi, p.6).
Non è difficile scorgere la nota che accomuna queste tre osservazioni generali: il riso sembra essere strettamente connesso con la vita sociale dell’uomo, con il suo essere un animale sociale. Possiamo allora – seguendo Bergson – far convergere i tre punti su cui abbiamo dianzi richiamato l’attenzione in un’unica tesi, che getta appunto la sua luce sul quando del riso: “Il “comico” nasce quando uomini riuniti in un gruppo dirigono l’attenzione su uno di loro, facendo tacere la loro sensibilità, ed esercitando solo la loro intelligenza” (ivi, p.7). E se le cose stanno così, se il riso come comportamento umano sorge nella vita associata, allora si può supporre che esso risponda a determinate esigenze della vita sociale.
3. Il riso ed il diavolo a molla. Per far luce sul motivo che ci spinge a ridere non basta indicare quando ridiamo: occorre riflettere anche su ciò di cui ridiamo. Orientarsi in questa seconda parte delle analisi vuol dire innanzitutto lasciarsi guidare dagli esempi, e tra questi uno gode di una posizione privilegiata proprio per la sua estrema semplicità: il gioco del diavolo a molla. “Noi tutti abbiamo giocato […] col diavolo che esce dalla sua scatola. Lo si schiaccia ed ecco si raddrizza; lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto, lo si scaccia sotto il coperchio ed esso fa saltare tutto” (p. 46) scrive Bergson, e propone subito dopo un’osservazione che ci spiega perché un simile gioco possa far ridere un bambino: “E’ il conflitto di due ostinazioni, di cui l’una puramente meccanica finisce ordinariamente per cedere all’altra, che se ne prende gioco” (ivi, p. 47). Del diavolo ci fa ridere la cieca ostinazione, il suo “saltar su” come una molla: È dunque il comportamento rigidamente meccanico di ciò che pure nel gioco vale come un essere dotato di un’autonoma volontà a far ridere il bambino.
Un comportamento rigidamente meccanico applicato a ciò che è (o immaginiamo che sia) vivente: su questa tesi dobbiamo riflettere perché per Bergson circoscrive in modo sufficientemente preciso l’ambito del comico.
Molti esempi di comicità possono esserle immediatamente ricondotti: una marionetta ci fa ridere perché i suoi gesti sono rigidi e meccanici, ed è per questa stessa ragione che ci sembra ridicolo chi – giunto in fondo alle scale – tenta di scendere anche da un ultimo inesistente gradino, con un gesto goffo che non è motivato da un fine reale, ma solo dal meccanismo acquisito della discesa. Altri invece ci costringono a disporci nella prospettiva propria dell’immaginazione che con le definizioni non procede con la stessa metodica precisione dell’intelletto: così, non dobbiamo stupirci se il topos della meccanicità si estende per l’immaginazione fino a coprire campi che non sembrano in senso stretto spettarle. Per l’immaginazione una macchina È innanzitutto ripetitiva: di qui la comicità che sorge dalla ripetizione dei gesti, delle azioni, dei pensieri. “Due volti simili, ciascuno dei quali preso isolatamente non fa ridere, presi insieme fanno ridere per la loro somiglianza” – diceva Pascal, e tutti sappiamo come un tic fisico o intellettuale (una frase, sempre la stessa, ripetuta troppo di sovente) sia causa di ilarità. Ma un meccanismo non è solo ripetizione: è anche – a dispetto del movimento – staticità. Una macchina è inchiodata alla sua funzione: così, chi voglia fare una caricatura, saprà farci ridere solo a patto di ritrarre nel volto una piega espressiva solidificata in un tratto stabile della fisionomia, un’espressione cui la macchina dei lineamenti non sa più sottrarsi. Nell’immagine della macchina si cela infine anche l’idea dell’ostinazione cieca, del movimento che non sa più aderire al presente, ma segue una regola tanto fissa quanto sorda alle esigenze del momento. Basta dunque che questa immagine si sovrapponga alla vita umana perché il riso si faccia avanti. Una simile sovrapposizione si ha per esempio
quando l’anima ci si mostrerà contrariata dai bisogni del corpo – da un lato la personalità morale con la sua energia intelligentemente variata, dall’altra il corpo stupidamente monotono interrompente sempre ogni cosa con la sua esigenza di macchina. Quanto più queste esigenze del corpo saranno meschine ed uniformemente ripetute, tanto più l’effetto sarà vivo (ivi, p. 33).
Non è dunque un caso – commenta Bergson – se i personaggi tragici debbono tenersi lontani da gesti che tradiscano le esigenze della corporeità, mentre il commediografo potrà senz’altro ottenere il riso del pubblico rappresentando i suoi personaggi comici in preda a un malanno o ad un fastidioso singhiozzo che interrompe ogni loro discorso.
Proprio come la vita dello spirito può essere ostacolata nel suo realizzarsi dalle esigenze della macchina corporea, così la forma della vita sociale può soffocarne il senso. La lettera – le regole e le convenzioni sociali – si sovrappone alla sostanza – la vita in comune, e dalla contemplazione di questo travestimento della vita sorge la comicità: il deputato che interpellando il ministro su di un assassinio famoso rammenta che il colpevole, dopo aver ucciso la vittima, È sceso dal treno in senso contrario alla sua direzione, violando così il regolamento, è – per Bergson – comico perché in lui l’adesione alla regola ha soffocato la comprensione della vita.
Potremo soffermarci ancora sulle strade che l’immaginazione comica percorre, e non sarebbe difficile mostrare come a partire dalle poche cose che abbiamo detto possano comprendersi le ragioni che ci spingono a ridere dei travestimenti o – e su questo punto dovremo in seguito ritornare – dei vizi di natura morale. Per ora ci basta invece il risultato cui siamo pervenuti: ciò di cui ridiamo è – per Bergson – tutto ciò in cui l’immaginazione scorge una sorta di meccanicizzazione della vita.
4. Il riso come castigo sociale. La comicità morale e la funzione sociale della commedia. Le considerazioni che abbiamo sin qui svolto ci permettono di formulare ora, senza ulteriori indugi, una risposta alla domanda da cui avevamo preso le mosse, – la domanda sul fine che il riso persegue. Il riso – avevamo osservato – deve avere una funzione sociale, e sorge – aggiungiamo ora – dalla constatazione di una sorta di contraddizione: ciò che dovrebbe comportarsi in modo libero e vivo sembra assoggettare i suoi gesti a leggi meccaniche, alla cieca ostinazione del meccanismo. Al riso spetta dunque il compito di sanare questa contraddizione, richiamando quella parte della società (reale o immaginaria) che è colpevole di un comportamento rigido e ostinato ad un atteggiamento più elastico, ad uno stile di vita più duttile e desto. Il riso è quindi un castigo sociale:.
È comico – scrive Bergson – qualunque individuo che segua automaticamente il suo cammino senza darsi pensiero di prendere contatto con gli altri. Il riso è là per correggere la sua distrazione e per svegliarlo dal suo sogno. […]. Tutte le piccole società che si formano sulla grande sono portate, per un vago istinto, ad inventare una moda per correggere e per addolcire la rigidità delle abitudini contratte altrove, e che sono da modificare. La Società propriamente detta non procede diversamente: bisogna che ciascuno dei suoi membri stia attento a ciò che gli È intorno, si modelli su quello che lo circonda, eviti infine di rinchiudersi nel suo carattere come in una torre di avorio. Perciò essa fa dominare su ciascuno, se non la minaccia di una correzione, per lo meno la prospettiva di un’umiliazione che per quanto leggera non è meno temibile. Tale si presenta la funzione del riso. Sempre un po’ umiliante per chi ne è l’oggetto, il riso è veramente una specie di castigo sociale (ivi, pp. 88-9).
Di questa funzione sociale del riso, la commedia È per Bergson un’espressione esemplare. Tra tutte le forme di comicità una in particolare sembra stringere un rapporto strettissimo con la sfera sociale: È la comicità morale. Le passioni spesso si prendono gioco di noi e subordinano tutte le nostre azioni ad un unico meccanismo. E’ questo ciò che accade ai personaggi comici di molte commedie: lo spettatore È chiamato a ridere di un uomo, i cui gesti sembrano quelli di una marionetta, mossa da un burattinaio – la gelosia, l’avarizia, la pavidità, ecc. – che ci è ben noto e di cui sappiamo prevedere i movimenti. Di qui la forma di tante commedie che hanno per protagonisti non già individualità ben determinate, ma personaggi tipici, marionette dietro alle quali traspare la passione che li domina. Ma di qui anche il fine che si prefiggono: correggere, ridendo, i costumi. Alle forme propriamente artistiche, caratterizzate dall’assoluta assenza di finalità pratiche si deve contrapporre dunque la commedia, che è – per Bergson – una forma artistica spuria, proprio perché affonda le sue radici nella vita e perché alla vita ritorna come ad un valore da salvaguardare e cui sottomettere i propri sforzi.
Vi è tuttavia una seconda ragione che spinge Bergson a dedicare tanto spazio alle considerazioni sulla commedia, ed è propriamente il carattere per così dire teatrale della comicità. Possiamo ridere soltanto quando la rigidità di un carattere o di un comportamento si fa gesto e si mostra apertamente agli occhi dell’immaginazione: non ci basta sapere che la paura della morte ha trasformato Argan in un burattino; per ridere dobbiamo vedere i gesti in cui la riduzione dell’uomo a cosa si fa spettacolo. Ma lo spettacolo comico implica uno spettatore che sappia per un attimo guardare alla vita come ad una rappresentazione teatrale:
Da ciò il carattere equivoco del comico. Esso non appartiene né completamente all’arte, né completamente alla vita. Da un lato i personaggi della vita reale non ci farebbero mai ridere se noi non fossimo capaci di assistere alle loro vicende come ad uno spettacolo visto dall’alto di una loggia; essi sono comici ai nostri occhi solo perché ci danno la commedia. Ma d’altra parte, anche a teatro, il piacere di ridere non è puro, cioè esclusivamente estetico, assolutamente disinteressato. Vi si associa sempre un pensiero occulto che la società ha per noi quando non l’abbiamo noi stessi; vi è sempre l’intenzione non confessata di umiliare e con ciò, è vero, di correggere, almeno esteriormente” (ivi, p. 89).
Il riso sorge così come un gesto che per strappare la vita dalla sua negazione implica una momentanea sospensione della vita stessa: È dunque una contemplazione della vita volta a sanare i pericoli che la mettono in forse.
5. Il riso e la metafisica bergsoniana. Nonostante la sua indubbia coerenza e la sua capacità di far luce su di un aspetto importante del comico, il saggio di Bergson sembra lasciare aperto più di un problema. Ciò che in particolare colpisce il lettore è forse il trovarsi di fronte ad un saggio che con tanto vigore sottolinea la funzione sociale del riso, senza tuttavia sfociare in un’indagine di natura sociologica che – tra le altre cose – ci mostri quali sono i processi di apprendimento del riso. Perché almeno questo è chiaro: se il riso è un gesto sociale che appartiene alla forma di vita propria dell’uomo, allora deve esistere qualcosa come un addestramento al riso, – un addestramento che insegni al bambino quali sono i vizi e i difetti di cui ridere e quando È opportuno riderne.
In realtà, basta dare uno sguardo alle brevi considerazioni che Bergson raccoglie intorno a questi problemi per rendersi conto che le sue analisi si muovono in un’altra direzione. Se con Bergson indichiamo quali siano i “difetti” censurati dal riso siamo innanzitutto ricondotti a ciò che ci rende non tanto immorali, quanto poco adatti alla società, ma dobbiamo poi – in secondo luogo – rammentare che troviamo comiche anche le fisionomie buffe nelle quali l’immaginazione può scorgere un irrigidimento della vita espressiva, ma in cui sarebbe insensato scorgere un problema per la società. Se il riso È un castigo sociale, allora si deve aggiungere che talvolta sembra castigare anche là dove non ce n’è alcun bisogno.
Non solo: di un vizio morale come l’avarizia o la gelosia, noi non sempre ridiamo, poiché – osserva in primo luogo Bergson – il riso chiede che il vizio da castigare non ci coinvolga troppo da vicino e ci permetta di mantenere la posizione dello spettatore.
In secondo luogo, tuttavia, Bergson attira la nostra attenzione sul fatto che uno stesso vizio – l’avarizia, per esempio – pu• talvolta suscitare il riso, talvolta il nostro disprezzo. Ora, la diversità della reazione non dipende solo dalla gravità della colpa, ma soprattutto dal modo in cui questa si palesa. E ancora una volta il cammino da seguire ci È indicato dall’esperienza letteraria. Gli eroi tragici ci rivelano il loro carattere nelle azioni, e con azioni Bergson intende i comportamenti volontari della soggettività. Il personaggio comico invece si rivela nei gesti, e cioè in quei movimenti e in quei discorsi nei quali uno stato d’animo si manifesta senza scopo e senza alcuna premeditazione. Nell’azione la persona intera è in gioco, nel gesto una parte isolata della persona si esprime all’insaputa o (per lo meno) in disparte dell’intera personalità (ivi, p. 94). Il gesto – potremmo allora esprimerci così – è una sorta di irruzione improvvisa dell’inconscio nella vita desta, ed è proprio questo carattere di involontarietà e di immediatezza che ci fa apparire comico anche un vizio che detestiamo.
Ma se il comico si esprime nel gesto, anche il riso è a sua volta un gesto sociale (ivi, p. 14) di cui si deve sottolineare l’immediatezza: non bisogna dunque stupirsi se
non ha tempo di osservare sempre dove tocca [… e se] talvolta castiga certi difetti come la malattia castiga certi eccessi, colpendo gli innocenti, risparmiando i colpevoli, mirando verso un risultato generale, senza preoccuparsi del singolo” (ivi, p. 126).
Così, accanto alla tesi secondo la quale il riso sorge come prodotto di un’antica abitudine sociale, Bergson viene sempre più chiaramente sostenendo che “il riso è semplicemente l’effetto di un meccanismo datoci dalla natura” (ivi, p. 126). Ed in questa prospettiva, il problema di un addestramento al riso non si pone, poiché il riso ci appare come una manifestazione diretta della natura, come una difesa immediata della vita che È la vita stessa a donarci, armandoci di una sorta di istintiva reazione alla comicità. Se dunque Bergson non si impegna sul terreno delle considerazioni sociologiche è proprio perché intende rispondere alla domanda sulle origini del riso sul terreno di una autentica metafisica della vita, che del resto si fa percepire in vari passaggi del saggio bergsoniano. La nostra immaginazione – scrive Bergson –
ha una sua filosofia ben salda; in tutte le forme umane essa scorge lo sforzo di un’anima che foggia la materia, anima infinitamente agile, eternamente mobile sottratta al peso perché non è la terra che l’attira… Con la sua leggerezza alata quest’anima comunica qualcosa al corpo che anima: l’immaterialità che passa così nella materia è ciò che si chiama grazia. Ma la materia resiste e si ostina. Essa attira, e vorrebbe convertire la propria inerzia e fare degenerare in automatismo l’attività sempre sveglia di questo principio superiore […]. Laddove la materia riesce a far crassa esteriormente la vita dell’anima, irrigidendone il movimento ed ostacolandone la grazia, ottiene dal corpo un effetto comico (ivi, pp. 19-20).
Non è difficile scorgere in queste pagine (o in quelle in cui si deducono le leggi della comicità dalla diretta negazione della nozione metafisica di vita) il germe di quella filosofia che troverà poi nell’Evoluzione creatrice la sua configurazione definitiva. La lotta tra l’urgere dinamico e multiforme della vita e la resistenza cieca e sorda che la materia le impone trova già qui, nella disamina sul comico, la sua prefigurazione. Così, non ci si deve stupire se l’abitudine al riso È tanto antica da affondare le sue radici in un meccanismo della natura (ivi, p. 126): il riso è sì un castigo sociale, ma le sue origini non appartengono alla società, ma alla vita stessa e debbono essere quindi viste sullo sfondo della lotta tra lo slancio vitale e l’inerzia della materia.
E se ci si pone in questa prospettiva, le considerazioni bergsoniane vengono a collocarsi nell’orizzonte problematico di una filosofia della vita, – un orizzonte cui già alludevano le pagine di Schopenhauer.
L’UMORISMO SECONDO PIRANDELLO
1. Le fonti. Al nome di Pirandello si lega innanzitutto un’ampia produzione letteraria che abbraccia opere di teatro, racconti e romanzi, e che fa del suo autore una delle figure più significative del panorama della letteratura europea del Novecento. Tuttavia, accanto al Pirandello letterato, vi è anche un Pirandello saggista che approfondisce con gli strumenti della critica e della riflessione filosofica alcuni temi della sua opera letteraria. È in questa luce che si colloca L’umorismo, un saggio pubblicato nel 1908 che raccoglie parzialmente le lezioni tenute da Pirandello all’Istituto Superiore di Magistero di Roma e che si divide n due parti ben distinte: una di carattere storico-letterario, l’altra di natura filosofica. Il libro è dedicato alla memoria della buon anima di Fu Mattia Pascal bibliotecario: il Pirandello filosofo si riconnette così al Pirandello letterato, impedendoci di tracciare un confine troppo netto tra gli ambiti della sua produzione.
2. L’essenza dell’umorismo. Tra le prime reazioni al saggio pirandelliano vi fu una breve recensione di croce, pubblicata nel 1909 su “La Critica”. Croce sembra essere in parte infastidito dallo spettacolo di un letterato che da filosofo affronta un tema – l’umorismo – senza nemmeno soffermarsi su ciò che egli aveva a suo tempo scritto su questo argomento. E tuttavia, al di là di queste motivazioni di basso profilo, all’origine della polemica vi è una differenza di natura teorica: per Croce, infatti, un’essenza dell’umorismo non vi è, poiché vi è soltanto l’atteggiamento storicamente mutevole che i singoli umoristi assumono nelle loro opere. Vi sono umoristi, ma non l’umorismo: cercare di fissarne l’essenza significa allora, per Croce, perdersi nelle analisi psicologiche tanto care alla cultura positivistica, ma così lontane dalle prospettive dell’idealismo storicistico verso cui Croce sente di doversi orientare.
Al contrario, le pagine pirandelliane sono caratterizzate dalla convinzione che un’essenza dell’umorismo vi sia e che debba essere indagata proprio nei termini psicologici suggeriti dalla cultura positivistica ed in particolare da Theodor Lipps – un autore che Pirandello critica, ma da cui almeno in parte dipende. Così Pirandello si discosta sin da principio da ogni tentativo di rendere conto della natura dell’umorismo nei termini di un’indagine storico-letteraria: a suo avviso, l’umorismo non è affatto una forma dello spirito sorta nella letteratura moderna dell’Europa settentrionale, come pure si era più volte sostenuto. L’umorismo non è una categoria storica, ma è un concetto che circoscrive un comportamento umano relativamente stabile nel tempo e comunque indagabile con gli strumenti dell’indagine psicologica. Su questo punto, dunque, Pirandello è vicino allo psicologismo di fine Ottocento, anche se, come vedremo, la riflessione sull’umorismo si staglia su di uno sfondo di natura esistenziale: l’analisi dei meccanismi psicologici dell’umorismo diviene così una riflessione tipicamente novecentesca su di una struttura di fondo dell’esistenza, su un modo di atteggiarsi dell’uomo rispetto alla propria vita ed al mondo.
3. Ironia e umorismo: l’Orlando furioso e il Don Quijote. Per venire a capo della natura dell’umorismo, Pirandello segue la via di una caratterizzazione per contrasto: si chiede cioè che cosa differenzi l’atteggiamento umoristico da quello ironico. Ora, il materiale che permette di tracciare questa distinzione può essere ricavato dalla storia della letteratura, e più precisamente dalla contrapposizione di due grandi opere che affrontano in una differente prospettiva il mondo antico degli ideali cavallereschi: l’Orlando furioso e il Don Quijote. L’Orlando furioso è, per Pirandello, il poema ironico per eccellenza. Il sorriso dell’ironia ha una sua funzione negativa: richiama il soggetto dall’oggetto, negandolo, e mostra come l’io non si perda nel mondo che descrive. Questa dunque è la funzione del riso cui Ariosto ci invita: Ariosto, scrive Pirandello, descrive infatti un mondo epico cui non crede più, e lo descrive lasciandoci ogni tanto percepire la sua estraneità ai valori del mondo cavalleresco. Così, anche senza addentrarsi nella trama dei significati che spettano al concetto ariostesco di finzione, risulta con chiarezza come l’ironia si giochi proprio sul crinale che separa l’illusione della favola dalla sua illusorietà, l’adesione ingenua del lettore alla narrazione dalla sua complicità con l’autore che ne svela la natura fantastica. Pirandello chiarisce bene il suo pensiero con una breve citazione dal poema ariostesco. Ruggiero è sull’ippogrifo – questa iperbole della velocità e della leggerezza – e vola alto nelle regioni aeree del cielo. Ma, avverte Ariosto, resta tuttavia un uomo, fatto di greve miscela terrestre: “Non crediate, signor, che però stia / per sì lungo cammin sempre sull’ale: / Ogni sera all’albergo se ne gia / schivando a suo poter d’alloggiar male”. Nella favola, commenta Pirandello, diviene evidente la realtà; il sogno si spezza, poiché il sognatore ci avvisa di essere ben desto: il sorriso ironico dell’autore ci strappa alla finzione aerea dell’ippogrifo e ci ricorda la stanchezza dei viaggi e le piccole quotidiane preoccupazioni del viaggiatore.
Alla funzione negatrice dell’ironia si contrappone la natura intimamente contraddittoria dell’umorismo: dall’Orlando furioso dobbiamo muovere al Don Quijote. Anche le pagine di Cervantes ci fanno spesso ridere, e il riso in questo caso non sorge per ridestarci da qualche finzione, ma per mostrarci nella realtà quanto alla realtà siano inadeguati i sogni e gli ideali del “cavaliere dalla triste figura”. Don Quijote scambia per giganti i mulini a vento, e noi lettori ridiamo per la cecità di quest’uomo imbevuto di favole, per la sua incapacità dio accettare la prosaicità del reale, il suo necessario scarto rispetto ai sogni della nostra immaginazione. E tuttavia il gesto comico del cavaliere che si fa disarcionare da un innocuo mulino a vento non è solo fonte di riso: ci costringe anche a pensare al nostro rapporto con il mondo, al nostro avere da tanto tempo rinunciato a cercare nel mondo reale il mondo fantasticato.
Il mondo degli ideali è diventato il mondo dei sogni, ed il lettore di Cervantes, non appena si rende conto che ridicola è proprio la grandezza e la nobiltà di Don Quijote, può ridere solo di un riso amaro. Il sorriso umoristico può nascere solo sulle ceneri del riso comico e sorge non appena comprendiamo che nel gesto ridicolo di Don Quijote si fa avanti una critica disperata della realtà, una critica che ha nel suo fallimento qualcosa di altamente tragico.
Di qui possiamo muovere per trarre le prime conclusioni: il riso umoristico non ha la pienezza ingenua della comicità, ma è venato da un sentimento contrastante che lo limita e lo contiene. Così, quando passiamo dalla comicità all’umorismo, il riso si fa amaro: certo, ridiamo ma insieme commiseriamo la sorte di chi pure troviamo ridicolo. Alla base dello stato d’animo che l’umorismo ci procura vi è dunque una vera e propria contraddizione emotiva: scherno e compassione si legano insieme e il riso si smorza e si vela di tristezza.
A questa contraddizione sul terreno emotivo fa da eco e da fondamento la contraddittorietà dei rapporti del soggetto umoristico con il mondo. Per tornare ancora una volta al nostro esempio: come lettori di Cervantes, ridiamo della lotta contro ai mulini a vento perché noi, gente compita, mai ci impegneremmo in un simile sciocco confronto. Eppure, non appena prendiamo le distanze dal mondo di Don Quijote e ci sentiamo così lontani dalle sue stranezze da poterne ridere tranquillamente, ecco che il suo mondo si fa nuovamente presso di noi: non siamo come Don Quijote, ma siamo pure uomini come lui, siamo forse più cinici e disillusi, ma egualmente ogni tanto ci abbandoniamo alla dolcezza ingenua dell’incanto. All’ironia e alla sua funzione negatrice si contrappone così l’umorismo in cui si esprime un atteggiamento apertamente contraddittorio.
4. Il sentimento del contrario. Nella definizione del concetto di umorismo o meglio nella descrizione di “quell’intimo processo che avviene, e che non può non avvenire, in tutti quegli scrittori che si dicono umoristi” (ivi, pp. 133-4) Pirandello dipende senz’altro da Lipps, e per Lipps l’umorismo affonda le sue radici nella comicità poiché è appunto un superamento del comico attraverso il comico.
Ora, per Pirandello come per altri autori, la comicità sorge dalla constatazione dell’inadeguatezza di un comportamento, di un modo di dire, di un gesto o anche soltanto di un viso: ci basta infatti imbatterci in una donna anziana truccata vistosamente, quasi a suggerire l’immagine di una giovinezza ormai inesorabilmente passata, perché – nota Pirandello – il riso si faccia avanti.- di qui la definizione proposta da Pirandello: la comicità nasce dall’avvertimento del contrario. La realtà non è come ci si vorrebbe far credere, e ridendo esprimiamo il nostro verdetto di condanna sulle apparenze e ribadiamo la loro difformità dal vero.
Dalla comicità passiamo tuttavia all’umorismo quando il contrasto non è più soltanto avvertito, ma è per così dire colto in tutta la pienezza del suo significato: l’umorismo è appunto il sentimento del contrario.
Non si tratta di definizioni ben scelte, anche perché esse illuminano soltanto l’esito finale di quell’intimo processo che Pirandello ha cuore. Tuttavia, se non ci fermiamo alle parole, ma cerchiamo di far luce sul loro significato, il senso della proposta pirandelliana si fa più chiaro e convincente. L’umorismo poggia sul terreno mobile della comicità: ha origine dunque dall’avvertimento del contrario e dalla condanna che, ridendo, pronunciamo. Ma l’umorismo è superamento della comicità: implica dunque la presenza di un operatore nuovo – la riflessione – che ci permetta di lasciare alle nostre spalle la comicità.
Due sono le funzioni che la riflessione esercita. La prima consiste nel mettere a distanza noi stessi: la riflessione ci permette di infatti di analizzare freddamente i nostri stati d’animo, ci consente di giudicarli, vagliando e soppesando i motivi che li hanno determinati (ivi, p 135). Di qui il secondo compito cui la riflessione assolve: riflettendo sui nostri stati d’animo, impariamo anche a relativizzarli, a cogliere le ragioni di ciò che avevamo precedentemente negato.
Torniamo allora alla situazione comica da cui avevamo precedentemente preso le mosse: dalla vecchia che si maschera da giovane e che, proprio per questo, desta lo spirito critico della comicità. Questa volta tuttavia il riso non riempie per intera la coscienza, ma cede la scena alla riflessione che ci mostra ciò che di ingenuo è racchiuso nel gesto di negazione della soggettività: certo, è ridicolo chi non sa accettare il trascorrere el tempo, ma è ben vero che basta riflettere un poco per scoprire che tutti cewrchiamo di esorcizzare la vecchiaia e la morte. Ridiamo, ma la riflessione ci costringe a scoprire le ragioni di ciò che è deriso, apre una breccia nello stato d’animo che ci separa dall’altro e riscopre una comunanza che la comicità aveva negato. Continuiamo ad avvertire il contrario che ci fa ridere, ma ora ne avvertiamo le ragioni e impariamo a scorgere nell’inadeguatezza comica una contraddizione insita nella stessa natura umana:
la riflessione – commenta Pirandello – lavorando in me, mi ha fatto andar oltre quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico (ivi, p. 135).
5. La riflessione e la letteratura umoristica. Sottolineare il ruolo della riflessione nell’umorismo è importante anche perché Pirandello muove di qui per indicare alcuni tratti caratteristici dello stile delle opere umoristiche. L’umorismo chiede che il soggetto non sia dominato dalle passioni: l’umorista dovrà saper raccontare senza “lasciarsi prendere la mano” dalla storia che viene narrando.
Di qui alcuni tratti caratteristici della letteratura umoristica. In primo luogo la sua tendenza alle digressioni: l’umorismo spezza di frequente l’unità della trama per inserire un nuovo e differente punto di vista che permetta di relativizzare l’intreccio delle passioni e dei sentimenti. Questo stesso obiettivo può tuttavia essere raggiunto, in secondo luogo, grazie all’intervento diretto dell’autore che, commentando in qualche modo gli eventi, ci costringe ad abbandonare la nostra posizione di lettori, immersi nella vicenda, per divenire ad un tratto solidali con una posizione ad essa esterna, con una prospettiva che, proprio per essere sita al di là della trama, può facilmente divenire umoristica.
Nel raccogliere queste poche osservazioni, Pirandello sembra pensare ad autori come Manzoni o Sterne: nei tratti che abbiamo appena indicato non sarebbe tuttavia illegittimo scorgere anche alcune delle caratteristiche più tipiche dello stile pirandelliano.
6. L’umorismo e la filosofia di Pirandello. Prima di concludere le nostre considerazioni vorremmo chiederci quali sono le ragioni che spingono Pirandello a riflettere con tanto impegno su questo tema. Ora, la risposta a questo interrogativo traspare nelle ultime pagine del suo saggio e può essere formulata così: l’umorismo è un tratto essenziale della condizione umana e fa tutt’uno con la filosofia della vita che anche in questo saggio Pirandello fa sua.
La prima significativa opera in cui Pirandello delinea una filosofia dell’esistenza e della condizione umana è senz’altro Il fu Mattia Pascal, ed è proprio alla buon’anima di quel bibliotecario che è dedicato il saggio sull’umorismo. Si tratta di una scelta su cui è opportuno riflettere e che ci costringe innanzitutto a far luce sull’elemento umoristico del romanzo, un elemento che traspare con chiarezza nell’apologo finale che ci presenta Mattia Pascal nell’atto di deporre fiori sulla sua tomba.
Vi è un senso in cui questa scena è senz’altro comica: quale gesto può sembrarci più ridicolo e sciocco che portare fiori sulla tomba di un vivo? E tuttavia l’avvertimento del contrario può facilmente trapassare nel suo sentimento: non solo Mattia Pascal, ma ogni uomo seppellisce se stesso poiché rimane impaniato nelle forme morte dell’esistenza, in quelle convenzioni ed abitudini che si sedimentano col tempo, rendendo invisibile il fluire continuo della vita che al di là da esse scorre inesorabilmente.
In questa filosofia della vita, in cui è chiara l’eco di Bergson o di Simmel, non è difficile scorgere la genesi di molti temi pirandelliani, ed anche la sua dottrina dell’umorismo affonda qui le sue radici. Sostenere che la vita si è persa ed arenata nelle sue morte forme vuol dire infatti alludere ad una situazione, in ultima istanza, comica: l’uomo è diventato prigioniero delle convenzioni e le sue azioni rammentano quelle di un burattino – e il burattino è un luogo classico della comicità.
Dalla comicità all’umorismo il passo è breve: basta rendersi conto che l’irrigidimento della vita che ci spinge a ridere di un qualche personaggio è in realtà un tratto caratteristico della natura umana. Il riso ingenuo e aperto che sorge non appena cogliamo nei gesti di un uomo la meccanica rigidità del burattino, si vena di tristezza e di amarezza non appena impariamo a ritrovare nel burattino l’uomo. L’atteggiamento umoristico si pone così, in Pirandello, come il frutto cui conduce un’amara filosofia dell’esistenza.
LUCREZIO VISTO DA BERGSON
Un professore di liceo, dinoccolato, dalla voce suadente, appassionato indagatore di un pensiero filosofico meno canonizzato, più ‘indiscreto’, poetico, fantasioso; un giovane studioso alla ricerca delle parole e dei concetti della filosofia, ma soprattutto della loro emanazione, dell’immagine che ne scaturivano. Era così Henri Bergson quando, a 25 anni, nel 1883 preparò per i suoi studenti un saggio su Lucrezio e il De rerum natura , analizzandone dei brani e lavorando anche sulla lingua del grande poeta-scienziato latino. Poeta, scienziato ma per Bergson soprattutto filosofo e sottile comunicatore di idee, dubbi, stimolazioni intellettuali, al punto che la stessa bellezza dei versi è come il veicolo gentile di una costante intenzione culturale. ‘ Si figurerà Lucrezio ‘ scrive Bergson nella premessa ‘ come un poeta che ha descritto la vita dei primi uomini, o gli effetti del fulmine, o la peste di Atene, per il piacere di descriverli. Al contrario, Lucrezio ha sempre descritto per dimostrare qualcosa; le sue rappresentazioni meglio riuscite sono destinate unicamente a farci capire, a farci accettare qualche grande principio filosofico ‘. Il poema di Lucrezio è dunque per Bergson in primo luogo un pensiero con cui confrontarsi, una sfida, anticipatrice di secoli, di una riflessione sulle cose del mondo, della vita, della natura, dei loro fenomeni comprensibili e incomprensibili; una riflessione guidata e sorvegliata da una intelligenza materialistica e atea, attraversata (come è anche giusto che sia per un poeta vissuto a Roma nel primo secolo avanti Cristo), dall’eco della mitologia e della fascinazione della poesia. ‘ Le idee mitologiche non hanno perso completamente il loro potere sulla mente del poeta. Malgrado egli dichiari che gli dèi non intervengono affatto nel mondo, che tutti gli esseri sono aggregazione di atomi, tutti i fenomeni dei movimenti di atomi, ogni tanto, senza che egli se ne accorga, affiora in lui la concezione pagana di una natura vivente, personificata ‘. Non so se l’inciso bergsoniano ‘ senza che lui se ne accorga ‘ sia l’esatta traduzione del testo (per la prima volta in edizione italiana, Lucrezio ); poichè la lettura plurale che Bergson fa del poema giustifica pienamente l’immaginazione e le finzioni poetiche di Lucrezio come necessarie alla sua visione scientifica e oggettiva della realtà fenomenica. Ed è evidente che un osservatore come Lucrezio non si lasciasse cogliere di sorpresa da nulla, nemmeno dalla sua poesia. E a questo punto che nell’introduzione di Laura Boella si facesse cenno, per analogia, a Leopardi (che giudicò Lucrezio ‘la prima voce’ dell’epoca latina), avrebbe giovato alla comprensione ‘attuale’ della filosofia tutta particolare e fuori sincrono di Lucrezio, perchè così è stato anche per il pensiero che struttura la poesia leopardiana. Non a caso Bergson scrive che ‘ ciò che più colpisce nell’opera di Lucrezio è la profonda malinconia. Il poema della natura è triste e scoraggiante […] I piaceri sono ingannevoli, non vi è gioia assoluta, e anche da ciò che è fonte di piacere esala una sorta di amarezza che, in mezzo ai profumi e ai fiori, ci serra la gola. ‘ Tuttavia, di questa natura crudele Lucrezio vuole trarre le ragioni, la ragione del vivere: la poesia può farne cogliere gli elementi angosciosi, la scienza, l’osservazione ne fanno scoprire i misteri e la bellezza. ‘ Particolare ammirevole ‘ scrive Bergson ‘ , Lucrezio scorge nella natura, al tempo stesso, ciò che interessa il geometra e ciò che seduce il pittore ‘. Da questa notazione si capisce quanto Lucrezio sia stato la cellula originaria, germinatrice del bergsonismo della ‘materia e memoria’ e della ‘evoluzione creatrice’ . Saper vedere più cose in una sola, è questa la lezione di Lucrezio che Bergson ha estratto come fondamento dello slancio creativo e intuitivo dell’intelligenza umana.
Tratto da La Repubblica del 30 agosto 2001.
PASSI TRATTI DALLE OPERE
Analisi della memoria
Del resto questo è ciò che la coscienza constata senza fatica tutte le volte che, per analizzare la memoria, segue il movimento stesso della memoria che lavora. Si tratta di ritrovare un ricordo, di evocare un periodo della nostra storia? Noi abbiamo coscienza di un atto sui generis attraverso il quale ci stacchiamo dal presente per ricollocarci dapprima nel passato in generale, e poi in una certa regione di esso: […]A poco a poco esso appare come una nebulosità che potrebbe condensarsi; da virtuale passa allo stato attuale; e man mano che i suoi contorni si delineano e la sua superficie si colora, esso tende a imitare la percezione. Ma con le sue profonde radici rimane attaccato al passato, e se, una volta realizzato, non risentisse della sua virtualità originaria, se non fosse contemporaneamente uno stato presente e qualcosa che spezza il presente, noi non lo riconosceremmo mai come ricordo.
(Bergson, Materia e memoria)
Il presente come condizione del passato
[…] tra il passato e il presente c’è ben altro che una semplice differenza di grado. Il mio presente è ciò che mi interessa, ciò che vive per me, e, in breve, ciò che mi provoca all’azione, mentre il mio passato è essenzialmente impotente. […]Cos’è per me il momento presente? La caratteristica del tempo è di scorrere; il tempo già trascorso è il passato, e chiamiamo presente l’istante in cui scorre. Ma qui non si può trattare di un istante matematico. […] La materia, in quanto estesa nello spazio, deve essere definita, a nostro avviso, un presente che ricomincia incessantemente, e, inversamente, il nostro presente è la materialità stessa della nostra esistenza, cioè un insieme di sensazioni e di movimenti, e nient’altro che questo. E questo insieme è determinato, unico per ciascun momento della durata, proprio perché sensazioni e movimenti occupano i luoghi dello spazio e perché, nello stesso luogo, non ci possono essere più cose contemporaneamente.
(Bergson, Materia e memoria)
La durata interiore
Io constato anzitutto che passo di stato in stato. Ho caldo ed ho freddo, sono lieto o triste, lavoro o non faccio nulla, guardo ciò che mi circonda o penso ad altro. Sensazioni, sentimenti, volizioni, rappresentazioni: ecco le modificazioni tra cui si divide la mia esistenza e che di volta in volta la colorano di sé. Io cambio, dunque, incessantemente. Ma non basta dir questo: il cambiamento è più radicale di quanto non sembri a prima vista. Di ciascuno dei miei stati psichici parlo, infatti, come se esso costituisse un blocco: dico sì che cambio, ma concepisco il cambiamento come un passaggio da uno stato al successivo e amo credere che ogni stato, considerato per se stesso, rimanga immutato per tutto il tempo durante il quale si produce. Eppure, un piccolo sforzo di attenzione basterebbe a rivelarmi che non c’è affezione, rappresentazione o volizione che non si modifichi di continuo: se uno stato di coscienza cessasse di cambiare, la sua durata cesserebbe di fluire. Il mio stato d’animo, avanzando sulla via del tempo, si arricchisce continuamente della propria durata: forma, per così dire, valanga con se medesimo. Se la nostra esistenza fosse costituita di stati separati, di cui un Io impassibile dovesse far la sintesi, non ci sarebbe per noi durata: poiché un Io che non muti non si svolge, come non si svolge uno stato psichico che resti identico a se stesso finchè non venga sostituito dallo stato successivo. Infatti, la nostra durata non è il susseguirsi di un istante ad un altro istante: in tal caso esisterebbe solo il presente, il passato non si perpetuerebbe nel presente e non ci sarebbe evoluzione né durata concreta. La durata è l’incessante progredire del passato che intacca l’avvenire e che, progredendo, si accresce. E poichè si accresce continuamente, il passato si conserva indefinitamente. La memoria non è la facoltà di classificar ricordi in un cassetto o di scriverli su di un registro. Non c’è registro, non c’è cassetto; anzi, a rigor di termini, non si può parlare di essa come di una “facoltà”: giacchè una facoltà funziona in modo intermittente, quando vuole o quando può, mentre l’accumularsi del passato su se stesso continua senza tregua. In realtà, il passato si conserva da se stesso, automaticamente. Esso ci segue, tutt’intero, in ogni momento: ciò che abbiamo sentito, pensato, voluto sin dalla prima infanzia è là, chino sul presente che esso sta per assorbire in sé, incalzante alla porta della coscienza, che vorrebbe lasciarlo fuori. La funzione del meccanismo cerebrale è appunto quella di ricacciare la massima parte del passato nell’incosciente per introdurre nella coscienza solo ciò che può illuminare la situazione attuale, agevolare l’azione che si prepara, compiere un lavoro utile. Talvolta qualche ricordo non necessario riesce a passar di contrabbando per la porta socchiusa; e questi messaggeri dell’inconscio ci avvertono del carico che trasciniamo dietro a noi senza averne consapevolezza. Ma, se anche non ne avessimo chiara coscienza, sentiremmo vagamente che il passato è sempre presente in noi. Che cosa siamo, infatti, che cos’è il nostro carattere se non la sintesi della storia da noi vissuta sin dalla nascita, prima anzi di essa, poiché portiamo con noi disposizioni prenatali? Certo noi pensiamo solo con una piccola parte del nostro passato; ma desideriamo, vogliamo, agiamo con tutto il nostro passato, comprese le nostre tendenze congenite. […] Il mio stato psichico attuale si spiega con ciò che c’era in me e agiva su di me: analizzandolo, non troverò in esso altri elementi. Ma nemmeno un’intelligenza sovrumana avrebbe potuto prevedere la forma semplice e indivisibile, che dà a tali elementi, affatto astratti, la loro organizzazione concreta: poiché prevedere significa proiettare nel futuro ciò che si è percepito in passato oppure raccogliere in un composto nuovo, diversamente ordinato, elementi già noti. Ma ciò che non è mai stato percepito e che è, insieme, semplice, è necessariamente imprevedibile. Tale è, precisamente, ogni nostro stato di coscienza, considerato come un momento di una storia in via di svolgimento: è semplice, e non può esser già stato percepito, poiché concentra nella sua unità indivisibile tutto ciò che è stato percepito più quello che il presente vi aggiunge. E’ un momento originale di una storia non meno originale.
(Bergson, L’evoluzione creatrice)
L’intuizione
Nell’uomo, la coscienza è soprattutto intelligenza: avrebbe dovuto, avrebbe potuto essere anche intuizione. Intuizione e intelligenza rappresentano due direzioni opposte dell’attività cosciente: la prima, procede nel senso stesso della vita; la seconda, in senso inverso, e come tale è naturalmente regolata sul movimento della materia. Un’umanità compiuta e perfetta sarebbe quella in cui tali forme dell’attività cosciente raggiungessero ambedue il loro pieno sviluppo. […] Di fatto, nell’umanità di cui facciam parte, l’intuizione è quasi completamente sacrificata all’intelligenza. Sembra che la coscienza abbia consumato il meglio della sua forza nella lotta per conquistar la materia e per riconquistare se stessa. Tale conquista, date le condizioni particolari in cui si è realizzata, esigeva che la conoscenza si adattasse alle abitudini della materia e concentrasse su questa la propria attenzione: ossia, che si determinasse specialmente come intelligenza. Tuttavia, l’intuizione sussiste sempre, ancorchè vaga e, soprattutto, discontinua, simile a una lampada quasi spenta, che si rianimi solo a tratti, per brevi istanti. Di queste intuizioni evanescenti, che illuminano il loro oggetto solo a tratti, deve impossessarsi la filosofia, dapprima per sostenerle, poi per dilatarle e per collegarle insieme. Quanto più procede nel suo lavoro, essa si avvede che l’intuizione è lo spirito stesso, e, in un certo senso, la vita stessa: l’intelligenza si ritaglia in essa attraverso un processo che imita quello che ha generato la materia. Solo così si rivela l’unità della vita mentale: ponendosi nell’intuizione per muovere da questa all’intelligenza, perché dall’intelligenza è impossibile passare all’intuizione. Tutti questi problemi rimarranno senza risposta, una filosofia fondata sull’intuizione sarà la negazione della scienza e verrà, presto o tardi, spazzata via dalla scienza, se non si deciderà a cercare la vita del corpo là dove questa effettivamente si trova: sulla via che conduce alla vita dello spirito. Ma in questo caso essa non avrà più da fare con questo o quell’essere vivente: la vita tutt’intera, a partire dall’impulso iniziale che l’ha lanciata nel mondo, le apparirà come un’onda che sale e che si oppone al movimento discendente della materia. Sulla massima parte della sua superficie, ad altezze diverse, la corrente vien convertita dalla materia in un vortice: su un punto solo essa passa liberamente, trascinando con sé l’ostacolo, che appesantirà il suo cammino ma non lo arresterà. In questo punto è l’umanità; e qui sta la nostra posizione privilegiata. D’altra parte, questa onda che sale è la coscienza. La coscienza è essenzialmente libera: è, anzi, la libertà stessa; ma non può attraversar la materia senza modellarsi su di essa, senza adattarsi ad essa. Tale adattamento è ciò che si chiama “intellettualità”. Ora, l’intelligenza, rivolgendosi verso la coscienza agente, cioè libera, la fa rientrare naturalmente negli schemi in cui è avvezza a veder inserirsi la materia. Perciò vede sempre la libertà sotto forma di necessità, trascura sempre la parte di novità o di creazione inerente all’atto libero; sostituisce sempre all’azione un’immagine artificiale e approssimativa di essa, ottenuta associando l’antico con l’antico e l’identico con l’identico. Così agli occhi di una filosofia che si sforza di riassorbire l’intelligenza nell’intuizione, molte difficoltà svaniscono o si attenuano. Ma una tale filosofia non solo rende più facile la speculazione; ci dà altresì più forza per vivere. In virtù di essa non ci sentiamo più isolati nell’umanità, e l’umanità non ci appare più isolata nella natura che essa domina: come il più piccolo granello di polvere è connesso con tutto intero il nostro sistema solare, ed è trascinato con esso in quel moto indivisibile di discesa che è la materialità stessa, così tutti gli esseri organici, dal più umile al più elevato, dalle origini prime della vita sino a oggi, in tutti i luoghi come in tutti i tempi, non fanno che manifestare in modo sensibile un impulso unico, inverso al movimento della materia e, in se stesso indivisibile. Tutti gli esseri viventi sono congiunti insieme, e tutti obbediscono al medesimo formidabile impulso. L’animale ha il suo punto d’appoggio nella pianta, l’uomo nella animalità, e l’umanità intera, nello spazio e nel tempo, è come uno sterminato esercito che galoppa al fianco di ciascuno di noi, avanti e dietro a noi, in una carica travolgente capace di rovesciare tutte le resistenze e di superare moltissimi ostacoli, forse anche la morte.
(Bergson, L’evoluzione creatrice)
TALCOTT PARSONS

Una delle più significative e influenti elaborazioni teoriche prodotte nell’ambito della sociologia novecentesca è quella dello studioso statunitense Talcott Parsons (1902-1979). Nel corso di un’attività intellettuale estremamente intensa Parsons ha rilanciato in seno alla sociologia americana (dedita fino ad allora a indagini quasi soltanto empiriche) l’importanza della riflessione concettuale e metodologica; ha recuperato e ripensato, in modo indubbiamente discutibile ma anche assai stimolante, la grande tradizione durkheimiana e weberiana; ha proposto un’interpretazione del sociale e della sua scienza assai raffinata e complessa. Le sue opere principali – da La struttura dell’azione sociale (1937) a Il sistema sociale (1951) a Teoria sociologica e società moderna (1967) – hanno esercitato una profonda influenza. Al centro della riflessione parsonsiana sta il concetto di azione sociale (in parte tratto dall’opera di Weber). Su un piano generale l’azione è per Parsons ogni comportamento motivato, cioè promosso da determinate cause e finalizzato a determinati obiettivi. Questa prima caratterizzazione parrebbe rinviare implicitamente (in qualche modo privilegiandolo) a un soggetto titolare di tale comportamento, e agente secondo certi interessi e regole. In parte tale rinvio c’è effettivamente, nel senso che Parsons dedica molta attenzione a tali referenti dell’azione (appunto soggetto, interessi, regole). Per un altro verso occorre precisare ch’egli considera unilaterale un’analisi dell’azione in termini esclusivamente soggettivo-motivazionali. L’azione che lo studioso americano ha in mente è in effetti qualcosa di assai più oggettivo e complesso, ossia include molte altre componenti e determinazioni che nulla hanno a che fare con la sfera dell’ego del soggetto e con le sue spinte personali. Fondamentalmente l’azione ha per Parsons quattro principali termini di riferimento: 1) un soggetto-agente , che (si badi) può essere un individuo, ma anche un gruppo, un ceto, o una collettività; 2) una situazione , che include, gli oggetti sia fisico-naturali che sociali coi quali il soggetto entra in rapporto; 3) un insieme di simboli , alla luce dei quali il soggetto vede e valuta elementi della situazione e in proprio stesso agire; 4) un insieme di regole , in rapporto alle quali l’azione si sviluppa e di determina. Ma il fatto essenziale è che l’azione sociale presenta i caratteri di un “sistema”. Ciò implica due cose congiunte: a) che l’azione è composta di elementi relativamente stabili, costituenti una totalità o un insieme organico; b) che tali elementi sono connessi tra loro secondo vincoli relativamente invarianti, e obbedienti a una determinata logica. Più precisamente, per Parsons le condizioni costituenti il “sistema-azione” sono tre; la “struttura”, la “funzione” e il “processo”. La prima si riferisce alla composizione del sistema: un sistema è (o ha) una struttura nel senso che i suoi elementi componenti devono rispondere a certe forme di organizzazione interna. La seconda si riferisce alla modalità d’azione del sistema: gli elementi di una struttura sono correlati tra loro in modo da rispondere dinamicamente a certi bisogni del sistema, e in modo che il gioco bisogni-risposte sia retto da leggi accertabili con precisione. Il terzo si riferisce invece al modus operandi del sistema-azione nel suo complesso; esso esprime il fatto che un sistema-azione¸ produce delle attività, dei mutamenti i quali obbediscono pure essi a determinati norme. È all’esame delle “funzioni” dell’azione sociale che Parsons si è dedicato in modo particolarmente approfondito. Le principali funzioni individuate da tale esame sono quattro: l'”adattamento”, il “conseguimento di scopi”, l'”integrazione” e la “latenza”. L’ adattamento consiste nel rapportarsi del soggetto sociale all’ambiente in modo da ricavarne le risorse di cui ha bisogno, e più in generale nel mediare determinate esigenze (del soggetto) con la situazione “esterna”. Il conseguimento di scopi consiste nell’elaborazione e nella sua messa in atto di strategie mirate¸ di condotta, volte alla conquista di determinati obbiettivi. L’ integrazione consiste in un’opera di tutela e difesa del sistema, attraverso il controllo dello stato dei suoi vari componenti e di un loro appropriato coordinamento. La latenza allude infine alla funzione, o alla necessità, che il sistema abbia una sorta di riserva di energia, o di riserva di motivazione, in grado di alimentare sotterraneamente i componenti del sistema stesso nell’espletamento dei loro compiti. Nella riflessione parsonsiana il concetto di funzione è altrettanto importante di quello di sistema, anche perché è riferibile a realtà più ampie di quelle sociali: non a caso la concezione del sociologo americano è stata definita “funzionalistica”. In effetti, non solo l’azione ma anche l’intero universo umano-sociale viene concepito come un grandioso meccanismo nel quale, al di là della varietà delle manifestazioni concrete visibili, si profilano appunto queste funzioni, in sé autonome eppure anche intrecciate tra loro secondo un complesso gioco di relazioni, le quali operano secondo norme relativamente costanti e sottoponibili a un’analisi scientifico-formale rigorosa. Rispetto al “sistema” dell’azione sociale il ” sistema della società ” occupa solo una parte, benché di grande rilievo. Anche relativamente a questo secondo sistema l’obiettivo dello studioso americano è di individuare le strutture o le funzioni che gli sono proprie. La caratteristica di fondo della società è per Parsons di tendere alla costituzione e alla salvaguardia di una situazione di equilibrio, un’ azione di solidarietà. I soggetti sociali (che non sono necessariamente degli individui ma anche e soprattutto dei gruppi sociali) intrecciano molteplici relazioni tra loro, governate da un complesso insieme di “aspettative” e di “norme”. Tali relazioni possono essere studiate in rapporto alle quattro funzioni fondamentali dell’azione sociale che si sono indicate sopra. Ed ecco che la funzione dell’adattamento diviene nel ‘sistema-società’ l’insieme delle attività riguardanti la produzione e la circolazione dei beni; la funzione del conseguimento di scopi vi diviene l’insieme delle attività riguardanti l’elaborazione di obiettivi collettivi e la mobilitazione di agenti e risorse sociali per realizzarli; la funzione dell’integrazione vi diviene l’insieme degli atti e delle istituzioni miranti a stabilire la coesione sociale; infine, la funzione della latenza vi diviene l’insieme di attività e strutture (culture, insegnamento, famiglia, ecc.) miranti a interiorizzare o ad alimentare i valori della socialità. Non basta. A ognuna di queste sfere corrisponde, per Parsons, una disciplina sociologica distinta. Così lo studio delle attività produttive viene assunto dall’economia; lo studio delle attività riguardanti obiettivi collettivi viene assunto dalla politica; lo studio degli atti e degli istituti di integrazione viene assunto dalla sociologia propriamente detta; lo studio delle attività di interiorizzazione e di sviluppo dei valori sociali viene assunto da discipline come la psicologia, l’antropologia e la scienza dell’educazione. Come si è visto, l’oggetto di quella particolare scienza sociale che è la sociologia è per Parsons il complesso di apparati e dispositivi volti ad affermare la solidarietà e l’integrazione (questo orientamento rinvia palesemente a Durkheim, anch’egli assai attento alla problematica della coesione sociale). Non è qui il caso di illustrare le complesse analisi parsonsiane dei fattori (istituzionali, comportamentali, normativi) operanti in tale prospettiva. Più importante attirare l’attenzione sull’interpretazione complessiva della società e della sociologia che emerge da esse. A questo proposito occorre sottolineare che, se è vero che Parsons ha dedicato non poca attenzione ai fattori della trasformazione sociale, innegabilmente il suo accento cade soprattutto sulla dimensione dell’integrazione e della coesione. Benché presentate in modo per così dire ‘oggettivo’, tali funzioni si configurano spesso, nelle sue pagine, come altrettanti valori – senza che questo passaggio da un discorso descrittivo a un discorso assiologico venga adeguatamente argomentato. Correlativamente , la problematica del conflitto e in parte dello stesso mutamento sociale appare meno approfondita di quella dell’equilibrio e della solidarietà. E proprio questo sarà uno dei temi maggiormente sottolineati dai sociologi più critici nei confronti delle posizioni parsonsiane. In realtà altri sono i limiti più rilevanti dell’autore della Struttura dell’azione sociale denunciati da tali critici. In primo luogo si è contestato il privilegiamento parsonsiano della dimensione in qualche modo ‘umano-soggettiva’ e culturale della realtà sociale; più che alle strutture (e ancor meno alle infrastrutture, soprattutto a quelle economiche) Parsons sembra guardare, come si è visto, all’azione-interazione dei soggetti sociali e al gioco di interessi e di motivazioni, di fini e di norme che le regolano. In secondo luogo si è sottolineato che l’ambizione di costruire una spiegazione unitaria dei fenomeni sociali è costata al nostro autore un prezzo assai alto; per un verso spingendolo sovente a estensioni, generalizzazioni e analogie un pò forzate; per un altro obbligandolo a svolgere un discorso estremamente astratto, non poco distante da certe concrete peculiarità delle strutture e dei processi sociali. L’astrattezza della concezione parsonsiana è poi aumentata dall’evidente predilezione dello studioso americano per il momento (certo importante) della concettualizzazione: una predilezione che lo porta da ultimo a trattare princìpi e modelli non tanto come mezzi per spiegare ‘altro’ (ossia la realtà sociale) quanto come fini ultimi della conoscenza sociologica. Tutto ciò non cancella però il grande rilievo del lavoro teorico di Parsons. Pochi studiosi hanno mostrato in modo più persuasivo di lui la possibilità di realizzare un’analisi rigorosa della realtà sociale. Pochi hanno pensato con più lucidità la duplice esigenza della sociologia di cogliere la specificità dei fenomeni oggetto della propria indagine e, insieme, le organiche relazioni che li legano ad altri fenomeni. Ma il merito maggiore dello studioso americano è di avere generalizzato e rigorizzato in sede sociologica i capitali concetti di funzione e di sistema. Sia il primo che il secondo si sono rivelati strumenti euristici estremamente fecondi per padroneggiare in sede cognitiva la complessità sociale e per collegare tra loro in modo non riduttivo strutture ed eventi in apparenza eterogenei. Assai importante è anche l’intuizione parsonsiana della grande utilità per l’analisi della società di concetti quali quelli di informazione, scambio, equilibrio, input/output e simili.
GUIDO CALOGERO

A cura di Diego Fusaro, Elena Ternullo, Alfio Squillaci
“L´unità della democrazia è l´unità degli uomini che, per qualunque motivo, sentono questo dovere di capirsi a vicenda e di tenere reciprocamente conto delle proprie opinioni e delle proprie preferenze. “
LA VITA
Nato a Roma nel 1904. Laureatosi nel 1925 in filosofia nell’università romana, con Gentile (con una tesi che sarà pubblicata nel 1927 col titolo I fondamenti della logica aristotelica), manterrà con il filosofo del regime rapporti di cordialità e di amicizia, diventando presto uno dei collaboratori più assidui dell’Enciclopedia Treccani e assumendo poi una sorta di responsabilità del settore filosofico. Calogero diceva sempre di sì alle richieste di collaborazione di Gentile, anche se il superlavoro e i frequenti soggiorni di studio in Germania lo costringevano a qualche ritardo. Ma i contatti fra i due erano tutt’altro che burocratici. Si basavano su una vera confluenza di idee e di interessi teorici. Via via che il discepolo chiarì la sua opposizione al fascismo, la questione politica venne tenuta in disparte; mai appannerà l’affetto reciproco. Fin dal 1929, a venticinque anni, Calogero è schedato dalla polizia politica come antifascista. Fatica a farsi rinnovare il passaporto, e senza gli interventi di Gentile non ci riuscirebbe: occorre che ogni anno il Senatore faccia ” una telefonata agli Interni “. Gentile stesso si confiderà con Calogero, dicendogli di evitare gli autori filosemiti (Cassirer), sebbene le leggi razziali non fossero ancora state promulgate. Quella di Calogero diventerà una firma consueta del Giornale critico della filosofia italiana. Non riuscì a dividerli neppure l’incombente presenza di Benedetto Croce nel quadro culturale italiano. In una lettera del 1935, Calogero chiarì a Gentile senza dar adito a dubbi che i suoi maestri erano due: lui e Croce. Calogero, chiamato fin dal 1934 alla cattedra di Storia della filosofia alla Normale, svolgeva dentro e fuori la Scuola attività antifascista clandestina, a partire dai tardi anni Trenta. Strinse amicizia con Bobbio, il quale disse: ” lo conobbi nel 1933 a un congresso hegeliano. M´impressionarono lo sguardo e la bravura “. Ottenuta successivamente la cattedra di filosofia all’Istituto Magistrale di Firenze, tornava spesso a Roma, dove manteneva contatti, abilmente nascosti, con gruppi di opposizione liberale. In Toscana conobbe e frequentò Aldo Capitini, con il quale nacque un forte sodalizio politico. I due si conobbero, prima che di persona, attraverso le proprie opere. Capitini aveva letto La filosofia e la vita , il libro che Calogero aveva pubblicato nel ’36 per la casa editrice Sansoni, e ne apprezzava la dottrina del ‘ moralismo assoluto ‘, che, con quel saggio, cominciava a svilupparsi, come elemento autonomo, dall’idealismo gentiliano. A sua volta, Calogero aveva letto, tra i primi, Elementi di un’esperienza religiosa , trovando forti consonanze con la moralità coniugata all’antifascismo che traspariva dalle pagine del libretto. Dalla collaborazione strettissima tra i due pensatori nacque il manifesto del liberalsocialismo, nel 1937. Anche il nome del movimento nacque da questa collaborazione, in cui era difficile anche per i due teorici distinguere i singoli apporti. Calogero stesso non sapeva attribuire ad uno dei due la paternità del nome: ” nome che non ricordo più se sia stato usato per la prima volta da Aldo Capitini o da me, e che volevamo riecheggiasse quello scelto da Carlo Rosselli “. Ricordando che Capitini non conosceva l’opera di Rosselli, prima della Liberazione, possiamo noi attribuire la paternità del nome a Calogero. Calogero difese poi strenuamente la denominazione del movimento, in una lunga polemica con Croce, svoltasi prima, dal 1940 al 1943, oralmente, poi per iscritto, e continuata anche dopo la Liberazione. Attorno a loro si venivano stringendo le nuove leve dell’antifascismo nazionale, i giovani che si stavano aprendo all’opposizione per reazione alla guerra di Spagna. Si trattava, quindi, di un antifascismo etico-politico, distinto rispetto all’antifascismo sociale delle classi subalterne, che basavano la propria opposizione sull’insostenibilità delle proprie condizioni di vita. Mentre queste ultime si rivolgevano di preferenza, scelto l’antifascismo, ai partiti marxisti, i giovani intellettuali trovavano molto più vicina l’opposizione etico-culturale di Capitini e degli antifascisti laici borghesi. Aderirono al movimento tra i più noti esponenti del liberalsocialismo toscano, basti ricordare Enzo Enriques Agnoletti, Tristano Codignola (figlio di Ernesto, l’ex gentiliano passato all’ opposizione), Luigi Russo, Piero Calamandrei, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Carlo Furno, Alberto Carocci, Carlo Francovich a Firenze. Nel triennio che precedette l’entrata in guerra dell’Italia, l’attività principale del gruppo liberalsocialista consistette nel reclutamento di nuovi adepti. I canali di reclutamento furono di due tipi, Calogero e i liberalsocialisti toscani, inseriti nelle strutture della cultura nazionale (Calogero aveva ottenuto, nel 1937, la cattedra di Storia della Filosofia nell’Università di Pisa, Codignola e Enriques Agnoletti occupavano posti direttivi nella casa editrice La Nuova Italia, Calamandrei era professore di Procedura Civile all’Università di Firenze), le sfruttavano per la propaganda antifascista; Capitini e i suoi amici perugini (insieme a Ragghianti, che a Bologna seguiva la via capitiniana), preferivano, invece, evitare ogni collaborazione con il regime, basandosi su una propaganda diretta. L’entrata in guerra dell’Italia non modificò l’azione dei liberalsocialisti, che era orientata verso un’unione, sempre più stretta, con i gruppi dell’antifascismo borghese. Mentre la collaborazione con cattolici e comunisti era limitata ai contatti individuali, con i giellisti operanti in Italia si giunse presto ad una collaborazione organica. L’assonanza tra il nome del movimento di Capitini e Calogero ed il titolo del libro di Rosselli che diede la base teorica a Giustizia e Libertà non deve far credere ad una coincidenza fra i due gruppi. Come abbiamo visto, il movimento liberalsocialista, dalla nascita, fu privo di influssi rosselliani diretti, e, dedicandosi principalmente all’attività interna, evitò di proposito contatti con l’emigrazione giellista. Altra differenza tra liberalsocialismo e Giustizia e Libertà, sottolineata da Mario Delle Piane, era che ” il socialismo liberale di Rosselli […] è una delle eresie del socialismo, mentre il liberalsocialismo è un’eresia del liberalismo “. Rosselli partiva, infatti, dalle posizioni di Bernstein e De Man, per svilupparle fino all’accettazione completa del metodo liberale: Calogero nasceva invece da una costola di Croce, giungendo fino alla riproposta delle istanze socialiste. In questo modo, i due movimenti erano giunti, da punti di partenza opposti, a conclusioni simili. Fu facile, quindi, trovare punti comuni per una collaborazione organica, in un convegno tenuto ad Assisi, nei primi mesi del ’40, nella casa di Alberto Apponi, e cui parteciparono Calogero, Capitini, Norberto Bobbio, Apponi, Luporini, Codignola, Giuriolo per il movimento liberalsocialista, e Giorgio Agosti, Antonio Zanotti, Francesco Flora ed altri per Giustizia e Libertà. Il movimento raccoglieva sempre nuove adesioni, allentando le pressioni che l’avevano tutelato per quattro anni dall’intervento della polizia. Il primo a cadere nella rete dell’OVRA fu il gruppo pugliese, che venne sgominato quasi completamente all’inizio del 1942. Le indagini si estesero poi a Firenze, dove il 27 gennaio 1942 la polizia politica arrestò Calogero, Enriques Agnoletti, Codignola, Francovich e altri, insieme a Capitini a Perugia e a Ragghianti a Bologna, trasferiti tutti presso le carceri fiorentine delle Murate. Le indagini, molto accurate, durarono quattro mesi. Gli imputati resistettero con fermezza, negando ogni addebito e trasferendo ogni contatto con gli altri accusati sul piano culturale (Capitini portò come elemento di difesa il suo libro, Elementi di un’esperienza religiosa , che passò, dato il titolo, per un’innocua pubblicazione religiosa). In tal modo, la polizia non poté attribuire con certezza agli arrestati i documenti sequestrati e li condannò a pene minime. Capitini fu rilasciato dopo aver ricevuto una diffida. Le pene più gravi furono comminate ad Enriques Agnoletti e al tipografo Bruno Niccoli, condannati a cinque anni di confino perché in contatto anche con i giellisti. Codignola fu condannato a tre anni di confino, Calogero a due anni di confino a Scanno, in Abruzzo, gli altri se la cavarono con diffide e ammonizioni. Già nei mesi precedenti l’arresto del gruppo toscano e di Capitini erano iniziati i contatti tra liberalsocialisti e giellisti, da una parte, e democratici moderati, dall’altra. Soprattutto il gruppo milanese che faceva capo a Ugo La Malfa, Ferruccio Parri e Adolfo Tino premeva per l’unione degli antifascisti non socialisti e non cattolici in un partito che fosse in grado di esplicare un’azione antifascista adeguata al rapido tracollo del regime. Queste pressioni si scontravano con le perplessità di molti esponenti dei due movimenti, tra cui Capitini, nei confronti di una collaborazione organica con gruppi ” piuttosto democratici repubblicani che socialisti “. A questo punto caddero l’arresto e la detenzione dei liberalsocialisti, che li tolsero dal dibattito politico per sei mesi, dal gennaio al giugno. In tal modo rimase campo libero per l’impostazione che La Malfa, il migliore politico del gruppo milanese, intendeva dare al partito: una formazione che si collocasse al centro dello schieramento politico, come partito di governo, espressione della borghesia piccola e media e dei suoi desideri di stabilità. La riunione che decise la nascita del partito, si tenne nella casa romana di Federico Comandini il 4 giugno 1942. Il giorno precedente erano stati inviati al confino i liberalsocialisti arrestati, mentre Capitini subiva la diffida e rientrava a Perugia controllato dalla polizia. Secondo De Luna alla riunione parteciparono La Malfa, Federico Comandini (cognato di Calogero, liberalsocialista ma vicino alle posizioni dei moderati), Mario Vinciguerra ed Edoardo Volterra (amici e collaboratori di Parri, in quel periodo fermato dalla polizia), il liberalsocialista perugino Franco Mercurelli, Vittorio Albasini Scrosati e Alberto Damiani, due giellisti milanesi amici di La Malfa, e due rappresentanti, non meglio identificati, per Italia meridionale e Sicilia. La rappresentanza dei liberalsocialisti era dunque fortemente minoritaria, sia sul piano quantitativo, sia su quello qualitativo. Di fronte ad uno dei più abili politici dell’antifascismo, si trovava, a difendere le ragioni dei ‘movimentisti’, solo una figura di secondo piano. D’altronde, anche la riunione preliminare tenutasi a Milano una settimana prima, nella quale erano stati definiti i ‘sette punti’ programmatici del futuro partito, aveva visto la presenza del solo Giuriolo, tra i collaboratori di Capitini e Calogero. I ‘sette punti’, elaborati da Ragghianti riflettendo le opinioni dei vari gruppi, avanzavano, nel campo economico, le prospettive di “economia a due settori” già teorizzate dai liberalsocialisti e dai giellisti. Sul piano giuridico, si riproponeva la pregiudiziale repubblicana. Mentre su quest’ultimo punto si registrava una completa unanimità, i progetti di nazionalizzazione erano concessioni fatte, per motivi puramente tattici, da La Malfa e dai suoi amici, poco convinti che spettasse al Partito d’Azione realizzare riforme di tipo socialista. Quando i confinati e i diffidati poterono, pur tra mille cautele, riprendere l’attività politica, si trovarono, così, di fronte alla scelta sul cornportamento da tenere nei confronti della nuova formazione politica. La maggioranza dei liberalsocialisti decise, individualmente, di aderire al nuovo partito. Tra questi, i nomi più famosi erano quelli di Calogero, Codignola, Enriques Agnoletti, Delle Piane, Fiore, Cifarelli (oltre a quelli non arrestati, come Apponi, Albertelli, Umberto Morra, Luigi Russo). Prima di accettare, Calogero chiese ed ottenne, da La Malfa, delle Precisazioni , che ribadissero l’importanza delle nazionalizzazioni previste.Nell’aprile e nel maggio del 1943 un’ondata di arresti e di denunce al Tribunale speciale colpì severamente il Partito d’Azione: a Milano furono arrestati Mario Vinciguerra e Antonio Zanotti; a Firenze Carlo Furno, a Siena Mario Delle Piane; a Ferrara Giorgio Bassani, a Modena Ragghianti, a Roma Federico Comandini, Sergio Fenoaltea, Bruno Visentini, a Bari Guido Calogero, Guido De Ruggiero, Tommaso Fiore. Arrestato dalla polizia fascista, Calogero fu condannato al confino a Scanno, in Abruzzo. Qui, nel settembre del ’43, dopo l’armistizio, ritrovò il discepolo Carlo Azeglio Ciampi, che anche per la sua influenza aderì al Partito d’Azione. Nel dopoguerra, Calogero proseguì la sua battaglia per l’affermarsi delle idee liberalsocialiste. Mise al centro della propria riflessione il valore della libertà, ma, riprendendo criticamente i filosofi precedenti quali Hobbes, Hume, Locke e Smith, sosteneva che la libertà individuale non deve essere intesa egoisticamente. Calogero elaborò quindi un’etica dell’altruismo ” tesa ad assumere in chiave laica il messaggio di solidarietà della morale cristiana “.Fu importante anche il suo rapporto con Norberto Bobbio. Rispondendo a Calogero, che nel novembre del ’45 lo invitava a collaborare alla sua nuova rivista “Liberalsocialismo”, Norberto Bobbio scriveva: ” mi interessa e mi piace il programma della tua rivista ( .. ) per quanto l’esperienza ci abbia insegnato che le premesse per una politica ‘liberalsocialista’ in Italia non ci sono, o ci saranno tra due secoli. Faremo i predicatori nel deserto, come del resto abbiamo sempre fatto… “. Dopo lo scioglimento del Partito d’Azione, alle elezioni del ’48, Calogero si schierò con il Fronte Popolare, insieme ad un folto gruppo di intellettuali e di personalità di grande prestigio, da Corrado Alvaro a Salvatore Quasimodo, da Renato Guttuso a Giorgio Bassani. Dal ’49 collaborò con una rubrica fissa a “Il Mondo” di Mario Pannunzio, dalle cui colonne si battè per la scuola laica. Negli anni Cinquanta fu di nuovo al fianco di Capitini, a sostegno dell’azione che Danilo Dolci svolgeva in Sicilia contro la mafia. Da Norberto Bobbio a Carlo Levi, da Elio Vittorini ad Ignazio Silone, da Giulio Einaudi a Riccardo Bauer, forte e convinto venne il sostegno a Dolci. Nel dicembre del 1955 fu tra i fondatori del Partito radicale, inizialmente denominato Partito Radicale dei Democratici e dei Liberali Italiani, insieme a Leo Valiani, Francesco Compagna, Giovanni Ferrara, Felice Ippolito, Franco Libonati, Alberto Mondadori, Arrigo Olivetti, Marco Pannella, Mario Pannunzio, Leopoldo Piccardi, Rosario Romeo, Ernesto Rossi, Nina Ruffini, Eugenio Scalfari, Paolo Ungari. Nel ’58, fece parte della lista repubblicana-radicale per la Camera dei deputati, insieme a Pacciardi e a Luigi Delfini. Nel 1962 fu anche proposto come segretario del partito radicale(al suo posto venne poi eletto Leone Cattani), ma rifiutò per motivi personali. In seguito uscì dal partito, ma rimase vicino ai radicali. Il 30 ottobre del 1966, insieme ad alcuni ex azionisti (Bruno Zevi, Norberto Bobbio, Manlio Rossi Doria), aderì al partito socialista unificato, che riuniva il Psi e il Psdi. Diventato direttore di “Panorama”, nel 1972 rilanciò il tema della doppia tessera (quella radicale e quella degli altri partiti) quale fattore di evoluzione dei partiti verso la costruzione di uno stato moderno a democrazia bipartitica, poiché ” i suoi veri partiti sono sempre e soltanto due, la destra e la sinistra, il partito della conservazione e il partito delle riforme “. Morì nel 1986.
IL PENSIERO
Nella lunga attività di ricerca filosofica di Guido Calogero spicca in primo piano – basta dare una scorsa alla lunga serie di pubblicazioni che ha accompagnato la sua vita accademica – l’attenzione posta ai problemi logici del pensiero antico. In una prima e sommaria periodizzazione interna alle opere e all’attività di Calogero, si può rilevare che l’interesse per tali problemi occupa grosso modo una prima fase della sua ricerca scientifica. In tale ambito si collocano I fondamenti della logica aristotelica (1927), gli Studi sull’eleatismo (1932), i primi quattro capitoli della Storia della logica Antica (1967), nonché l’attiva collaborazione alla “Enciclopedia Italiana” che si sostanziò in una nutritissima serie di voci concernenti la filosofia antica (Socrate, Platone, Senofane, Logica etc) ed infine numerosi studi specialistici, molti dei quali dedicati alla traduzione, con commento ed interpretazione, di dialoghi platonici. I risultati teorici raggiunti in questi studi daranno luogo a una successiva serie di scritti quali La Conclusione della filosofia del conoscere (1938), La scuola dell’uomo (1939) e la progettazione delle Lezioni di Filosofia , che insieme possono costituire una seconda fase, in cui all’attività dello storico della filosofia antica si affianca e in parte si sostituisce l’enucleazione di quei temi che successivamente, con maggiore ampiezza e sviluppo, verranno trattati nella “Filosofia del dialogo”, ultima fase e punto di approdo della più che trentennale attività del Nostro. E’ necessario rilevare, come vedremo in seguito, che la suddetta ripartizione intende sottolineare dei motivi conduttori, non certo isolare cicli di ricerca cronologicamente e tematicamente autonomi, poiché l’intera produzione calogeriana non lo permetterebbe, permeata com’è da una unità di riflessione che, seppure con maggiore o minore grado di sviluppo, attraversa tutta la sua opera. L’interesse di Calogero per gli studi di logica antica ha un’ origine ben precisa che data al 1924, anno in cui Giovanni Gentile riprese l’insegnamento all’Università di Roma dopo la parentesi ministeriale. Calogero seguì con vivo interesse le lezioni di Gentile e se ne entusiasmò a tal punto da decidere di dirottare il corso dei suoi studi, inizialmente avviati nel settore della filologia classica verso la filosofia. L’anno dopo infatti, appena ventunenne, si laureerà con una tesi sulla logica in Aristotele, che successivamente rielaborata darà luogo all’importante volume I fondamenti della logica aristotelica . In questo lavoro Calogero propone, nella forma di un’indagine serrata, aderente filologicamente ai testi, una interpretazione della logica aristotelica pietra angolare del grandioso edificio della logica occidentale che, se sarà decisiva ai fini della sua biografia intellettuale, desterà non di meno interesse e attenzione all’interno della comunità degli studiosi di Aristotele. Erano infatti quelli gli anni in cui un rinnovato interesse si incentrava sull’opera del grande Stagirita. Si pensi, per fare un esempio, agli studi di parte ‘logicista’ intrapresi dalla Scuola di Varsavia (Lukasiewicz, Bochenski, etc) tesi a riconsiderare le vecchie interpretazioni del Trendelenburg, del Prantl. In questa atmosfera si pone lo studio di Calogero ma il suo contributo va in direzione decisamente opposta agli esiti propugnati dai logici formali e a correzione della tradizionale interpretazione degli studiosi dell’800. E’ bene subito notare che già in quest’ambito è possibile rintracciare le radici del futuro antilogicismo (e antignoseologismo) del Calogero, che costituisce uno dei motivi conduttori a cui si accennava sopra, e che senz’altro si pone a fondamento speculativo anche di quelle ricerche non direttamente riconducibili a questi temi. E ci sarà altresì utile notare che è da alcune impostazioni attualistiche che il lavoro prende le mosse precisamente da quelle espresse nel volume gentiliano Sistema di Logica come teoria del conoscere . In questo volume il filosofo attualista individuava nella logica classica il campo di pertinenza del ‘logo astratto’ o pensiero pensato e nella dialettica moderna quello del ‘logo concreto’ o pensiero pensante, tentando la conciliazione tra questi due momenti alla luce di uno tra i più importanti capisaldi della sua dottrina, quello della definitiva unificazione di teorico e pratico nell’assoluta unità spirituale. E’ sotto la suggestione di questa problematica che Calogero intraprende il suo studio della logica classica, considerando l’immenso edificio fin dalle sue fondamenta (la logica aristotelica appunto) e tentando di estendere i risultati a cui perviene col suo criterio ermeneutico, ben oltre i confini della logica classica. Così operando, pone un nucleo di autonoma ricerca filosofica che si distacca dal mero operare dello storico della filosofia. L’assunto fondamentale del libro è costituito dalla necessità posta con vigore e forza d’analisi da Calogero di evidenziare e nettamente distinguere all’interno della logica aristotelica due momenti specifici dell’attività dello spirito conoscitivo: uno noetico e l’altro dianoetico . Il primo si configura come pura intuizione o appercezione intellettuale, ” specchio peculiare della verità nella sua piena ed assoluta esistenza “, forma dell’autocoscienza divina, noesis noeseos , ed è il momento conoscitivo fondamentale. In esso pensante e pensato si identificano così perfettamente da costituirsi in indissolubile unità. Da tale momento discende l’attività dianoetica dell’intelletto. E’ essa conoscenza del pensiero discorsivo, dispone infatti i contenuti noetici tramite l’analisi o la sintesi, nelle forme dei giudizi e delle argomentazioni. Ed è proprio in tale campo che opera la logica come scienza formale dei princìpi che regolano il ragionamento, con un metodo che fa astrazione dal contenuto. Mentre il nous ci fornisce un sapere immediato, adeguato perfettamente al reale, la dianoia rappresenta una forma di conoscenza inferiore, in quanto opera un’ alterazione soggettiva del reale. Calogero mette in evidenza il carattere intuitivo dell’attività noetica, aliena da qualsiasi contaminazione logica propria dell’attività dianoetica, affermando la necessità, dopo averne operato la distinzione, di subordinare e risolvere quest’ultima in quella. Tale distinzione e subordinazione è per Calogero ben chiara già nella teorizzazione originaria aristotelica, ma ad essa fu infedele lo stesso Aristotele. Infatti, questi tentando di fondare una tecnica (l’Analitica) dell’analisi logica della conoscenza, staccata dal contenuto stesso di quest’ultima, capace di fornirci un criterio formale di verità, ha determinato nei suoi seguaci e nell’intera tradizione filosofica l’ errore di confondere le verità noetiche con le verità dianoetiche , cioè di assegnare a quest’ultime la facoltà di esclusiva competenza delle prime, per cui quelle che erano le forme di mero collegamento logico acquistano la facoltà di rispecchiare tout-court il reale nella sua obiettiva e immediata esistenza. Per cui il risultato sorprendente cui perviene Calogero in questa ricerca lo porta ad affermare che come già per le antiche concezioni della metafisica ” anche il problema della logica aristotelica […] è un problema da rivivere, riconoscere e dimenticare ” così come le vecchie e nuove posizioni logiche a gnoseologiche. Tale ricerca poneva così di fatto l’esigenza di una completa revisione della storia della logica classica, e del modo in cui essa era stata valutata ed assorbita dalla filosofia, moderna. Al fine di approfondire ulteriormente il problema logico, Calogero si dedicò a una sua ricostruzione storica, studiandone la configurazione che esso aveva assunto nel pensiero eleatico. Così dopo cinque anni dall’apparizione de I fondamenti della logica aristotelica , pubblicò i risultati di tali ricerche nel volume Studi sull’Eleatismo che apportava un rinnovamento nell’interpretazione dei testi e delle concezioni dei maggiori Eleati. Dopo tale studio specialistico, Calogero anticipò sommariamente le proprie idee, circa l’evoluzione della logica e della dialettica, antiche e moderne, mettendone in risalto le aporie in esse prodotte dal fraintendimento della struttura della logica aristotelica. Tale configurazione storica del problema ci viene presentata nella voce “Logica”, pubblicata nell’Enciclopedia Italiana. E’ questa una presentazione panoramica delle varie teorizzazioni logiche, dai presocratici fino alle posizioni, a lui contemporanee, di Croce e Gentile. In tale excursus Calogero illustra le conseguenze derivate nella trattazione della dottrina logica da parte dei seguaci di Aristotele dalla confusione e commistione tra attività noetica e attività dianoetica della conoscenza, la cui distinzione, peraltro già chiaramente teorizzata dal filosofo stagirita, è tuttavia fondamentale recuperare per poter intendere la effettiva struttura della logica aristotelica. La dottrina della conoscenza fino ad Aristotele fu, a suo giudizio, soprattutto logica e dopo di lui soprattutto gnoseologica, ” giacché mentre in quel primo periodo, la capacità del pensiero ad attingere il reale fu in genere presupposta e l’indagine si riferì principalmente alle necessarie forme di tale pensiero, che venivano ad essere forme della realtà, nel secondo periodo, messa in questione quell’attitudine, il problema del criterio della verità, e cioè quello della distinzione fra le conoscenze che corrispondevano all’oggetto e quelle che non gli corrispondevano, venne in primo piano e soverchiò nel campo della dottrina della conoscenza ogni altra questione “. In questo passo Calogero ha come referente polemico i primi peripatetici (Teofrasto in primis) e i teorici del criterio di verità, cioè gli Stoici. Si veda ad esempio la mordace critica sollevata a proposito dei sillogismi ipotetici di questi ultimi, ” sillogismi che non sillogizzavano nulla, perché […] non fornivano che implicazioni tautologiche di constatazioni di fatto annuncianti la necessaria connessione o incompatibilità di due verità obiettive. Gli stoici elevarono a sistema questi tentativi dei primi peripatetici, con risultati che tradizionalmente irrisi, vorrebbero ora, coerentemente, rimettere in onore quegli storici e teorici della moderna logicistica, che partecipano fra le altre, anche di questa sofferta confusione mentale “. Come si vede, questa critica così radicale coinvolge oltre agli stoici, tutte le elaborazioni successive da quelle medievali a quella leibniziana a quella logicista tendenti a creare una scienza autonoma delle forme logiche. Per altro verso, Calogero aderisce alla critica mossa dalla scuola scettica al sillogismo aristotelico, che seppure non vinceva Aristotele, ” mostrava una volta per sempre come lo massima creazione logica dell’antichità, non potesse mai servire come strumento per la conquista di nuovo sapere, ma solo come mezzo per riconoscere quali conoscenze fossero state implicite in altre già date “. Il sillogismo infatti per Calogero si configura non come forma di conoscenza ex novo ma come strumento di ulteriore analisi e approfondimento delle conoscenze già acquisite ( nota notae est nota rei ipsius ). Da ciò che si è finora detto appare in tutta la sua evidenza il carattere funzionale dello studio della logica antica a cui Calogero si è applicato fin dal lontano ’25 per oltre un decennio. Studio, come si è visto, teso a verificare il principio secondo il quale è impossibile staccare, separandola dal soggetto pensante, una logica del pensato, costruirla quindi come scienza autonoma e pretendere con siffatto strumento aprioristico di esplicare una teoria delle forme della conoscenza. Negli anni successivi, soprattutto in occasione della compilazione del primo volume delle lezioni di filosofia (Logica, Gnoseologia, Ontologia) Calogero stigmatizzerà ogni tentativo di istituire una scienza della logica, ogni costituzione di leggi logiche, come impossibili costruzioni di ” grimaldelli dell’assoluto “. Ma di questo si parlerà in seguito. Qui ci basti sottolineare ancora una volta che il serrato confronto con la logica antica attraverso lo studio dei presocratici, degli Eleati, di Socrate, di Platone e Aristotele , sarà insieme all’adesione a certe posizioni dell’attualismo (unità di teoretico e pratico) uno dei luoghi di decantazione dell’antintellettualismo e antiteoreticismo calogeriani e uno degli ambiti preparatori di quella “filosofia del fare” che tanta parte occupa nella ” Filosofia del Dialogo “. In La Conclusione della filosofia del conoscere (1938) Calogero giudica ormai compiuta la filosofia del conoscere: se la filosofia è atto, l’atto è qualcosa che si vive e che ha, quindi, il significato di operare e modificare la realtà. Ne scaturisce la centralità dell’impegno etico, di cui Calogero, nel dopoguerra, ravviserà il criterio direttivo nel principio del dialogo, ovvero nel dovere di comprendere le ragioni degli altri. Calogero fa riferimento al rapporto fra gli individui, alla relazione dialogica, alla democrazia come ciò che rende possibile il dialogo, che non è la definizione più comune di democrazia, per cui usualmente si intende, appunto, il rapporto fra l´insieme dei singoli e il potere. Questo in Calogero è implicito. Egli si richiama costantemente al rapporto fra gli individui, al dialogo inteso come reciprocità, ad un continuo domandare e rispondere: la democrazia è vista attraverso il dialogo, che è regola fondamentale ma anche valore. L´ideale della democrazia come colloquio spiega in qualche modo anche la sua visione sociale degli assetti democratici: tutti devono avere la possibilità di prendere parte allo scambio dialogico, devono avere l´effettiva capacità e l´effettivo potere di discutere con gli altri. E´ forse qui che si può rinvenire un´istanza propriamente socialista, in quanto l´effettività presuppone forme di eguaglianza fra gli individui: l´idea di eguaglianza – principio guida dell´azione del movimento operaio fin dai suoi esordi – arricchisce il liberalismo, come ho sostenuto in più occasioni. Ma per Calogero eguaglianza e libertà sono intimamente unite, inseparabili e, attraverso la loro unità, definiscono i cardini di una società giusta. Qui può situarsi un fecondo spazio di congiunzione fra il liberalsocialismo e le odierne forme di contrattualismo rilanciate da John Rawls e ispirate al principio dell´equità. La ricerca di Calogero di coniugare le due universali aspirazioni di libertà ed eguaglianza fu continua e sostanziata da uno spirito che, in fondo in fondo, sembra richiamare – anche se in un contesto laico – la lezione evangelica. Una tendenza questa che si può rinvenire del resto anche in alcuni autori del laburismo inglese, esperienza politica alla quale, come accennato, Calogero guardava come fondamentale riferimento per le sorti della nostra democrazia e, in particolare, della sinistra. Il tentativo di enucleare alcuni caratteri irrinunciabili del sistema democratico, alla ricerca delle modalità e delle ragioni di una convivenza sostanziata di valori autentici, e la possibilità di sviluppare l´idea liberalsocialista al fine di realizzare una società giusta attestano, a tutt´oggi, la vitalità della riflessione politica di Calogero. Egli era un idealista immanentista, la sua filosofia derivava da quella che era allora la filosofia dominante in Italia. Ma sulla questione del diritto e della nonviolenza le loro posizioni erano senz´altro diverse, e alcuni passaggi del saggio I diritti dell´uomo e la natura della politica , contenuto in questa raccolta, ne sono una chiara dimostrazione. Un altro punto nodale è il suo modo di intendere il socialismo. La sua simpatia per questa prospettiva culturale e politica va senz´altro attribuita alla sua ammirazione per l´Inghilterra e per il laburismo. Naturalmente bisognerebbe anche rivedere il suo libro sul marxismo, Il metodo dell´economia e il marxismo , che a suo tempo ebbe una certa fortuna tra coloro che si stavano avviando sulla strada dell´antifascismo. Sarebbe una buona occasione, fra l´altro, per richiamare l´attenzione su un testo ormai dimenticato e che pure presenta, ancora oggi, qualche interesse rispetto al dibattito continuato e sempre attuale sulla storia del marxismo. Le istanze socialiste di Calogero si raccolgono attorno all´idea di una società giusta fondata sul dialogo e la reciprocità, su un´idea di democrazia come colloquio integrale perché tutti devono avere il diritto-dovere di prendervi parte. Scrive per esempio Calogero in L´abbiccì della democrazia : ” l´unità della democrazia è l´unità degli uomini che, per qualunque motivo, sentono questo dovere di capirsi a vicenda e di tenere reciprocamente conto delle proprie opinioni e delle proprie preferenze “. E´ un modo singolare e originale di definire la democrazia. Quando si parla di democrazia s´intende, primariamente, la partecipazione al potere, richiamando una nozione di potere dal basso.
IL FUTURO E L’ETERNO
Nella rivista bimestrale “La Cultura” edita dal Grande Oriente d’Italia, Edizioni Erasmo, diretta da Guido Calogero -fascicolo 6, Novembre 1963 – è apparso un articolo firmato dallo stesso direttore ed intitolato: “il futuro e l’eterno”. Calogero, in forza dei propri princìpi morali, assunse in ogni occasione ferme posizioni in difesa della libertà e della tolleranza, ritenendo quest’ultima una condizione irrinunciabile per assicurare la libertà. Calogero non era massone. Tuttavia egli accettò consapevolmente di dirigere una rivista edita dalla Massoneria di Palazzo Giustiniani e la diresse con il vigore morale che derivava dai suoi convincimenti umanitari, del vedere se stesso in mezzo agli altri e con gli altri e, quindi, con il proposito di intendere e di farsi intendere. Appare interessante, ed ancora attuale, il pensiero che egli esprime in quell’articolo, nel quale cerca di spiegare il suo punto di vista, su ciò che può mutare ed ha un futuro, e su ciò che non può mutare ed è eterno. Si tratta di aspetti che riguardano chiunque voglia accedere a quella che lui chiama ” la bussola dell’universo “, di quello strumento cioè che, se bene utilizzato, è in grado di orientare correttamente le nostre azioni. Si domanda Calogero: ” nel rapido mutare delle cose, sono per mutare anche i valori di fondo? La velocità delle nostre rotte farà impazzire anche le nostre bussole? C’è qualcosa a cui possiamo credere, al di là della critica di ogni fede? ” E successivamente tenta di rispondere a questi inquietanti quesiti. Egli scrive:
” Allora mi è tornato in mente che, negli anni trenta, quando il problema fondamentale era quello di vincere il falso storicismo e di svegliare gli animi alla lotta per la libertà, il discorso che si faceva era apparentemente l’opposto, ma in realtà lo stesso, di quello che ancora oggi mi sembra necessario fare qui. Anche allora il problema era quello del rapporto tra il futuro e l’eterno, tra ciò che può cambiare domani e ciò che non può cambiare mai. In una famosa pagina dell’epilogo della sua “Storia d’Europa nel secolo decimonono”, Croce, a chi si domandava se alla libertà fosse riservato l’avvenire, aveva risposto che essa aveva qualcosa di meglio che l’avvenire, perché aveva l’eterno. Era una formula potente ed era, in fondo, anche una verità. Ma noi allora contestavamo in essa quanto in essa era certamente da combattere: cioè il convincimento, conforme al vecchio storicismo vichiano e hegeliano, che certi valori fossero assicurati provvidenzialmente dalla storia, la quale si serbava razionale al di là di ogni personale tragedia degli individui. Di fronte a questo, noi ricordavamo che i valori sono le cose per cui si trepida, non le cose che sono garantite da una eterna necessità. Ci premeva la sorte del futuro, non l’immobile volto dell’eterno. E distinguevamo, giustamente, tra la libertà che non viene meno mai, quella che ciascuno di noi ha per se stesso e che nessuna prigione gli può togliere (la libertà di consentire o di non consentire, di approvare o disapprovare nell’intimo, per quanto ostacolato possa essere il proprio potere di esprimersi) e la libertà di questo stesso esprimersi, in ogni manifestazione e forma e attività della vita: quella libertà che può essere sempre ampliata o decurtata, garantita o messa in pericolo, ed al cui paritetico sviluppo è dedicata ogni struttura della civiltà. Quest’ultima libertà era, allora, a rischio mortale […]. Oggi piuttosto che morire per mancanza di libertà noi sembriamo quasi soffrire di una malattia inversa, cioè del timore che ogni norma decada in arbitrio e che ogni stabilità si dissolva nel contingente, è necessario non già fare il discorso opposto, ma considerere l’opposto aspetto dì quella medesima verità. Se allora difendevamo il rischio e l’impegno del futuro contro la contemplazione dell’eterno, oggi, al fine di non lasciarci travolgere dalle sole incertezze del presente, non dobbiamo dimenticare che c’è anche l’eterno “.
“Ma quale è questo eterno?” E’ questa la nuova domanda che si pone Calogero. Egli ravvisa nella ” filosofia del dialogo ” lo strumento idoneo per riconoscere l’eterno. Si spiega con un esempio. Ove vi fossero scienziati di gran lunga superiori ai Newton, agli Einstein, ai Fermi, capaci di trovare una interpretazione del mondo tanto soddisfacente da far credere che dopo non resti nient’altro da fare, salvo che ” gioire e contemplare di tale siffatta finale verità “, e dicessero una cosa simile ai loro colleghi, si escluderebbero da soli dalla comunità della scienza. E ciò perché ” anche nella scienza c’è un indiscutibile: ed è l’assoluto della discutibilità “. Chi non accetta questa regola di fondo, questo assoluto, consistente nel diritto di mettere qualsiasi conquista scientifica in discussione, in quel momento egli si pone fuori della comunità della scienza: ” ogni universo scientifico può mutare, non già la libertà del discuterlo “. Con tale esempio egli indica, nel progredire della scienza, il futuro, e nel permanente diritto alla discutibilità, la continuità assoluta e quindi l’eterno. Un eterno, e questo va sottolineato per la sua importanza, non derivante da una condizione divina ma da una premessa condizionante, di origine umana, in base alla quale la scienza e il suo universo possono essere posti “sempre” in discussione. Si tratta di una premessa che esprime il diritto a disporre di una personale opinione sugli eventi scientifici, diritto alla cui base è posto perentoriamente un atteggiamento di tolleranza condiviso ed accettato da tutti. E proprio in questo atteggiamento sta il presupposto della filosofia o della ” legge del dialogo “, come in altri punti del suo scritto la definisce Calogero. Filosofia o legge del dialogo, che allora costituiva un impegno al quale si debbono aperture inconsuete tra i diversi punti di vista religiosi, politici e filosofici. E proprio a quel periodo risale una prima apertura della Chiesa cattolica nei confronti delle chiese protestanti e finanche nei confronti della Massoneria. Egli prosegue ricercando il massimo profitto nell’esempio portato: ” vediamo allora che la perenne regola del dialogo scientifico non è altro che la universale norma del mutuo intendersi, la quale è poi il fondamento di ogni etica, di ogni sistema di diritti, e quindi di ogni organizzazione civile “. E la legge del capire gli altri, così come si vuole essere capiti e di comportarsi in conseguenza: il ché, egli aggiunge maliziosamente, ” è qualcosa di più che il semplice fare agli altri ciò che si vorrebbe fosse fatto a sé, perché, alla stregua di questa seconda norma, noi potremmo imporre agli altri le nostre preferenze, e quindi sentirei dire da George Bernard Shaw che non dobbiamo fare agli altri quel che vorremmo fosse fatto a noi, in quanto essi potrebbero avere gusti diversi dai nostri “. ” Nel suo spirito “, egli continua, ” anche quella legge evangelica non è che la legge del dialogo come lo è la legge socratica del ‘nemo sua sponte peccat’ e quindi della perenne doverosità dell’intendere le altrui ragioni e del chiarire agli altri le proprie “. Calogero rafforza tale tesi aggiungendo che il valore di questa norma non dipende da chi l’ha scoperta o rivelata, dalla firma che porta: ” nessuno ha il diritto d’autore su quello che è il fondamento di ogni diritto. Come diceva il re buddista Asoka: importa molto rispettare la propria filosofia,e religione, ma ancora più importa rispettare la religione degli altri. I discorsi possono essere compatibili o incompatibili, ma la regola del dialogo dei discorrenti trascende qualsiasi loro discorso […]. Alla legge del dialogo noi possiamo conformarci o non conformarci, ma non possiamo mai evadere dal suo radicale dilemma. Possiamo anche gettare nel cestino il libro coi dilemmi di Zenone, quando non ci interessino quelle discussioni sulla unità e molteplicità. Ma non possiamo mai sfuggire a questa alternativa: o essere soli o essere con altri. O voglio intendere altri, oppure voglio restare solo con me stesso, cioè considerare l’universo come semplice strumento del mio volere […]. La morale è una scelta per cui non è dato non scegliere: qualunque cosa si faccia si sceglie sempre una delle due alternative. Ogni moralità è sempre un’opzione, ma essa si esercita nel quadro di una dilemmatica che non è un’opzione perché è sempre e assolutamente e trascendentalmente necessaria “. Da questo ragionamento egli fa discendere quella che chiama “la bussola morale dell’universo”: in ogni situazione cosmica possibile è sempre fermo il dilemma radicale del collaborare con gli altri o al suo contrario.Dopo tali indicazioni aggiunge altre considerazioni e altre domande:” che cosa importa allora chiedersi se la moralità sia del passato o dell’avvenire? La vera Morale è sempre la stessa per la eccellente ragione che è la legge di convivenza di tutti con gli altri, nella loro volontà di capirsi, di rispettarsi a vicenda. Tutti sono uguali di fronte a questa legge, quale che ne sia la stirpe o la chiesa: il prossimo, non colui che è figlio dello stesso padre, ma colui che è fatto prossimo dalla volontà di capirlo. Non c’è neppure bisogno che sia propriamente un uomo: può essere anche il lupo di Gubbio, come un Angelo o Dio. ” Dopo aver accennato polemicamente alla facilità con cui i critici si gettano sulle novità stracciandosi le vesti per gridare al miracolo di una nuova estetica o di una nuova morale, Calogero li esorta ad una maggiore ponderatezza, ricordando che ” quel che occorre è tener ben ferma la solidità dei criteri di fondo, perché c’è una eterna estetica, così come c’è una eterna morale.” Mentre appare limpidamente espresso il pensiero di Calogero relativamente alla storicità ed alla eternità della morale, sicché se ne deduce che sebbene gli atteggiamenti possano mutare a causa del mutare delle circostanze, resta tuttavia un aspetto che non può mai mutare – il dilemma: Io con gli altri o Io da solo – viene da domandarsi se sia riuscito ad indicare con altrettanta chiarezza i presupposti di un possibile giudizio su ciò che è morale e ciò che morale non è. E’ su questo punto che vale la pena di svolgere qualche ulteriore riflessione. Calogero individua nel dilemma dell’Io con gli altri o dell’Io da solo, e nella scelta ineludibile che esso porta con sé, l’eterno, ciò che non muta, che resta sempre uguale a se stesso. Che vi sia comunque e sempre un dilemma e che su questo dilemma si debba scegliere, è indubitabile ed inevitabile. E’ tuttavia al senso della scelta, allorquando l’Io avrà deciso di stare con gli altri o di restare solo, che viene rinviata la comprensione del significato morale da attribuire al gesto compiuto, perché è solo nel momento della scelta che tale gesto potrà essere classificato o buono o cattivo. E se è incontestabile il contenuto morale del dilemma “Io con altri o da solo”, altrettanto incontestabile appare l’osservazione che vede tale contenuto estrinsecarsi soltanto nel momento in cui i fatti si svolgono, ovvero quando avviene la scelta, ed è perciò giudicabile. Calogero non possedeva probabilmente la foga, né tantomeno la retorica, del predicatore, tantoché piuttosto che affermare, preferiva argomentare. Un più sottile modo di esprimersi, magari meno incisivo, ma certamente più convincente. Nel suo articolo Calogero non si dilunga molto per dire quale è la scelta giusta da fare, tuttavia lo fa con molta chiarezza e senza equivoci. E non solo perché lo ha dimostrato con la sua vita coerentemente condotta “con gli altri” e non da solo, sicché pochi possono vantare più di lui una partecipazione ai problemi di tutti, ma perché dalla sua indicazione discende l’eternità dei valori morali che egli intende condividere con gli altri, con tutte le conseguenze che ne derivano sul terreno della comprensione reciproca, su quello dei diritti, su quello dei doveri. A questo punto, c’è solo da prendere atto della coincidenza dei valori morali da lui indicati, con i valori che sono propri della Massoneria. Non c’è bisogno di spendere molte parole: l’ Io con gli altri”, ricordato da Calogero, è esaltato dalla Massoneria con la scelta dei valori della Fraternità, della Libertà, della Uguaglianza. Valori che sono i cardini di un sistema morale che dichiara esplicitamente la solidarietà e la comprensione tra tutti gli uomini della terra.
LA POLITICA
A cura di Vittorio Emanuele Esposito
Guido Calogero e Giovanni Gentile, suo primo maestro – cui si aggiunse, per scelta ideale, Benedetto Croce, la cui influenza sulla formazione del pensiero calogeriano fu almeno pari, se non superiore a quella del filosofo siciliano – intrattennero sempre rapporti di affettuosa amicizia e di reciproca stima, documentati dalle lettere che si scambiarono anche nei momenti più critici della loro esistenza. Ciò non toglie che il giovane allievo, manifestando fin dall’inizio grande indipendenza mentale, assumesse posizioni radicalmente critiche nei confronti delle sovrastrutture metafisiche dell’attualismo di Gentile e dello storicismo di Croce ( al quale ultimo rimproverò il teologismo e il provvidenzialismo di matrice hegeliana) e combattesse, anche se in misura e forme diverse, le scelte politiche di entrambi, cioè l’identificazione del primo con il fascismo e il liberalismo di stampo conservatore del secondo. Per parte sua Calogero si schierò subito, per disposizione del suo animo e grazie all’assimilazione dello spirito dei greci, al suo apprezzamento dei modelli anglosassoni e allo studio di John Dewey, a favore dell’ideale di una democrazia integrale in cui la partecipazione e la discussione delle scelte di interesse collettivo doveva diventare costume di vita e in cui la libertà dell’uno doveva trovare il proprio limite nella pari libertà degli altri, coniugandosi con la giustizia economica e l’uguaglianza sociale. Gentile, pur soffrendo per gli atteggiamenti ribelli del suo discepolo, nella liberalità che indubbiamente fu un aspetto caratterizzante della sua persona, gli affidò il compito di redigere gli articoli di filosofia e di storia della filosofia per l’ Enciclopedia Italiana, di cui era direttore. Dal 1928 al 1937 Calogero scrisse, infatti, per l’Enciclopedia più di 700 voci, che ancora oggi si leggono con grande interesse, per l’ampiezza e la profondità delle sue conoscenze, soprattutto nel campo della filosofia greca, e per l’ originalità interpretativa rispetto a molti luoghi comuni della filosofia accademica. Gentile intervenne anche più volte perché venisse rinnovato il passaporto al giovane professore, schedato dalla polizia politica come antifascista fin dal 1929. Ottenuta la cattedra di Storia della filosofia all’ Università di Pisa, negli anni Trenta, Calogero tenne contemporaneamente seminari e curò esercitazioni di storia di filosofia antica presso la Normale, discutendo fino a tarda notte con i suoi studenti, sempre con puntuali riferimenti, citati a memoria, di testi filosofici e dossografici. Ma, disobbedendo ai divieti opposti sotto forma di paterni consigli da Gentile, le sue lezioni e le sue conversazioni avevano spesso come oggetto autori ‘filo-semiti’ ,come E.Cassirer, e filosofi contemporanei come W.James, che gli consentivano di mettere a fuoco tematiche etico-politiche e di intraprendere quell’opera di rieducazione e rinnovamento delle coscienze di cui avvertiva l’urgente bisogno a causa dell’oppressione esercitata dalla dittatura e del clima di grigio conformismo che si era diffuso nella scuola e nell’università. Per la natura del suo insegnamento, affiancato presto dall’attività clandestina, attirò su di sé l’attenzione della polizia fascista . Decisivo in questi anni fu l’incontro con Aldo Capitini, teorico della non violenza, ispiratore delle marce della pace ed autore del saggio Elementi di un’esperienza religiosa in cui Calogero riscontrò una forte consonanza con la propria tesi dell’autonomia e dell’assolutezza della scelta morale e con la propria opposizione etica al fascismo, nonostante non ne condividesse l’ istanza religiosa e nutrisse riserve sul ‘metodo’ della non violenza. Dal sodalizio spirituale tra Capitini e Calogero nacque l’idea di dar vita ad un movimento culturale e politico nel quale i giovani intellettuali che, dopo la guerra di Spagna, si opponevano sempre più apertamente al fascismo trovassero le basi ideali e morali per condurre una lotta rigeneratrice. Il movimento fu denominato liberalsocialismo da Calogero che ne scrisse anche il Manifesto, con un esplicito richiamo al socialismo liberale di Carlo Rosselli, ma, insieme, con la volontà di sottolineare la sua estraneità alla tradizione marxista. Al movimento aderirono Enzo Enriques Agnoletti, Tristano Codignola, Luigi Russo, Piero Calamandrei, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Alberto Carocci, Carlo Francovich, Ludovico Ragghianti, Raffaello Ramat. Vi furono vicini anche l’attuale Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Norberto Bobbio, il quale, prima di morire, ebbe modo di sottolineare la vitalità e l’attualità del liberalsocialismo, indicandolo come possibile prospettiva per una sinistra rinnovata dopo la fine del comunismo. Già in precedenza, negli anni Sessanta, Bobbio aveva sintetizzato il problema della sinistra italiana dicendo a Giorgio Amendola : “Noi abbiamo bisogno della vostra forza, ma voi avete bisogno dei nostri principi”. In effetti il liberalsocialismo nacque per porre rimedio, in nome del socialismo, agli squilibri economici e sociali prodotti da un liberismo economico senza altra regola che quella del profitto personale e di parte, che progressivamente restringe l’area della ricchezza e del potere e dilata quella della miseria e della subalternità. La svolta autoritaria incombe sempre quando questa situazione si estremizza. Da questo punto di vista il movimento di Calogero e Capitini era una ripresa della democrazia risorgimentale e del pensiero di Mazzini che vedeva nella soluzione della questione sociale, ottenuta con il metodo della libertà, la condizione per l’equilibrio interno e internazionale. Il movimento, che aveva cellule organizzative a Firenze, Perugia, Bologna, Roma e Bari stabilì una collaborazione organica con i gruppi di “Giustizia e Libertà”, che si ispiravano alle idee di Carlo Rosselli (ucciso in Francia nel 1937 insieme al fratello Nello da una banda di fascisti francesi, forse su mandato di Mussolini) e successivamente con il gruppo milanese dei democratici moderati che facevano capo a Ugo La Malfa, Ferruccio Parri e Adolfo Tino. Queste tre componenti diedero vita, poi, al Partito d’Azione, cui si deve l’intransigente opzione a favore dello Stato repubblicano, contro la tendenza al compromesso con la monarchia che accomunava, per motivi diversi, i liberali di Croce e i comunisti di Togliatti. Calogero fu arrestato la prima volta nel febbraio del 1942 e rinchiuso in una cella del carcere delle Murate a Firenze. Qui ottenne il privilegio di poter scrivere e, in pochi mesi, compose i tre volumi delle Lezioni di filosofia, dedicati rispettivamente alla Logica, all’Etica e all’ Estetica. In quei mesi di intensa concentrazione, ma di ‘clausura spirituale’ e di ‘mancanza di comunicativa’, egli ebbe modo di rinnovare la sua fede nell’ ‘universale colloquio umano’ e di vedere con maggiore convinzione nel linguaggio, ovvero nel pensiero che si atteggia in forma comunicativa e si apre al pensiero e all’esperienza degli altri, l’unico modo di evadere ‘dal chiuso carcere di se stessi’ , di affrancarsi dal buio e di uscire dalle tenebre per conquistare la luce. Il carcere fu poi trasformato in confino e Calogero si trasferì a Scanno in Abruzzo con la sua famiglia. Nella primavera del 1943 una nuova ondata di arresti si abbattè sui componenti del neonato Partito d’Azione. Tra questi: lo scrittore Giorgio Bassani, il filosofo Guido De Ruggiero e lo stesso Calogero, che fu arrestato per la seconda volta a Bari nel luglio di quell’anno e subito dopo liberato. Ritornò allora a Scanno per riabbracciare la famiglia e qui fu raggiunto da Carlo Azeglio Ciampi, che era stato suo discepolo alla Normale di Pisa e che trascorse con lui sei mesi, aiutandolo a battere a macchina i manoscritti delle Lezioni di filosofia. Ciampi passò poi le linee per riprendere servizio nell’esercito italiano il giorno stesso dell’eccidio delle Fosse Ardeatine (24 marzo), in cui trovò la morte un altro diletto allievo di Calogero: Pilo Albertelli. Calogero rimase, invece, nel territorio occupato dai tedeschi. Dopo la Liberazione egli si dedicò ad elaborare gli assetti istituzionali più adeguati alla propria idea di democrazia integrale, assegnando un rilievo di primaria importanza alla legge costituzionale, nella parte relativa ai principi e in quella riguardante l’ordinamento dello Stato. Nella sua concezione, infatti, il diritto, che ha le proprie radici nell’etica del dialogo, assume priorità sul mondo della politica, che è esercizio di persuasione, ma anche di forza e di coazione e deve, perciò, essere disciplinato dall’ordinamento giuridico e incontrare il proprio limite nei diritti dell’uomo e del cittadino. Per questo egli accentuava il ruolo della Corte costituzionale, come organo di garanzia totalmente autonomo e al di sopra delle parti. Occorre anche ricordare che egli fondò a Roma la prima scuola per operatori sociali (CEPAS), considerando gli assistenti sociali come “necessari collaboratori della convivenza civile”. In seguito allo scioglimento del Partito d’Azione per gli insanabili contrasti tra l’ala democratica liberale e l’ala socialista, Calogero, insieme a molti intellettuali di prestigio come Corrado Alvaro, Salvatore Quasimodo, Renato Guttuso e Giorgio Bassani aderì al Fronte Popolare. La sua battaglia per la filosofia del dialogo e per la democrazia continuò sulle colonne de “Il Mondo” di Mario Pannunzio. Molti di questi articoli, pubblicati nella rubrica intitolata “Quaderno”, furono poi raccolti nel libro Quaderno Laico (1967). Uno dei temi prediletti fu quello della scuola, che Calogero voleva rinnovata attraverso un rapporto dialogico tra insegnanti e studenti, che fosse reciproco apprendimento e produzione di una cultura nuova e comune, e voleva soprattutto sottratta ad ogni indottrinamento di natura religiosa, filosofica o ideologica. Con Aldo Capitini ed altri intellettuali sostenne l’azione di Danilo Dolci contro la mafia. Nel 1955 insieme a Leo Valiani, Francesco Compagna, Marco Pannella, Mario Pannunzio, Leopoldo Piccardi, Ernesto Rossi, Rosario Romeo, Eugenio Scalfari, Arrigo Olivetti ed altri fondò il Partito Radicale. Alcuni anni dopo abbandonò il partito per aderire al Partito Socialista Unificato, ma fu sostenitore della doppia tessera e continuò a battersi per la democrazia bipartitica, prospettata dai radicali, convinto che “i veri partiti sono sempre e soltanto due, la destra e la sinistra, il partito della conservazione e il partito delle riforme” Nel 1972 divenne direttore di “Panorama”. I temi più propriamente filosofici vennero sviluppati su “La cultura”, la rivista di Cesare De Lollis, cui Calogero aveva collaborato in gioventù e che egli riportò a nuova vita, a partire dal 1963, insieme al genero Gennaro Sasso, poi a lui subentrato nella direzione. In essa Calogero sintetizzava la sua appassionata esperienza intellettuale con il richiamo a Socrate: il meghiston agathon, il bene supremo, è lo stesso principio del dialogo che impone di dare e chiedere sempre conto delle nostre reciproche opinioni e di sforzarci di comprendere gli altri senza giudicarli. Il liberalsocialismo ebbe un proprio manifesto redatto in gran parte e poi rielaborato dallo stesso Calogero nel 1940. In esso veniva enunciato, in premessa, il proponimento di combattere “per l’unico e indivisibile ideale della giustizia e della libertà”, opponendosi tanto al conservatorismo che si traveste da liberalismo, quanto all’estremismo sociale che non tiene nel debito conto l’esigenza della libertà e riconoscendo come proprio nemico il fascismo, come ideologia illiberale e antiugualitaria e come regime che esprimeva interessi oligarchici. Libertà e giustizia devono essere entrambe sempre presenti e operanti, devono, cioè, essere volute sempre insieme e, dunque, nei programmi e nell’azione politica, l’una non deve essere mai disgiunta e sacrificata all’altra Tale assunto scaturisce direttamente dal principio etico dell’altruismo (non c’è vita morale senza riconoscimento del diritto altrui) successivamente formulato da Calogero come principio del dialogo, che costituisce l’unico metro di giudizio della storia e il canone dell’autentico progresso. La storia e la politica si giudicano, infatti, in base ai concreti avanzamenti verso più ampie e ricche possibilità di vita, ma, insieme, verso una sempre maggiore parità del diritto degli individui di fruirne, cioè verso una sempre più equa distribuzione sia dei beni spirituali, come l’istruzione e la cultura, sia dei beni materiali ed economici. In questo progresso soltanto consiste la civiltà. Se la battaglia per le libertà civili e politiche ha avuto successo ed oggi, ad esempio, la libertà di parola e di voto sono state acquisite come diritto di tutti, non altrettanto è accaduto per la libertà economica che esiste in forma altamente sperequata: per alcuni come libertà di appropriarsi della ricchezza collettiva in misura soverchiante e per altri come libertà di morire di fame. La libertà che si deve volere, l’unica che può rappresentare un valore per tutti e che è in grado di animare e nobilitare la lotta politica, è per Calogero la libertà giusta. Nel mondo odierno, però, sussiste meno giustizia che libertà. Anche se la battaglia per i diritti civili e politici è lontana dall’essere compiuta e vinta e richiede sul piano interno e internazionale il massimo impegno, un impegno ancora più ampio e determinato occorre per l’uguaglianza economica Per questo all’educazione liberale, che riguarda le libertà formali, si deve affiancare l’educazione socialista che riguarda la garanzia delle condizioni materiali necessarie a ciascuno per potersi affermare nella vita. Suo compito specifico è quello di contrastare e modificare il gusto ancora prevalente di possedere più degli altri, allo stesso modo in cui, nell’età moderna, sono stati combattuti i privilegi sociali e politici, ottenendo un radicale cambiamento di mentalità. Da queste premesse derivano i due principi fondamentali del liberalsocialismo: 1. assicurare la libertà nel suo funzionamento effettivo 2. costruire il socialismo attraverso questa libertà Da un lato occorre rafforzare il fronte comune delle libertà, dall’altro mettere mano a riforme sociali che siano figlie della democrazia e della libertà. Una delle prime mete da raggiungere nel campo delle riforme sociali è la massima proporzionalità possibile tra il lavoro che si compie e il bene economico di cui si dispone. I mezzi tecnici e giuridici per realizzare questo intento saranno graduati in rapporto alle possibilità della situazione, ma la linea di tendenza è quella della battaglia contro il godimento sedentario dell’accumulato e dell’ereditato. Man mano che contadini, operai, tecnici e dirigenti saranno capaci di agire come imprenditori e amministratori, la figura del proprietario puro dovrà scomparire. Quanto più si svilupperà lo spirito della solidarietà e dell’uguaglianza, tanto più sarà possibile ravvicinare le distanze fra i compensi delle varie forme di lavoro, senza inaridire il gusto dell’operosità e l’iniziativa creatrice. L’istanza anticapitalistica contenuta in queste proposizioni è radicale, anche se temperata dal riferimento alle concrete possibilità offerte dalla situazione storica e dalla consapevolezza delle difficoltà oggettive e soggettive che si oppongono. Ma non c’è dubbio che occorra impiantare nella coscienza morale degli uomini l’ideale cristiano e mazziniano della giustizia e dell’uguaglianza anche sul piano della ricchezza: “…bisogna tanto suscitare nel proprio animo il gusto di lavorare e di produrre, quanto reprimervi quello del guadagnare e del possedere in misura soverchiante la media comune.[Il liberalsocialismo] vuole… che ciascuno sia compensato, con la ricchezza prodotta, in misura congrua al suo effettivo lavoro, vuole che non sia riconosciuta la legittimità del possesso ed uso privato del puro interesse del capitale, ma solo quella della reale attività e fatica dell’imprenditore e del dirigente, vuole che con la ricchezza appartenente alla società…venga assicurato ad ognuno il diritto di partecipare al lavoro comune e di raggiungere la piena esplicazione delle proprie attitudini, e parimenti venga assicurato uno speciale soccorso per tutti coloro che si trovino in condizioni di inferiorità …” Il raggiungimento di queste mete rende necessario uno sforzo di ideazione degli assetti politici e giuridici più adatti a far procedere la civiltà in direzione della sempre maggiore socialità della ricchezza. Nello specifico il Manifesto accenna a norme regolanti la successione legittima, l’amministrazione delle società anonime, gli orari e i salari dei lavoratori, che devono essere sottratti al privato arbitrio economico del testante, dell’amministratore e del datore di lavoro. Sul piano internazionale il liberalsociocialismo –viene affermato- difende gli stessi principi di libertà e di giustizia per tutti. Di conseguenza: Niente nazionalismo, niente razzismo, niente imperialismo, niente distinzione di principio fra politica ed etica, ma difesa di ogni organismo che favorisca la realizzazione di questi principi nel mondo, internazionalizzazione…delle colonie [siamo negli anni quaranta, ndr] e delle grandi fonti di materie prime e progressiva estensione dei diritti di cittadinanza al di là dei limiti delle nazioni. Il liberalsocialismo, avendo fatto tesoro del meglio delle tradizioni politiche dei grandi partiti, riconosce ai liberali di essere stati i protagonisti della lotta per la libertà, ma rimprovera ad essi l’incertezza che li ha indotti all’iniziale propensione per il fascismo in nome dello Stato forte, lasciando la libertà ai nemici della libertà; ai marxisti, del socialismo e del comunismo, dice: la nostra aspirazione è la vostra aspirazione, la nostra verità è la vostra verità, quando essa sia liberata dai miti del materialismo storico e del socialismo scientifico e ricorda che Marx scrisse il Manifesto e il Capitale a Londra all’ombra delle libertà inglesi; ai cattolici, infine, fa presente che il suo ideale non è altro che l’eterno ideale del Vangelo, essendo il liberalsocialismo una forma di cristianesimo pratico, calato nella realtà: “ Chi ama il suo prossimo come se stesso, non può non lavorare per la giustizia e per la libertà”.
MARTIN BUBER

A cura di Diego Fusaro
Martin Buber nasce a Vienna e studia in svariate università europee, annoverando fra i suoi maestri pensatori del calibro di Simmel e Dilthey, che molto incideranno sulla sua formazione. Dopo un periodo di “dispersione”, egli tornò nel seno dell’ebraismo, aderendo al movimento sionista. Docente a Francoforte, dopo l’avvento del nazismo perse la sua cattedra e nel 1938 si trasferì a Gerusalemme, dove ricoprì la cattedra di Filosofia sociale e difese l’ideale di una pacifica convivenza fra Arabi ed Ebrei. La morte lo colse nel 1965. Nel 1923 pubblicò una delle opere più famose, Io e Tu, proprio nell’anno in cui cominciò ad insegnare a Francoforte. Nel 1925 incontrò Franz Rosenzweig, con il quale tradurrà la Bibbia (impresa che porterà a termine nel 1962). Fra gli scritti successivi, meritano senz’altro di esser ricordati: Il problema dell’uomo (1943) ed Eclissi di Dio (1952), oltrechè i suoi interessantissimi studi sullo hassidismo, ovvero su quel movimento dell’ebraismo europeo orientale sorto nel XVIII secolo e caratterizzato dall’importanza attribuita all’azione. Buber elabora innanzitutto una prospettiva di pensiero il cui cardine sono i temi del dialogo e della relazione: infatti, a partire dall’idea secondo cui l’uomo non è una sostanza, ma una fitta trama di rapporti e di relazioni, egli è pervenuto a quella che si potrebbe definire una sorta di relazionismo personalista. Ad avviso di Buber, il mondo è duplice, giacchè l’uomo può porsi dinanzi all’essere in due modi distinti, richiamati dalle due parole-base (Grundworte) che può pronunciare al suo cospetto: Io-Tu e Io-Esso. Di primo acchito, si potrebbe essere indotti a pensare che la parola Io-Tu alluda ai rapporti con gli altri uomini e la parola Io-Esso si riferisca invece a quelli con le cose inanimate. In realtà la questione è più complessa, in quanto l’Esso può comprendere anche Lui o Lei. L’Io-Esso, allora, finisce piuttosto per coincidere con l’esperienza, concepita come l’ambito dei rapporti impersonali, strumentali e superficiali con l’alterità – sia umana sia extraumana -; tale schema dualistico – corrispondente almeno in parte a quello propsettato da Marcel tra essere e avere – presuppone che l’Io dell’Io-Esso sia l’individuo, mentre l’Io dell’Io-Tu sia la persona: con la precisazione, però, che “nessun uomo è pura persona, nessuno è pura individualità. […] Ognuno vive nell’Io dal duplice volto” (Io e Tu). Agli occhi di Buber, l’Ioa utentico (la persona) si costituisce unicamente rapportandosi con le altre persone – sullo sfondo vi è la lezione hegeliana (Fenomenologia dello Spirito) dell’autocoscienza che si relaziona ad altre autocoscienze -, giacchè l’Io “si fa Io solo nel Tu“. Ma asserire che la realtà umana è costitutivamente relazione equivale a dire che essa è costitutivamente dialogo, per cui, se la dimensione dell’Io-Esso è la superficiale dimensione del possesso e dell’avere, la dimensione dell’Io-Tu, di contro, è la profonda ed intima dimensione del dialogo e dell’essere: Io-Tu corrisponde all’essere, Io-Esso all’avere. Tale dialogo trova la sua compiuta manifestazione nel rapporto teandrico, ovvero nel Rapporto instaurantesi fra l’Io e Dio stesso: “ogni singolo Tu è un canale di osservazione verso il Tu eterno. Attraverso ogni singolo Tu la parola-base si indirizza all’eterno” (Io e Tu). Un Tu eterno – precisa Buber – che non può esser ridotto in nessun caso all’Esso, ossia ad oggetto di possesso e di conoscenza: “guai a colui che è invasato a tal punto da credere di possedere Dio“, ammonisce Buber. Di conseguenza, il Dio-oggetto della teologia è un falso Dio: il vero Dio, quello vivente della Bibbia, è un Tu con cui si parla e non un Tu di cui si parla, è un Dio a cui l’uomo rende testimonianza non già con la scienza, bensì con il suo impegno nel mondo a favore del prossimo:
“Quando io ero bambino, lessi una vecchia leggenda ebraica che allora non potevo capire. Raccontava nient’altro che questo: ‘dinanzi alle porte di Roma sta seduto un mendicante lebbroso ed aspetta. E’ il messia’. Mi recai allora da un vecchio e gli chiesi: ‘che cosa aspetta?’ e il vecchio mi dette la risposta ch’io allora non capii e che ho imparato a capire molto più tardi. Egli mi disse: ‘Te’“. (Sette discorsi sull’ebraismo)
Nel suo scritto Eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia, Buber nota come attraverso i tempi si sia eccessivamente abusato della parola “Dio”, a tal punto che il suo significato è diventato opaco e vuoto; ciò non toglie, tuttavia, che tutte le volte che qualcuno la impiega per riferirsi al Tu assoluto, allora essa acquista un insostituibile valore esistenziale:
“‘Sì’, risposi, è la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio umano. Nessun’altra è stata tanto insudiciata e lacerata. Proprio per questo non devo rinunciare ad essa. Generazioni di uomini hanno lacerato questo nome con la loro divisione in partiti religiosi; hanno ucciso e sono morti per questa idea e il nome di Dio porta tutte le loro impronte digitali e il loro sangue. Dove potrei trovare una parola che gli assomigliasse per indicare l’Altissimo? Se prendessi il concetto più puro e più splendido dalla tesoreria più riposta dei filosofi, vi potrei trovare soltanto una pallida idea ma non la presenza di colui che intendo, di colui che generazioni di uomini con le loro innumerevoli vite e morti hanno onorato e denigrato. Intendo parlare di quell’Essere a cui si rivolge l’umanità straziata ed esultante. Certamente essi designano caricature e scrivono sotto ‘Dio’; si uccidono a vicenda e lo fanno ‘in nome di Dio’. Ma quando scompare ogni illusione e ogni inganno, quando gli stanno di fronte nell’oscurità più profonda e non dicono più ‘Egli, Egli’, ma sospirano ‘Tu, Tu’ e implorano ‘Tu’, intendono lo stesso essere; e quando vi aggiungono ‘Dio’, non invocano forse il vero Dio, l’unico vivente, il Dio delle creature umane?” (L’eclissi di Dio).
Ciò non toglie, però, che proprio il Dio vivente appaia, oggigiorno, irrimediabilmente perduto, quasi come se si fosse eclissato: e questo in virtù del prevalere della relazione Io-Esso e dell’esaltazione soggettivistica della filosofia moderna: l’essere è stato scalzato dall’avere, Dio dall’uomo. A proposito del primo punto, Buber così si esprime:
“Nel nostro tempo la relazione Io-Esso si è molto gonfiata e, quasi incontrastata, ha assunto la direzione e il comando. Signore di quest’ora è l’Io di tale relazione, un Io che tutto possiede, tutto fa e a tutto si adatta, incapace di pronunciare il Tu e di andare incontro a un’esistenza con autenticità. Questo Ego (Ichheit) ormai onnipotente, con tutto quell’Esso intorno a sé, non può naturalmente riconoscere né Dio, né un reale Assoluto, che manifesta la sua origine non-umana all’uomo. L’Ego si inserisce in mezzo, oscurandoci la luce del cielo” (L’eclissi di Dio).
A proposito del secondo punto, poi, Buber nota:
“il soggetto, che sempre apparve annesso all’essere per prestargli il servigio della contemplazione, dichiara di aver generato e di generare esso stesso l’essere […] lo spirito umano dice di essere il signore delle sue opere e annichila concettualmente l’’ssolutezza e l’Assoluto“(L’eclissi di Dio).
Contrapponendosi con forza a Nietzsche e al nichilismo moderno, sfociante nell’ateismo, Buber dichiara che Dio non è definitivamente morto, ma si è solo temporaneamente eclissato (non del tutto diversamente, Horkheimer – di fronte alle atrocità del nazismo – aveva parlato di “eclissi della ragione”): da ciò nasce la fiducia nel Suo ritorno. “L’eclissi della luce di Dio non è l’estinguersi, già domani ciò che si è frapposto potrebbe ritirarsi” (L’eclissi di Dio): in particolare, ciò che si è temporaneamente frapposto tra noi e Dio, eclissandolo, è – per così dire – la nube dell’Esso e dell’Ego, nube che fa sì che il profondo rapporto Io-Tu sia oscurato da quello superficiale Io-Esso. Buber ha riproposto inoltre, con grande attenzione, la questione dell’identità ebraica. Quali sono le caratteristiche dell’ebraismo? Una prima caratteristica è la coscienza della scissione e l’anelito all’unità; una seconda è la ricerca di una relazione tra morale e religione, intendendo la religiosità come azione e come spinta messianica verso il futuro. Questi princìpi – unità, azione e futuro – sono i princìpi validi anche per l’umanità: un autentico ritorno all’ebraismo coincide per lui ad un ritorno verso la vera umanità.
SUL DIALOGO: “L’autentico dialogo e quindi ogni reale compimento della relazione interumana significa accettazione dell’alterità. […] L’umanità e il genere umano divengono in incontri autentici. Qui l’uomo si apprende non semplicemente limitato dagli uomini, rimandato alla propria finitezza, parzialità, bisogno di integrazione, ma viene esaudito il proprio rapporto alla verità attraverso quello distinto, secondo l’individuazione, dell’altro, distinto per far sorgere e sviluppare un rapporto determinato alla stessa verità. Ali uomini è necessario e a essi concesso di attestarsi reciprocamente in autentici incontri nel loro essere individuale”. (Separazione e relazione)
IO, TU E ESSO: “Lo scopo della relazione è la sua stessa essenza, ovvero il contatto con il Tu; poiché attraverso il contatto ogni Tu coglie un alito del Tu, cioè della vita eterna. Chi sta nella relazione partecipa a una realtà, cioè a un essere, che non è puramente in lui né puramente fuori di lui. Tutta la realtà è un agire cui io partecipo senza potermi adattare a essa. Dove non v’è partecipazione non v’è nemmeno realtà. Dove v’è egoismo non v’è realtà. La partecipazione è tanto piú completa quanto piú immediato è il contatto del Tu. È la partecipazione alla realtà che fa l’Io reale; ed esso è tanto piú reale quanto piú completa è la partecipazione” (Io e tu).
CARLA LONZI

“Il femminismo mi si è presentato come lo sbocco tra le alternative simboliche della condizione femminile, la prostituzione e la clausura: riuscire a vivere senza vendere il proprio corpo e senza rinunciarvi. Senza perdersi e senza mettersi in salvo. Ritrovare una completezza, un’identità contro una civiltà maschile che l’aveva resa irraggiungibile“.
VITA, OPERE E PENSIERO
Nata a Firenze il 6 marzo 1931, Carla Lonzi si laurea in storia a dell’Arte con Roberto Longhi, ed esercita la professione di critica d’arte fino al 1970, quando, avvicinatasi al femminismo, fonda il gruppo Rivolta Femminile e una piccola casa editrice ad esso collegato. Il 1970 è l’anno della scoperta per Carla Lonzi dell’esistenza del femminismo nel mondo, è il momento di massima apertura in cui prevale lo sdegno per la consapevolezza che la cultura maschile aveva da sempre teorizzato l’inferiorità della donna. I suoi scritti, Sputiamo su Hegel del 1970 e La donna clitoridea e la donna vaginale del 1971, ci regalano una nuova dimensione, appassionata ed estrema, del suo pensiero. Sono gli anni della contestazione, della ribellione e del rifiuto per quella società che vede la donna ancora sottomessa al modello maschile. Carla Lonzi ha un ruolo fondamentale nella elaborazione del Manifesto di Rivolta femminile (1970), che contiene i pensieri più significativi intorno all’idea generale del femminismo. Durante la primavera del 1970 Carla Lonzi cominicia ciò che lei stessa definisce la sua presa di coscienza stimolata dalla scoperta del femminismo e dai contatti con le donne di Rivolta Femminile. Morirà nel 1982, a Roma. L’inizio di questo percorso è segnato dall’uscita di alcuni scritti della Lonzi i quali sono considerati da quest’ultima come una premessa all’esperienza più personale che, in seguito, verrà portata avanti con l’autocoscienza. E’ appunto la pratica di quest’esperienza che le permette di portare alla luce al di fuori di sé ciò che risultava dalla sua opera di introspezione. Ciò a cui punta Carla Lonzi non è infatti la teorizzazione di una lotta contro il predominio maschile in quanto lei stessa si rivolge verso la libera espressione di sé. Lei stessa si era resa conto, sperimentandolo sulla sua pelle, della situazione di subordinazione che caratterizzava il ruolo che la società impone alla donna. Secondo la Lonzi la donna incarnava perfettamente la figura dello spettatore dell’opera d’arte il quale vive completamente dimentico di sé e delle proprie capacità creative. La donna, come lo spettatore, non ha la possibilità di proporre il proprio punto di vista e di fornire il proprio apporto creativo ma deve vivere nell’illusione del rapporto che le è fornita dall’uomo. Le conclusioni a cui arriva la Lonzi, riflettendo su questo problema, non sono, però, frutto di una semplice teorizzazione. Carla Lonzi parte sempre dall’analisi della propria esperienza e ogni testo che essa scrive risulta motivato dalle necessità interiori di quest’ultima. I primi scritti che la Lonzi redige in occasione del suo ingresso in Rivolta Femminile sono motivati soltanto dalla necessità di portare al di fuori di sé, di estromettere, tutto lo sdegno che lei stessa provava nei confronti della sottomissione, o meglio dell’inespressività, in cui viveva la donna. Questi testi quindi non vogliono essere dei punti ideologici, delle teorie con cui regolare lo sviluppo di Rivolta Femminile, ma sono il punto di partenza che permette alla Lonzi di approdare, piano piano, alla scoperta di sé. Il Manifesto di Rivolta femminile è redatto nel luglio del 1970 con la collaborazione di Carla Accardi e Elvira Banotti. In questo scritto sono raccolte le frasi più significative che l’idea del femminismo aveva portato al gruppo di Rivolta Femmninile. Il bisogno di esprimersi che queste donne sperimentano nei loro primi incontri è accolto, lo dice la Lonzi, come sinonimo stesso di liberazione. Liberarsi per la Lonzi, come per le altre donne appartenenti a Rivolta Femminile, non vuole dire accettare la stessa vita dell’uomo ma significa esprimere il proprio senso dell’esistenza. Il Manifesto di Rivolta Femminile diventa proprio il mezzo adatto attraverso cui questo gruppo di donne ha la possibilità portare sulla carta le proprie idee relative al loro ingresso nel femminismo. Ciò che in quest’occasione si cerca di porre in luce è la necessità di fornire voce e sostanza all’identità femminile individuando gli elementi di misconoscimento contro cui ci si ribellava. Carla Lonzi afferma infatti come la donna, ponendosi come soggetto, rifiuti il ruolo assoluto e autoritario che è svolto dall’uomo. Ogni valore costituito dalla società è stato sfruttato a discapito della donna la quale non ha la libertà di decidere ma viene inglobata dentro i vincoli sociali. Il matrimonio come anche la regolamentazione della vita sessuale sono necessità del potere che non lascia libertà di decisione. Questa situazione di imparità era anche appoggiata, agli occhi della Lonzi, dalle teorie metafisiche elaborate dai grandi sistematici del pensiero. Essi avevano mantenuto il principio della donna come essere aggiuntivo legato alla sfera privata. Secondo quest’ultima, infatti, discipline tanto diverse quali la psicoanalisi, il cattolicesimo e il marxismo, hanno un punto ideologico in comune: la considerazione della donna come un essere sussidiario e complementare. Ciò, però, risulta motivato dal fatto che queste dottrine erano nate come forme di regolazione e di interpretazione dei rapporti tra uomo in quanto superiore e la donna in quanto inferiore. La presa di coscienza di una simile situazione porta la Lonzi a riflettere su ciò che era stato scritto dai grandi filosofi del passato confutando i principi patriarcali che reggevano i loro scritti. Sputiamo su Hegel è scritto da Carla Lonzi nell’estate del 1970. Qui lei stessa spiega come la donna è oppressa in quanto donna. Il fattore sessuale è l’elemento discriminante e non il livello sociale. Anche il marxismo quindi affidando la rivoluzione alla classe operaia aveva desunto una teoria rivoluzionaria dalla matrice della cultura patriarcale poiché aveva escluso la considerazione della donna come oppressa e come portatrice di futuro. Secondo Hegel la donna è il principio divino che presiede alla famiglia e che non oltrepassa lo stadio della soggettività. Per questo motivo la donna, riconoscendosi solo nella famiglia, non può raggiungere l’universalità per cui l’uomo diventa cittadino. La Lonzi nota come in Hegel l’essere donna non sia riconosciuto come una condizione umana poiché dipende da un principio divino il quale s’incarna quindi in un’essenza immutabile. Dando alla differenza sessuale della sostanza spirituale Hegel non riconosce l’origine umana dell’oppressione della donna. L’inferiorità della donna non fa parte della storia umana ma è una condizione immutabile. Secondo la Lonzi la cancellazione dell’inferiorizzazione della donna dalla storia aveva permesso a Hegel di vertere la sua teoria politica sulla dialettica tra superiore e inferiore dove il primo è il padrone e il secondo è il servo. La condizione della donna, essendo contemplata come principio divino, non è considerata in questa dinamica sociale. Secondo la Lonzi ciò derivava dal fatto che se Hegel avesse dovuto applicare al rapporto donna-uomo la dialettica servo-padrone avrebbe incontrato un ostacolo non indifferente poiché sul piano donna- uomo non esiste una soluzione che elimina l’altro per cui è vanificato il traguardo della presa di potere che distingue invece la logica servo-padrone. La donna è sottomessa all’autorità patriarcale e l’unico valore che le viene riconosciuto è quello di essersi adeguata come se questa fosse la propria natura. L’unica cosa che la donna contrappone alle costruzioni dell’uomo è la sua dimensione esistenziale per cui non possiede nessuna mitizzazione dei fatti che ha compiuto. La rivoluzione simbolica che la donna opera mettendosi in posizione di soggetto è considerata un cominciare da capo anche da Carla Lonzi che così si esprime in Sputiamo su Hegel: “Il destino imprevisto del mondo sta nel ricominciare il cammino per percorrerlo con la donna come soggetto”. Con il rivoluzionamento, nei testi di Rivolta femminile si dice anche chiaramente il suo risultato logico che è il concetto di differenza sessuale. La differenza tra donna e uomo viene infatti presentata come qualcosa da cui non si può prescindere. Non c’è libertà né pensiero per la donna senza pensiero della differenza. Il Manifesto si apre con questa idea: “La donna non va definita in rapporto all’uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà. L ‘uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna. La donna è l’altro rispetto all’uomo. L’uomo è l’altro rispetto alla donna.” Viene perciò duramente respinto il programma di uguaglianza tra i sessi con cui si pretenderebbe di assicurare alle donne piena dignità umana. In Sputiamo su Hegel si sostiene che lo stato sociale assegnato al sesso femminile sia tale che “un uomo preferirebbe non essere mai nato se dovesse considerarlo per se stesso”. Le donne lo hanno sopportato, lo sopportano aiutandosi per una parte, una parte difficilmente misurabile, con l’aiuto delle fantasie. E’ difficile sapere al momento quanta parte di fantasie ci aiuta a sostenere la nostra differenza trovandoci esposte alle esibizioni del sesso maschile. Di solito si viene a saperlo quando è troppo tardi, quando cioè viene meno la forza di fantasticare. Allora la mente femminile si arrende e cade in quello stato che gli psicologi chiamano depressione. Carla Lonzi chiamò autocoscienza la pratica secondo la quale le donne parlavano della propria esperienza esponendosi alle altre. Era una via per sottrarre la coscienza di sé alle interpretazioni che ne dava la cultura maschile. Con questa pratica la propria soggettività femminile trovava modo di emergere nel confronto con altre donne. La confutazione delle teorie basilari del patriarcato continua anche con l’uscita nell’estate del 1971 dell’ultimo scritto della Lonzi: La donna clitoridea e la donna vaginale. In questo testo la Lonzi attaccava le teorie freudiane legate alla sessualità femminile individuando in esse gli stessi elementi repressivi presenti nella dialettica servo-padrone elaborata dal marxismo. Entrambi gli ambiti miravano ad un’utopia patriarcale dove la donna è programmata come un essere represso ed assoggettato. Secondo la Lonzi, nel caso di Freud, l’uomo costringendo la donna ad un tipo di rapporto vaginale la priva della sua autonoma sessualità che corrisponde invece alla clitoride. Il modello di donna vaginale, in luogo di clitoridea, imposto dalla società patriarcale alla donna impedisce a quest’ultima la manifestazione della propria sessualità e la porta ad acquisire la rinuncia e la sottomissione come caratteristiche del suo essere femminile. Carla Lonzi spiega ancora come, dal punto di vista patriarcale, la donna vaginale sia considerata come la manifestatrice di una giusta sessualità mentre la clitoridea rappresenta l’immatura, la mascolinizzata e addirittura, per la psicoanalisi di Freud, la frigida. Il femminismo ribalta invece queste teorie. La donna vaginale è vista come colei che è stata plasmata come consenziente del godimento dell’uomo, o patriarca, mentre la clitoridea, non accondiscendendo alla situazione d’integrazione che riguarda la donna passiva, si è espressa in una sessualità diversa che non coincide col coito. Per godere dell’orgasmo clitorideo la donna deve trovare un’autonomia psichica. Questa autonomia, di cui gode la donna che si è allontanata dalla dimensione di assoggettamento imposta alla donna vaginale, è assolutamente inconcepibile per la civiltà maschile tant’è che viene considerata come un rifiuto dell’uomo ed un presupposto per l’inclinazione al lesbismo. La Lonzi spiega invece come fosse importante affermare il proprio sesso e non solo soddisfarlo. Se la donna che prova l’orgasmo clitorideo non prende coscienza del fatto che sta esprimendo la propria sessualità resterà ugualmente succube dell’uomo. La mancata presa di coscienza porta infatti la donna a non distanziarsi dal modello sessuale dell’uomo e si adopererà per dimenticare il suo tradimento e la sua non idoneità la ruolo che le è imposto dalla società patriarcale. Attraverso questi testi la Lonzi mette in chiaro i punti che nella sua esperienza personale, come in quella delle altre donne di Rivolta, aveva individuato come fattori discriminanti nei confronti della donna. Il raggiungimento di una simile consapevolezza, e la successiva necessità di redigere per iscritto le sue osservazioni, era stato possibile grazie al confronto e al riconoscimento che aveva provato entrando in contatto con le donne di Rivolta Femminile e alla pratica dell’autocoscienza. Ogni testo della Lonzi è scritto infatti in autocoscienza in quanto lei stessa parte sempre dall’analisi e dalla verifica della propria esperienza.
DAL MANIFESTO:
Dal Manifesto:
“La donna non va definita in rapporto all’uomo (…). L’uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna.”
“La donna come soggetto non rifiuta l’uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. “
“Chiediamo referenze di millenni di pensiero filosofico che ha teorizzato l’inferiorità della donna.”
“Della grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto noi consideriamo responsabili i sistematici del pensiero: essi hanno mantenuto il principio della donna come essere aggiuntivo per la riproduzione della umanità, legame con la divinità o soglia del mondo animale; sfera privata e pietas. Hanno giustificato nella metafisica ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna.”
“Sputiamo su Hegel.”
“Unifichiamo le situazioni e gli episodi dell’esperienza storica femminista: in essa la donna si è manifestata interrompendo per la prima volta il monologo della civiltà patriarcale.”
RENÉ LE SENNE

A cura di Filosofia e dintorni
“Come cogliere il senso dell’essere? Calandosi fino in fondo nella profondità della coscienza, immergendosi con occhio filosofico nell’intimità della propria esistenza” (Trattato di caratterologia)
Vita
René Le Senne nasce a Elbeuf (Francia) nel 1882. Dopo la laurea in filosofia ottiene la cattedra alla Sorbona. Assieme a L. Lavelle è uno dei massimi rappresentanti dello spiritualismo francese tra le due guerre.
Le diverse espressioni della filosofia dell’esistenza, che interessano l’Europa nel corso degli anni venti e trenta, trovano favorevole accoglienza in Francia. Da un lato la tradizione dello spiritualismo ottocentesco, rinnovata agli albori del nuovo secolo dalla filosofia di Bergson, offre un terreno particolarmente propizio a una filosofia che accentua il lato personale della meditazione filosofica. Dall’altro l’inedita apertura dei filosofi francesi al mondo culturale tedesco fornisce l’occasione per la penetrazione in Francia delle varie correnti della filosofia della vita (Lebensphilosophie), della tenomenologia e della filosofia dell’esistenza. E’ soprattutto con la nascita parallela della rivista “Recherches philosophiques”, fondata da Alexandre Koyré nel 1932, e della collana Philosophie de l‘Esprit, fondata da René Le Senne nel 1934, che si possono individuare due correnti esistenzialiste, che si è soliti distinguere in una di “sinistra” e in una di “destra”.
La corrente “di destra” dell’esistenzialismo francese, ha in René Le Senne (1882-1954) uno dei suoi maggiori rappresentanti. Essa si ricollega più direttamente allo spiritualismo e assume un atteggiamento meno polemico nei riguardi della tradizione, in particolare dell’idealismo. Il programma della Philosophie de l ‘Esprit, la collana di testi filosofici che darà voce a questa tendenza spiritualistica, è stato redatto con l’intento di richiamare l’uomo al senso della sua esistenza e di recuperare, nell’indagine filosofica, il valore dell’impegno e della serietà metafisica di chi, riflettendo su di sé e sul rapporto che lo unisce alla realtà, ricerca anche la propria salvezza. Essi si richiamano, in polemica con l’intellettualismo e il positivismo, all’idealismo di Hamelin e allo spiritualismo di Maine de Biran, ricongiungendosi per loro tramite alla linea principale della filosofia francese di Cartesio e Malebranche.
Professore alla Sorbona, esponente dello spiritualismo assiologico, Le Senne è noto soprattutto per il suo Trattato di caratterologia. E’ considerato il fondatore della caratterologia, ossia della branca della psicologia che ha per oggetto lo studio del carattere.
Muore a Parigi nel 1954.
Opere
>> Introduzione alla filosofia (1925)
>> Il dovere (1930)
>> Ostacolo e valore [1934], Morcelliana, Brescia, 1950
>> Trattato di morale generale (1942)
>> Trattato di caratterologia [1945], SEI, Torino, 1960
>> Il destino personale (1951)
>> La scoperta di Dio (pubblicato postumo, nel 1955)
Il pensiero e la Caratteriologia
I concetti cardinali della filosofia ideo/esistenziale di Le Senne sono quelli di ostacolo e di frattura, che sono assunti dal filosofo francese come simboli della condizione esistenziale propria dell’uomo. Questi temi sono affrontati soprattutto nell’opera “Ostacolo e valore”. L’essenza dell’uomo consiste nella consapevolezza della sua azione: l’uomo è infatti innanzitutto azione. Ma questa è resa possibile dalla consapevolezza della resistenza opposta dalla realtà: quest’ultima si pone infatti come ostacolo all’agire umano. Ne segue dunque che il limite è la condizione necessaria dell’esistenza: ma la coscienza di questo limite, lungi dal produrre disperazione o angoscia (come avviene in certo esistenzialismo), deve diventare occasione per scoprire valori assoluti e trascendenti. L’uomo, di fatto, partecipa di questi valori: ma ne diventa consapevole solo nella misura in cui fa esperienza degli ostacoli concreti, i quali gli permettono di avvertire la frattura tra la realtà esistenziale e il mondo dei valori. In questa prospettiva, per Le Senne la possibilità dello scacco di fronte all’esistenza si converte in un’apertura verso la realtà dell’Assoluto (apertura che, in verità, rievoca la concezione di Jaspers).
Contro le idee diffuse che il carattere è troppo individuale e troppo insondabile, la caratterologia si propone come obiettivo l’applicazione di regole, metodi e mezzi oggettivi di indagine. Essa, preso atto della grande variabilità degli individui, cerca di stabilirne le costanti generali. La caratterologia di Le Senne è una tipologia psicologica e in quanto tale nella sua impostazione e nel suo orientamento ignora qualsiasi riferimento biotipologico e psichiatrico. Per questo resta al di fuori degli indirizzi statistici e matematici delle moderne teorie sulla costituzione e sul temperamento e dagli indirizzi psichiatrici che utilizzano prevalentemente metodi clinici.
Le Senne propone una caratterologia sulla base di precedenti lavori di Heymans (1) seguendo lo spirito del movimento caratterologico francese fine ottocento, cioè solo in modo psicologico ed empirico. Inoltre la caratterologia di Le Senne si è tenuta costantemente al di fuori dei metodi e dei concetti della psicologia ufficiale e non ha fatto uso di un metodo scientifico. “Non meraviglia pertanto se dagli psicologi e dagli ambienti qualificati essa non sia considerata” (2). Nonostante questo essa rimane un buon strumento di lavoro. Vari studiosi, tra cui Caille, Rivère e Vels, l’hanno proposta in campo grafologico e la pratica ne mostra l’utilità. Attualmente in Italia è il prof. Bornoroni che ne ha scoperto l’utilità nel campo della medicina olistica (3). Oggi sono stati fatti importanti studi di riferimento tra questa caratterologia, la biotipologia di Ippocrate e la tipologia junghiana ed è proprio questo che la rende più applicabile.
La caratterologia di Le Senne prende in considerazione solo quattro fattori del carattere umano: l’emotività, l’attività e la risonanza delle emozioni e l’ampiezza di campo di coscienza.
L’emotività viene definita come “quel tratto generale della nostra vita mentale per cui nessun avvenimento da noi subito come contenuto d’una percezione o d’un pensiero può prodursi senza commuoverci in qualche misura e cioè, senza provocare nella nostra vita organica e psichica un turbamento più o meno forte”. (4)
L’attività è la tendenza all’azione che parte dal soggetto stesso. Gli avvenimenti esterni non costituiscono che “delle occasioni, dei pretesti, se non ci fossero, egli le cercherebbe, li provocherebbe, poiché vive per agire“. (5)
L’inattivo agisce soltanto sotto la spinta di una necessità; l’attivo agisce per un bisogno interno.
La proprietà dell’attività si rivela molto bene dal comportamento di fronte agli ostacoli; per l’attivo “il sorgere di un ostacolo rafforza l’azione da lui compiuta proprio nella direzione che l’ostacolo vieta” (6); per l’inattivo le difficoltà costituiscono un motivo di scoraggiamento e di ritiro.
La risonanza viene definita come la persistenza degli effetti prodotti da un determinato evento dopo che esso è passato. In base a questa proprietà, si possono dividere gli individui in primari (quando l’influenza di una data esperienza non si prolunga molto nel tempo dopo che essa è passata) e secondari (se le esperienze passate continuano a influenzare il presente anche dopo il loro termine).
Si può dire che il primario “vive nel presente, si rinnova con esso”, mentre il secondario “smorza il presente […] opponendo alle circostanze attuali la ripercussione d’una moltitudine di impressioni passate“. (7)
L’ampiezza è il grado di consapevolezza che la coscienza ha di sé. Indirettamente può anche essere definita come la quantità di immagini, di rappresentazioni, di emozioni e di sensazioni che la mente riesce a tenere presenti simultaneamente e in maniera integrata.
In base alle diverse combinazioni di queste proprietà, Le Senne distingue 8 caratteri fondamentali:
– Nervoso (E.nA.P.)
– Sentimentale (E.nA.S.)
– Collerico (E.A.P.)
– Passionale (E.A.S.)
– Sanguigno (nE.A.P.)
– Flemmatico (nE.A.S.)
– Amorfo (nE.nA.P.)
– Flemmatico (nE.nA.S.)
Gli otto tipi di carattere secondo Le Senne non sono altro che una combinazione dei biotipi di Ippocrate e dei tipi junghiani come segue:
a) il Nervoso e il Sentimentale di Le Senne hanno in comune il tipo nervoso di Ippocrate e l’intuizione di Jung;
b) il Collerico e il Passionato di Le Senne hanno in comune il sanguigno – nervoso di Ippocrate e il sentimento di Jung;
c) Il Sanguigno e il Flemmatico di Le Senne hanno per base il sanguigno – linfatico di Ippocrate e il pensiero di Jung;
d) l’Amorfo e l’Apatico di Le Senne hanno in comune il linfatico di Ippocrate e la sensazione di Jung (8)
L’approccio di Le Senne si è rivelato particolarmente adatto alle applicazioni grafologiche, per la sua immediata comprensibilità. Oggi è tra le tipologie più usate, specialmente dai grafologi francesi e spagnoli.
Bibliografia Italiana
G. Magnani, Itinerario al valore in René Le Senne, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1971
E. Cetineo, René Le Senne: idealismo personalistico e metafisica axiologica, Palumbo, Palermo, 1952
A. Guzzo – G. Clava – C. Rosso – M. Ghio, René Le Senne, Edizioni di “Filosofia”, Torino, 1951
Andrea Le Gall, Caratterologia dei fanciulli e degli adolescenti, SEI, Torino
Basato sulla caratterologia di René Le Senne.
Note
(1) G. Heymans (1875 – 1930), psicologo olandese e professore all’Università di Grononga.
(2) N. Galli, La caratterologia di G. Heymans e R. Le Senne, o.c., p. 237.
(3) C. Bornoroni, Manuale di farmacologia omeopatica, Ipsa editore, Palermo 1994.
(4) Le Senne, Trattato di caratterologia, SEI, Torino, 1960, pag. 55.
(5) Le Senne, Op. cit., pag. 67
(6) Le Senne, Ivi
(7) Le Senne, Op. cit., pag. 77
(8) N. Palaferri, Tipologia umana. Caratteriologia e grafologia, Libreria “G. Moretti”, Urbino, 1999, p. 105
CARL GUSTAV JUNG

Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l’attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l’autore, il pubblico e il critico.
IL PENSIERO
Carl Gustav Jung fu uno dei più noti e influenti seguaci di Freud. Nato nel 1875 a Kesswil, in Svizzera, figlio di un pastore protestante,Jung si laurea in Medicina e nel 1900 entra a lavorare nell’ ospedale psichiatrico di Zurigo, diretto da Eugen Bleuler (1857-1939). Venuto a conoscenza delle teorie di Freud, intrattiene con lui scambi epistolari ed entra a far parte del movimento psicoanalitico, ma con la pubblicazione del suo volume Trasformazioni e simboli della libido (1912) vengono alla luce i suoi dissensi teorici con Freud e nel 1913 il loro rapporto si interrompe. Nel 1920, Jung intraprende viaggi in vari continenti per studiare le culture primitive e, nel 1921, pubblica il libro Tipi psicologici . Nominato nel 1930 presidente onorario della Società tedesca di psicoterapia, dopo l’ avvento del nazismo, nel 1933, non dà le dimissioni, ma collabora con Herman Goring, sino al 1940, alla riorganizzazione della Società. Nel 1948 viene fondato il Carl Gustav Jung Institut per l’ insegnamento della teoria e dei metodi di quella che è ormai denominata psicologia analitica , per distinguerla dalla psicoanalisi freudiana. Jung muore nel 1961. Jung condivide inizialmente con Freud l’ ipotesi che le manifestazioni delle malattie mentali, per essere comprese, richiedono il riferimento alla storia individuale del paziente e ai processi di rimozione che che l’ accompagnano. Successivamente, però, egli comincia a dubitare che i contenuti rimossi siano di natura esclusivamente sessuale e arriva a formulare l’ idea che i fenomeni psichici siano manifestazioni di un’ unica energia presente nella natura e non riducibili alla sola sessualità: la libido . Alla nozione di libido Jung attribuisce caratteristiche che richiamano lo slancio vitale di Bergson: essa è una pulsione dinamica della vita, che garantisce la conservazione degli individui e delle specie. Secondo Jung, Freud privilegiava eccessivamente la componente biologica di essa a scapito di quella spirituale e ne dava una rappresentazione intrisa di pessimismo: si trattava invece, di una forza essenzialmente sana, protesa verso il futuro, dalla quale dipendono le realizzazioni più alte della cultura occidentale. La libido, infatti, è suscettibile di evoluzione, e può essere spostata su oggetti immateriali ed è, dunque, spiritualizzabile; solo quando tale evoluzione è bloccata e avvengono regressioni, si originano le nevrosi . La nevrosi, infatti, è prodotta non tanto da avvenimenti risalenti alla prima infanzia, quanto da un conflitto presente, ovvero dall’ incapacità di adattarsi alle richieste dell’ ambiente o di trasformarlo: in questa situazione vince l’ inerzia, particolarmente forte nei bambini e nei primitivi, e si regredisce a forme più arcaiche di funzionamento della libido . Grazie all’ attività di produzione dei simboli , l’ uomo primitivo riuscì a trasferire l’ energia psichica da manifestazioni pulsionali immediate, a manifestazioni mediate, orientate verso fini creativi e, in tal modo, effettuò la transizione dal piano della natura a quello della cultura. I simboli della libido manifestano contenuti che trascendono la coscienza e aprono, dunque, al mondo dei valori religiosi; la religione , a sua volta, attraverso i suoi simboli, sposta la libido fuori dall’ ambito strettamente familiare, a cui Freud la restringeva, e la rende disponibile agli usi sociali. In tal modo, Jung veniva ad attribuire alla religione una funzione decisiva nello sviluppo della civiltà. Nell’ ultima fase della sua attività, egli condannerà la massificazione e la perdita di spiritualità del mondo moderno, nonchè il predominio incontrastato della scienza, e guarderà con crescente interesse alle culture e alle religioni orientali e all’ esegesi delle simbologie presenti in esse. Il simbolo, svolgendo una funzione mediatrice fra l’ inconscio e la coscienza può operare come agente trasformatore della natura stessa dell’ uomo, conducendolo ad individuarsi sempre più articolatamente come un Io. Ogni cosa può essere impiegata e funzionare da simbolo, ma alcuni simboli hanno una ricorrenza universale, che rimanda all’ esistenza di quelli che Jung chiama archetipi , cioè letteralmente modelli: i simboli non sono altro che trasformazioni della libido, nelle quali si esprimono gli archetipi. Gli archetipi non sono idee, ma possibilità di rappresentazioni, ossia disposizioni a riprodurre forme e immagini virtuali, tipiche del mondo e della vita, le quali corrispondono alle esperienze compiute dall’ umanità nello sviluppo della coscienza. Essi si trasmettono ereditariamente e rappresentano una sorta di memoria dell’ umanità, sedimentata in un inconscio collettivo , non puramente individuale, ma presente in tutti i popoli, senza alcuna distinzione di luogo e di tempo: la mia vita è la storia di un’ autorealizzazione dell’inconscio , afferma Jung . Gli archetipi lasciano le loro tracce nei miti, nelle favole e nei sogni, che contrariamente a quanto pensava Freud, non sono appagamento di desideri puramente individuali legati alla sessualità infantile, ma espressioni dell’ inconscio collettivo. Un’ analisi comparata di questi materiali è in grado di portarli alla luce: Jung menziona tra gli archetipi più importanti quello del vecchio, della grande madre, della ruota, delle stelle e così via. Essi, però, non si presentano mai all’ analisi allo stato puro, ma attraverso loro manifestazioni in simboli: ogni individuo li avverte come bisogni e li può esprimere in modo storicamente variabile, secondo le diverse situazioni etniche, nazionali o familiari. In tal modo, l’ inconscio collettivo, attraverso gli archetipi, può condizionare e dirigere la condotta dell’ individuo nei suoi rapporti col mondo, inducendolo a ripetere esperienze collettive e, quindi ostacolandolo nel suo ulteriore sviluppo, oppure guidandolo nei suoi progetti. A proposito dell’inconscio collettivo, dice Jung in una conferenza tenuta nel 1936:
L’inconscio collettivo è una parte della psiche che si può distinguere in negativo dall’inconscio personale per il fatto che non deve, come questo, la sua esistenza all’esperienza personale e non è perciò un’acquisizione personale. […] l’inconscio personale consiste soprattutto in “complessi”; il contenuto dell’inconscio collettivo, invece, è formato essenzialmente da “archetipi”. Il concetto di archetipo, che è un indispensabile correlato dell’idea di inconscio collettivo, indica l’esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque. La ricerca mitologica la chiama “motivi”; nella psicologia dei primitivi esse corrispondono al concetto di raprésentations colletives di Lévy-Bruhl; nel campo della religione comparata sono state definite da Hubert e Mauss “categorie dell’immaginazione.
I complessi di rappresentazioni che mediano questa interazione fra coscienza e inconscio e fra inconscio individuale e inconscio collettivo sono strutturati secondo coppie di opposti. Una di queste coppie è costituita dall’ Io , inteso come il complesso di rappresentazioni coscienti e permanenti, in cui è riposta la propria identità, con tutti i principi e valori accolti e riconosciuti, e dall’ Ombra , intesa come l’ insieme delle possibilità di esistenza respinte dal soggetto come non proprie in quanto considerate negative. Sul piano dell’ inconscio collettivo, una variante dell’ archetipo Ombra è rappresentata dal diavolo. L’ inconscio collettivo è il punto di arrivo dell’ analisi, secondo Jung: questa, infatti, risale dal sintomo al complesso e da questo simbolo all’ archetipo. Obiettivo della terapia è la realizzazione dinamica del Sé , come espressione individuale di quel che è universalmente umano e, quindi, come superamento continuo del conflitto tra la coscienza e l’ inconscio. A tale scopo è necessario che sia superata una fusione e identificazione immediata con gli archetipi e sia, invece, effettuata una integrazione di essi nella coscienza, in modo che questa possa allargare i propri confini e diventare capace di operare scelte che portino all’ attuazione del Sè. La terapia non mira, dunque, a recuperare il rimosso, come voleva Freud, ma a recuperare gli archetipi, in modo che nella psiche possano coesistere i contrari senza produrre conflitti e scissioni: la razionalità e l’ irrazionalità, il maschile e il femminile, l’ estroversione e l’ introversione, il pensiero e la sensazione. L’ obiettivo non è l’ eliminazione di uno di questi contrari, perchè ciò condurrebbe a un impoverimento del Sè, che diventerebbe unilaterale: si tratta, invece, di integrare armonicamente ciascun contrario con l’ altro, assecondando le tendenze vitali del paziente all’ autorealizzazione. Su questi presupposti, Jung costruì una tipologia di caratteri, ossia di forme individuali stabili, la quale fondata prevalentemente sulla distinzione fra estroversione e introversione : nel primo caso, l’ energia libidica è orientata all’ esterno, mentre nel secondo, è distolta dagli oggetti esterni per concentrarsi sul mondo interno del soggetto. Però, anche quando predomina uno di questi tratti caratteristici, ciò non significa, secondo Jung , che l’ opposto sia del tutto scomparso e inoperante. Jung concepisce il Sé come la totalità psichica rispetto a cui l’Io, la nostra parte cosciente, è solo una piccola parte. Va ricordato che Jung è stato buon lettore di Kant, che a sua volta aveva paragonato la ragione a un’isola nell’oceano dell’irrazionale. Diventar se stessi, o come dice Jung ” individuarsi “, significa non arroccarsi nella propria identità egoica, ma aprirsi al Sé, ossia a quell’altro da noi che è dentro di noi, senza il quale non c’è sviluppo psichico. La dinamica Io e Sé ha in Jung un’accentuazione intrapsichica, è pensata cioè come una dinamica interna all’individuo, mentre le odierne psicologie del Sé hanno un’accentuazione interpsichica, pensano cioè a una relazione tra due individui (madrebambino). Per quel che riguarda il sentimento , Jung dice: Quando io uso la parola “sentimento” in contrasto con “pensiero”, mi riferisco a un giudizio di valore, per esempio: piacevole o spiacevole, buono o cattivo, e via dicendo. Secondo questa definizione il sentimento non è un’emozione (che, come dice la parola, è involontaria). Il sentimento, come l’intendo io, è (come il pensiero) una funzione razionale (cioè imperativa), mentre l’intuizione è una funzione irrazionale (cioè percettiva).
FRASI FAMOSE
Conoscere le nostre paure è il miglior metodo per occuparsi delle paure degli altri.
Di regola, le grandi decisioni della vita umana hanno a che fare più con gli istinti e altri misteriosi fattori inconsci che con la volontà cosciente, le buone intenzioni, la ragionevolezza.
Il vero capo è sempre guidato
La parola credere è una cosa difficile per me. Io non credo. Devo avere una ragione per certe ipotesi. Anche se conosco una cosa non è detto che debba crederci.
Il cervello è visto come un’appendice dei genitali.
La solitudine è per me una fonte di guarigione che rende la mia vita degna di essere vissuta. Il parlare è spesso un tormento per me e ho bisogno di molti giorni di silenzio per ricoverarmi dalla futilità delle parole
Mostratemi un uomo sano di mente e lo curerò per voi.
Questa intera creazione è essenzialmente soggettiva, e il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l’attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l’autore, il pubblico e il critico.
Se c’è un qualche cosa che vogliamo cambiare nel bambino, prima dovremmo esaminarlo bene e vedere se non è un qualche cosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi
Io sono semplicemente convinto che qualche parte del Se’ o dell’Anima dell’uomo non sia soggetta alle leggi dello spazio e del tempo.
La mia vita è la storia di un’ autorealizzazione dell’inconscio.
HEIDEGGER

La grandezza dell’uomo si misura in base a quel che cerca e all’insistenza con cui egli resta alla ricerca.
CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE
1889,
Martin Heidegger nasce a Messkirch, Baden, il 26 settembre del 1899 (cinque mesi dopo nascerà a Vienna il filosofo suo contemporaneo Wittgenstein). I suoi genitori, Friedrich e Joanna Heidegger, lo educarono agli studi classici.
1909,
Si iscrive all’università di Friburgo, dopo aver frequentato le scuole prima a Costanza e poi nella stessa città universitaria.
1913,
Porta a termine gli studi universitari con la tesi su La teoria del giudizio nello psicologismo. Contributo critico-positivo alla logica.
1916,
Dopo essere divenuto libero docente presso l’università di Friburgo, nel marzo diventa assistente di Husserl, che venne chiamato per occupare la cattedra di filosofia. Prende il via un periodo di grande intesa tra i due filosofi.
1923,
Sempre a Friburgo, tiene dei seminari e corsi sulla filosofia classica e medievale. Lascia Friburgo per andare ad occupare la cattedra di filosofia dell’università di Marburgo. Qui tiene lezioni su Kant, Aristotele, Platone e Cartesio.
1928,
E’ chiamato a succedere a Husserl alla cattedra di Friburgo.
1933,
E’ nominato rettore dell’università di Friburgo. Nel suo discorso, Autoaffermazione dell’università tedesca, tenuto durante l’insediamento al rettorato, sono evidente le idee politiche che lo avevano fatto aderira, nello stesso anno, al Partito nazionalsocialista. Si dimetterà dalla carica di rettore dopo un anno dalla sua nomina di rettora per incompatibilità con il regime politico. Da questo momento comincia un periodo di lungo silenzio, Heidegger infatti non scriverà nè pubblicherà quasi nulla.
1935,
Nella suo scritto, Introduzione alla matafisica, sono evidenti chiari accenni con il regime nazista, che egli vede come evento strettamente legato alla metafisica, la sua posizione rimarrà comunque sempre ambigua.
1936,
Tiene una conferenza su Hölderlin e l’essenza della poesia a Roma.
1942,
Esca La dottrina platonica della verità.
1944
Un divieto delle potenze occupanti impedisce ad Heidegger di portare avanti la sua attività accademica. Riprende in questi anni a pubblicare nuovamente.
1950,
Tiene una serie di conferenze tra le quali quella di Monaco su La cosa; i temi trattati in questi seminari sarranno gli elementi su cui si svilupperà la meditazione heideggeriana negli anni successivi.
1958,
Riprende, seppur in un primo momento in forma privata, corsi all’università, che hanno per tema il pensiero di filosofi come: Parmenide, Aristotele, Leibniz.
1976,
Muore a Messkirch, il 26 settembre del 1976.
RIASSUNTO SU HEIDEGGER
"Arriviamo a capire che cosa significa pensare quando noi stessi pensiamo. Perché un tale tentativo riesca, dobbiamo essere preparati ad imparare a pensare. Non appena ci impegnamo in questo imparare, abbiamo già anche confessato che non siamo capaci di pensare. Eppure, l'uomo significa colui che può pensare, e ciò a giusto titolo " ("Che cosa significa pensare").
Martin Heidegger (1889-1976) ha una formazione giovanile di stampo teologico e religioso, molto influenzata dall'ambiente familiare, e questa matrice teologica resterà costante in tutto il suo pensiero; la sua fu una vita piuttosto regolare, segnata da pochi eventi, tra i quali il più importante fu senz'altro l'adesione al nazismo: ciò ha fatto molto discutere e proprio per via di quest'adesione, dopo il 1945, Heidegger fu emarginato dagli ambienti culturali tedeschi. Essa risulta particolarmente fastidiosa se teniamo presente che il suo maestro, Husserl, fu espulso dalla Germania in quanto ebreo e Heidegger gli prese il posto negli ambienti accademici: in veste di rettore dell'università, pronunciò un acceso discorso in cui tesseva le lodi del nazismo; ma, per onestà, è bene ricordare che egli non ha mai abiurato, ma, al contrario, si è sempre assunto le sue responsabilità. E del resto la sua adesione al nazismo durò pochissimo: dopo il celebre discorso in cui elogiava il nazismo, Heidegger se ne allontanò, ritirandosi all'interno della vita accademica, e arrivò perfino ad opporsi vivamente all'espulsione nazista degli insegnanti ebrei. Trattando il suo pensiero, ci accorgeremo di come in realtà l'adesione heideggeriana al nazismo sia più complessa del previsto e non possa risolversi in una questione di comodo: si tratta di un'adesione che potremmo, in un certo senso, definire "strumentale", in quanto Heidegger vede nel nazismo non un fine, ma uno strumento attraverso il quale far emergere alcune cose importanti. Sul versante culturale, gli studiosi del suo pensiero hanno individuato essenzialmente due fasi nella sua filosofia: il punto di confine tra di esse si colloca, anche se in modo non del tutto ben definito (poiché in quegli anni il filosofo pubblica pochissimo), all'incirca negli anni '30. Dopo aver pronunciato il discorso rettorale di adesione al nazismo ed essersi immediatamente ritirato nella vita accademica, non pubblica più quasi nulla fino agli anni '40. Da quel momento in poi si entra in una nuova stagione del suo pensiero: tra l'Heidegger degli anni '20 e quello degli anni '40 troviamo quella che lui stesso definisce "Kehre", ovvero una svolta. Sul fatto che una svolta ci sia stata nel suo pensiero tutti gli studiosi concordano: meno chiaro, tuttavia, è di che genere essa sia stata. Qualcuno ha sostenuto che si tratta di una svolta radicale e che l'Heidegger degli anni '40 dica cose diversissime da quello degli anni '30, ma c'è anche chi, sulla scia dell'interpretazione che Heidegger stesso dà del proprio pensiero, tende a intendere tale svolta come lieve e piuttosto sfumata. Secondo questa linea interpretativa, il problema centrale nella filosofia heideggeriana resterebbe sempre lo stesso e a cambiare sarebbero esclusivamente gli strumenti impiegati dal filosofo nel tentativo di risolverlo. Questo permetterebbe anche di capire, almeno in parte, perché si studia Heidegger tra gli esistenzialisti sebbene egli non abbia mai accettato di essere etichettato come tale e, anzi, dopo la svolta, abbia polemizzato aspramente con l'esistenzialismo: ancora più curioso rispetto a questo rifiuto dell'etichetta esistenzialista è il fatto che la stragrande maggioranza dei pensatori esistenzialisti si ispiri ad Heidegger sebbene egli neghi che la propria filosofia sia esistenzialista. In gioventù, Heidegger oscilla fra teologia, fenomenologia e ontologia: proprio come Nietzsche, anch'egli può essere considerato un pensatore "inattuale", che scrive nel Novecento ma che si occupa di problemi fin troppo classici. Heidegger, infatti, dedica costantemente la sua attenzione alla metafisica, in particolare alla dottrina dell'essere in Aristotele: come testimonianza dei suoi interessi metafisici merita di essere ricordata la sua tesi di dottorato su "La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto" (1915). L'ontologia sarà il nucleo di indagine della filosofia heideggeriana, anche nei momenti in cui il filosofo sembrerà più distante da essa. In questo periodo giovanile, però, egli si occupa anche di teologia di tradizione paolina: affrontando il problema della teologia cristiana, Heidegger insiste sul carattere di "evento" tipico dei contenuti cristiani. Nell'ontologia tradizionale le strutture fondamentali della realtà non avvengono, ma sono: ad avvenire sono i fatti, mentre, secondo quella tradizione avviata da Parmenide, l'essere in quanto tale è statico; in una concezione del genere, nota Heidegger, l'essere e il tempo sono due concetti che si escludono a vicenda, poiché l'essere è atemporale e il tempo è la dimensione del divenire. La novità introdotta dal cristianesimo è che l'essere per antonomasia (Dio) non si limita ad essere, ma, attraverso l'incarnazione del Verbo, avviene, cosicchè ci si trova di fronte ad un evento dell'essere. Si tratta di un'innovazione radicale, che stravolge la tradizione di stampo parmenidea: il fatto stesso che Platone parlasse in una sola opera (Il Timeo) del tempo e in essa non trattasse dell'essere (le idee), attesta la tradizionale inconciliabilità delle nozioni di essere e di tempo. Queste riflessioni di fondo resteranno costanti in tutta l'attività filosofica di Heidegger, tant'è che la sua opera più famosa, del 1927, si intitolerà "Essere e tempo". E una delle principali prerogative di Heidegger è di giocare con le parole: in tedesco, "Essere e tempo" si intitola "Sein und Zeit" e il filosofo fa notare la forte assonanza tra i due termini, quasi come se, in definitiva, l'essere e il tempo fossero la stessa cosa. Ma in gioventù Heidegger, oltrechè dalla teologia, risulta anche influenzato dalla fenomenologia di Husserl: in particolare, in Heidegger resta l'idea husserliana che la coscienza sia sempre costitutivamente intenzionale; la coscienza, in altri termini, si riferisce sempre a qualcos'altro, qualsiasi atto umano è un riferirsi a qualcosa, cosicchè il nostro volere, pensare, e fare è sempre riferito a qualcosa. Se l'atteggiamento di Husserl, però, era iperclassico, in quanto portava all'esasperazione la tendenza teoretica riservata da Aristotele alla filosofia, quasi sganciandosi dal mondo (che non a caso veniva da Husserl messo tra parentesi), l'indagine esistenzialista (sebbene Heidegger rifiuti di essere bollato come "esistenzialista") verte sull'esistenza e quest'ultima implica l'essere immersi in quel mondo sul quale Husserl sospendeva il giudizio. Dunque Heidegger eredità la nozione husserliana di "intenzionalità", ma respinge nettamente l'ipotesi che essa resti interna solo all'orizzonte della coscienza: ne consegue che per Heidegger il carattere intenzionale non implica soltanto il tendere alle idee, ma anche il tendere e il riferirsi al mondo; questo atteggiamento, proprio di Heidegger, rispecchia in realtà buona parte delle posizioni esistenzialistiche, che per lo più vedono come marginale l'aspetto teoretico, tanto caro ad Husserl, perché l'esistenza è, in primo luogo, essere nel mondo. Se nel periodo giovanile il filosofo oscillava soprattutto tra la teologia e la fenomenologia, con la prima fase vera e propria della sua filosofia egli proietta la propria indagine sull'essere. Questa fase si apre con la pubblicazione di " Essere e tempo " : all'inizio dell'opera, Heidegger dichiara di condividere sostanzialmente l'antica affermazione aristotelica secondo cui il problema della filosofia è chiarire che cosa è l'essere; egli proverà dunque a fornire una risposta a tale quesito, ma fa subito notare come si debba necessariamente dare a tale domanda una risposta articolata in termini diversi rispetto a qualsiasi altra. Se alla domanda "cosa è x?" (dove x sta per "uomo", "animale", "casa", ecc) si può rispondere dando una definizione, cioè effettuando un ritaglio all'interno dell'essere, quest'operazione è inattuabile se ci domandiamo "cosa è l'essere", dato che l'essere è appunto quell'orizzonte all'interno del quale ritagliamo delle porzioni nel dare definizioni. E se l'essere è quell'orizzonte ultimo su cui si stagliano tutte le cose tranne che l'essere stesso, allora non ci si dovrà interrogare sulla definizione dell'essere, ma sul senso dell'essere: ed è a questo proposito che Heidegger si propone di percorrere una nuova strada, quella dell'analisi dell'esistenza. Infatti, per provare a comprendere il senso dell'essere si deve provare a porre questa domanda passando attraverso l'analisi di quell'ente particolarissimo che è radicato nell'essere e che si pone esso stesso domande sull'essere, quell'ente cioè per cui l'essere rappresenta un problema: per provare a cogliere il senso dell'essere si deve dunque provare ad indagare l'esistenza umana, dal momento che l'uomo è immerso nell'essere e ha la capacità di interrogarsi su di esso ( " l'uomo significa colui che può pensare ") . Cosa sono l'essere, l'ente e l'esistenza? L'essere, propriamente, non è una cosa: come aveva sottolineato Aristotele, la filosofia deve indagare sull'essere in quanto essere, depurato da ogni qualità ad esso inerente; da ciò deriva il fatto che l'essere non sia una cosa, ma l'orizzonte su cui si possono definire e riconoscere le singole cose, che altro non sono se non gli "enti". L'esistenza, invece, ha sempre un carattere di trascendenza, come aveva già sottolineato Kierkegaard: ciò significa che un ente che esiste sta fuori di sé, ovvero non è mai solo ciò che è in quel determinato momento, ma anche quello che progetta di essere per il futuro. Ogni esistenza, dunque, è un progetto, un essere slanciato verso l'avvenire: se la pietra racchiude in se stessa tutto il proprio significato, l'uomo, invece, non è mai tutto in se stesso, ma si trascende di continuo, quasi come se pendesse in avanti. Sotto questo profilo, per Heidegger, solo l'uomo esiste: ecco perché l'uomo è un ente ma, a differenza degli altri enti, è dotato di esistenza. Heidegger tende frequentemente ad impiegare parole antiche colorandole di nuovi significati, convinto che scavando in esse si possano trovare significati nascosti e più profondi. Per fare ciò, si avvale di un artificio grafico che mette in luce come, pur essendo termini di vecchia data, vengano ripresi in una nuova accezione: mette i trattini tra le lettere; e così progetto diventa pro-getto, a sottolineare l'idea del gettarsi avanti dell'esistenza; quest'ultima diventa e-sistenza, con l'idea del venir fuori di continuo verso il futuro. Letteralmente, "esistenza" in tedesco sarebbe "da-sein", cioè "essere qui": in italiano diventa "esser-ci" e implica che l'esistenza sia sempre situata in un luogo del mondo e questo è connesso con l'intenzionalità fenomenologica (per cui ogni atto è un riferirsi a qualcosa) e con l'idea che l'uomo sia l'unico ente che si interroga sull'essere; inoltre, suggerisce l'idea sartreana secondo la quale l'uomo è gettato nel mondo ed è condannato ad essere libero. Quella di Heidegger è dunque una posizione apparentemente esistenzialista che, se megli analizzata, si rivela invece ontologica: infatti, al pensatore tedesco interessa l'essere ma, poiché non lo si può trattare come tutti gli altri oggetti, egli ricorre ad un' "analitica dell'esistenza" orientata a cogliere il senso dell'essere. Ecco perché, per Heidegger, l'analitica esistenziale non è un obiettivo, ma solo uno strumento: e in "Essere e tempo" egli attua questa analitica dell'esistenza nel tentativo di cogliere il senso dell'essere, non per fare un'analisi fine a se stessa sul senso dell'esistenza umana; l'opera, tuttavia, resta incompiuta perché Heidegger dice che gli è mancato il linguaggio per sviluppare pienamente l'analisi ontologica. Da queste considerazioni emerge come, in realtà, il tema trattato nell'opera è "Esistenza e tempo", in quanto, per indagare sull'essere attraverso l'esistenza, Heidegger finisce per non trattare affatto la tematica dell'essere. L'ambiguità sta quindi nel fatto che ci troviamo di fronte ad un'opera che, nelle intenzioni dell'autore, doveva essere ontologica ma che in fin dei conti non fa altro che trattare dell'esistenza: ed è per questo motivo che molti pensatori hanno visto in Heidegger il punto di partenza per le riflessioni esistenzialistiche. Ma, stando a quanto abbiamo finora detto, possiamo dare ragione ad Heidegger quando dice che la "svolta" nel suo pensiero non è stata così radicale: il suo obiettivo resta sempre e comunque quello ontologico e se anche in "Essere e tempo" risalta l'analitica esistenziale, ciò non toglie che essa resti un mero strumento; sia nella sua prima fase (quella "esistenzialista") sia nella seconda (che sarà "ermeneutica") l'essere resta al centro dell'indagine. Nel periodo in cui Heidegger conduce l'analisi esistenziale, risulta centrale la coppia autenticità/inautenticità : già Kierkegaard, a suo tempo, aveva insistito sul fatto che è più facile che si salvi chi crede in qualcosa di sbagliato ma in modo sincero e autentico piuttosto di chi crede in modo inautentico in cose giuste. Heidegger riprende questa coppia di concetti e li applica all'esistenza, scavando, come sempre, nell'intimità delle parole e scoprendo in esse una verità nascosta. In particolare, egli nota, nella parola "autentico" è racchiusa la radice greca " autoV " , che significa "se stesso"; una cosa, pertanto, sarà autentica quando è se stessa, quando è propria fino in fondo. Cerchiamo di capire meglio in che senso: si può parlare di esistenza autentica quando l'esser-ci, soggetto dell'esistenza, compie scelte vere, appunto "autentiche", quando cioè nelle scelte mette in gioco se stesso come l'Abramo di Kierkegaard. Viceversa, un'esistenza sarà inautentica quando sarà caratterizzata da non-scelte, da un'assoluta non-originarietà. La distinzione nell'ambito dell'analitica esistenziale tra autentico e inautentico viene poi da Heidegger inserita in un contesto fenomenologico: si tratta, dice Heidegger, di vedere le strutture di fondo dell'esistenza così come esse si manifestano nella " quotidianità media ", ovvero nella vita di tutti i giorni. E dunque il pensatore tedesco procede all'analisi dei modi fondamentali in cui l'esistenza si manifesta: il primo concetto che emerge è che l'esistenza è un essere-nel-mondo ; i trattini tra una parola e l'altra servono, in questo caso, non a separare (come era nel caso dell'esser-ci), bensì ad unire. E dire "essere nel mondo" senza i trattini è un altro modo per dire esser-ci, dato che "essere qui" vuol dire appunto essere situati nel mondo: se invece poniamo i trattini tra una parola e l'altra (essere-nel-mondo), tutto cambia. Se infatti lo scrivo senza trattini, do per scontato che ci sia un mondo già costituito e un essere che ad esso si rapporta; ma Heidegger vuole sottolineare come il mondo, propriamente parlando, esiste solo nella misura in cui è costituito dalla coscienza: essa si riferisce sempre, husserlianamente, a qualcosa e ciò comporta un relazionarsi pratico col mondo; ne consegue che, proprio come per Husserl era la coscienza ad essere intenzionale, anche per Heidegger le cose stanno in questi termini. Il mondo non è un qualcosa che esista prima: al contrario, è la natura stessa della coscienza che, proprio in virtù del suo naturale relazionarsi intenzionale, si crea il mondo, il quale si trova così ad esistere solo nella misura in cui ci sono coscienze che si relazionano a qualcosa. Con quest'asserzione, però, Heidegger non intende avvicinarsi alle tesi idealistiche e, soprattutto, fichteane dell'Io che pone il non-Io: infatti, non è la coscienza che produce il mondo in sè, ma, semplicemente, il mondo è l'insieme delle cose utilizzabili. Che poi ci sia un mondo indipendente da noi e dalla nostra coscienza, ad Heidegger non interessa, perché per noi esiste solo e soltanto il mondo con cui ci relazioniamo e quel mondo è appunto prodotto dalla coscienza, come si evince benissimo nel momento in cui Heidegger dice che esso è l'insieme delle cose che possiamo utilizzare. In tale prospettiva, è centrale la categoria di cura : la cura consiste nel badare e nel prestare attenzione alle cose poiché, se la coscienza è intenzionalità, allora essa non può che tendere alle cose del mondo e prendersene cura. Ed è a questo punto che affiora uno dei maggiori stravolgimenti mai avvenuti nella cultura occidentale: da Aristotele in poi era invalsa l'idea che l'uomo avesse nell'ambito della realtà un atteggiamento teoretico da cui tutti gli altri derivavano (la tecnica stessa altro non era se non un'applicazione del sapere); Heidegger stravolge questa concezione antichissima e sostiene che l'atteggiamento intenzionale della coscienza costituisce il mondo come insieme di cose utilizzabili con l'inevitabile conseguenza che la modalità originaria della coscienza è pratica, volta all'azione, poiché tende a usare le cose e a crearsi un mondo di cose utilizzabili. L'attività conoscitiva non è più, aristotelicamente, alla base della natura umana ma, al contrario, è uno dei tanti modi in cui si possono utilizzare le cose come strumenti dell'esistenza: conoscere una cosa è uno dei tanti modi in cui posso usare quella cosa, instaurando con essa un rapporto teoretico. In questa maniera, l'esser-ci è essere-nel-mondo: il problema è che ci sono due modi diversi di essere situati nel mondo; uno è quello dell'autenticità, l'altro è quello dell'inautenticità. L'uomo, infatti, è un essere e, in quanto tale, nel relazionarsi col mondo manifesta spesso una tendenza che Heidegger definisce alla "deiezione", cioè al trasformarsi in una cosa come le altre: e ciò che distingue le cose dall'uomo è che esse sono tutte in se stesse, mentre l'esser-ci è sempre trascendente, ossia affacciato sul futuro. E nel suo relazionarsi col mondo, potrà assumere atteggiamenti che lo portino a rinunciare all'autenticità, rinunciando in questo modo all'esistenza e alla progettualità; il che richiama alla mente la vita estetica di Don Giovanni delineata da Kierkegaard, una vita in cui l'unica vera scelta che si compie è quella di non scegliere, cioè di lasciarsi vivere passivamente: e questa esistenza è immanentistica, non è vera, bensì è inautentica, dato che perde il suo carattere di libera progettualità proiettata nel futuro. L'esistenza inautentica, precisa Heidegger, è caratterizzata dal " Si " riflessivo (si fa, si pensa, si crede, ecc), imperante nell'età della massificazione: e con il solito scavo nella terminologia, si può notare come in tedesco la parola "man" ("Si") è molto affine a "mensch" ("uomo"), a sottolineare che il "Si" è l'atteggiamento proprio dell'uomo che si dedica ad un'esistenza inautentica, non propria. In particolare, questo atteggiamento nasce nel momento in cui l'uomo rinuncia alle proprie scelte per comportarsi nel modo in cui lo spinge a comportarsi il "Si", cioè la collettività: e in ciò egli diventa una "cosa" priva di progettualità, viene passivamente trascinato dalla corrente e si trova di fronte alla scelta conformistica. Quando l'esistenza umana è inautentica, perché dominata dal "Si", l'uomo non parla più né è indotto ad aspirare alla conoscenza: il parlare cede il passo alla "chiacchiera" e la conoscenza viene sostituita dalla "curiosità". Infatti, nel momento in cui cedo al "Si", non parlo più di cose che coscientemente sento mie e di cui voglio parlare con gli altri. Al contrario, "chiacchiero" avvalendomi di modi di pensare comune e tendo a parlare delle cose di cui tutti parlano nel modo in cui tutti ne chiacchierano. E Heidegger nota una cosa piuttosto interessante: non si può sfuggire al "Si" nemmeno facendo gli anticonformisti perché, in definitiva, anche l'anti-conformismo è un conformismo. Nel momento in cui regna il conformismo, infatti, tutti cercano disperatamente di sottrarsi ad esso e perciò si rifugiano nell'anti-conformismo che, diventando meta di tutti, è ancora sotto il controllo del "Si": trasgredendo la norma non si esce dai ranghi del "Si", nota Heidegger, perché non si compie una libera scelta personale, ma anzi si trasgredisce come "Si" trasgredisce, cioè nello stesso modo in cui lo fanno anche gli altri. Un esempio di anti-conformismo che sfugge al "Si" può essere quello di Socrate, il quale sa tanto inquadrarsi perfettamente nelle situazioni canoniche quanto sottrarsi ad esse: nel "Simposio" platonico, egli partecipa come tutti gli altri al convito ma poi, quand'è il momento, se ne va. Proprio in virtù dell'autenticità delle sue scelte egli è un vero anti-conformista: sceglie sempre liberamente senza mai farsi influenzare dal "Si". Oltrechè dalla chiacchiera, l'epoca contemporanea è secondo Heidegger caratterizzata dalla curiosità: l'interesse culturale autentico e genuino, profondo e motivato interiormente viene meno e cede il passo ad una banale e morbosa curiosità dominata dal "Si". Il risultato di questa situazione è la " deiezione ", cioè la trasformazione dell'uomo in cosa come tutte le altre: egli perde la sua libertà di scelta e tradisce l'esistenza autentica, abbracciando quella inautentica; quest'ultima, priva di ogni progettualità nel futuro, esula dalla temporalità, a differenza di quella autentica. Esaminiamo dunque l'esistenza autentica: centrale è il concetto di angoscia , che, come Kierkegaard, Heidegger riconduce alla paura del nulla. La grande novità consiste tuttavia nel fatto che Heidegger collega in positivo questo sentimento del nulla al problema della morte: riprendendo un'antica espressione platonica, si può affermare che la vita del saggio è una lunga preparazione alla morte, la quale (nella prospettiva platonica) altro non è se non un trapasso ad un'altra vita puramente spirituale; Dante stesso, similmente, afferma che il vivere è un correre alla morte. Heidegger, invece, parla espressamente di essere-per-la-morte , espressione che, un po' come quella platonica, suggerisce come il vivere sia in funzione della morte. In sostanza, ciò che Heidegger vuol dire quando parla di essere-per-la-morte è che la caratteristica costitutiva dell'esser-ci è di essere finito e, in virtù di ciò, di sentire la prospettiva del nulla e di essere colto per questo dall'angoscia, la quale è, appunto, il sentimento della morte: ora, questo sentimento, nella tradizione precedente ad Heidegger era per lo più stato considerato come distruttivo, dal momento che, in vista della morte, ogni nostra azione perde di significato e, non a caso, di fronte al senso di questo carattere distruttivo della morte l'uomo è ricorso alla religione, cioè al convincimento che la morte non sia la fine di tutto; così era anche per Platone, che concepiva la morte come apertura di una nuova e più alta prospettiva di vita. Per Heidegger, invece, con essa finisce tutto e vivere per la morte significa condurre la propria esistenza nella piena consapevolezza che il nostro orizzonte di vita è limitato, senza però far perdere di significato alla vita o approdare alla religione, come invece è sempre stato tradizionalmente. Heidegger dice infatti che sono proprio il carattere finito dell'esistenza e l'angoscia che ne deriva a conferire un senso alla vita: è proprio l'angoscia, ovvero l'aver sempre presente la finitudine della propria esistenza, a dare un senso autentico alle scelte che si compiono. Infatti, si può parlare di "esistenza autentica" solo nel caso in cui vi sia progettualità e libertà assoluta nelle scelte: ma le scelte, se inquadrate in un orizzonte di vita infinito, non hanno senso, non sono progettuali fino in fondo. In una prospettiva di vita eterna, le scelte perdono di significato perché sono sempre reversibili: supponendo di godere di una vita eterna, nel momento in cui scelgo un lavoro scartandone un altro, non sto compiendo una scelta totalmente libera e progettuale, perché se anche quel lavoro non mi piace, posso sempre sceglierne un altro, senza perdere mai tempo (visto che usufruisco di una vita eterna). Sembra quasi che Heidegger legga l'eventualità di una vita eterna come una condanna. E molti suoi lettori, riflettendo su queste sue considerazioni, hanno evocato a tal proposito la letteratura sui vampiri: essi esemplificano perfettamente la tematica heideggeriana dell'immortalità come condanna a vivere in eterno. Nell'ambito della vita finita, questo non avviene: il numero di anni di cui si dispone è finito, come anche il numero di scelte che si possono fare; e poi, oltre ad essere limitate, le scelte che si possono fare si escludono a vicenda e, spesso, non sono reversibili: come diceva Kierkegaard, la "logica" dell'esistenza è quella dell' "aut-aut", si sceglie liberamente o una cosa o l'altra, e il fatto stesso di compiere quella scelta esclude l'altra. Ecco perché per Heidegger l'esistenza è autentica quando è pervasa dall'angoscia che scaturisce dal prendere coscienza della nostra finitudine: e il vivere-per-la-morte ha dunque una valenza altamente positiva, in quanto rende autentiche le scelte e, con esse, la vita; cosa che non potrebbe avvenire in una prospettiva di vita eterna. La conclusione provvisoria (in quanto l'opera resta incompiuta per la "mancanza di linguaggio" che impedisce all'autore di proseguire) di "Essere e tempo" concerne il carattere intrinsecamente storico dell'esistenza: le riflessioni sull'essere-per-la-morte suggeriscono efficacemente come l'esistenza non si collochi nell'eternità, ma in una dimensione storica e temporale; e Heidegger fa notare (sulla scia della constatazione epicurea che la morte non la incontriamo mai perché quando ci siamo noi non c'è lei e viceversa) che il fatto della morte non lo viviamo veramente mai, giacchè possiamo vivere come fatto solamente la morte altrui, mentre la nostra la viviamo sempre e soltanto come possibilità solo nostra, nella consapevolezza che, prima o poi, essa ci coglierà. Ne consegue che la morte ha per noi un significato non come fatto, ma come possibilità: e, a questo punto, Heidegger fa acutamente notare come nella società moderna, in cui non si parla ma si chiacchiera e non si aspira alla conoscenza ma alla curiosità, la morte è stata rimossa. E l'aspetto più inautentico dell'esistenza della società di massa risiede proprio nel fatto che si vive perfino la morte nel "Si": non più "io muoio", ma "Si muore", quasi come se la morte non ci coinvolgesse mai in prima persona; essa viene tragicamente inserita nel "Si" generico e, pertanto, perde il suo significato di possibilità: viene meno l'essere-per-la-morte e, con esso, la libertà di scelta. Heidegger contrappone quindi la posizione comune sulla morte a quella che il saggio deve far propria: l'opinione comune esorcizza l'idea della morte, ritiene pusillanime intrattenervisi, la lascia indeterminata e in realtà nasconde la paura effettiva che la certezza della morte suscita. Il saggio invece ignora la paura e affronta l'angoscia della morte, vi convive e anzi anticipa dentro di sé la possibilità che essa si verifichi; scopre così che " la morte è la possibilità più propria dell'esser-ci ", e in tal modo si sottrae alla schiavitù dell'opinione comune, aprendosi alla possibilità di essere autenticamente se stesso e liberandosi dalle illusioni e dagli autoinganni del "Si". Scrive Heidegger, in "Essere e tempo", sull'atteggiamento del "Si" verso la morte: " il Si ha già pronta un'interpretazione anche per questo evento. Ciò che si dice a questo proposito, in modo esplicito o sfuggente, come per lo più accade, è questo: una volta o l'altra si morirà, ma, per ora, si è ancora vivi. L'analisi del 'si muore' svela inequivocabilmente il modo di essere dell'essere-quotidiano-per-la-morte. In un discorso del genere la morte è concepita come qualcosa di indeterminato che, certamente, un giorno o l'altro, finirà per accadere, ma che, per intanto, non è ancora presente e quindi non ci minaccia. Il 'si muore' diffonde la convinzione che la morte riguarda il Si anonimo. L'interpretazione pubblica dell'esser-ci dice: 'si muore'; ma poiché si allude sempre a ognuno degli Altri e a noi nella forma del Si anonimo, si sottintende: di volta in volta non sono io ". Ma la morte è la cosa che più di tutte ci appartiene ed è nostra fino in fondo, tant'è che nessun altro può viverla al posto nostro: essa è anzi l'unica certezza della nostra esistenza, in quanto, pur non potendo sapere pressochè nulla di ciò che ci accadrà in futuro, ciononostante possiamo con certezza affermare che, prima o poi, ci toccherà morire. L'esistenza, nota Heidegger, è proiettata nel tempo e, soprattutto, nel tempo futuro, poiché essa è, per sua natura, progettualità; e nell'analisi che egli fa della temporalità , critica aspramente la tradizionale concezione che intende il tempo come una "cosa" divisa in tre parti (passato, presente, futuro): non si tratta di tre parti distinte, ma di tre aspetti della medesima cosa. A tal proposito, Heidegger fa notare come la parola tedesca che significa "storia" è molto simile al verbo "mandare" e, per questo motivo, egli tende ad interpretare la storia come destino; e questo, egli afferma, vale tanto per i popoli quanto per i singoli. Nel concetto di "storia come destino" Heidegger vede sintetizzata l'identità dei tre aspetti (passato, presente, futuro) che costituiscono il tempo: e dire che per ciascuno di noi la storia è destino implica che essa non sia solo il passato, né, tantomeno, semplicemente il futuro. Al contrario, l'idea che Heidegger evince dalla somiglianza della parola "storia" con la parola "mandare" è che il passato possa da noi essere vissuto in due maniere differenti: da un lato, lo si può accettare come un dato di fatto senza significati reconditi; ma, dall'altro lato, lo si può intendere come un "mandato", cioè come un destino. E così possiamo concepire il nostro passato come un incarico ricevuto e proprio nella possibilità che abbiamo nel presente di scegliere se vedere il passato come mero dato di fatto o come destino risiede la possibilità che secondo Heidegger abbiamo di scegliere, paradossalmente, il nostro passato: inoltre, se lo leggiamo come un "mandato", possiamo progettare in base ad esso il nostro futuro e, da questa stretta dipendenza fra le tre dimensioni temporali (passato, presente, futuro), si capisce benissimo come per Heidegger esse siano tre aspetti della medesima cosa. Infatti, l'io e i popoli compiono le loro scelte nel presente sulla base di un destino radicato nel passato e in vista di un progetto situato nel futuro. Sulla base di queste considerazioni, si può facilmente arguire perché Heidegger parli di " storicità dell'esistenza " : e con essa si chiude "Essere e tempo", questa lunga e complessa analisi dell'esser-ci come via per cogliere l'essere. L'opera si chiude con un avvertimento dell'autore: " il chiarimento della costituzione dell'essere e dell'esserci resta soltanto una via: il fine è l'elaborazione del problema dell'essere in generale "; non essendo riuscito a mantener fede al suo proposito di indagare sull'essere, egli si propone ora di impostare la sua indagine in una nuova maniera. Ed è per questo motivo che Heidegger, dalla storicità dell'esistenza, cercherà di passare alla "storicità dell'essere": i due concetti chiave del secondo Heidegger (quello del dopo la svolta) sono la metafisica e la verità. Egli opera una vera e propria distruzione della metafisica e un radicale stravolgimento della nozione di "verità", due operazioni che richiamano immediatamente alla mente la filosofia di Nietzsche. Tuttavia, siamo di fronte a prospettive assai diverse, quasi antitetiche: nel caso della distruzione della metafisica, la partita si gioca tutta sul significato da attribuire al termine "metafisica". Essa, per Nietzsche, altro non era se non un'ontologia, una pura e semplice pretesa di descrivere com'è il mondo; tant'è che, dichiarato il venir meno dell'essere, anche la metafisica, intesa appunto come descrizione dell'essere, perdeva ogni significato. Per Heidegger, però, la metafisica non è riducibile all'ontologia, in quanto non è il fare discorsi sull'essere, bensì è un certo modo di fare discorsi sull'essere: in particolare, la metafisica sarà quel modo specifico di fare discorsi sull'essere che smarrisce l'autentico significato dell'essere stesso, con il risultato che "ontologia" e "metafisica" sono due concetti antitetici. Detto un po' banalmente: l'ontologia fa discorsi sull'essere, la metafisica fa discorsi sballati sull'essere. E per Heidegger la distruzione della metafisica si configura come rivalutazione totale dell'ontologia, mentre invece Nietzsche, distrutta una, non poteva che far saltare anche l'altra. La caratteristica portante della metafisica è, dunque, di concepire l'essere in modo errato: il problema del fraintendimento dell'essere era già affiorato in "Essere e tempo", quando Heidegger faceva notare che l'essere non può essere studiato come un qualsiasi ente, in quanto, essendo impossibile individuarne i confini, non può diventare un oggetto di indagine. E il grande errore della metafisica sta proprio nel concepire l'essere come un qualsiasi altro ente: nel corso della storia, ora l'ha concepito come la somma di tutti gli enti, ora come l'ente supremo (il Dio della teologia, e Heidegger parla appunto di onto-teo-logia), ora, in maniera più raffinata, come aspetto comune a tutti gli enti (Aristotele l'aveva inteso così). La metafisica, dunque, ha concepito l'essere come un ente: ha cioè " smarrito la differenza ontologica ", cioè la differenza che sussiste tra essere e ente. A questo proposito, Heidegger distingue tra un livello "ontologico" proprio dell'essere e un livello "ontico" in cui l'essere viene confuso con gli enti e lo si abbassa al loro livello (che è appunto "ontico"), privandolo della sua specificità. E Heidegger si propone di rivendicare un'ontologia: quello della metafisica, però, non è solamente un errore, bensì è, dice Heidegger, un " erramento "; il che suggerisce, contemporaneamente, l'idea dell'errore e dell'andare vagando. Si tratta di capire che l'errore della metafisica, commesso molti secoli addietro da Platone e dalla sua "ontificazione" dell'essere (attuatasi attraverso l'indebita trasformazione dell'essere in idee), non è puramente accidentale; al contrario, si è da allora sempre più verificato un erramento, uno sbandamento continuo in virtù del quale l'essere è sempre stato interpretato scorrettamente. Si deve pertanto tornare all'epoca in cui per la prima volta si è commesso tale errore per porre ad esso un riparo: ma è, dice Heidegger, un qualcosa di ben più profondo di un semplice errore. Infatti, non solo è un errore dell'essere, ma è anche un erramento dell'essere, il quale ha una sua storia e che, quindi, non è definito una volta per tutte; viceversa, l'essere segue un suo percorso lungo il quale, di volta in volta, si manifesta in modo diverso e i modi in cui esso si manifesta all'uomo sono in continua trasformazione, sicchè ci si trova di fronte ad un erramento che è, al contempo, dell'essere e dell'uomo. E anche se la metafisica è stata un errore, cioè un modo errato di manifestarsi dell'essere, ciò non toglie che in determinate epoche storiche l'essere non poteva che manifestarsi in quel modo: in particolare, l'epoca della metafisica, iniziata con Platone e chiusasi con Nietzsche (compreso), è l'epoca in cui l'essere si è, paradossalmente, manifestato sotto forma di oblio e di smarrimento. Come senz'altro si ricorderà, Nietzsche non solo aveva mutato il contenuto della verità: ne aveva stravolto la nozione stessa. Heidegger, in modo analogo, compie un'operazione simile e mette in luce l'esistenza di due concetti diversi di verità: un concetto metafisico di verità, e uno ontologico. Il concetto metafisico intende la verità come correttezza, ossia corrispondenza tra ciò che abbiamo nella nostra mente e ciò che è presente nella realtà esterna. La verità metafisicamente intesa tende allora a configurarsi come dominio dell'oggetto da parte del soggetto. Questa concezione della verità, invalsa con Platone, si è protratta per tutto il corso della storia, fino a Nietzsche compreso: se infatti concepiamo la verità metafisica come controllo e dominio dell'oggetto, allora siamo indotti a interpretare in senso metafisico perfino il pensiero scientifico e tecnico. La scienza e la tecnica, infatti, si configurano come estremizzazione dell'atteggiamento metafisico, in quanto si propongono di dominare concettualmente e materialmente un oggetto esterno al soggetto. Nietzsche stesso (a cui Heidegger dedica due volumi intitolati "Nietzsche") appare come il prodotto estremo dell'era metafisica: lo si evince benissimo dalla nozione nietzscheana di "volontà di potenza", nozione secondo la quale viene meno l'importanza dell'essere e viene portato all'estremo il dominio concettuale del mondo da parte del soggetto; infatti, venendo a mancare l'essere, il soggetto si impone e propone interpretazioni potenti, che promuovono la vitalità e risultano sganciate dall'essere. Nietzsche stesso, del resto, dava un giudizio altamente positivo della tecnica, la quale, come abbiam visto, è un'espressione fortissima della metafisica. L'atteggiamento ontologico, invece, lo troviamo in un'altra accezione del termine verità: Heidegger, come suo solito, scava all'interno delle parole per riportare in superficie significati nascosti; la parola su cui egli compie ora tale operazione è la parola greca alhqeia ("verità"); essa, letteralmente, è costituita dall' a privativa e dal verbo lanqanw ("nascondere"), cosicchè la verità è ciò che non sta nascosto. Nell'interpretazione heideggeriana, l' alhqeia è il non-nascondimento dell'essere; ma non nel senso che sta all'uomo rimuovere il velo che occulta la verità (cioè l'essere), come invece era per Schopenhauer. Al contrario, è l'essere stesso che si disvela: e non è un caso che l'ontologo per eccellenza, Parmenide, nel suo ipotetico viaggio narrato nel testo " Peri fusewV " incontrava diverse divinità (simboleggianti l'essere) che si toglievano da sole il velo che le copriva, senza che fosse il filosofo a compiere tale operazione. Con l'ontologia, dunque, la verità non è più concepita in funzione del soggetto, come invece avveniva con la metafisica: al contrario, il nuovo attore del processo non è più l'uomo, ma l'essere stesso, che si manifesta disvelandosi. La storia dell'essere, dice Heidegger, si articola in diverse tappe, ciascuna delle quali è caratterizzata da un modo particolare di manifestarsi dell'essere: ad ogni epoca storica corrisponde una particolare manifestazione dell'essere. Sorge però spontaneo un quesito: se l'essere è ciò che è, ovvero se l'essere è sempre quello, allora che senso ha parlare di una "storia" dell'essere? A questo punto Heidegger compie un nuovo scavo nelle parole: il termine "epoca" deriva dal greco epoch , con il quale gli scettici designavano la sospensione di giudizio sul mondo; Husserl stesso aveva impiegato tale termine per indicare l'atto con cui poneva il mondo "tra parentesi". Ogni epoca, secondo Heidegger, è una sospensione della manifestazione dell'essere; ciò significa che il manifestarsi dell'essere come alhqeia implica che esso si disveli ma anche che sia un venir fuori da un nascondimento che fa parte della natura stessa dell'essere; in altri termini, quest'ultimo presenta nella sua natura sia il disvelamento sia il nascondimento, cosicchè in ogni epoca l'essere è disvelato ma, al contempo, resta in qualche misura nascosto. E i diversi equilibri, in continua trasformazione, che si instaurano nell'essere tra il venir fuori e lo stare nascosto rappresentano le epoche storiche. Ne consegue che ogni epoca è diversa dalle altre perché in ogni epoca l'essere si manifesta diversamente, rimanendo in sospeso ( epoch ) tra l'uscir fuori e il restar nascosto. Ma ogni epoca, dice Heidegger, si manifesta anche come pensiero: il filosofo tedesco, da un certo momento in poi, abbandona il termine "filosofia", intriso di concezioni metafisiche accumulatesi nei secoli, e sceglie il termine "pensiero", più rispettoso nei confronti dell'essere. In questa fase della riflessione heideggeriana, successiva alla "svolta", l'uomo non è più l'attore della conoscenza, ma assume un atteggiamento collaborativo con l'essere. L'uomo deve infatti mettersi " in ascolto dell'essere " , quasi come se in attesa di una rivelazione improvvisa, e allora con l'espressione "pensiero dell'essere" si designano, contemporaneamente, l'attività con cui l'uomo riflette sull'essere sia l'attività con cui l'essere riflette su se stesso. L'uomo non è più il protagonista (come invece era in "Essere e tempo"), ma è il collaboratore dell'essere; o, per usare un'espressione heideggeriana divenuta celebre, l'uomo è il " pastore dell'essere ": e il pastore non è il proprietario del gregge, ma è semplicemente colui che lo custodisce. Allo stesso modo, l'uomo è tenuto a custodire l'essere senza per questo divenirne il padrone. Questa nuova posizione affiora soprattutto nella "Lettera sull'umanismo" (1947), con la quale Heidegger capovolge la prospettiva sartreana emersa in "L'esistenzialismo è un umanismo" e interpreta il compito del pensiero come impegno non per l'uomo (come invece violeva Sartre), ma per l'essere. In questo modo, il pensatore tedesco prende le distanze dall'esistenzialismo, a cui rinfaccia di assegnare il primato a quell'ente che è l'uomo, dimenticandosi dell'essere; l'uomo, dice Heidegger, è solo il " pastore dell'essere ", colui al quale è affidato il compito di salvaguardare e custodire nel pensiero la verità dell'essere. Con un'altra espressione divenuta altrettanto famosa, Heidegger sostiene che " il linguaggio è la casa dell'essere " : ed è in questa casa che l'uomo conduce la propria esistenza come inquilino, non come possessore, giacchè la casa appartiene all'essere. L'espressione heideggeriana rimanda inevitabilmente alla convinzione degli antichi secondo la quale il tempio è la casa di Dio, nel senso che è il luogo in cui Dio si manifesta meglio. Similmente, nella prospettiva heideggeriana, l'essere si manifesta al meglio nel linguaggio, che dell'essere costituisce appunto la casa: con quest'idea ritorna la tesi, già emersa in "Essere e tempo", secondo la quale, per indagare l'essere, si deve indagare quell'ente particolare che sa riflettere sull'essere stesso; è solo nell'uomo che, attraverso il linguaggio, l'essere si manifesta al meglio. Ma Heidegger stravolge la nozione di linguaggio: infatti, il linguaggio che esprime il pensiero dell'essere non è un modo per comunicare, ma è il modo in cui l'essere si manifesta, ed è solo mettendosi in ascolto che si entra in contatto con esso. E dire che l'uomo abita nella casa dell'essere, cioè nel linguaggio, significa riconoscere che il linguaggio non è uno strumento che l'uomo si dà: al contrario, egli nasce e vive nel linguaggio, giacchè la sua vita è calata in esso, dall'inizio alla fine. E questo è vero per il linguaggio ma, più ancora, per l'essere: nella concezione ermeneutica si sottolinea, appunto, l'impossibilità di staccarsi dall'oggetto e di vederlo in modo distaccato, cosicchè non si può ipotizzare una conoscenza veramente oggettiva, bensì una comprensione dall'interno. Da tutte queste considerazioni emerge come sia impossibile parlare del linguaggio e dell'essere in modo oggettivo e distaccato: a rigore, anzi, non si può neanche mai parlare del linguaggio, in quanto ci si trova sempre e comunque a parlare nel linguaggio. Allo stesso modo, non si può parlare dell'essere in modo distaccato, poiché, in quanto enti, siamo parti in causa: ma è possibile diventare strumenti in cui l'essere si manifesta attraverso il linguaggio; si può cioè lavorare sull'essere dall'interno, in modo ermeneutico, ed è ciò che si propone di fare soprattutto Gadamer, l'allievo di Heidegger. Molto rilevante è una raccolta di saggi il cui titolo è traducibile tanto con "Sentieri del bosco" quanto con "Sentieri interrotti": Heidegger si serve infatti di una parola tecnica che indica quei sentieri del bosco che non portano da nessuna parte, ma che permettono solo di addentrarsi nel bosco. Con quest'immagine, Heidegger vuole dirci che l'essere è come un bosco e che i sentieri non sono strade verso l'essere, ma strade all'interno di esso, cosicchè si può girovagare all'interno dell'essere, senza un criterio che ci permetta di attingerlo; ed è anche in virtù di questa amara constatazione che Heidegger si allontana sempre più dalla filosofia per accostarsi alla poesia (intesa come manifestarsi dell'essere nel linguaggio) e al mettersi a disposizione dell'essere. Heidegger parla esplicitamente di " pensiero rammemorante ": in ogni epoca l'essere si manifesta e, al contempo, si nasconde (la metafisica stessa è un modo di manifestarsi) e questo viene espresso dallo stesso pensiero dei grandi filosofi, attraverso i quali l'essere si manifesta e si nasconde. Dunque, nelle pagine scritte dai vari filosofi e pensatori della storia c'è un detto (manifestarsi dell'essere) e un non-detto (tenersi nascosto dell'essere), presente ma nascosto dalle parole; e noi moderni possiamo approfittare del fatto che viviamo in un'altra epoca, in cui l'essere si manifesta diversamente, per far emergere dal pensiero degli antichi il loro non-detto: in questo consiste appunto il pensiero rammemorante. Grazie alle nuove disvelazioni dell'essere realizzatesi nelle nuove epoche storiche, possiamo in altri termini far emergere cose che i pensatori del passato hanno detto senza saperlo, inavvertitamente. Per rimanere all'immagine del bosco, Heidegger usa un'antica parola tedesca che significa, contemporaneamente, "illuminazione" e "radura"; la radura, quella parte del bosco in cui non vi sono piante, è dunque il luogo in cui si realizza una vera e propria illuminazione; questo significa che se è vero che i sentieri del bosco non portano da nessuna parte e, meno che mai, all'essere, è anche vero che possono condurre a radure in cui l'essere si illumina, in cui cioè si può far luce su di esso. Molto hegelianamente, heidegger sostiene che ogni manifestazione dell'essere è legittima: anche la tecnica , dunque, ha, in quanto espressione dell'essere, una sua legittimità, ma tuttavia essa è, come la scienza, una forma esasperata della metafisica. Proprio perché espressione della metafisica, dunque, la tecnica non può certo essere assolutamente positiva: ma, dice hegelianamente Heidegger, è necessario che gli aspetti negativi vengano vissuti fino in fondo per poter sperare in un cambiamento radicale; tanto più che Hölderlin (il poeta preferito di Heidegger) ha insegnato che " dove è il pericolo, cresce anche ciò che salva ". Il vantaggio della tecnica, se proprio vogliamo vedere come Hegel " la rosa nella croce ", sta nel far emergere la vera e profonda natura della metafisica e del suo tipico dominio dell'uomo sull'essere. Solo se si prende coscienza dell'erramento della metafisica con la tecnica si prospetta anche la possibilità di un nuovo e più corretto cominciamento filosofico. E qualcosa di simile Heidegger lo pensava anche del nazismo: dopo averlo letto, in un periodo in cui simpatizzava ancora per esso, come destino scelto attivamente dal popolo tedesco, egli maturò sempre più la convinzione che il nazismo non fosse positivo in sé, ma solo nella misura in cui, come la tecnica, faceva emergere in una forma estrema l'errore/erramento della metafisica. Anche nell'opera d'arte (soprattutto i quadri) assistiamo sempre ad un gioco tra il detto e il non-detto, cosicchè si cerca di far emergere dalla materia qualche significato, come se l'artista si facesse portavoce dell'essere. E nell'epoca d'arte l'essere si manifesta e si nasconde contemporaneamente: sicchè il critico di oggi può leggere in essa dei significati che l'autore non sapeva di averci messo. Questo giustifica anche il fatto che spesso il critico tira fuori concetti che l'artista non conosceva, ma che ciononostante erano presenti nell'opera d'arte. In questo modo, viene anche giustificata la pluralità delle interpretazioni della medesima opera.
RIASSUNTO DI ESSERE E TEMPO
Essere e Tempo I
Domanda sull’essere. Heidegger si pone la domanda “cos’è l’essere?”. In tal domanda possiamo individuare un cercato (ciò che si domanda), un ricercato (ciò che si trova), e un interrogato (ciò a cui si domanda); il nostro cercato è l’essere, il nostro ricercato è il senso dell’essere, l’interrogato non può che essere un ente, in quanto l’essere è sempre di un ente; questo ente è l’esserci dell’uomo, poiché è costitutivamente apertura all’essere, dunque ne ha sempre una comprensione preconcettuale. Interrogare l’esserci significa studiare le strutture del suo modo d’essere, cioè l’esistenza.
Esistenza. L’esistenza è una possibilità di rapporti che l’uomo può determinare, è trascendersi, progettarsi.
Comprensione ontica ed ontologica. L’uomo posto di fronte alle scelte che deve compiere, ha dapprima una conoscenza ontica del mondo, cioè lo assume come dato, poi però riflettendo si perviene ad una conoscenza ontologica cioè delle strutture dell’esserci che danno un senso al mondo.
Esserci. L’analitica dell’esserci non è studiare il soggetto invece dell’oggetto, poiché l’esserci è costitutivamente apertura al mondo e comprensione di esso. L’esserci è essere-nel-mondo, rapporto con esso, e l’esserci è la totalità del rapporto, non solo un polo di essa.
Mondo. il mondo in cui l’esserci è, per Heidegger, non è né l’insieme degli enti intramondani, né una cornice che li circonda, ma è il campo d’apparizione degli enti che accompagna la comprensione; il mondo è un esistenziale, cioè una struttura dell’esserci, non un ente esso stesso.
Essere-nel-mondo. L’essere dell’esserci è essere-nel-mondo, il che significa prendersi cura degli enti, utilizzarli e maneggiarli, progettare trascendendoli per realizzare un progetto che fa capo all’esserci stesso.
Enti. Gli altri enti dunque hanno il loro essere nella loro utilizzabilità da parte dell’esserci. Fra l’altro, la semplice-presenza degli enti, cioè il fatto di prenderli come dati, è anche essa una forma di utilizzo, utilizzo per il puro conoscere.
Il prendersi cura ha una circospezione, cioè una precomprensione dei rimandi degli enti fra loro: un ente rimanda sempre ad un altro e lo significa in rapporto ad un fine ultimo; tutti questi rimandi fanno capo all’esserci, , il quale ha una precomprensione della totalità dei rimandi, totalità che costituisce il mondo.
Coesistenza. Rispetto agli altri, l’esserci ha cura di essi, e questo può darsi in due modi: o togliere loro le cure, o aiutarli a prendersi cura delle loro cose.
Modi di essere-nel-mondo. L’uomo si trova in una situazione affettiva, nella quale sente di essere-gettato, sente la sua fatticità, ed è una modalità passiva. Poi è nel comprendere, cioè nel progettare; infine è nel parlare.
Esistenza inautentica. Alla base di questa c’è una comprensione ontica, che prende il mondo come dato. È l’esistenza del Si (si dice, si fa), l’esistenza in cui uno è tutti e nessuno, in modo fittizio e convenzionale. Questa esistenza è determinata dalla chiacchiera (il linguaggio che originariamente svela l’essere si banalizza), dalla curiosità (la ricerca del nuovo per l’apparenza visibile), dell’equivoco (non si capisce chi è il “si dice”).
Deiezione. La deiezione è quella che permette all’uomo, avendo commerci coi fatti, di ritenersi un fatto, poiché si sente un essere-gettato; la situazione emotiva, che per natura fa sentire il proprio essere gettato, lo fa sentire abbandonato a ciò che è.
Cura e circolarità della Cura. La Cura è la totalità delle strutture dell’esserci, che si prende cura e ha cura. La struttura di questa cura è circolare; infatti mentre da una parte progetta in avanti, nel futuro, dall’altra la situazione emotiva gli fa sentire la propria gettatezza che lo fa tornare indietro.
Essere e Tempo II
Morte. L’esserci è determinato dall’incompiutezza, dalla mancanza. Fra ciò che manca c’è anche la sua fine, la morte. La morte non va concepita in modo epicureo come scomparsa dell’io, né in modo inautentico come fatto. La morte è una possibilità dell’esserci, è la possibilità più propria (concerne l’essere stesso), incondizionata (l’uomo vi si trova davanti da solo), insormontabile (si eliminano tutte le altre possibilità), certa.
Con la anticipazione della morte, l’uomo comprende autenticamente sé stesso, ma ha anche la situazione emotiva dell’angoscia, che lo pone di fronte al nulla della morte, che è possibilità dell’impossibilità di possibilità.
Essere-per-la-morte. La morte non va rifuggita, ma affrontata con la decisone anticipatrice di essa: non è il suicidio o l’attesa (forme di realizzazione che tolgono il carattere di possibilità), ma è tenere presente che questa possibilità c’è sempre: così l’uomo si considera come poter-essere e vede le cose come possibilità, vede la sua possibilità di realizzarsi.
Voce della coscienza. Quello che porta l’uomo alla decisione anticipatrice e all’inizio della vita autentica è la voce della coscienza che lo richiama alla sua nullità. L’esserci è nullità: sia perché è fondamento di sé, ma essendo gettato, è infondato; sia perché nella scelta nullifica altre possibilità; sia perché sarà nullificato dalla morte. L’esserci è il nullo fondamento di un nullificante. Tale nullità non è privazione ma è il nulla assoluto che precede tutto. La voce della coscienza richiama a tale nulla e spinge a sceglierlo, cioè a scegliere la morte, per progettarlo.
Temporalità. La Cura, cioè l’essere dell’esserci, è temporalità. Il progetto è il futuro, l’essere-gettato è il passato e la deiezione è il presente; si parla di essere-avanti-a-sé, di essere-stato e di essere-presso. Questa temporalità dell’essere ha poi originato la temporalità della progettazione, quella ordinaria.
Storia. L’esserci, è storicizzarsi, è determinare mondi storici nel lasso di tempo fra la vita e la morte; è progettare, è tornare indietro alle possibilità ricevute in eredità, e tramandarne di nuove.
Circolarità di vita autentica ed inautentica e differenze con la circolarità della Cura. Un esserci può passare tutta la vita nell’esistenza del Si o percorrere un circolo fra vita autentica ed inautentica. L’esistenza è possibilità, ma le possibilità sono istituite dall’uomo; quindi quando ci si chiede il proprio senso, o lo si cerca nel mondo (valore dell’universo all’interno del quale io mi trovo), o in me stesso come dato (io padrone di me faccio delle scelte perché ho un valore di me intrinseco). L’esserci si sente gettato quando capisce che il mondo non ha senso e nemmeno lui stesso; ma sentendosi gettato, sostituisce un progetto assolto, un valore assoluto, un senso assoluto con un altro di assoluto, ma in questo modo non entra affatto nella vita autentica. Questa circolarità della Cura è ben diversa dalla circolarità di vita autentica-vita inautentica. Essere-per-la-morte non significa sentirsi gettato, ma significa considerare che tutte le scelte non sono assolute ma destinate a essere superate; l’uomo deve scegliere con una riflessione sulla morte, deve pensare che quello che sceglie non va elevato a valore assoluto. Tuttavia, in questa situazione, rischia di rimanere paralizzato, perché nulla assurge ad assoluto; allora cade nell’errore opposto, cioè progettandoti considera il suo progetto come un assoluto, ma ciò è necessario, poiché per fare qualcosa bisogna crederci. In questo modo però si eleva una scelta a valore assoluto, e così ricadi nella vita inautentica.
Il problema della terza sezione di Essere e Tempo
Il rovesciamento. Heidegger, una volta evidenziato che la temporalità era il senso dell’essere dell’esserci, avrebbe dovuto vedere l’essere in quanto tale e la sua temporalità; dopo aver studiato il rapporto dell’esserci con l’essere, avrebbe dovuto studiare il rapporto dell’essere con l’esserci. Quindi non si trattava più di andare dall’ente all’essere come aveva fatto finora e come avevano fatto i metafisici tradizionali, poiché in questo modo l’essere risulta sempre in misura dell’ente. Heidegger doveva andare dall’essere all’ente. Ma, appunto, questo era un processo che la metafisica non aveva mai fatto, e dunque Heidegger non aveva la terminologia adatta al percorso che si riproponeva.
Verità. L’essere per Heidegger è infatti qualcosa che mette in luce gli enti, che ne fa da sfondo. L’essere è verità, ma non come adaequatio rei et intellectus , cioè uguaglianza di essere e verità, fondando l’essere sulla verità; la verità per Heidegger è aletheia , disvelamento, apertura. La verità si disvela, e disvelandosi si apre, cosicché in essa uomo ed enti si possono incontrare. Ma se è disvelamento, c’è anche una parte celata: l’essere stesso, che è niente (= non-ente), implica una parte negata, nascosta. Si capisce perché Heidegger parli di verità chiaroscurale.
Ontologia. Heidegger vuole fare dell’ontologia, cioè vuole esporre il pensiero dell’essere, il pensiero che viene pensato dall’essere, il suo disvelamento. Le strutture esistenziali, riferite prima all’esserci, andranno all’essere. L’esserci ora potrà conoscere ma solo perché è in un mondo che fa capo all’essere e in cui ci sono altri enti illuminati dall’essere; l’esserci deve dunque aprirsi all’essere, abbandonarvisi, e interpretarsi come appartenente all’essere; ma l’essere ha bisogno dell’uomo come termine del suo disvelarsi; l’uomo è il pastore dell’essere, custode della sua verità rivelata.
Critica alla metafisica
Storia. Per Heidegger l’essere, come l’esserci, si storicizza nella forma dell’invio; l’uomo è sempre rinviato ad un mondo storico che ha già una sua comprensione dell’essere. La successione dei mondi è la storia dell’essere; ma tale storia è fatta di epoche, cioè di momenti di sospensione del disvelamento dell’essere. L’essere è evento, poiché si storicizza, e l’evento di questo non-disvelamento, di questo oblio dell’essere nel mondo occidentale è la metafisica.
Metafisica. La storia della metafisica è storia dell’oblio dell’essere. La metafisica e il suo oblio dell’essere è il corrispondente dell’alienazione di Marx, della reificazione di Lukács, cioè è la causa dello scadimento della società occidentale. La metafisica, più in particolare, come oblio, è oblio della differenza ontologica fra essere ed ente; differenza di cui si è tenuto conto, che ha operato, ma mai fatto oggetto di attenzione. Heidegger vuole superare la metafisica tornando alla verità chiaroscurale dell’essere.
Storia della metafisica. Dapprima i metafisici hanno stabilito l’essere come essere oggettivo, poi hanno posto l’uomo al punto massimo, poi hanno reso l’oggettività un prodotto del soggetto, e infine l’uomo è stato elevato ancora più in alto, spezzando ogni legame colla realtà. La metafisica comincia con Platone, il quale nasconde il carattere chiaroscurale della verità e la definisce conformità intelletto-oggetto. Con Cartesio l’essere-vero è certo per il soggetto, poiché il pensiero viene assolutizzato. Hegel riconduce tutto allo Spirito. Nietzsche infine parla di volontà di potenza che esaurisce tutta la realtà; Nietzsche fa metafisica sbagliata (a differenza di Heidegger che fa una metafisica più corretta), poiché in lui non c’è esistenzialismo, non c’è uno scarto fra essere ed esserci, ma la volontà di potenza viene posta come assoluto. Dopo Nietzsche la metafisica non può più espandersi.
Tecnica
La tecnica per Heidegger è il compimento della metafisica, poiché la tecnica ritiene l’uomo capace di utilizzare tutto l’ente, fino in fondo (imposizione). Ma la stessa imposizione è svelamento dell’essere.
Opera d’arte
Un’opera d’arte non è un ente intramondano nella rete dei rimandi, ma ente che dischiude un suo mondo, istituisce un mondo di valori e di significati, che provengono dalla materialità fisica della terra. La terra è il tratto di chiusura implicato in un’apertura, ma è una chiusura che contiene molti altri significati per epoche e culture successive.
Linguaggio
La poesia è un arte molto importante, poiché si avvale della parola, cosa che schiude mondi nuovi. Il linguaggio è la casa dell’essere, perché l’incontro degli enti può avvenire solo col linguaggio. Però non si può parlare del linguaggio: infatti, parlando del linguaggio siamo già in esso, che ci ha preceduto. Esiste una circolarità ermeneutica fra uomo e linguaggio: infatti, usare il linguaggio per parlare di qualcosa significa che già abbiamo una comprensione di quel qualcosa come un mondo, e la comprensione non può avercela fornita che il linguaggio. Tale circolarità si articola come chiamata e ascolto: il linguaggio che pensiamo di usare, in verità viene prima di noi, poiché senza di esso nemmeno possiamo pensare, dunque essere uomini.
IL NIETZSCHE DI HEIDEGGER
Il Nietzsche di Heidegger – di cui ora viene proposto il compendio – riunisce le ricerche e i corsi universitari di Heidegger su Nietzsche tra il 1936 e il 1946.
Già a partire dal 1930 (è lo stesso Heidegger ad indicare questa data, nella “Premessa” del suo Nietzsche), Nietzsche era diventato per Heidegger un inelubibile punto di riferimento. Ma dal 1936/37 al 1940 Heidegger tiene lezione quasi esclusivamente su Nietzsche, in un confronto serrato che egli definisce una “Aus-einander-setzung“, e la grafia con i trattini, nel vocabolario heideggeriano, sottolinendo le varie componenti della parola, accentua il significato di un disporsi dell’uno contro l’altro, e quindi di un contendere come in un corpo a corpo. (Il termine è impiegato per tradurre il concetto di pòlemos in Eraclito). Ecco i titoli dei corsi:
Nel semestre invernale 1936/37: “Nietzsche. La volontà di potenza”. Nell’opera del ’61 il titolo diventa: “La volontà di potenza come arte”.
Nel semestre estivo del 1937: “La posizione metafisica di fondo di Nietzsche”, con il sottotitolo: “L’eterno ritorno dell’uguale”, divenuto l’unico titolo nel Nietzsche del ’61.
Nel semestre estivo del 1939 (dopo un intervallo di due anni, causato, nel pieno del suo “corpo a corpo”, da un grave esaurimento nervoso che lo costringe ad interrompere l’attività didattica): “La dottrina nietzscheana della volontà di potenza come conoscenza”, divenuta poi: “La volontà di potenza come conoscenza”.
In questo stesso periodo scrive un testo che mostra la connessione tra la dottrina della volontà di potenza e il pensiero dell’eterno ritorno, che nel Nietzsche si trova all’inizio del secondo tomo con il titolo: “L’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza”.
Nel secondo trimestre del 1940: “Nietzsche: il nichilismo europeo”, nel secondo tomo del libro del ’61.
Nell’agosto dello stesso anno egli prepara un ulteriore testo intitolato: “La metafisica di Nietzsche, che viene annunciato per il semestre invernale del 1941/42 (in realtà, poi tenne un altro corso) e che fu inserito nel Nietzsche.
A questi corsi sono aggiunte alcune trattazioni stese fra il 1940 e il 1946. Il risultato è la grande opera pubblicata in due tomi nel 1961 dall’editore Neske di Pfullingen. La traduzione italiana è la versione integrale di tale opera, riunita in un unico volume.
La strategia di Heidegger nei confronti di Nietzsche va oltre i confini di una mera interpretazione: non solo infatti la sua lettura del testo nietzscheano è in funzione del progetto filosofico che va elaborando, ma egli “pensa in parallelo” con Nietzsche, in una continua e serrata interrogazione. Come egli scrive, “rimane comunque decisivo [..] ascoltare Nietzsche stesso, porre le domande con lui, per mezzo di lui e così al tempo stesso contro di lui, ma per l’unica intima cosa comune in questione nella filosofia occidentale”.
La “cosa in questione” è il problema dell’ essere, che, secondo Heidegger, Nietzsche ha in comune con la tradizione della metafisica occidentale. Per Heidegger, Nietzsche è un pensatore “essenziale”, proprio perchè ha pensato un unico pensiero, quello dell’essere, interpretato come volontà di potenza ed eterno ritorno dell’uguale. Non è mia intenzione, in questa sede, soffermarmi sull’interpretazione heideggeriana di Nietzsche (di cui il mio compendio vuole essere un invito e una guida agile alla lettura), ma piuttosto indicare, per grandi linee, il contesto teorico in cui matura tale confronto.
Nietzsche occupa una posizione particolare nello sviluppo del pensiero di Heidegger successivo a Essere e tempo, e ne condiziona gli esiti speculativi. In questa fase, la filosofia di Heidegger è incentrata sul problema della metafisica e della sua storia; a ciò egli è sollecitato dalle stesse conclusioni della sua opera principale. Nella Lettera sull’umanismo del 1947, egli dice che la “svolta” (Kehre) dall’analitica esistenziale – incentrata sull’esserci, ossia sull’uomo – verso l’analisi del senso dell’essere in generale, non c’è stata, perchè il linguaggio, ancora sostanzialmente condizionato dall’apparato concettuale della metafisica, l’ha resa impossibile. Ne emergeva la necessità, dunque, di ripensare la storia della metafisica occidentale e individuarne l'”errore” che la caratterizza. Gli scritti che scandiscono questo nuovo itineriario sono, in particolare, L’essenza della verità del 1930 (pubblicata nel 1943), l’ Introduzione alla metafisica del 1935 (edito nel 1953), Hoelderlin e l’essenza della poesia del 1937, i già citati lavori su Nietzsche, e, infine, La dottrina di Platone sulla verità del 1942.
Va chiarito, in primo luogo, che cosa intende Heidegger per “metafisica”: essa si identifica in quella tradizione di pensiero che pone il problema dell’essere dell’ente, andando oltre (metà) l’ente stesso, in una dimensione trascendente, ma che tuttavia lo risolve in modo errato, poichè riconduce l’essere sullo stesso piano dell’ente, concependolo come semplice-presenza (Vorhandenheit) – secondo la terminologia di Essere e tempo. Ciò avviene sia pensando l’essere come il carattere comune di tutti gli enti, il più astratto e indeterminato – il che rende possibile il suo rovesciamento nel nulla, come nella Logica di Hegel -; sia come causa e fondamento degli enti – il Dio della teologia aristotelica e cristiana. In ogni caso si oscura la “differenza ontologica” che distingue l’essere dall’ente e si giunge a quell’ “oblio dell’essere” (Seinsvergessenheit) che contraddistingue la storia della metafisica occidentale fino a oggi.
Ora, questi sviluppi, contenuti implicitamente già in Essere e tempo (là dove si descrive la comprensione dell’essere nell’esistenza inautentica) e tematizzati nelle opere immediatamente successive Che cos’è la metafisica? e L’essenza del fondamento – entrambe del 1929 – trovano tuttavia una più ampia articolazione negli scritti sopracitati degli anni trenta e quaranta. Ed è appunto in questo periodo che la problematica heideggeriana si confronta con la filosofia di Nietzsche. Ma per comprendere meglio questo punto, occorre seguire più da vicino la ricostruzione che Heidegger compie della storia della metafisica, sottolineando alcune tappe fondamentali. La storia della metafisica si rende comprensibile se si parte dal problema dell’ essenza della verità. Fare la storia della verità, non significa solo ricostruire i diversi significati di una parola, ma ripensare la storia dello stesso essere e, quindi, la nostra storia. Ma nostra non nel senso che è stata decisa da noi, poichè, se è vero che per Heidegger la metafisica è l’apertura storica da cui dipende il destino di noi occidentali, tuttavia tale apertura non dipende da noi, bensì dall’essere. Schematicamente, seguendo le diverse ricostruzioni che Heidegger ha elaborato negli scritti di questo periodo, possiamo articolare tale storia secondo cinque tappe fondamentali:
1) Nel mondo greco. In greco, la parola verità, a-lètheia, è formata da un alpha privativo e dal verbo lathein che significa essere nascosto; di qui la verità come “svelamento” (Unverborgenheit); il che implica un originario legame di svelamento e nascondimento, una originaria coappartenenza di verità e di non-verità. Ciò che la verità svela è la natura (physis), ossia l’essere nel suo originario manifestarsi. (La radice phu è comune sia a physis che a phainesthai, manifestare). La verità, per i Greci, è dunque il manifestarsi dell’essere che, sottraendosi al nascondimento, si offre in visione. Ma già nel pensiero greco questo originario legame di svelamento e di nascondimento viene dimenticato.
2) Nel platonismo. Con Platone si assiste a un capovolgimento dell’essenza della verità che sarà decisivo per la storia dell’Occidente. Il vero diventa l’ idéa, ciò che è “visibile”, afferrabile con esattezza dal nostro intelletto. La radice id del termine greco idéa è la stessa del verbo latino video (vedere) e videor (apparire), ma ora non si tratta più dell’apparire dell’essere, ma dello sguardo dell’uomo sull’essere stesso. La verità “cade sotto il giogo dell’idea”, diventa qualcosa di relativo all’uomo, al suo saper “vedere” correttamente l’ente. La verità, da originaria manifestazione di ciò che si nasconde, è diventata correttezza dello sguardo rivolto all’idea, che consiste nella corrispondenza (orthòtes in greco, adaequatio in latino) tra l’idea e la cosa. In questo passaggio, che riduce l’essere a oggetto di valutazione dell’uomo, Heidegger ha visto le premesse del dominio della tecnica.
3) In Aristotele e nel Medioevo. La concezione della verità come corrispondenza tra il pensiero o la proposizione e le cose, presuppone che l’essere sia qualcosa di effettivamente presente. Da qui si sviluppa la metafisica come onto-teo-logia, ossia quella dottrina dell’essere dell’ente, che concepisce come tratto essenziale dell’essere la presenza effettiva. I passaggi successivi sono rappresentati da Aristotele, che privilegia la concezione dell’essere come enèrgheia, l’esistenza in atto, e dal Medioevo, che identifica l’essere in un ente supremo – il Dio della teologia cristiana, causa del mondo e fondamento di tutti gli enti – al quale vengono attribuite, oltre alla presenza, la capacità di fondazione e la causalità.
4) In Cartesio e nell’idealismo tedesco. Con Cartesio, da cui prende avvio la scienza moderna, l’uomo si instaura come soggetto, “prendendo posto nel bel mezzo dell’ente”. La verità diventa la certezza del soggetto umano, e l’essere si trasforma in oggetto, in qualcosa che sta di fronte (Gegen-stand) al calcolo e al progetto tecnico dell’uomo. Con ciò si rende possibile la tecnicizzazione del mondo, la quale, dunque, si configura come il naturale sbocco del pensiero metafisico. L’idealismo, da Fichte a Hegel, ha proseguito sulla medesima via che riconduce l’essere delle cose all’io, e, dunque, alla volontà del soggetto.
5) In Nietzsche. Heidegger vede Nietzsche come il pensatore del compimento della metafisica, in cui si attua “il massimo e più profondo raccoglimento, cioè il compimento di tutte le posizioni di fondo essenziali della filosofia occidentale da Platone in poi.”
In Nietzsche giunge al termine il platonismo, ossia la tradizione di pensiero caratterizzata dalla distinzione tra mondo vero e mondo apparente, che l’Occidente ha fatto propria grazie anche al cristianesimo, una forma di “platonismo per il popolo”. Il nichilismo, ossia il venir meno dei valori e il depotenziamento della vita, è connaturato con tale tradizione, che svaluta il mondo sensibile e la corporeità. Nietzsche non si limita tuttavia a rovesciare il platonismo – nel senso di mantenere la struttura di quest’ultimo invertendone gli spazi – il mondo sensibile al posto del soprasensibile – ma effettua un passaggio più elaborato, uno “svicolamento” (Herausdrehung) che comporta una profonda trasformazione filosofica e una metamorfosi dell’uomo: il superuomo, inteso come l’uomo che va oltre (ueber) l’uomo che c’è stato finora. In opposizione al platonismo, Nietzsche pensa l’essere come volontà di potenza ed eterno ritorno (dottrine che risponderebbero alle tradizionali domande metafisiche sul “che cosa” e sul “come” l’ente è), in altri termini, come potenziamento e innalzamento incessante, in un perenne ritorno su di sè. Caduta la distinzione metafisica tra mondo vero e mondo apparente, la verità dell’essere è posta senza fondamento, in certo qual modo solo su se stessa. Tuttavia, l’essere pensato come volontà di potenza, (o volontà di volontà, termine che, secondo Heidegger, esprime meglio la totale infondatezza della volontà che vuole solo se stessa) rappresenta l’estrema radicalizzazione del soggettivismo e dell’antropomorfismo, esemplificata nella massima di Nietzsche:
““Antropomorfizzare“ il mondo, cioè sentirci sempre più in esso come signori”.
Anche la filosofia di Nietzsche, pertanto, rimane, per Heidegger, nell’ambito del nichilismo, della storia, cioè, in cui “dell’essere non ne è più niente”. Il nichilismo è quindi il compimento della metafisica, che culmina nel trionfo della razionalità scientifica; il mondo, in cui si è persa ogni traccia della differenza ontologica, si è così trasformato in un immenso arsenale di strumenti della “volontà di potenza”. Con Nietzsche, dunque, la metafisica perviene alla sua forma estrema, e solo in questa forma diviene comprensibile la sua essenza, che consiste nell’oblio dell’essere. Di tale evento, di cui noi non siamo semplici spettatori, poichè la storia della metafisica, come si è detto, è anche la nostra, veniamo a conoscenza solo quando è giunto alla fine. Ma nel momento in cui si apre la possibilità di ripensare l’essenza della metafisica, occorre di nuovo volgersi al primo inizio, per attingere nuove possibilità e un altro destino dell’essere. Per questo, secondo Heidegger
“Dobbiamo pensare Nietzsche, vale a dire sempre il suo unico pensiero e quindi il semplice pensiero-guida della metafisica occidentale, fino al suo proprio limite interno. Esperiremo allora come prima cosa, quanto ampiamente e quanto decisamente l’essere sia già coperto dall’ombra dell’ente e della supremazia del cosiddetto reale. […] Eppure, scorgendo questa ombra come ombra, noi stiamo già in un’altra luce, senza trovare il fuoco da cui emana il suo rilucere”.
Libro Primo
I – La volontà di potenza come arte (1936/37)
Nietzsche come pensatore metafisico
L’ espressione “La volontà di potenza” ha in N. un duplice ruolo: 1) è il titolo della sua opera capitale, programmata per anni ma mai realizzata; 2) è la denominanazione di ciò che costituisce il carattere fondamentale di tutto ciò che è. In questo secondo senso, è la risposta a quella che è da sempre la domanda-guida (Leitfrage) della filosofia che chiede che cosa è l’ente: tutto ciò che è, è per N. volontà di potenza. Nostra intenzione è chiarire la posizione di fondo all’interno della quale N. sviluppa la domanda-guida del pensiero occidentale. N. è un grande pensatore, un pensatore genuino, nel suo pensiero la tradizione del pensiero occidentale si raccoglie e si compie secondo una prospettiva decisiva. Per questo un confronto con N. è un confronto con il pensiero occidentale fino a oggi.
Il libro “La volontà di potenza”
La programmata opera filosofica capitale di N. non fu mai realizzata. Il testo di cui oggi disponiamo, intitolato La volontà di potenza contiene lavori preliminari ed elaborazioni parziali. Il piano secondo il quale i frammenti sono ordinati, l’articolazione in quattro libri e i titoli di essi sono di N.. I piani, i progetti, le articolazioni dell’opera sono cambiati più volte, senza che ci fosse una elaborazione dell’insieme che consenta di intravvedere un abbozzo determinante. Nell’ultimo anno (1888), prima del crollo, sono definitivamente abbandonati i piani iniziali.
L’autentica filosofia di N. non arriva mai ad assumere una forma definitiva nelle opere pubblicate; ciò che egli ha pubblicato è sempre avanscena. La prima edizione della Volontà di potenza, apparsa nel 1901 dopo la morte di N., comprendeva 483 brani, ordinati secondo un piano dell’Autore del 1887. Nel 1906 vi fu una nuova edizione, notevolmente accresciuta, comprendente 1067 brani; ma l’intero materiale è contenuto nell’edizione completa, nei volumi XIII e XIV dei frammenti postumi. Questi brani, per lo più, non sono semplici frammenti e annotazioni fugaci, ma aforismi accuratamente elaborati.
Piani e lavori preliminari alla “costruzione capitale”
Dall’ 82 all’88 N. elabora diversi piani e progetti, che mutano di volta in volta. Si possono tuttavia distinguere tre posizioni fondamentali (la prima, che cronologicamente si estende dall’ 82 all’83; la seconda, che comprende gli anni dall’85 all’87; la terza, che va dall’87 all’88).
Ognuna di esse è caratterizzata da un titolo predominante. La prima ha per titolo: Filosofia dell’eterno ritorno, con il sottotitolo: Un tentativo di trasvalutazione di tutti i valori. La seconda è intitolata: La volontà di potenza, con il sottotitolo: Tentativo di una trasvalutazione di tutti i valori. La terza: Trasvalutazione di tutti i valori.
“Eterno ritorno”, “volontà di potenza” e “trasvalutazione” sono le tre parole-guida sotto le quali sta la progettata opera capitale. Per comprendere la filosofia di N. occorre cogliere la connessione tra questi concetti e la loro relazione necessaria con la metafisica occidentale.
L’unità di volontà di potenza, eterno ritorno e trasvalutazione
La dottrina dell’eterno ritorno è intimamente connessa a quella della volontà di potenza, ed entrambe, nella loro unità, si autocomprendono come trasvalutazione di tutti i valori. Ma in che senso eterno ritorno e volontà di potenza sono connessi? Di questa domanda, in quanto decisiva, ci occuperemo più a fondo in seguito; per ora, basti una risposta allusiva.
L’espressione “volontà di potenza” nomina il carattere fondamentale dell’ente in quanto ente. Con ciò non si è ancora risposto alla prima autentica domanda della filosofia, bensì all’ultima domanda preliminare. La domanda decisiva che si pone al termine della filosofia occidentale è quella sul senso dell’essere, é la domanda fondamentale (Grundfrage), che non è sviluppata come tale nella storia della filosofia; anche in N. rimane entro la domanda-guida. La questione dell’essere è il pensiero più grave della filosofia, e non è un caso che l’eterno ritorno, per N. sia denominato “il pensiero più grave”. Con tale dottrina N. pensa quel pensiero che domina per intero tutta la storia della filosofia occidentale. Pensare l’essere come eterno ritorno significa pensarlo come tempo: l’eternità non come un “ora” che resta fermo, nè come una successione all’infinito, ma come l’ “ora” che si ripercuote su se stesso.
Se non si coglie la connessione tra la volontà di potenza, come carattere fondamentale dell’ente, e l’eterno ritorno, come determinazione somma dell’essere, non si comprende neppure il contenuto metafisico della dottrina della volontà di potenza.
Se però è la dottrina dell’eterno ritorno ad essere il nucleo più intimo della filosofia di N., in realtà, il suo sforzo decisivo è quello di mostrare il carattere fondamentale dell’ente come volontà di potenza; in questo senso la volontà di potenza è la dottrina centrale.
Nell’interpretazione dell’opera, non ci atterremo alla successione dei singoli brani così come si presenta nella raccolta postuma, poichè tale ordinamento è arbitrario e inessenziale. Occorre pensare i singoli brani secondo il loro movimento speculativo interno. E’ comunque decisivo ascoltare N. stesso, porre le domande con lui, per mezzo di lui e così al tempo stesso contro di lui, ma per l’unica intima cosa comune in questione nella filosofia occidentale.
La struttura dell'”opera capitale”. Il modo di pensare di Nietzsche come rovesciamento
Determiniano la posizione metafisica di N. per mezzo di due tesi: 1) Il carattere fondamentale dell’ente in quanto tale è “la volontà di potenza”. 2) L’essere è “l’eterno ritorno dell’ugale”. Se interroghiamo a fondo la filosofia di N. secondo queste due tesi, andiamo oltre la sua posizione e quella della filosofia a lui precedente. Ma soltanto questo andare oltre consente di ritornare su Nietzsche. Ciò avverrà per mezzo di una interpretazione della Volontà di potenza.
Il piano di quest’opera, su cui si basa l’edizione in volume, secondo un progetto dell’87, presenta la seguente forma:
La volontà di potenza – Tentativo di una trasvalutazione di tutti i valori
Libro primo: Il nichilismo europeo.
Libro secondo: Critica dei valori finora supremi.
Libro terzo: Principio di una nuova posizione di valori.
Libro quarto: Disciplina e allevamento.
La nostra interrogazione comincia e si limita al terzo libro. Per N. una posizione di valori è una posizione in base alla quale si determina il modo come deve essere tutto ciò che è. Una “nuova” posizione porrà, rispetto a quella antica, un valore diverso che sarà determinante per il futuro. Per questo nel secondo libro è premessa una critica dei valori supremi finora in vigore, legati al cristianesimo, alla morale e alla filosofia. Tali valori vengono confutati in base all’origine problematica della loro posizione. Questa critica è a sua volta preceduta da una esposizione del nichilismo europeo, contenuta nel primo libro. Il nichilismo per N. è il fatto fondamentale della storia occidentale; esso consiste nella svalutazione dei valori supremi attraverso un lungo processo storico che inizia nei secoli prima di Cristo, giunge fino al XX secolo e interesserà i secoli venturi. Il nichilismo non ha solo un carattere puramente negativo, di dissoluzione; non esclude, per lunghi tratti del suo cammmino storico, momenti di ascesa creativa. “Corruzione” e “degenerazione fisiologica” non sono cause del nichilismo, ma conseguenze, per cui esso non può essere semplicemente superato con la loro eliminazione, ma solo ritardato. Il contromovimento che si oppone al nichilismo, appartiene anch’esso alla storia del nichilismo, è interno ad esso, e sarà una transvalutazione di tutti i valori.
Ogni nuova posizione di valori dovrà ‘allevare’ coloro che portano il nuovo atteggiamento, nonchè i nuovi bisogni e le nuove esigenze. Perciò l’opera termina, nel quarto libro con “Disciplina e allevamento”.
La posizione dei valori supremi non avviene di colpo, ma coloro che li pongono, ossia i filosofi, i creatori, devono tentare nuove strade; con il loro domandare devono mettere alla prova l’ente in relazione al suo essere e alla sua verità. N. scrive: “Facciamo un tentativo con la verità! Forse sarà la rovina dell’umanità! Orsù!”
Qual è il principio della nuova posizione dei valori? E’ importante anzitutto chiarire il titolo del terzo libro. Il termine “principio” significa fondamento, nel senso dell’archè dei Greci: ciò a partire da cui una cosa si determina diventando quello che è. Il principio di una nuova posizione dei valori è quindi il fondamento di un porre valori nuovi rispetto a quelli finora in vigore. N. vuole fondare in modo nuovo la maniera in cui i valori vengono posti. Questo fondamento è la volontà di potenza. Come la si deve intendere? Abbiamo detto che per N. la volontà di potenza denomina il carattere fondamentale dell’ente, ciò che propriamente è. Ora, la riflessione decisiva di N. procede così: se si deve fissare ciò che propriamente deve essere, lo si potrà fare solo se prima si saprà con chiarezza che cosa è e che cosa costituisce l’essere. Per questo la volontà di potenza è già in se stessa un porre valori, poichè l’ente è concepito come volontà di potenza. E quindi diventa superfluo un “dover essere” che si sovrapponga all’ente affinchè questo lo prenda per misura.
Mettere in evidenza il principio della nuova posizione dei valori significa anzitutto dimostrare che la volontà di potenza è il carattere fondamentale dell’ente. In relazione a tale compito i curatori della Volontà di potenza hanno suddiviso il terzo libro in quattro capitoli:
I. La volontà di potenza come conoscenza
II. La volontà di potenza nella natura.
III. La volontà di potenza come società e individuo.
IV. La volontà di potenza come arte.
Tale disposizione appare ben fondata, sulla base dei manoscritti di cui disponiamo; i curatori hanno utilizzato, per la suddivisioneripartizione dei capitoli e la ripartizione degli aforismi diverse indicazioni di N. .
Iniziamo l’interpretazione dal quarto e ultimo capitolo: “La volontà di potenza come arte”, che comprende gli aforismi dal n. 794 al n. 853. Iniziamo dal quarto e non dal primo capitolo per ragioni che dipendono dal contenuto stesso: è soprattutto in base alla concezione nietzscheana dell’arte che si può comprendere il significato della volontà di potenza. Affinchè però l’espressionr “volontà di potenza” non continui a restare una mera parola, anticipiamo i tratti dell’interpretazione del quarto capitolo, domandando: 1) Che cosa intende N. con questa espressione? 2) Perchè il carattere fondamentale dell’ente è denominato come volontà?
L’essere dell’ente come volontà nella metafisica tradizionale
La concezione dell’essere dell’ente come volontà è in linea con la migliore tradizione della filosofia tedesca. La troviamo in Schopenhauer, la cui opera Il mondo come volontà e rappresentazione, fu inizialmente uno stimolo per la filosofia di N., anche se egli intende per volontà qualcosa di completamente diverso. L’opera di Schopenhauer, d’altra parte, è profondamente debitrice nei confronti di Schelling e di Hegel. Questi ultimi hanno interpretato l’essere come volontà. Schelling ha scritto nel trattato Sull’essenza della libertà umana che il volere è l’essere originario. E Hegel, nella Fenomenologia dello spirito, ha concepito l’essenza dell’essere come sapere, ma il sapere come uguale per essenza al volere. Entrambi erano consapevoli di interpretare il pensiero di un altro grande pensatore tedesco, Leibniz, il quale determinava l’essenza dell’essere come unità originaria di perceptio e appetitus, di rappresentazione e volontà.
Tuttavia la dottrina di N. non è dipendente da quella di questi grandi pensatori. Un grande pensatore del resto è tale perchè è in grado di trasformare in modo originale il pensiero degli altri “grandi”. Ciò vale per N., la cui dottrina dell’essere come volontà si inserisce nella corrente di pensiero più profonda e necessaria della metafisica occidentale.
La volontà come volontà di potenza
Per N. la volontà non è altro che volontà di potenza, e la potenza non è altro che l’essenza della volontà. La volontà di potenza è allora volontà di volontà, cioè volere è volere se stesso.
Se vogliamo tentare di chiarire concetti che pretendono di cogliere l’essere dell’ente, non ci possiamo richiamare ad un ente determinato o ad un modo d’essere particolare. Così, ad esempio, non si può dire che la volontà è una facoltà psichica, perchè se è la volontà a determinare l’essenza di ogni cosa, non è quest’ultima che avrà il carattere della psiche, ma sarà la psiche ad avere il carattere della volontà. Se la volontà di potenza connota l’essere stesso, non ci sarà più nulla che possa determinare ulteriormente la volontà. La volontà è volontà; ma questa definizione, formalmente corretta, non dice più nulla, e può indurre in errore in quanto si crede che alla semplice parola corrisponda una cosa altrettanto semplice.
Nietzsche nondimeno la denomina a volte come “affetto”, come “passione”, come “sentimento”, o come “comando”. Anche se questo modo di procedere può suscitare perplessità, in quanto non si tratta di determinazioni chiarite a sufficienza, va considerato che, data la polisemia del concetto di volontà, non restava a N., per definirne l’essenza, che utilizzare termini noti.
La determinazione del volere che si impone per prima, è quella di un tendere a.., mirare a qualcosa, essere diretti a qualcosa. (Anche se nell’essere diretti a qualcosa, come per es. nella rappresentazione, non è insito ancora un volere).
Si dice anche volere nel senso di desiderare; ma il volere non è un desiderare, poichè implica la risolutezza del comando. Nel volere inoltre è implicito il riferimento ad un oggetto: l’errore di Schopenhauer, al proposito, è quello di ritenere che esista un volere puro, senza un oggetto determinato. Sta invece nell’essenza del volere che in esso consistano il voluto e il volente. E’ contenuto nel volere l’ essere risoluto a se stesso, un volere al di là di se stesso e la determinatezza dell’oggetto. Quando N. accentua il carattere di comando della volontà, intende evidenziarne la risolutezza e la fermezza. In questa fermezza del volere che si slancia oltre se stessa sta l'”essere signore di..”. In questo senso la volontà è potenza, e la potenza volontà. Pertanto l’espressione “volontà di potenza” non significa che la potenza sia il fine della volontà, un qualcosa che va ad aggiungersi ad essa, ma un chiarimento della volontà stessa.
Solo dopo aver chiarito questi aspetti di fondo, si possono comprendere le ulteriori connotazioni del concetto di volontà.
La volontà come affetto, passione e sentimento
N. chiama la volontà sia affetto, sia passione, sia sentimento. In un brano della Volontà di potenza (il n. 688), egli definisce la volontà di potenza l’affetto originario, e tutti gli affetti forme derivate di essa. Queste spiegazioni non vanno intese nell’ottica della psicologia comune.
La caratteristica essenziale di un affetto è quella di trasportarci fuori di noi stessi. Nell’affetto siamo sovreccitati, non siamo più padroni di noi stessi, siamo al di là, fuori di noi. Nell’affetto la volontà diviene non volontà. Così in tedesco l’ira si dice anche Un-wille, alla lettera: non volontà, appunto.
Oltre che come affetto la volontà è connotata anche come passione. La passione è qualcosa di sostanzialmente diverso dall’affetto. In essa c’è uno slancio che non rende ciechi, ma al contrario lucidi, freddi, come ad es. nell’odio. Una passione ha anche una maggiore persistenza e compattezza, che non chiude l’io in se stesso, ma lo raccoglie aprendolo. In questo senso la volontà è un essere padrone-di-sè, nel quale diventiamo lucidi e prendiamo potere dell’ente intorno a noi e in noi.
Un sentimento invece è il modo in cui ci troviamo nei confronti delle cose e di noi stessi. Nel sentimento si apre e si mantiene aperto tale modo di essere, è esso stesso questo stato originario. Ne viene una ulteriore delucidazione dell’essenza della volontà, per cui essa si schiude a se stessa. Nel volere mettiamo in luce noi stessi, la nostra identità, e tale luce è implicita nell’essenza della volontà, non deriva da una riflessione che sopravvenga dopo.
N. designa la volontà ora come affetto, ora come passione e sentimento, ma dietro questi termini vede qualcosa di più originario: essi sono, nel fondo della loro essenza, volontà di potenza. Perciò non ha molto senso definire “emozionale” la sua concezione, in contrapposizione a quella idealistica.
L’interpretazione idealistica della dottrina nietzscheana della volontà
Se per interpretazione idealistica della volontà si intende quella concezione che dice che la volontà nella sua essenza è un rappresentare, ossia è determinata da idee, allora idealistica è l’intera tradizione occidentale che inizia con Aristotele. Questi, trattando della natura del desiderio, dice infatti che “ciò che nel desiderio è desiderato muove, e l’intelletto, il rappresentare, muove soltanto perchè si rappresenta ciò che nel desiderio è desiderato”.
Il pensiero filosofico successivo fa propria questa concezione. Per Kant la volontà e quella facoltà desiderativa che agisce secondo concetti. Il rappresentare differenzia la volontà desiderativa dall’appetito cieco. Anche nell’idealismo tedesco viene ripreso questo concetto. Per Hegel sapere e volere sono la stessa cosa. Il vero sapere è anche agire. Nietzsche stesso dice: “volere, cioè comandare”, ossia: “mirare in modo chiaro, teso” ad una cosa. E in ciò è insito appunto il rappresentare, il pensiero che comanda. Tuttavia, se vogliamo avvicinarci il più possibile alla concezione nietzscheana della volontà dobbiamo evitare tutte le denominazioni usuali, sia che vengano definite idealistiche o emozionali, o altro.
Volontà e potenza. L’essenza della potenza
Ogni volere è un voler-essere-di-più; quindi è potenza nel senso del potenziamento, dell’elevazione; è anche autoaffermazione, nel senso di un riandare all’essenza, all’origine. La volontà di potenza è dunque volontà di essenza, e in quanto tale è qualcosa che crea e distrugge: l’essere-signore-al-di-là-di-sè è sempre anche annientamento. Anche il nulla, la distruzione fanno parte dell’essenza dell’essere. Con tale concezione N. si ricollega al pensiero occidentale.
L’idealismo tedesco ha pensato l’essere come volontà, e si è spinto fino a pensare il negativo come appartenente all’essere. Hegel, nella Prefazione alla Fenomenologia dello spirito ha parlato di “immane potenza del negativo” e ha scritto che la vita dello spirito è quella “che sopporta la morte e che in essa si mantiene”.
N. che non approvava il disprezzo di Schopenhauer verso l’idealismo, nel brano n. 416 della Volontà di potenza, ha esaltato la “grandiosa iniziativa” della filosofia tedesca che ha pensato “un panteismo in cui il male, l’errore e il dolore non siano avvertiti come argomenti contro la divinità”.
Anche per quanto riguarda il concetto di potenza come determinazione dell’essere N. si ricollega alla tradizione metafisica occidentale. La potenza, per N., in quanto forza, significa essere pronti ad operare, essere capaci di.. (dynamis). Ma potenza è anche l’atto del dominio, l’essere-all’opera-della-forza (enèrgheia), nonchè venire-a-se-stesso nella semplicità dell’essenza (entelècheia). Ma dùnamis, enèrgheia ed entelècheia sono per Aristotele le determinazioni supreme dell’essere. Vi è quindi un’intima relazione fra la volontà di potenza di N. e la metafisica di Aristotele. Ciò non significa intepretare N. attraverso Aristotele, piuttosto, entrambe le dottrine devono essere riprese nel contesto di una domanda più originaria.
La domanda-guida e la domanda fondamentale della filosofia
Incominciamo l’intepretazione del terzo libro con il quarto e ultimo capitolo, intitolato “La volontà di potenza come arte”. Chiarendo come N. concepisce l’arte, si chiarisce perchè l’intepretazione della volontà di potenza debba cominciare proprio dall’arte. Occorre però tenere ben saldo l’intento filosofico fondamentale dell’interpretazione, che si articola nella domanda-guida (Leitfrage) – che chiede che cosa è l’ente – e nella domanda fondamentale (Grundfrage) – che chiede che cosa è l’essere-. Queste domande conducono oltre N., ma portano allo scoperto e rendono fertile il suo pensiero. La domanda fondamentale rimane estranea a N., come al pensiero a lui precedente.
In N. il problema dell’essenza della verità (che è incluso in tali domande), è legato all’interpretazione dell’ente in quanto volontà di potenza. E dato che l’arte ha una posizione eminente nel contesto di tale interpretazione, allora è nell’arte che diviene centrale la questione della verità.
Le cinque tesi sull’arte
Tentiamo una prima connotazione dell’essenza dell’arte in Nietzsche, mettendo in risalto, sulla base di passi importanti, cinque tesi sull’arte.
Che l’arte abbia una posizione decisiva nel compito di una nuova fondazione dei valori lo si evince anche dal brano 797 della Volontà di potenza, in cui N. afferma: “Il fenomeno dell’ ‘artista’ è ancora quello più trasparente, che si può scrutare più facilmente”. “Più trasparente” significa più facilmente accessibile nella sua essenza.
Questo perchè essere artista significa produrre, porre in essere qualcosa che ancora non è: nella produzione artistica noi partecipiamo per così dire al divenire dell’ente, e possiamo coglierne nel modo più chiaro l’ essenza. E poichè l’essenza dell’ente è la volontà di potenza, e nell’essere artista si trova il modo più trasparente della volontà di potenza, la meditazione sull’arte è decisamente prioritaria. Va tenuto presente anche che N. vede l’arte nella prospettiva dell’artista, ossia di colui che crea e produce, non in quella di coloro che ne fruiscono.
Torniamo al brano 797; ne possiamo ricavare due tesi essenziali:
1) L’arte è la forma più trasparente e più nota della volontà di potenza.
2) L’arte deve essere concepita dalla prospettiva dell’artista.
Sempre nello stesso brano, N. aggiunge che è guardando all’essenza dell’artista che vanno considerate anche le altre forme della volontà di potenza – natura, religione, morale. Secondo N., anche gli enti che non sono prodotti dall’artista hanno un modo di essere che corrisponde a quello di ciò che è creato dall’artista. Il concetto di arte non è inteso in senso stretto, nell’accezione di “belle arti”, ma è esteso a ogni saper produrre e a ogni cosa prodotta. Da qui si può formulare una terza tesi:
3) L’arte è l’accadere fondamentale di ogni ente; l’ente è, in quanto è, qualcosa che si crea, qualcosa di creato.
Ora, affermare che l’accadimento fondamentale di ogni ente è arte, significa dire che è la forma somma della volontà di potenza; la volontà di potenza, come l’arte, è un creare e un distruggere. Già nella Nascita della tragedia N. vedeva l’arte come carattere fondamentale dell’ente, laddove egli parlava di arte come attività metafisica. E’ dunque dall’arte, e non più dalla morale, dalla religione e dalla filosofia, che dovrà partire una nuova posizione di valori, che dovrà essere una trasvalutazione dei valori stessi. Secondo N., i valori tradizionali, determinati dal platonismo e dal cristianesimo, presuppongono una svalutazione del mondo sensibile, a vantaggio del cosiddetto “mondo vero”. Ora, caduto il “mondo vero”, il vero mondo è soltanto quello sensibile che è l’oggetto proprio dell’arte. L’arte afferma dunque ciò che il platonismo e il cristianesimo negano. Per questo N. afferma che essa costituisce l’unica controforza contro ogni volontà che rinneghi la vita. Con ciò si ottiene la quarta tesi:
4) L’arte è il contromovimento per eccellenza che si oppone al nichilismo.
Dunque ogni attività, compresa quella filosofica, devono essere determinati dall’arte. Ne deriva che al posto del filosofo moralista e nichilista, che guarda al cosiddetto mondo superiore, deve essere collocata la figura del filosofo-artista, il filosofo del contromovimento che operando sull’ente decide anche della verità di quest’ultimo.
Dire che per N. nell’arte si decide della verità, può apparire in contrasto con il fatto che egli definisce l’arte come volontà di parvenza che si oppone alla “volontà di verità”. Ma per N. la volontà di parvenza è volontà del sensibile e della sua ricchezza, mentre la “volontà di verità”, corrisponde alla volontà del “mondo vero” di Platone e del cristianesimo. La volontà di un “vero” siffatto è, in realtà, un dire no a questo nostro mondo, dove l’arte è di casa. In vista di un “mondo vero”, la sottomissione, la compassione, l’umiltà diventano valori autentici, mentre ogni elevazione creatrice, e ogni orgoglio della vita non sono che abbaglio e peccato. Da ciò si ricava la tesi:
5) L’arte vale di più della “verità”.
Sulla scorta di queste cinque tesi va ricordata l’affermazione di N. secondo cui l’arte è il massimo stimolante della vita; stimolante è ciò che potenzia, che “eleva al di là di sè”, ossia è volontà di potenza. L’affermazione quindi che l’arte è il massimo stimolante della vita significa che l’arte è volontà di potenza, ed è la tesi capitale di N., che viene delucidata dalle altre cinque.
A questo punto domandiamo.
1) Che cosa offre la concezione nietzscheana dell’arte in vista di determinare l’essenza della volontà di potenza?
2) Che cosa significa tale concezione per il sapere dell’arte?
Sei fatti fondamentali ricavati dalla storia dell’estetica
Cominciamo dalla seconda questione. Anche se N. non si pone la questione dell’arte come manifestazione della cultura, soltanto una riflessione sull’estetica ci consente di capire l’interpretazione nietzscheana dell’arte; peraltro egli si muove in linea con la tradizione. Secondo quest’ultima, la riflessione sul sapere dell’arte è denominata estetica, il cui oggetto è il comportamento sensibile e lo stato sentimentale in rapporto al bello. Il termine “estetica” per designare la riflessione sul bello e sull’arte è recente, e risale al XVIII secolo, ma tale riflessione è antica. Per connotare l’essenza dell’estetica, il suo ruolo entro il pensiero metafisico e il suo riferimento alla storia dell’arte europea, prendiamo in considerazione sei fatti fondamentali.
1) La grande arte greca è priva di una corrispondente riflessione concettuale che la pensi. Ciò non significa che tale arte sia solo “vissuta”. Piuttosto, essa si manifesta in un contesto di lucido sapere, così da non avere bisogno di un’estetica.
2) L’estetica nasce presso i Greci quando la grande arte, nonchè la grande filosofia che le è parallela, si approssima alla fine. In tale periodo, con Platone ed Aristotele, vengono coniati quei concetti fondamentali che da allora in poi definiranno ogni posizione dell’arte.
Anzitutto la coppia di concetti materia – forma (ylè – morfè). Questa concezione ha origine nella concezione dell’ente, fondata da Platone, che guarda al suo aspetto : eìdos, idèa. Dove l’ente viene percepito come ente e distinto dagli altri in base al suo aspetto, i suoi confini sono avvertiti come limitazione interna ed esterna. La forma è ciò che delimita, ciò che è delimitato la materia. A questa coppia di concetti si unisce un altro termine, la tècne, con cui i Greci denominano sia l’arte che l’artigianato. Con ciò non si intende equiparare l’arte all’artigianato: la tècne non è un semplice fare o un produrre, ma un tipo di sapere che guida ogni iniziativa umana. Successivamente, con l’emergere della distinzione di materia e forma, il termine perde la sua forza semantica originaria e viene riferita alla fabbricazione di cose belle, e quindi la riflessione su questi concetti si sposta nell’ambito dell’estetica.
3) Il terzo fatto coincide con l’inizio dell’età moderna. L’uomo e il suo sapere diventano il luogo della decisione che stabilisce come l’ente vada sperimentato, determinato e configurato. La libera presa di posizione dell’uomo, il suo modo di sentire le cose, in breve: il suo gusto, diventano il tribunale che decide dell’ente. In metafisica, la certezza dell’essere e la sua verità sono fondate sull’autocoscienza del cogito. La stessa riflessione sul bello viene riferita in modo esclusivo allo stato sentimentale dell’uomo. E’ in questo periodo che l’estetica viene fondata e praticata consapevolmente. Di pari passo la grande arte si avvia verso la decadenza. Tale decadenza non consiste in una peggiore qualità del prodotto, ma nel fatto che l’arte non assolve più il compito di rendere manifesta nelle opere la verità dell’ente nel suo insieme. Da qui capiamo il quarto fatto:
4) La grande arte è alla fine nel momento in cui l’estetica raggiunge la sua massima altezza. La grandezza di questa estetica consiste proprio nel riconoscere la fine della grande arte: tale estetica è quella di Hegel. Egli non ha inteso negare la possibilità e l’esistenza di singole opere d’arte, ma affermare che essa ha perduto per sempre il suo potere assoluto. Da ciò deriva la posizione dell’arte nel XIX secolo, che può essere indicata in un quinto punto.
5) Il XIX secolo, in relazione alla decadenza dell’arte che perde la sua essenza, osa compiere, ad opera di Richard Wagner, il tentativo dell’ “opera d’arte totale”. Essa consiste nel fatto che tutte le arti, e in funzione predominante la poesia e la musica, devono essere congiunte in una sola opera. Inoltre, l’arte deve diventare la celebrazione della comunità del popolo, la sua religione.
L’ “opera d’arte totale” realizza il dominio dell’arte come musica, e con esso il dominio dello stato sentimentale puro, dissolvendo ogni elemento stabile nel languido, nell’evanescente, esaltando la sfrenatezza dei sensi: “l’estasi del sonnambulo”, come la definisce Nietzsche. Nell’ “opera d’arte totale” l’arte deve ridiventare bisogno assoluto, ma l’assoluto è concepito ormai come sentimento puro; per questo il tentativo di Wagner è destinato al fallimento. D’altro canto, fu proprio questa ebbrezza sentimentale dell’opera wagneriana ad incantare il giovane Nietzsche per quella dimensione che egli poi definì dionisiaca. Mentre Wagner tuttavia cercava la mera esaltazione del dionisiaco, N. mirava a domarlo, a dargli forma: la rottura fra i due era inevitabile.
Nel XIX secolo il sapere dell’arte, in corrispondenza alla crescente incapacità di un sapere metafisico, si trasforma in una indagine scientifica sui puri fatti della storia dell’arte. La storia dell’arte e la dimensione estetica, diventano oggetto di una ricerca condotta con i metodi delle scienze naturali. Ma tale lavoro e fervore intorno all’arte, non è altro che il proscenio di quell’accadere che N. enunciò come nichilismo. Con questo arriviamo all’indicazione dell’ultimo fatto fondamentale:
6) Ciò che Hegel ha enunciato riguardo all’arte – l’aver perso la potenza di configurare l’assoluto – N. lo ha riconosciuto riguardo i “valori supremi”. Ma mentre per Hegel è l’arte, e non la religione, la morale e la filosofia, a cadere vittima del nichilismo, per N., al contrario, l’arte rappresenta il contromovimento.
Mentre inoltre per Hegel l’arte diviene oggetto di un sapere metafisico, N. considera la riflessione sull’arte una “fisiologia dell’arte”. “L’estetica è per l’appunto nient’altro che una fisiologia applicata”, egli scrive infatti in Nietzsche contra Wagner del 1888. Dunque, da un lato l’arte è il contromovimento che si oppone al nichilismo, dall’altro è “fisiologia”: indagine scientifica degli stati e dei processi corporali e delle cause che li provocano.
L’ebbrezza come stato estetico
Vista dall’esterno questa posizione sembra assurda: come può l’arte porre nuovi criteri e valori se viene ricondotta a processi nervosi e a semplici relazioni causali? Per cercare di cogliere una unità fra cose apparentemente contrastanti, esamineremo un abbozzo di N., comprendente una sequenza di diciasette appunti numerati, intitolato “Per la fisiologia dell’arte“, che si trova tra i piani della “Volontà di potenza“. Nonostante tale abbozzo non contenga un’idea direttrice visibile, fornisce tuttavia un quadro di ciò di cui si deve trattare.
“Per la fisiologia dell’arte”
Per determinare meglio il materiale, seguiremo un duplice filo conduttore: anzitutto la considerazione della dottrina della volontà di potenza, quindi le dottrine capitali dell’estetica tradizionale.
La questione dell’arte in N. è estetica, poichè essa viene determinata facendo ricorso allo stato sentimentale dell’uomo a cui appartengono la produzione e la fruizione del bello. Ma questa estetica deve essere fisiologia: gli stati sentimentali sono indagati nella loro corrispondenza con gli stati corporei. E’ l’unità psicosomatica dell’uomo ad essere posta come ambito degli stati estetici; quindi quando N. parla di fisiologia intende anche l’ambito psicologico.
Leggiamo innanzitutto un passo del Crepuscolo degli idoli (1888), intitolato “Per la psicologia dell’artista“. In esso N. afferma che lo stato estetico fondamentale è l’ebbrezza, nelle sue varie forme (derivanti da eccitazione sessuale, dagli affetti forti, dalla festa, da narcotici, ecc.). Possiamo confrontare questo passo con il brano 798 della Volontà di potenza, in cui N. parla di “due stati nei quali l’arte stessa insorge nell’uomo come una forza della natura”. Questi stati sono l’apollineo e il dionisiaco, che vengono concepiti quindi come la condizione preliminare dell’arte. Tali concetti erano già stati sviluppati nella Nascita della tragedia, nella quale, in particolare, l’apollineo e il dionisiaco venivano associati ai fenomeni fisiologici del sogno e dell’ebbrezza. Anche nel frammento 798 della Volontà di potenza l’apollineo ha il carattere del sogno, e il dionisiaco dell’ebbrezza. Ora però, nel passo del Crepuscolo degli idoli, si afferma che anche l’apollineo è una specie di ebbrezza: l’ebbrezza diviene lo stato estetico fondamentale.
A questo punto, occorre pertanto chiarire: 1) Qual è l’essenza generale dell’ebbrezza? 2) In quale senso essa è lo stato estetico fondamentale?
Alla prima domanda N., nel Crepuscolo degli idoli, dà una risposta concisa: “L’essenziale nell’ebbrezza è il sentimento del potenziamento della forza e della pienezza”. L’ebbrezza ora è definita come un sentimento. Il sentimento, come si è precedentemente chiarito, è il modo come ci troviamo presso di noi e presso le cose; è la disposizione in virtù della quale noi siamo trasportati al di là di noi stessi. Ora, che l’ebbrezza sia un sentimento non è in contraddizione col fatto che essa sia uno stato fisiologico. Noi non “abbiamo” un corpo, ma “siamo” corpi; il sentirsi, nel sentimento, è il modo nel quale noi siamo un corpo in carne e ossa in una certa disposizione d’animo.
Ora, nell’ebbrezza è contenuto sia il sentimento del potenziamento della forza che il sentimento della pienezza. Il potenziamento della forza non sta ad indicare tanto un “di più”, una crescita di forza, ma deve essere inteso come una disposizione d’animo verso l’ente nella quale l’ente stesso è esperito come più ricco e più essenziale. Analogamente, la pienezza indica la massima apertura e la massima esaltazione.
Si potrebbe connotare l’ebbrezza anche come una passione, in quanto non è uno stato passeggero, ma qualcosa che permane. Rimane comunque difficile applicare all’ebbrezza termini quali sentimento, affetto, passione.
Per quanto riguarda la seconda domanda, dobbiamo chiederci, secondo le parole di N., in quale senso l’ ebbrezza è “inevitabile” perchè vi sia arte, se essa sia soltanto una condizione dell’arte o la fonte perenne. Abbiamo visto che l’ebbrezza è una disposizione d’animo che ci apre fino alla pienezza delle nostre facoltà, le quali si stimolano e si esaltano a vicenda. Procediamo continuando a domandare che cosa è determinante in questa disposizione perchè possa essere chiamata estetica.
La dottrina kantiana del bello. Il suo fraintendimento a opera di Schopenhauer e di Nietzsche
Non vi è in N. una esposizione costruita e fondata sul bello e sulla bellezza. Le sue tesi risultano dal rovesciamento delle vedute estetiche di Schopenhauer. Queste, esposte nel terzo libro del Mondo come volontà e rappresentazione, non sono ben fondate, ma sono un fraintendimento dell’estetica kantiana.
Il fraintendimento delle idee di Kant sul bello e sull’arte, non riguarda solo Schopenhauer e Nietzsche, ma gran parte della storia della filosofia. Tale fraintendimento nasce da una asserzione di Kant sul bello, sviluppata nei parr. 2-5 della Critica del Giudizio. “Bello”, per Kant, è ciò che piace soltanto in modo puro, “senza interesse”. Per Schopenhauer ciò si identifica nella sospensione della volontà; in N., secondo uno schema di contrapposizione, “bello” diviene l’ebbrezza, ossia il contrario di ogni “piacere disinteressato”.
Ma in Kant l’espressione “piacere disinteressato”, lungi dall’ indicare un’indifferenza verso l’oggetto, al contrario, ne è una valorizzazione. In Kant il termine “interesse” ha una valenza negativa, sta a indicare ciò che può distoglierci dall’individuazione del bello in quanto tale. Solo dopo aver messo da parte ogni “interesse”, possiamo cogliere l’oggetto nel suo proprio rango e nella sua dignità, e quindi nella sua bellezza.
Peraltro, il fraintendimento dell’estetica kantiana è un limite che N. condivide con il proprio tempo. Però ora si tratta di capire, all’interno di tale contesto storico, ciò che N. dice sulla bellezza. Anch’egli determina il bello come ciò che piace, inteso come ciò che ci si addice, che ci corrisponde. Il bello è dunque ciò che apprezziamo e veneriamo come l’immagine-modello (Vor-bild) del nostro essere. N. scrive che il bello “è l’estasi di essere nel nostro mondo”, ossia mediante il bello l’uomo penetra in uno stato fondamentale in cui perviene alla pienezza fondata sulla sua essenza. Una cosa analoga Kant intende con il “piacere della riflessione”, quale comportamento fondamentale in rapporto al bello. Ora, tale stato, per N., e un elevarci-al-di-là-di-noi nella pienezza delle nostre facoltà essenziali: in altri termini tale stato coincide con l’ebbrezza.
L’ebbrezza come forza creatrice di forme
Cerchiamo ora di demarcare meglio l’ambito dello stato estetico. Per N. l’essenza del creare non è sviluppata partendo dall’essenza di ciò che è creato, dall’opera, ma dallo stato del comportamento estetico. Da un lato, per N., il creare è un atto vitale, un produrre condizionato dall’ebbrezza, di cui è possibile fornire una descrizione fisiologica: dilatazione vascolare, temperatura, secrezione, ecc.; dall’altro, il creare è legato all’essenza dell’ebbrezza e della bellezza, ed implica l’andare-al-di-là-di-sè, il vedere le cose in modo “più pieno”, “più semplice”, più intenso”. Questo aspetto del creare viene definito da Nietzsche “idealizzare”, ossia “estrapolare i tratti capitali”. L’ “idealizzare” è il segno supremo della potenza, poichè in esso i contrasti sono domati: “Che non sia necessaria alcuna violenza, che tutto segua, obbedisca con tanta facilità, facendo buon viso all’obbedienza – ciò delizia la volontà di potenza dell’artista”. (La volontà di potenza, n. 821).
Lo stato estetico di chi recepisce l’opera d’arte è visto da N. in corrispondenza con lo stato di coloro che creano: recepire l’arte è un rivivere il creare.
Quanto esposto finora ci consente di cogliere nello stato estetico non soltanto meccanismi psicosomatici, ma piuttosto i processi dell'”idealizzare” e dell’ “estrapolare i tratti capitali”. Il sentimento estetico non è perciò una commozione cieca e passeggera, ma è riferito a una struttura, ossia, nella terminologia dell’estetica usata da N., ad una “forma”. N. spiega la “forma” come un “esporsi”, un “farsi pubblico”, e in ciò si avvicina al significato originario del termine. I Greci chiamavano “forma” (morfè) la figura, l’aspetto di un ente (eìdos), ciò in cui l’ente si espone e viene alla luce. La forma va visto in relazione all’ebbrezza. Quest’ultimo termine non rinvia al caos, ma all’opposto, indica la vittoria della forma che fonda l’ambito in cui l’ebbrezza diviene possibile come tale.
Il termine “forma” non va visto inoltre in opposizione al “contenuto”. “Forma” non è “margine”, limite esterno di un contenuto, ma sua componente essenziale; la forma è l’unico vero contenuto.
Ora però, quando N. tenta di caratterizzare le leggi della forma, nomina quelle leggi logiche e matematiche, che sono viste a loro volta in relazione alla vita fisiologica. “I sentimenti logici”, “il piacere dell’ordinato”, che costituiscono la base dei giudizi di valore estetico, non sono altro che i sentimenti di tutti gli esseri organici “in rapporto alla pericolosità della loro situazione, o alla difficoltà del loro nutrimento”.
Occorre tuttavia determinare meglio l’ambito in cui si collocano tutti questi elementi: l’ebbrezza quale stato estetico fondamentale, la bellezza, e gli stati del creare e del recepire; quindi la forma e il “sentimento dell’ordinato” quale condizione della vita fisiologica.
Cerchiamo di chiarire, semplificandole, le connotazioni fin qui date da N.. Limitiamoci ai due termini essenziali dell’ebbrezza e della bellezza, che stanno fra di loro in un rapporto reciproco. L’ebbrezza è la disposizione fondamentale; la bellezza ciò che predispone e determina. A prima vista si potrebbe definire la prima come l’elemento soggettivo, la seconda, quello oggettivo. L’ebbrezza tuttavia fa saltare la soggettività del soggetto: in essa infatti il soggetto è andato al di là di sè; la bellezza, d’altra parte, spezza il cerchio dell’oggetto separato e a sè stante – giacchè una bellezza in sè non esiste – e lo porta alla coappartenenza essenziale e originaria con il soggetto.
Lo stato estetico dunque non è nè oggettivo nè soggettivo; i due termini fondamentali, ebbrezza e bellezza, denominano con la stessa estensione l’intero stato estetico.
Il grande stile
N. parla di “grande stile“, quando si riferisce a quella realtà dell’arte pervenuta alla sua essenza. Il grande stile è lontano dall’arte “eroica” e “tronfia” di Wagner, ed implica la padronanza della misura e della legge, nonchè la calma propria delle anime forti. Lo stile severo, classico, è quello che maggiormente si avvicina ad esso. “Lo stile classico rappresenta essenzialmente questa calma, semplificazione, abbreviazione, concentrazione – il sentimento sommo della potenza è concentrato nel tipo classico”. (La volontà di potenza, n. 799).
Nel grande stile trovano la loro sintesi anche l’arte come contromovimento che si oppone al nichilismo, e l’arte come oggetto della fisiologia. Il grande stile esige, da un lato, la misura e la legge che vengono poste nel domare il caos e l’elemento dell’ebbrezza, e quindi presuppone la dimensione fisiologica; dall’altro, esso è rango e decisione, necessari per porre misure e valori nuovi per realizzare il contromovimento. L’arte come grande stile è la semplice calma che domina, conservandola, la somma pienezza della vita e riconduce ad unità gli opposti. Così questa estetica viene portata oltre se stessa: gli stati artistici sono colti in modo estremo, là dove massimamente si distaccano dallo spirito, nella dimensione fisiologica
Associando il grande stile al gusto classico, N. non intende riferirsi al classicismo, che egli associa alla mancanza di contrasti, alla povertà interiore. Il classico, più che a un’epoca dell’arte, è una struttura dell’esistenza, la cui condizione fondamentale è costituita dal dominio della legge sul caos, che si compie all’insegna di una originaria libertà.
Nelle riflessioni di N. che cercano di fissare la differenza tra classico e romantico, si può definire l’essenza dell’arte di grande stile e coglierne la dimensione formatrice e creativa. Riferendosi ai concetti di classico e romantico, N. non pensa all’arte intorno al 1800, ma all’arte di Wagner e alla tragedia greca. Nel “classico”, ciò che crea è la pienezza e la sovrabbondanza; nel “romantico”, è invece l’insufficienza, la mancanza. Il primo è “attivo”, il secondo “reattivo”. Tale distinzione di attivo e reattivo si interseca con un’altra, quella di essere e divenire, che tuttavia non manca di ambiguità. Così, ad es., l’esigenza di divenire – di divenire altro, e quindi di distruzione – può essere sia espressione di “forza stracolma e gravida di futuro”, come nell’arte dionisiaca, ma può appartenere anche all’insoddisfazione e all’odio. Analogamente, l’esigenza di essere può derivare sia dalla pienezza che dalla sofferenza, come nel “pessimismo romantico” di Wagner.
Il classico è desiderio di essere che proviene dalla pienezza, e in questo senso “stile classico” e “grande stile” paiono coincidere. Quest’ultimo, però, come essenza vera e propria dell’arte, rinvia ad una unità più originaria di attivo e reattivo e di essere e divenire. Da questo punto di vista, dall’essenza dell’arte come grande stile, si chiarisce la posizione metafisica di fondo di N.: il grande stile è il sentimento sommo della potenza, e la potenza è il dominio della calma che conserva e trasfigura gli opposti.
La fondazione delle cinque tesi sull’arte
Dall’essenza dell’arte può scaturire la fondazione delle cinque tesi fornulate in precedenza. La prima tesi dice che l’arte è la forma più nota e più trasparente della volontà di potenza. Questa tesi si può chiarire nel modo seguente. L’arte è la forma a noi più nota poichè è uno stato dell’uomo, dunque di noi stessi, e questo ha la sua fondazione nella concezione del modo secondo cui è data la dimensione in cui, dal punto di vista estetico, l’arte è reale; ossia, nell’ebbrezza della vita fisiologica del corpo. Dal momento che l’arte ha il proprio fondamento nello stato estetico, e questo è concepito in termini fisiologici, essa è la dimensione nella quale l’ente diventa per noi più perscrutabile.
La seconda tesi, che dice che l’arte deve essere concepita dalla prospettiva dell’artista, si dimostra considerando che solo nell’attività produttrice dell’artista diviene reale la creazione dell’arte. Da questa posizione è garantito l’accesso al creare in generale, e quindi alla volontà di potenza.
La terza tesi dice che l’arte è l’accadere fondamentale nell’ente nel suo insieme. Questa tesi, insieme alla quarta, che dice che l’arte è il contromovimento che si oppone al nichilismo, può essere fondata soltanto a partire dalla quinta tesi. E’ solo partendo da quest’ultima, che dice che l’arte vale più della verità – e quindi conferisce alla prima un primato unico – che si può stabilire che l’arte è l’accadere fondamentale. Per fondare questa tesi occorre rispondere alla domanda preliminare della filosofia, sull’essenza della verità.
La discrepanza, che suscita sgomento, tra arte e verità
Secondo N., in un appunto del 1888, il rapporto tra arte e verità è una discrepanza che suscita sgomento:
“Il rapporto dell’arte con la verità è stata la prima cosa che mi ha impensierito: e ancora adesso sto, con un sacro sgomento, dinanzi a questa discrepanza”.
Per vedere in quale misura l’arte entra in rapporto con la verità, bisogna dire in modo più chiaro di quanto si sia fatto finora che cosa intende Nietzsche con questo termine. Diventa necessario a questo punto procedere a un chiarimento preliminare sul concetto di verità. Va sottolineato che: 1) la necessità del chiarimento trova la sua ragione nella velatezza dell’essenza delle parole fondamentali come verità, bellezza, essere, conoscenza. La stessa esistenza umana è espressamente rinviata ai riferimenti nominati in tali concetti. Il termine “verità”, come tutte le parole fondamentali, ha diversi significati, fra loro connessi storicamente e necessariamente. Esso è dunque storico, sia nel senso che i significati sono diversi da epoca a epoca, sia che è fondatore di storia, a seconda dell’interpretazione che diviene dominante. 2) Vi sono due linee capitali entro le quali i significati di tali parole oscillano: la linea essenziale e la linea distolta dall’essenza. Il termine “verità” può riferirsi alla prima, quando denomina l’essenza del vero, e in tal caso la verità è una soltanto, o all’altra, quando si riferisce a un certo particolare vero, e allora ammette il plurale. Si ritiene abitualmente che nel primo caso si denomini l’universale, nel secondo i casi particolari che cadono sotto di esso. Senonchè questa è una semplificazione che, portando a identificare l’essenza come qualcosa di immutabile, ne misconosce il carattere storico. L’unità dell’essenza può essere pensata tuttavia anche attraverso il mutamento: infatti ciò che è mutato può diventare quell’Uno che vale per i molti; ciò che si mantiene è l’elemento immutabile che è durevolmente presente nel suo mutamento.
Ora, per quanto riguarda N., la parola “verità” si muove lungo la linea distolta dall’essenza. Ciò vuol dire che N. non pone la questione autentica dell’essenza del vero, e quindi della necessaria possibilità del mutamento della sua essenza e non sviluppa nemmeno l’ambito di questa questione. Tale omissione peraltro riguarda l’intera storia della filosofia occidentale.
Ma che cosa è il vero, ciò che soddisfa l’essenza della verità? Il vero è il vero ente, ciò che è in verità reale; questo vuol dire: ciò che è conosciuto, soltanto nella conocenza, infatti, il vero viene fissato come tale. E conoscere è sempre un’adeguazione alla cosa, “un commisurarsi con”.., per cui è insito nel vero il riferimento a un qualche parametro. Ma per chiarire meglio l’essenza del conoscere descriviamo, nei suoi tratti capitali, due specie fondamentali di conoscenza: la concezione del platonismo e quella positivista.
La verità nel platonismo e nel positivismo. Il tentativo nietzscheano di rovesciare il platonismo in base all’esperienza fondamentale del nichilismo
Nel platonismo il conoscere è un’adeguazione all’ idea, intesa come realtà soprasensibile; è un commisurarsi ad esso, rappresentandolo. Alla base di tale concezione c’è una determinata interpretazione dell’essere; tale forma di conoscenza ha un senso soltanto sul terreno della metafisica. Anche per il positivismo il conoscere è un commisurare, ma ciò che costituisce il parametro è il positum, ossia il sensibile. Per N. la questione della verità si mantiene nell’ambito del pensiero occidentale, per quanto si discosti nel particolare dai pensatori precedenti: conoscere è cogliere il reale in termini teorico-scientifici. La verità è l’oggetto a cui si riferisce il conoscere; mentre l’arte è un creare riferito alla bellezza. Ma per quanto riguarda la questione del rapporto tra arte e verità che suscita sgomento, occorre un ulteriore chiarimento sul rapporto tra la sua concezione e gli indirizzi del platonismo e del positivismo. Egli stesso definisce la sua concezione un platonismo rovesciato: mentre per Platone il sovrasensisbile è il vero ente e il sensibile deve essere commisurato ad esso, nella prospettiva del rovesciamento, il sensibile diventa l’ente vero e proprio. Con ciò sembrerebbe che la posizione di N. si identifichi con quella del positivismo. In realtà il rovesciamento nietzscheano va compreso alla luce dell’esperienza fondamentale del nichilismo e della svalutazione dei valori supremi che in esso si attua, che portano la forza dell’esistenza storica dei popoli a indebolirsi. Ma il nichilismo trova la sua origine proprio nel primato del soprasensibile, che si realizza nel platonismo e successivamente nel cristianesimo, una sorta di “platonismo per il popolo”. In tale ottica, rovesciare il platonismo non significa solo sostituire meccanicamente un punto di vista gnoseologico con un altro, quello del positivismo. Oltre a diroccare il primato del soprasensibile, il rovesciamento significa anche: cercare e stabilire ciò che è. Significa mantenere, in comune con il platonismo, la convinzione che sia la verità, assicurata per la via della conoscenza, a fornire l’ambito per la nuova fondazione dell’esistenza. E questa viene ancorata al sensibile, che viene dichiarato il vero ente, e viene salvato, in opposizione al platonismo e al nichilismo. Ora, anche l’arte, come contromovimento che si oppone al nichilismo, si muove nella stessa direzione. Ecco quindi che arte e verità, creare e conoscere si incontrano nella prospettiva che mira a salvare il sensibile e a superare il nichilismo.
Ambito e contesto della riflessione di Platone sul rapporto tra arte e verità
Nel platonismo, in cui il soprasensibile è la verità e l’arte in quanto affermazione del sensibile è rinnegata, il rapporto arte-verità è evidentemente un rapporto di antitesi, quindi di discrepanza; viceversa, in una situazione rovesciata, tale discrepanza dovrebbe essere eliminata. Eppure N. dice che il rapporto arte e verità è una discrepanza che genera sgomento. Dobbiamo capire il senso di queste parole se vogliamo cogliere la posizione metafisica di N.. Partiremo dalla posizione filosofica di Platone: la questione se nel platonismo sussista necessariamente un contrasto tra la verità e l’arte va risolta in base alla sua opera.
Platone pone la questione del rapporto tra arte e verità nella Repubblica, il grande dialogo sullo Stato nel quale la forma fondamentale della comunità umana viene fondata sul sapere. Si decide dell’essenza dell’arte e del suo ruolo entro lo Stato in base al rapporto con l’ente e all’essenza della verità. L’arte, a differenza della filosofia che è elevata al rango supremo, ha una posizione subordinata all’interno della comunità, in quanto è mìmesis, riproduzione, imitazione e reca in sè il pericolo della illusione e della menzogna. Nel decimo libro della Repubblica si approfondisce il concetto di mìmesis e si decide del rapporto tra arte e verità.
La “Repubblica ” di Platone: la distanza dell’arte (mimesi) dalla verità (idea)
Per comprendere l’essenza della mimesi, occorre sottolineare che per Platone l’imitare si muove nell’ambito del fabbricare, in senso ampio, in relazione all’unicità dell’idea. Ogni cosa che viene fabbricata da un produttore si mantiene nell’ambito dell’idea che fa da guida a quest’ultimo. Ma ci sono due modi sostanzialmente diversi di produrre: uno, proprio dell’artigiano, che consiste nel far apparire l’idea nella materia; e un altro, proprio dell’artista, che la fa apparire nell’immagine, nell’estraneità di un altro materiale. Ogni singolo ente si mostra dunque in tre modi e può essere prodotto da tre tipi di produttori: nel primo, l’ente consiste nell’unicità della sua essenza, nell’idea, e può essere prodotto solo dal dio; nel secondo appare nella materia ad opera dell’artigiano, e nel terzo si mostra nell’immagine per mezzo dell’artista. In questo senso quest’ultimo è “‘imitatore” (mimetès): poichè ci mostra l’idea, ma offuscata in un terzo elemento, lontana dall’essere e dalla sua pura visibilità. Per il concetto platonico di mimesi, dunque, non è decisivo il riprodurre, il copiare, ma il fatto di essere in grado di farlo meno di quanto lo faccia l’artigiano. In quanto l’arte è lontana dalla verità, essa non produce l’idea ma un’immagine in un ambito estraneo, il suo modo di produrre è offuscamento e simulazione. Sussiste pertanto nel platonismo una distanza tra arte e verità. Ma la distanza non è discrepanza.
Il “Fedro” di Platone: bellezza e verità in una discrepanza che rende felici
Se però, per N., il rapporto arte e verità è una discrepanza, e la filosofia di N. è un rovesciamento del platonismo, ne consegue che anche nel platonismo deve esserci una discrepanza, ma rovesciata. Dunque il platonismo può essere una indicazione per scoprire in N. – in forma rovesciata – la discrepanza e il suo sito.
Ora, poichè il termine “discrepanza” indica non solo divergenza, ma anche una sorta di coappartenenza, si può parlare di discrepanza solo fra termini che abbiano lo stesso rango. Non si può quindi parlare di discrepanza tra arte e verità, finchè l’arte – secondo l’esposizione della Repubblica – si trova in una posizione inferiore rispetto alla verità. Perchè possa esserci una discrepanza l’arte deve prima essere elevata all’identico rango della verità.
Si rende allora necessario considerare l’arte in Platone secondo un altro riguardo. Nel Fedro, dialogo di grande ricchezza in cui si tratta del bello, dell’anima e dell’amore, emerge una diversa interpretazione platonica della connessione tra arte e verità.
In questo dialogo il bello viene discusso nell’ambito della caratterizzazione del rapporto dell’uomo con l’ente in quanto tale. Secondo Platone, è propria dell’essenza dell’uomo la vista dell’essere. Essa domina in lui fin dall’inizio, ma, a causa del corpo, non può essere scorta nel suo inoffuscato splendore. La riconquista, il rinnovamento della vista dell’essere, avviene attraverso il bello: la cosa più appariscente nell’ambito sensibile, che ci “rapisce e trasporta” nella vista dell’essere. In questo contesto, verità e bellezza si coappartengono, sono riferite nella loro essenza alla stessa cosa, all’essere. Ma in tale coappartenenza si dividono: l’essere e la verità si riferiscono al sovrasensibile, la bellezza al sensibile.
Questa è dunque una discrepanza che tuttavia non genera sgomento, ma rende felici: il bello eleva oltre il sensibile e riporta al vero. Per lo stesso motivo, nel platonismo tale discrepanza viene elusa. Ma dove il platonismo viene rovesciato, ciò che si lasciava occultare deve venire allo scoperto, e ciò che poteva pretendersi felice deve suscitare sgomento.
Il rovesciamento del platonismo in Nietzsche
Anche per N., bellezza e verità, per entrare in discrepanza, devono prima coappartenersi nel riferimento all’essere. Ma per N. l’essere è volontà di potenza; quindi, dall’essenza della volontà di potenza deve risultare una originaria coappartenenza di bellezza e verità che diventa una discrepanza.
Ora, N. non si limita a capovolgere il platonismo, nel senso di mantenere la struttura di quest’ultimo invertendone gli spazi – il mondo sensibile al posto del soprasensibile-, ma effettua uno svincolamento (Herausdrehung), che comporta una profonda trasformazione filosofica.
Termini quali “mondo vero” e “mondo apparente”, propri del platonismo, vengono aboliti.
Si prenda il brano intitolato “Come il ‘mondo vero’ finì per diventare favola. Storia di un errore”, che si trova nel Crepuscolo degli idoli. In esso N. articola in sei capitoletti una storia del pensiero occidentale che arriva alle soglie della sua filosofia. Tale storia è scandita dal progressivo venire meno dell’idea centrale del platonismo, quella del mondo soprasensibile.
Nella prima fase, che corrisponde alla dottrina di Platone (N. distingue tra Platone e platonismo), fra mondo sensibile e mondo vero c’è una sostanziale continuità: il mondo vero è raggiungibile dal virtuoso, che è in grado di distogliersi dal mondo sensibile; l’ idea è esperita come visione, che conferisce a ogni ente il potere di essere se stesso. Ma già nella seconda fase – che si configura come un platonismo distinto dal pensiero di Platone – viene operata una rottura con il sensibile, e il mondo vero, non più presente nell’ambito dell’esistenza umana, diviene irraggiungibile per il tempo di quest’ultima.
Il terzo periodo designa quella forma di platonismo raggiunta dalla filosofia di Kant. Il soprasensibile, assolutamente irraggiungibile per la conoscenza, è ora un postulato della ragione pratica. Nel quarto, conseguente agli sviluppi del kantismo, vi è un superamento del platonismo, che avviene però senza esiti creativi. Nel quinto, il mondo vero viene abolito. Nondimeno rimane ancora il mondo sensibile e il posto vuoto del mondo superiore. In tale fase, N. designa già il tratto del proprio cammino filosofico che corrisponde alle opere aforistiche, da Umano, troppo umano alla Gaia scienza. Occorre un nuovo passaggio, che si compie nel sesto periodo, in cui anche il mondo apparente viene tolto. Questo è il compito che N. si propone nell’ultima fase della sua filosofia, quella dello Zarathustra.
Abolire il mondo apparente non significa abolire il sensibile, poichè il mondo apparente è il mondo sensibile nello schema del platonismo. La sua abolizione, al contrario, significa valorizzare il sensibile ed eliminare l’eccedenza del soprasensibile. Compiendo questo passo, N. dunque trasforma lo schema gerarchico del platonismo, non si limita a capovolgerlo.
In tutti e sei i capitoli, la storia del platonismo è messa in relazione con un tipo d’uomo che si rapporta al mondo vero. Di conseguenza, il rovesciamento del platonismo diventa una metamorfosi dell’uomo: alla fine del platonismo c’è il superuomo, l’uomo che va oltre (ueber) l’uomo che c’è stato finora.
La nuova interpretazione della sensibilità e la discrepanza, che suscita sgomento, tra arte e verità
Con il rovesciamento, la filosofia di N. guadagna stabilità. In essa emerge una nuova interpretazione del sensibile, per cogliere la quale dobbiamo rifarci all’esposizione nietzscheana dell’arte, in particolare alla sua “estetica fisiologica”. Come realtà fondamentale dell’arte N. ha individuato l’ebbrezza. Questo concetto fa riferimento allo sviluppo della forza e della pienezza e al potenziamento di tutte le facoltà; al tempo stesso contiene l’elemento fisiologico sensibile-corporale. Inoltre, il riferimento al concetto di forma, ne mette in risalto la stabilità e la legge. Ne deriva che il sensibile è orientato alla visione d’insieme; la sua essenza è costituita dall’ordine e dalla stabilità.
In questo contesto si inserisce la concezione “prospettica”. Per N. il vivente è aperto verso le altre forze in modo tale da incorporarle o da escluderle. Di conseguenza viene attuata dal vivente una interpretazione dell’ambiente e di tutto quanto accade. Da qui deriva che “il carattere prospettico [è] la condizione fondamentale di ogni vita”.
La natura organica è caratterizzata da una moltitudine di impulsi e di forze, ciascuno dei quali ha la sua prospettiva. Ma anche il mondo inorganico è “prospettico”, solo che in esso, i “rapporti di potenza” sono fissati in modo univoco. Secondo tale concezione, che ricorda molto quella leibniziana, ogni punto di forza è in sè prospettico.
Il sensibile, dunque, per N., non è più l’apparenza, è l’autentica realtà. Ma in tale concezione è inclusa costituzionalmente l’errore, la parvenza. Poichè il reale è prospettico, il vero è ciò che appare fissato nell’orizzonte di un essere vivente, in una pluralità di impulsi in lotta fra loro e in sè prospettici. Ossia, esso non è che una illusorietà costitutiva dell’essere vivente come tale. “Nel mondo organico comincia l’errore”, scrive N.. E ancora: “La verità è la specie di errore senza la quale una determinata specie di esseri viventi non potrebbe vivere”.
La verità è una specie di parvenza che si giustifica come condizione necessaria dell’affermazione della vita. Ora, anche l’arte e i sentimenti estetici hanno anch’essi il loro fondamento nell’essenza della vita. L’arte è connessa con l’apparire prospettico, anzi è il potenziamento di tale apparire. La sua “attività metafisica” consiste nell’essere la più autentica volontà di parvenza, in cui si fa visibile la somma legge dell’esistenza. La verità invece è una “stasi”, una parvenza fissata, e quindi una inibizione della vita, un sintomo di degenerazione.
Ora siamo in grado di comprendere in quale misura arte e verità, nel platonismo rovesciato di N., costituiscano una discrepanza. I due termini infatti, partendo da una unità – costituita dall’apparire prospettico – divergono, in quanto l’arte potenzia la vita più di quanto non faccia la verità. Entrambe, ugualmente necessarie, sono tuttavia divise.
E questo rapporto diviene tale da generare sgomento a causa del fatto che l’arte, in seguito alla morte di Dio, assume un’altra necessarietà, quella di diventare l’autentica legislatrice per l’essere dell’ente: dopo tale evento l’esistenza può essere sopportata soltanto nel creare.
II. L’eterno ritorno dell’uguale (1937)
La dottrina dell’eterno ritorno come pensiero fondamentale della metafisica di Nietzsche
La concezione dell’eterno ritorno dell’uguale di N. non è “eccentrica” rispetto alla sua filosofia, come sostiene qualche commentatore, bensì la dottrina fondamentale, che definisce la sua posizione metafisica di fondo. Essa contiene una asserzione sull’ente nel suo insieme, e nasce attraverso un duro confronto con dottrine che hanno influito sul pensiero occidentale, come quella platonica e cristiana. Domandare intorno a tale dottrina significa dunque domandare sulla posizione metafisica di Nietzsche all’interno del pensiero occidentale e sulla storia stessa della metafisica. In conseguenza di ciò il corso si articolerà nel modo seguente:
a) una esposizione provvisoria della sua genesi, della sua forma e del suo ambito;
b) l’essenza di una posizione metafisica di fondo;
c) L’interpretazione della dottrina dell’eterno ritorno quale ultima posizione metafisica fondamentale nel pensiero occidentale;
d) la fine della filosofia occidentale e il suo altro inizio.
La discussione del punto c) costituisce la conclusione del corso universitario “la volontà di potenza come conoscenza, e quella del punto d) è tentata sotto il titolo “La determinazione del nichilismo secondo la storia dell’essere”.
La genesi della dottrina dell’eterno ritorno
Ascoltiamo anzitutto il resoconto di Nietzsche sulla genesi del pensiero dell’eterno ritorno che si trova in Ecce homo. In quest’opera, N. afferma che tale pensiero gli giunse all’improvviso nell’agosto dell 1881, mentre passeggiava attraverso i boschi dell’ Engadina superiore. Tale “pensiero” equivale ad uno scuotimento dell’intero essere: è un progetto sull’ente nel suo insieme, in base al quale le cose cambiano volto e peso.
Dal momento in cui tale pensiero si insedia saldamente nel destino. di N., questi si dedica interamente a svilupparlo, progettando di non lasciar trapelare nulla di esso per i dieci anni a venire. In realtà, nelle opere pubblicate negli anni successivi, in particolare nella Gaia scienza, nello Zarathustra e in Al di là del bene e del male egli effettua tre comunicazioni, anche se in forma mascherata.
Tuttavia, da questi velati riferimenti non è possibile comprendere tale pensiero fondamentale. Solo prendendo visione del lascito manoscritto se ne può avere un quadro più chiaro. E’ di grande importanza anche discernere tra ciò che N. stesso ha comunicato al riguardo e ciò che tenne per sè.
La prima comunicazione di Nietzsche della dottrina dell’eterno ritorno
N. ne parla per la prima volta nella conclusione della Gaia scienza, nel brano 341, intitolato Il peso più grande. Non è un caso che questo pensiero demoniaco, spaventoso, tutt’altro che “gaio”, venga comunicato in quest’opera che si riferisce, nel titolo, alla scienza, ossia all’autentico sapere: l’eterno ritorno dell’uguale appartiene essenzialmente a quel sapere fondamentale. Anche il titolo del brano è importante per la sua comprensione. Il peso stabilizza, raccoglie le forze, dà loro determinatezza, ma nello stesso tempo trasforma la direzione del loro movimento. Tale pensiero deve dunque essere un peso, nel senso del raccogliere, dell’attrarre e del mutare direzione; deve essere cioè determinante per l’ente nel suo insieme. Per questo N. lo definisce “il pensiero dei pensieri” e al tempo stesso il “pensiero più grave”: esso non pensa nulla di arbitrario, ma l’ente in quanto tale. E per questo non è presentato da N. stesso, non proviene da uno qualsiasi degli uomini d’oggi, ma da un demone; nè giunge in un momento qualsiasi, ma “nella più solitaria delle solitudini”: solo nella solitudine è possibile quell’appropriazione autentica (Vereingentlichung) dell’uomo, in cui viene deciso il peso delle cose e dell’uomo stesso.
“Incipit Tragoedia”
Pensando l’eterno ritorno, il tragico diventa il carattere fondamentale dell’ente. “Incipit Tragoedia” è il titolo del brano successivo, che rinvia appunto al concetto di tragico. Ma come intende N. l’essenza del tragico e quale collegamento vi è fra questo e il pensiero dell’eterno ritorno?
Fin dal suo scritto sulla Nascita della tragedia, N., rifiutando l’interpretazione catartica della tragedia di Aristotele, considera lo spirito tragico come quello che accoglie in sè le supreme contraddizioni. Il tragico è per N. coappartenenza degli opposti: vi è tragedia dove il terribile viene affermato come l’intima antitesi del bello. E il pensiero dell’eterno ritorno esprime appunto l’essenza del tragico, in quanto è suprema affermazione che include anche il no estremo; con esso l’annientamento e il dolore entrano a far parte dell’ente.
Tale brano, che conclude la Gaia scienza, costituisce poi, immutato, l’inizio della prima parte di Così parlò Zarathustra, l’opera che descrive in forma poetica la tragedia dell’eroe Zarathustra, il primo autentico pensatore del “pensiero dei pensieri”.
La seconda comunicazione della dottrina dell’eterno ritorno
Lo Zarathustra nel suo insieme costituisce la seconda comunicazione della dottrina dell’ eterno ritorno. Zarathustra, come si è detto, è il pensatore eroico che inizia la tragedia, ossia infonde nell’ente lo spirito tragico. L’essenza di Zarathustra è il pensiero dell’eterno ritorno, che viene esposto per immagini poetiche e per parabole nella terza parte dell’opera. Sarebbe tuttavia un fraindendimento dello Zarathustra concepire questa comunicazione come una “teoria” esposta in forma poetica; l’intimo compito di quest’opera è la creazione della figura di Zarathustra, in cui è esposta indirettamente la dottrina. Per N. in questo momento è più essenziale il “come” della comunicazione che non il “che cosa”; il suo “contenuto” non può essere capito dall’uomo di oggi. Per comprendere “il pensiero più grave” occorre che l’uomo sia trasformato in superuomo, cioè nell’uomo che è andato oltre se stesso. Visto con gli occhi del superuomo, il tipo di uomo che c’è stato finora è l’ “ultimo uomo”, ossia l’uomo mediocre, che rimpicciolisce e banalizza tutto ciò che è intorno a lui.
“La visione e l’enigma”
Si parla più chiaramente dell’eterno ritorno in due brani della terza parte, il primo dei quali è intitolato “La visione e l’enigma”.
Si tratta non di un enigma qualsiasi, ma dell’enigma puro e semplice, nel quale si cela la comprensione dell’ ente nel suo insieme. Il cogliere tale enigma comporta un “salto” senza un qualsiasi filo conduttore, si tratta di arrischiare la verità dell’ente nel suo insieme. Non c’è peraltro da indovinare una soluzione con la quale ogni problematicità si risolverebbe: l’enigma non può essere tolto di mezzo come enigma.
Il brano si configura come un racconto esposto da Zarathustra ai marinai della nave che lo trasporta nel “mare aperto”: egli parla loro della sua salita su di un sentiero di montagna – nel racconto di Zarathustra si associano due immagini essenziali, il mare e la montagna, ossia l’altezza e la profondità estreme che alludono al pensiero dei pensieri – in compagnia di uno strano personaggio, il nano, che rappresenta lo “spirito di gravità”, l’ “arcinemico” di Zarathustra. Giunti davanti ad una porta carraia, sulla quale sta scritta la parola “attimo”, e da cui si dipartono, in direzioni opposte, due sentieri infiniti – la porta carraia e i due sentieri simboleggiano il tempo e l’eternità -, Zarathustra domanda al nano: “Credi tu, nano, che queste vie si contraddicano in eterno?” Questi risponde: “Tutte le cose diritte mentono [..]. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo”.
Benchè il nano abbia fatto riferimento al circolo dell’eterno ritorno, non ha indovinato l’enigma, perchè ha preso le cose “troppo alla leggera”. Nondimeno Zarathustra rivolge al nano una seconda domanda: “Guarda, continuai, questo attimo!”. Zarathustra domanda ora partendo dall’attimo; e in riferimento ad esso si deve pensare di nuovo l’intera visione che esige una propria posizione nell’ “attimo” stesso, cioè nel tempo. In tal modo la domanda è posta ad un livello infinitamente superiore, tale da non poter essere soddisfatta dal nano, che scompare dalla scena, sostituito da una seconda visione, nella quale appare un pastore “cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca”.
Gli animali di Zarathustra
Interrompiamo l’interpretazione del capitolo a questo punto, per riprenderla in un contesto successivo in cui, dopo l’esposizione sull’essenza del nichilismo, saremo più preparati a comprenderlo. Rileviamo ancora solo poche cose del capitolo “Il convalescente”, del terzo libro dello Zarathustra, cominciando dagli animali di Zarathustra e da ciò che simboleggiano.
Essi sono l’aquila e il serpente, non si tratta di animali qualsiasi, poichè la loro essenza è un’immagine dell’essenza dello stesso Zarathustra. E come questi è il maestro dell’eterno ritorno, così essi rinviano a tale pensiero. Quando Zarathustra li scorge per la prima volta – nel Prologo dell’opera -, l’aquila volteggia nel cielo in larghi circoli, mentre il serpente le sta inanellato al collo: è un evidente riferimento al circolo dell’eterno ritorno. Inoltre, l’aquila simboleggia l’orgoglio dell’altitudine, il serpente la prudenza e la padronanza della maschera: sono atteggiamenti legati al tipo di sapere proprio del loro padrone. Infine, sono gli animali della solitudine di Zarathustra, che parlano al loro maestro nel linguaggio immediato ed essenziale dei simboli.
“Il convalescente”
Il quart’ultimo capitolo della terza parte dello Zarathustra tratta più direttamente dell’eterno ritorno. Zarathustra è “convalescente”; egli è tornato in sè, dopo la malattia che lo ha colpito per sette giorni e sette notti. Ciò significa: egli ha finalmente pensato nella sua interezza il pensiero più grave, la sua ultima profondità, lo ha intimamente incorporato nel suo intero contenuto ed è giunto così a se stesso. E’ diventato “il portavoce del circolo”. In questo contesto i suoi animali gli si avvicinano e gli parlano di questo pensiero con parole suadenti. Rammentano a Zarathustra che il mondo lo attende come un giardino: tutte le cose sono ordinate in modo nuovo e brillano alla luce della nuova conoscenza. Ma Zarathustra li smentisce ironicamente, li chiama “maliziosi burloni e organetti cantastorie”: egli non si lascia lusingare dalle loro parole; essi, come il nano, hanno preso il pensiero dell’eterno ritorno “troppo alla leggera”.
Va sottolineato che anche in questo brano, come nel precedente, Zarahustra non contrappone una intepretazione della dottrina diversa da quella che gli viene presentata. Solo indirettamente ci dice come essa deve essere intesa. Sia il nano che gli animali, quando parlano del circolo, si collocano al di fuori di esso. Così il nano, di fronte alla porta carraia, dice che le due vie convergeranno all’infinito. Ma Zarathustra dice invece che esse “sbattono la testa l’una contro l’altra”. Infatti, se ci collochiamo nell’attimo, non come semplici spettatori, ma come agenti attivamente, le due vie del passato e del futuro non convergono, ma scorrono in direzioni contrarie.
L’ essenziale della dottrina è che il futuro è frutto di una decisione: l’anello si chiude nell’attimo che è il centro del contrasto. L’eternità non è quindi qualcosa di esteriore e di eternamente uguale, ma è nell’attimo, che è lo scontro di futuro e passato e che determina il modo in cui tutto ritorna. L’attimo è la cosa più breve ma al tempo stesso più compiuta, in cui si può afferrare la totalità del ritorno: nell’immagine, questo è l’anello vivente del serpente.
La terza comunicazione della dottrina dell’eterno ritorno
La terza comunicazione si trova in Al di là del bene e del male, nell’aforisma n. 56 del terzo capitolo, intitolato “L’essere religioso”. Tale brano nella sua parte finale fa un qualche riferimento alla divinità. Nel descrivere l’ideale dell’uomo vitale, che dice sì alla vita e alla sua infinita ripetizione, l’aforisma termina con la frase: “circolus vitiosus deus?”, laddove il circolus è l’anello del ritorno, il vitiosus fa riferimento a vitium, il difetto, il patire, ciò che corrompe. Circolus vitiosus è dunque l’anello che fa ritornare anche questo vitium, ossia il male e il dolore. E il deus? Nell’ateismo peculiare di Nietzsche il dio non può essere che una domanda. Nell’esperienza tragica dell’ente, determinato dall’anello tremendo dell’eterno ritorno, sorge la domanda del dio, intorno al quale, come scrisse Nietzsche dicianovenne, “tutto diventa mondo”. Ma se il dio cui si fa riferimento è “solo” una domanda, anche lo stesso pensiero dell’eterno ritorno è “solo” una domanda.
L’ esposizione dell’ eterno ritorno non rinvia ad una dottrina filosofica o ad una teoria scientifica; tutte e tre le comunicazioni sono domande espresse in forme e gradi diversi. Dobbiamo dunque domandarci che cosa sia nella sua forma questo pensiero che non può essere costretto nelle nostre rubriche abituali, ma, al contrario, deve portare noi a svincolarci da ciò che è abituale.
Prendiamo ora in visione ciò che N. ha pensato sull’eterno ritorno, senza però renderlo pubblico.
Il pensiero dell’eterno ritorno nelle annotazioni non pubblicate
La pubblicazione dei frammenti postumi ci attesta della presenza del pensiero capitale di N. dal 1881 al 1889, sia pure in forme diverse a seconda dell’ambito e della direzione in cui si muove il suo pensiero filosofico. Tentiamo ora di descrivere, secondo l’ordine cronologico, le annotazioni che trattano di questo pensiero.
Le quattro annotazioni dell’agosto 1881
Consideriamo ora quattro annotazioni dell’agosto 1881, che sono al tempo stesso schizzi per un’opera. Il primo schizzo dice:
“Il ritorno dell’uguale
“Abbozzo
“1. L’assimilazione degli errori fondamentali.
“2. L’assimilazione delle passioni.
“3. L’assimilazione del sapere, anche di quel sapere che rinuncia. (Passione della conoscenza).
“4. L’uomo innocente. L’individuo come esperimento. La facilitazione della vita, l’umiliazione, l’indebolimento – transizione.
“5. Il nuovo peso: l’eterno ritorno dell’uguale. Importanza infinita del nostro sapere, dei nostri errori, delle nostre abitudini e modi di vivere per tutto ciò che verrà. Che faccimo noi con il resto della nostra vita, – noi, che ne abbiamo vissuto la maggior parte senza sapere la cosa più essenziale? Noi insegniamo questa dottrina, – è il mezzo più efficace per assimilarcela. Il nostro tipo di beatitudine in quanto maestri della più grande dottrina.”
Solo al punto 5 si parla dell’eterno ritorno, e anche qui non si dice nulla sul contenuto. La parola ricorrente è piuttosto “l’assimilazione”. Il nuovo pensiero deve essere assimilato, perchè diventi l’atteggiamento di fondo di ogni pensare. Si tratta dunque dell’effetto della dottrina sull’uomo, indicata come un nuovo tipo di beatitudine.
Nel secondo abbozzo si dice:
“1) La conoscenza più potente.
“2) Le opinioni e gli errori trasformano l’uomo e gli danno istinti, ovvero: gli errori assimilati.
“3) La necessità e l’innocenza.
“4) Il gioco della vita“
In questo abbozzo è tenuto d’occhio più il carattere “metafisico” della dottrina che non l’effetto sull’uomo. Vi si parla di “gioco” e di “innocenza”. Il riferimento è ad Eraclito, al frammento che dice: “L’eone è un fanciullo che gioca, che gioca con le tessere di una scacchiera; di un fanciullo è il regno”; laddove il termine “eone” (aiòn) è tradotto generalmente come “tempo del cosmo”, ma si riferisce anche al tempo della nostra vita. Ciò significa che l’ente nel suo insieme è dominato dall’innocenza. L’abbozzo successivo dice:
“Meriggio ed eternità
“Indicazioni per una nuova vita
“Zarathustra, nato sul lago Urmi, lasciò a trent’anni la sua patria, si recò nella provincia di Aria e in dieci anni di solitudine sui monti compose lo Zend-Avesta.
“Il sole della conoscenza risplende di nuovo a mezzodì: e il serpente dell’eternità s’inanella alla sua luce — : è il vostro tempo, fratelli del meriggio!”
In questo abbozzo i concetti-chiave sono “meriggio” ed “eternità”; entrambe indicano il tempo, l'”attimo” in cui viene pensato l’eterno ritorno. Del meriggio, del momento in cui cioè il sole è più alto e le cose sono senza ombra si parla nello Zarathustra, nella conclusione della prima parte. Nel centro luminoso del meriggio si scontrano il passato e il futuro e così si imbattono nella decisione.
Il quarto abbozzo è intitolato: “Per il progetto di un nuovo modo di vivere” ed è suddiviso in quattro libri i cui titoli principali sono: Primo libro: Della disantropomorfizzazione della natura. Secondo libro: Dell’assimilazione delle esperienze. Terzo libro: Della felicità ultima del solitario. Quarto libro: Annulus aeternitatis.
Il primo e il quarto libro abbracciano il secondo e il terzo, che trattano dell’uomo. La disantropomorfizzazione della natura, di cui si parla, significa l’eliminazione dei concetti umani in essa proiettati, come colpa, intenzione, fine, provvidenza. La “nuova vita”, è un nuovo modo di stare in mezzo all’ente, una nuova specie di verità e quindi una trasformazione dell’ente. Questo ente nel suo insieme viene determinato nel quarto libro come “l’anello dell’eternità”.
Ciò che colpisce di questi abbozzi è la ricchezza delle prospettive. Si può supporre che nel suo primo spiegamento, il pensiero dell’eterno ritorno, come tutti i grandi pensieri, contenga tutto l’essenziale, che rimane però inesplicato. E importanti non sono tanto le annotazioni esplicite con cui questo elemento primo viene successivamente sviluppato da N., ma piuttosto la nuova chiarezza che da esso irradia sul suo pensiero e le nuove dimensioni a cui viene elevata la sua filosofia.
Esposizione sinottica del pensiero dell’eterno ritorno: l’ente nel suo insieme come vita, come forza; il mondo come caos
La posizione raggiunta con i quattro abbozzi sarà un punto di riferimento nel patrimonio di annotazioni che ora menzioneremo. Il primo gruppo di esse appartiene al periodo immediatamente successivo all’agosto del 1881 fino alla pubblicazione della Gaia scienza, avvenuta un anno più tardi. Nell’interpretazione di questi frammenti scegliamo la via di una esposizione sinottica, articolandone il contenuto essenziale in dieci punti, per metterne in evidenza la connessione interna.
1) Che cosa è in vista? Il mondo nel suo carattere complessivo. Il mondo, per N., consta di non vivente e vivente, rappresentati nello stesso sviluppo del divenire. Egli afferma sia che il non vivente è la “cenere” di innumerevoli esseri viventi, postulando che il vivente determini la provenienza del non vivente, sia che la vita è soltanto una specie del non vivente, ammettendo che è il non vivente a determinare la specie del vivente.
2) Qual è il carattere generale del mondo? La “forza“. Quest’ultimo è un concetto che non si può determinare in modo univoco. N. non intende tale termine nel senso della fisica, per la quale è pensato in un contesto tecnico e calcolativo; nè esso può essere spiegato con il linguaggio delle scienze matematiche. Ciò che N. chiama forza, negli anni immediatamente successivi si chiarisce nei termini di “volontà di potenza”.
3) La forza è limitata o illimitata? E’ limitata. Ciò risulta dall’essenza stessa della forza. L’infinità, per N., è infatti incompatibile con il concetto di forza, che è in sè qualcosa di stabile e di determinato.
4) Che cosa risulta come conseguenza intrinseca dell’essenziale finitezza della forza? Che la totalità del mondo rimane finita. Tale finitezza non è determinata dall’esterno, ma proviene dal mondo stesso. La forza del mondo non subisce alcuna diminuzione nè alcun incremento.
5) Dalla finitezza dell’ente non deriva una “stasi”, ma un costante “divenire”: non c’è un equilibrio della forza. Il “divenire” va qui inteso in un senso assai ampio, non significa sviluppo o progresso.
6) Poichè il mondo è un costante divenire – benchè come somma di forza sia in sè finito – ci sono effetti infiniti. Quando N. parla di mondo “infinito”, non intende negare la sua essenziale finitezza. Infinito significa qui “smisurato”, cioè praticamente non numerabile.
7) Dov’è che questa forza universale è in quanto mondo finito? In quale spazio? Per N. lo spazio è soltanto una “forma soggettiva”, così come la rappresentazione della “materia”. Lo spazio in quanto tale è la stessa formazione della forza e dei rapporti tra forze.
8) Che ne è del tempo, che di solito viene nominato insieme allo spazio? Il tempo, a differenza del carattere fittizio dello spazio, è reale e illimitato, infinito. N. coglie questo tempo reale infinito come “eternità”.
9) Tutte queste connotazioni del mondo riguardo la forza, la finitezza, il divenire, lo spazio e il tempo, vengono pensate congiuntamente e riportate alla determinazione principale – con la quale N. definisce il “carattere complessivo del mondo” -, che consiste nella tesi enunciata nel brano 109 della Gaia scienza, secondo cui : “Il carattere complessivo del mondo è […] caos per tutta l’eternità”. Questa tesi ha per N. una funzione direttrice, in quanto fissa la rappresentazione dell’ente in quanto tale come divenire necessario, in modo tale da escludere dall’ente concetti antropomorfici quali ordine, bellezza, forma, legge, organismo. La nozione di “caos” ha quindi, per N., una connotazione negativa, con la quale egli pratica una sorta di “teologia negativa”, volta a disantropomorfizzare l’ente. Egli tuttavia determina il caos con una carattere generale, che è la necessità.
10) Con la tesi: il caos universale è in sè necessità, viene caratterizzato l’universo, al cui essere è attribuito, come elemento fondamentale, l’eterno ritorno dell’uguale.
La perplessità della “antropomorfizzazione” dell’ente
Si potrebbe pensare che nel pensiero dell’eterno ritorno sia insista una antropomorfizzazione, in quanto esso è riferito sia all’ente nel suo insieme, sia all’uomo che lo pensa. Vi è infatti un coinvolgimento essenziale dell’uomo, legato al fatto che l’eternità e il tempo del ritorno sono concepiti in base all’ “attimo”, e dunque alla decisione. Occorre chiarire questo aspetto, che rischia di infirmare questo pensiero nella sua evidenza e verità.
Ogni concezione dell’ente è inevitabilmente una antropomorfizzazione, in quanto prospettata dall’uomo e riferita ad esso. In questo senso, anche qualsiasi tentativo di disantropomorfizzazione è una antropomorfizzazione, poichè è attuato dall’uomo. Queste riflessioni appaiono insuperabili, e generano atteggiamenti di scetticismo o di rassegnazione. Ma ci si dimentica di porre la domanda preliminare su chi sia l’uomo. Certo, anche questa cade sotto la medesima questione, ed è effettivamente possibile che la definizione essenziale dell’uomo rimanga sempre affare dell’uomo; ma può anche darsi che tale definizione elevi l’uomo oltre se stesso, e quindi lo disantropomorfizzi.
Ora, la domanda sull’essenza dell’uomo non può essere definita nè dalla scienza, nè da una fede, ma deve innestarsi sull’ essenza del linguaggio, dato che esso è l’originario risonare della verità di un mondo. La domanda sull’uomo, già nella sua impostazione, deve coinvolgere fin dall’inizio l’uomo e l’ente nel suo insieme in una sorta di circolo in cui, da una parte, l’ente viene interpretato dall’uomo, ma, dall’altra, l’uomo è interpretato partendo dall’ente. Anche nel pensiero dell’eterno ritorno vige una medesima circolarità, poichè, attraverso l’essenza dell’eternità come meriggio e attimo vi è un riferimento all’uomo; anche qui si richiede di pensare l’uomo partendo dal mondo e il mondo partendo dall’uomo. Ciò significa che in tale pensiero è contenuta sia l’estrema antropomorfizzazione, sia il contrario di essa.
La dimostrazione nietzscheana della dottrina dell’eterno ritorno
Bisogna ora seguire le dimostrazioni nietzscheane della dottrina dell’ eterno ritorno dell’uguale. Nell’esaminare la forza probatoria di queste dimostrazioni, occorre tuttavia tener presente che tale dottrina va misurata in base alla sua legge propria, superando l’opinione erronea che quelle di N. siano dimostrazioni “naturalistiche”. Se si deve dimostrare che l’eterno ritorno è la determinazione fondamentale della totalità del mondo, che esso è il modo in cui l’ente nel suo insieme è, lo si può fare soltando mostrando che tale determinazione risulta necessariamente dalla costituzione della totalità del mondo.
Ora, dal carattere della forza risulta la finitezza del mondo e del suo divenire; dalla finitezza del divenire è escluso uno scorrere all’infinito, ma ne risulta uno scorrere in sè ricorrente. Dato inoltre il tempo come infinito, ed essendo escluso uno stato di equilibrio, ne deriva che le possibilità dell’ente devono ripetersi all’infinito. E poichè la concatenazione degli effetti tra i singoli processi del divenire è una concatenazione conchiusa – sebbene praticamente smisurata – ognuno di essi ritornerà uguale. Dunque il carattere della totalità del mondo, in quanto eterno caos della necessità, è l’eterno ritorno dell’uguale.
Il presunto procedimento “naturalistico” nella dimostrazione. Filosofia e scienza
La dimostrazione di N. della dottrina dell’eterno ritorno non è “scientifica” – e quindi non sottostà in nessun punto al tribunale della scienza della natura – in quanto fa uso di concetti che non appartengono alla scienza della natura. Quest’ultima fa uso di termini quali forza, spazio, tempo, movimento, ma non può dire che cosa siano. Una scienza, in quanto tale, non può domandare intorno ai propri concetti fondamentali, che le rimangono inaccessibili. Questo è il compito della filosofia, che non è, peraltro, giustapposta alle scienze, ma è racchiusa nell’ambito più intimo della scienza stessa. Quest’ultima può essere vero sapere e andare oltre una mera tecnica soltanto se domanda intorno alla verità dell’ente, si muove nelle posizioni di fondo dell’ente e le fa diventare operative. Ciò non significa adottare il linguaggio e i concetti della filosofia, ma può avvenire sia attraverso il pensiero proprio di una filosofia che chiami in causa il domandare scientifico, sia attraverso l’intima forza del domandare della scienza stessa. Solo così è possibile un profondo accordo tra pensiero filosofico e ricerca scientifica, in una fertile coappartenenza interiore, senza che esteriormente e istituzionalmente debbano occuparsi l’uno dell’altra.
Il carattere della “dimostrazione” della dottrina dell’eterno ritorno
In apparenza la dimostrazione dell’eterno ritorno è una inferenza, che deduce una conclusione da una premessa maggiore; da proposizioni sull’ essenza dell’ente nel suo insieme trae delle conclusioni sul modo di essere di questo ente. In realtà solo con la determinazione della totalità del mondo come eterno ritorno, si rende visibile l’essenza del mondo come eterno caos; in altri termini: l’essenza diviene visibile solo con la conclusione. Quindi non inferenza, ma svelamento di posizioni che sono poste con il progetto dell’ente nel suo insieme.
Ma allora, se questo carattere fondamentale non può essere dimostrato deduttivamente, ma soltanto attribuito, si ripropone la questione dell’antropomorfizzazione. Tanto più che N., nello stesso periodo in cui tenta di pensare l’essenza del mondo come eterno ritorno dell’uguale, si convince che si pensa sempre e soltanto da un “angolo di mondo”, l’uomo è concepito come “colui che sta in un angolo” (Ecken-steher). “Noi non possiamo vedere dietro il nostro angolo”, scrive all’aforisma 374 della Gaia scienza.
Ma l’intenzione di escludere ogni antropomorfizzazione nel pensare l’essenza del mondo, non si concilia con tale concezione dell’uomo. N. cerca di conciliare ambedue le possibilità: esige la suprema antropomorfizzazione dell’ente e l’estrema naturalizzazione dell’uomo. E allora diviene decisivo sapere da quale angolo l’uomo veda, poichè l’antropomorfizzazione diviene tanto più inessenziale quanto più originariamente l’uomo assume la collocazione di un angolo essenziale. I due termini, la totalità del mondo e il pensiero del pensatore, non si possono separare. Questa riflessione chiarisce che, nel pensare il pensiero più grave, ciò che è pensato non si può separare dal come lo si pensa. Anche da questo possiamo desumere quanto sia fuorviante immaginare le dimostrazioni dell’eterno ritorno al modo delle dimostrazioni fisiche e matematiche.
Il pensiero dell’eterno ritorno come fede
La seconda parte di questo gruppo di annotazioni è stata intitolata dai primi curatori dei frammenti postumi “Effetto della dottrina sull’umanità”; mentre la prima parte recava il titolo “Esposizione e fondazione della dottrina”. Ciò presuppone una concezione arbitraria che fa dell’eterno ritorno una “teoria” con conseguenti effetti pratici. Come si è visto, proprio l’inestricabilità del come del pensiero dal che cosa del pensato vanifica una distinzione di questo tipo.
La caratterizzazione più importante di questo secondo gruppo di annotazioni è quello che connota il pensiero dell’eterno ritorno come “fede”. Qui il pensiero viene messo in relazione con il contenuto di determinate religioni, quelle che svalutano la vita dell’ aldiqua. N. lo definisce come “la religione delle anime più libere, serene e sublimi”. Ciò non significa che tale pensiero sia una sorta di religione personale di N. che possa essere espunta senza conseguenze dalla sua filosofia. Fede non è per N. l’assenso a una dottrina rivelata. D’altra parte, il pensiero dell’eterno ritorno determina da sè, in modo nuovo, l’essenza della religione. L’essenza della fede, secondo le stesse parole di N., consiste nel “tenere-per-vero“. Il tenere-per-vero è il tenersi nel vero e quindi un tenersi nel duplice senso di avere un sostegno (Halt) e di mantenere un contegno (Haltung). Questo tenersi riceve la sua determinazione da ciò che è posto come vero. Il vero per N. è ciò che, nel continuo fluire di quel che diviene, è fissato in determinate rappresentazioni-guida; fede quindi, per N., è fissare ciò che muta continuamente e consolidare se stesso in questo riferimento al fissare.
Ora, N. afferma ripetutamente che il pensare il pensiero più grave diventa il supremo conoscere, e, insieme, un creare e un donare, quindi la forma fondamentale del sacro e del “religioso”. Tuttavia N. designa come religioso questo pensiero perchè, in quanto pensiero dell’ente nel suo insieme, fissa l’ente stesso nel suo progetto dell’essere, fissa il modo in cui l’essere è in quanto caos della necessità del costante divenire.
D’altra parte, questo pensiero, riguardando l’ente nel suo insieme, non può essere dimostrato con dei fatti mediante relazione causale, ma è sempre soltanto una possibilità. Ciò non significa che esso sia svalutato, il tenersi in questo pensiero è anch’esso essenziale per il suo essere vero; il sostegno si determina in base al contegno e non viceversa. Noi, in conformità con l’intera storia occidentale siamo abituati a pensare soltanto in base al reale, dimentichiamo che il pensare la possibilità è sempre un pensare creativo. Ma la possibilità di cui qui si domanda è più potente di qualsiasi cosa reale ed effettiva. N. afferma infatti che tale pensiero contiene “la possibilità di determinare e di ordinare nuovamente i singoli uomini nei loro affetti”. Esso porta un’altra storia: non solo perchè lascia dietro di sè delle conseguenze e dei fatti, ma perchè nella prospettiva di quel pensiero si fa diverso il modo di accadere e di agire.
Sennonchè, a questo punto emerge una nuova domanda: se tutto è necessario, se tutto ritorna come era già, allora tutto è indifferente e ogni pensare e programmare non diventano superflui? Questo pensiero, insomma, porterebbe ad una sorta di fatalismo.
Il pensiero dell’eterno ritorno e la libertà
Nell’anello della necessità, infatti, la libertà sembra essere tanto superflua quanto impossibile; questo pensiero riconduce alla antica questione del rapporto tra libertà e necessità. Nondimeno, in questa prospettiva viene perso di vista l’essenziale: l’eterno ritorno va pensato a partire dall’attimo, in base al quale viene deciso ciò che ritornerà. Dunque, questo pensiero non deve essere costretto dentro la tradizionale antinomia, ma deve essere pensato in base a se stesso.
Percepirsi in una sequenza di avvenimenti che si ripetono continuamente in una monotonia circolare, invece, significa percepirsi dall’esterno, dimenticando che soltanto l’uomo, nella temporalità, determina il modo in cui sta nell’anello dell’ente.
Concludiamo con una osservazione di N., nella quale si fa luce il riferimento dell’eterno ritorno al tempo. Si tratta del già menzionato brano intitolato “Meriggio ed eternità”, che afferma:
“E, in generale, in ogni anello dell’esistenza umana vi è sempre un’ora nella quale, prima a uno, poi a molti, poi a tutti si presenta il pensiero più possente, quello dell’eterno ritorno di tutte le cose: – ogni volta è questa, per l’umanità, l’ora del meriggio”.
Sappiamo che per N. il meriggio rinvia all’attimo, al momento in cui le ore ante-meridiane e post-meridiane, passato e futuro, si incontrano. Questo punto di incontro è l’attimo dell’eternità, in cui l’esistenza umana viene trasfigurata nella sua altezza somma e nella sua volontà più forte.
Retrospettiva sulle annotazioni dell’epoca della “Gaia scienza” (1881/82)
Se confrontiamo il copioso materiale che si trova nelle annotazioni del periodo corrispondente alla pubblicazione della Gaia scienza, nella quale si trova la prima comunicazione della dottrina, vediamo che il materiale pubblicato sta in una grande sproporzione con quanto N. già aveva pensato e sapeva. La prima comunicazione di N. nei brani 341 e 342 (“Il peso più grande” e “Incipit Tragedia”) della Gaia scienza racchiude tuttavia le due direzioni di fondo essenziali di questo pensiero: l’eterno ritorno in quanto pensiero che contribuisce anch’esso a formare e a trasformare l’ente nel suo insieme; e in quanto, per essere pensato, richiede il suo pensatore e maestro proprio.
E’ soprattutto a causa della “velatezza” delle comunicazioni pubblicate che la Gaia scienza e Così parlò Zarathustra, nelle quali si enunciava la nuova filosofia, rimasero incomprese. Se ora muoviamo dallo Zarathustra e leggiamo i frammenti postumi corrispondenti, osserviamo che il rapporto tra quanto comunicato e quanto rimase inedito è opposto rispetto al periodo della Gaia scienza.
Le annotazioni del periodo dello “Zarathustra” (1883/84)
Le annotazioni di questo periodo sono tanto esigui nelle dimensioni quanto importanti nel contenuto, che è espresso in forma estremamente concisa.
Nel brano n. 720 si afferma: “La vita stessa creò questo pensiero che è il più grave per la vita, essa vuole superare il suo ostacolo più alto!” L’eterno ritorno è presentato come scaturente dall’essenza della vita; esso è il più grave per la vita, in quanto è il più difficile da pensare e offre la resistenza più tenace al potenziamento della vita stessa.
Altri brani fanno riferimento all'”eraclitismo” di N., il quale, intorno al 1881, parla sovente del “flusso perenne di tutte le cose”, e chiama tale dottrina “l’ultima verità”, quella che non tollera più alcuna assimilazione: infatti la concezione della perenne instabilità non può essere tenuta per vera dall’uomo, pena la sua completa distruzione. Ora però, nel brano n.723, N. scrive : “Io vi insegno la redenzione dal flusso perenne”. Ciò vuol dire che l’eterno ritorno “fissa” il flusso perenne, ne determina il carattere essenziale, superandone il carattere distruttivo. Il divenire viene mantenuto come divenire, e tuttavia viene immessa in questo divenire la stabilità, cioè l’essere. In tal senso, anche questa verità può essere assimilata.
Nel brano n. 727 N. afferma: “Un processo infinito non può essere pensato altrimenti se non come periodico“. Si ribadisce che, nell’infinità del tempo reale, per un mondo finito, soggetto al divenire, è possibile soltanto un corso circolare. Inoltre, i singoli avvenimenti non vanno pensati in modo esteriore, come accostati in serie l’uno all’altro, ma ciascuno è sempre la risonanza del tutto e la consonanza con il tutto. (“Non lo sai? In ogni azione che tu fai è ripetuta e compendiata la storia di tutto l’accadere”. N. 726).
La considerazione che con il pensiero del ritorno tutto diverrebbe indifferente, ha inquietato N. seriamente e lo ha portato a riflettere sulle conseguenze della dottrina, cui si accenna nel brano n. 729 : “Paura delle conseguenze della dottrina: le nature migliori andranno forse in rovina per causa sua? Saranno le peggiori ad accettarla?”
La dottrina si affermerà dapprima presso “la plebaglia, che è fredda e senza grandi crisi interiori”, mentre “gli uomini supremi” saranno guadagnati a sè per ultimi. (N. 730).
Le annotazioni del periodo della “Volontà di potenza” (1884-1888)
Dal 1884 fino alla fine della sua attività, N. è occupato dal progetto di un’opera che esponga sistematicamente la sua filosofia. Il patrimonio di inediti di questo periodo è molto abbondante ed è articolato secondo diversi piani e progetti. Il pensiero dell’eterno ritorno è al centro del suo pensiero, e deve guidare l’opera capitale. (E’ quindi priva di fondamento l’interpretazione secondo cui questa dottrina sia stata messa da parte e abbandonata).
L’opera capitale, tuttavia, non fu mai composta; restano soltanto frammenti singoli, annotazioni che non trovano una configurazione compiuta. L’opera esistente, intitolata appunto La volontà di potenza, è stata compilata dai curatori dei frammenti postumi, che si sono avvalsi di piani e di progetti abbandonati da N. stesso. (Il quale per un certo tempo, ma solo per un certo tempo, aveva effettivamente pensato di dare questo titolo alla sua opera). Tale opera è dunque un falso che ha profondamente fuorviato l’interpretazione della filosofia di N..
Se ora passiamo all’analisi dei piani vediamo che il pensiero dell’eterno ritorno assume ovunque la posizione determinante. Nei piani e nei progetti degli anni 1884/85 emerge il tentativo di costruire l’opera capitale, di cui lo Zarathustra è stato il preambolo; manca tuttavia qualsiasi traccia di un’opera dal titolo La volontà di potenza. Nel 1885 si trova invece l’annotazione: La volontà di potenza. Tentativo di una interpretazione di ogni accadere. In tale piano si vede come la questione della volontà di potenza è inquadrata nella filosofia dell’eterno ritorno. (Un importante rinvio alla connessione tra questi due concetti si trova già in un piano n. 2 dell’anno precedente).
Negli anni immediaamente successivi viene messa in atto l’interpretazione di ogni accadere come volontà di potenza, che diviene il centro della progettata costruzione. Il tutto rimane nondimeno retto e determinato dal pensiero dell’eterno ritorno. In altri termini: la filosofia che N. progetta di esporre è quella dell’eterno ritorno; per darle forma c’è bisogno dell’interpretazione di ogni accadere come volontà di potenza. Per questo il termine “volontà di potenza” entra nel titolo dell’opera progettata.
Il piano del 1886 è intitolato “La volontà di potenza. Tentativo di una trasvalutazione di tutti i valori”. Trasvalutazione è ciò che il peso più grande – l’eterno ritorno – deve operare nei confronti dei valori, cioè del potenziamento della vita.
I piani dell’anno seguente hanno una struttura unitaria, e, sebbene la dottrina della volontà di potenza sia preminente, il pensiero dell’eterno ritorno conserva una posizione non indebolita. Esso diviene il punto “critico”, nel contesto dell’evento del nichilismo, tra l’epoca divenuta senza peso e quella che cerca nuovi pesi.
Anche i piani della primavera e dell’estate del 1888, l’ultimo anno di attività di N., presentano gli stessi tratti, ogni volta il piano va a culminare nel pensiero dell’eterno ritorno. Negli ultimo piani dell’autunno del 1888 il titolo La volontà di potenza scompare di nuovo come titolo principale per fare il posto a quello che finora era il sottotitolo: Trasvalutazione di tutti i valori.
I curatori della volontà di potenza, hanno opportunamente distribuito, seguendo le indicazioni dello stesso N., i brani sulla dottrina dell’eterno ritorno in due luoghi: nel primo libro, Il nichilismo europeo, e nel quarto libro, Disciplina e allevamento.
La questione del nichilismo e dell’eterno ritorno, trattata nel primo libro, richiede una discussione a sè. Ora entriamo brevemente nel merito di quanto è raccolto nel libro quarto, per vedere se, nelle annotazioni tra il 1884 e il 1888, ci sia un ulteriore sviluppo della dottrina.
Ad un confronto sommario, niente sembra sia cambiato rispetto al periodo precedente. Ma ad uno sguardo più attento (soprattutto se teniamo conto che N. in questo periodo ripensa a fondo la sua filosofia), emerge un quadro diverso. Occorre anche leggere i 15 brani dell’edizione oggi disponibile non nell’ordinamento dato dai curatori, ma secondo la loro successione cronologica. Rimandiamo la discussione di tali brani al momento in cui procederemo alla interpretazione vera e propria del pensiero fondamentale di N.; metteremo in evidenza una sola circostanza essenziale.
N. parla, in modo più chiaro di prima, dei “presupposti” della dottrina dell’eterno ritorno. Questo, in un primo momento, è strano; infatti, il pensiero fondamentale che tutto determina non può avere presupposti. In realtà, N. pensa ora l’eterno ritorno partendo dalla volontà di potenza, intesa come la costituzione generale di tutto ciò che è. La volontà di potenza, dunque, sarebbe il “presupposto” dell’eterno ritorno, secondo i seguenti sensi:
1) ne sarebbe il fondamento conoscitivo (Erkenntnisgrund, ratio conoscendi), in quanto da essa, come carattere di forza dell’universo, si può arguire l’eterno ritorno;
2) ne sarebbe il fondamento reale (Sachgrund, ratio essendi), in quanto l’eterno ritorno è possibile soltanto se dell’ente in quanto tale è propria la costituzione della volontà di potenza.
3) in quanto la costituzione dell’ente (il suo “che cosa”, la quidditas, essentia) fonda il modo dell’essere (il suo “come” e il suo “che è”, l’existentia).
La questione del rapporto tra volontà di potenza ed eterno ritorno era oscura per N. stesso, fonte di inquietudine per il suo pensiero. In ogni caso, per N., fra i due concetti vi è una essenziale coappartenenza. Lo dimostra il rifacimento di uno dei 15 brani, il n.1067, che, nella seconda versione, nella conclusione, dice: “Questo mondo è la volontà di potenza – e nient’altro!“. Ma nella prima versione, alla domanda “Che cos’è per me il mondo?” N. rispondeva: é l’eterno ritorno dell’uguale.
La forma della dottrina dell’eterno ritorno
Per forma intendiamo la struttura interna della sua verità, prefigurata da questa stessa verità. La domanda, se la dottrina di N. abbia una forma in questo senso, non ha una risposta immediata. Ovunque nei pensieri di N. si manifesta indirettamente una propria legge della verità. Per coglierla occorre superare le comode rappresentazioni correnti che pretendono di inquadrare la sua filosofia e guadagnare una prospettiva dalla quale sarà possibile cogliere una posizione di fondo, i fondamenti determinanti della forma. Tale prospettiva può risultare da una visione che anticipi l’insieme della sua filosofia.
I tre poli, mobili l’uno rispetto all’altro, intorno ai quali ruotano gli sforzi relativi alla costruzione della sua opera capitale sono l’eterno ritorno, la volontà di potenza e la trasvalutazione di tutti i valori. Il complesso in cui questi tre termini sono legati in una coappartenenza originaria e unitaria, è la forma cercata. Tutti e tre significano l’insieme di questa filosofia, e nessuno la coglie pienamente, perchè la forma di questa filosofia non si lascia costringere in una sola direzione.
Questi tre poli sono riconoscibili anche dai titoli dell’opera progettata, ognuno dei quali viene scelto in successione come principale; noi non seguiremo, tuttavia, la via di un confronto dei piani e dei titoli, che rimarrebbe all’esterno della filosofia di N..
Occorre invece guardare all’ambito che questo pensiero abbraccia e sul quale è sovrano.
L’ambito del pensiero dell’eterno ritorno: la dottrina dell’eterno ritorno come superamento del nichilismo
L’ “ambito” è il contesto unitario da cui questo pensiero è determinato e a sua volta determina; la circoscrizione della sua provenienza e del suo dominio. Tale ambito deve assicurare al pensiero dell’eterno ritorno la sua determinatezza, per evitare che sia pensato in termini generici.
Nella filosofia di N. c’è da rilevare una caratteristica essenziale: il pensiero di questo filosofo costituisce un contromovimento e un rovesciamento rispetto all’intera filosofia occidentale, interpretata come platonismo. Scagliandosi contro i valori supremi di quella tradizione, esso diventa il “rovesciamento di tutti i valori”.
Un rovesciamento di tale portata, nella sua necessarietà, deve scaturire da questa tradizione e contemporaneamente rimanervi radicato. Se ora l’eterno ritorno è il pensiero fondamentale dell’autentica filosofia di N., allora l’essenza di questo pensiero deve essere radicata in quell’esperienza della storia occidentale dalla quale scaturisce la necessità di un contromoviemnto e di un rovesciamento. Questa esperienza è quell’evento fondamentale dell’uomo occidentale designato come “nichilismo”. [Una delucidazione approfondita dell’essenza del nichilismo è fornita nel secondo libro di quest’opera].
Solo dal sapere dell’evento del nichilismo come il fatto fondamentale della storia, ci si apre l’ambito del pensiero dell’eterno ritorno. Il confronto con il nichilismo è la cosa più difficile, tanto più che anche il pensiero dell’eterno ritorno ha un carattere nichilistico, in quanto, eternizzando l'”invano”, esclude un fine ultimo per l’ente. N. scrive: “Pensiamo questo pensiero nella forma più terribile: l’esistenza, così com’è, senza senso e scopo, ma inevitabilmente ritornante, senza un finale nel nulla: l’eterno ritorno”. (La volontà di potenza, n. 55).
Ma l’eterno ritorno costituisce il superamento del nichilismo solo se è colto nel suo carattere di attimo e di decisione. In quanto superamento del nichilismo esso lo presuppone, tuttavia, nel senso che lo pensa fino in fondo, all’estremo.
Attimo ed eterno ritorno
A questo punto possiamo riprendere il seguito del racconto di Zarathustra nella “Visione e l’enigma” che avevamo lasciato in sospeso, e al tempo stesso ripensarlo a fondo nell’insieme.
La seconda visione di Zarathustra, caratterizzata dall’immagine del pastore dormiente, “cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca”, si svolge in un paesaggio desolato, segnato dall’ululare di un cane. Tutto evoca l’immagine speculare opposta all’atmosfera d
L’ESSERE-PER-LA-MORTE
Introduzione”Benché la rinascita della ‘metafisica’ sia considerata una conquista del nostro tempo, tuttavia il problema dell’essere è purtroppo dimenticato”. Così inizia l’opera più famosa di Heidegger, Essere e tempo. Heidegger imposta la questione del problema dell’essere – che considera “oscura e aggrovigliata” -, indagando e analizzando “quell’ente che noi che cerchiamo, già siamo”. La metafisica si presenta nel primo Heidegger come analisi dell’Esserci, cioè di quell’essere, appunto, “che noi stessi già siamo, e che ha, fra le altre possibilità, quella del cercare”. Come viene detto in questo passo, l’Esserci è caratterizzato, nel suo essere-nel-mondo, dall’essere-per-la-morte. Se l’Esserci è definito dalla possibilità di essere, la morte gli si presenta come il limite e la negazione di questa possibilità e gli chiede di accettare l’essere per la morte come “orizzonte in cui si iscrive la sua vita”. Il “Si muore” cerca di esorcizzare l’angoscia davanti alla morte, di tranquillizzare gli uomini, ma Heidegger considera inautentico questo approccio all’essere-per-la-morte, che, invece, richiede all’uomo di progettarsi sapendo quale è la possibilità estrema che gli appartiene. Sapendo che non può solidificarsi su nessuna delle situazioni esistenziali raggiunte.
Testo di HeideggerLa morte sovrasta l’esserci. La morte non è affatto una semplice presenza non ancora attuatasi, non è un mancare ultimo ridotto ad minimum, ma è, prima di tutto, un’imminenza che sovrasta. Ma all’esserci, come essere-nel-mondo, sovrastano molte cose. Il carattere d’imminenza sovrastante non è esclusivo della morte. Un’interpretazione del genere potrebbe far credere che la morte sia un evento che s’incontra nel mondo, minaccioso nella sua imminenza. Un temporale può sovrastare come imminente; la riparazione d’una casa, l’arrivo d’un amico, possono essere imminenti; tutte cose, queste, che sono semplici-presenze o utilizzabili o compresenze. Il sovrastare della morte non ha un essere di questo genere. […] La morte è una possibilità di essere che l’esserci stesso deve sempre assumersi da sé. Nella morte l’esserci sovrasta se stesso nel suo poter-essere più proprio. In questa possibilità ne va per l’esserci puramente e semplicemente del suo essere-nel-mondo. La morte è per l’esserci la possibilità di non-poter-più-esserci. Poiché in questa possibilità l’esserci sovrasta se stesso, esso viene completamente rimandato al proprio poter-essere più proprio. In questo sovrastare dell’esserci a se stesso, dileguano tutti i rapporti con gli altri esserci. Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è, nel contempo, l’estrema. Nella sua qualità di poter-essere, l’esserci non può superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Come tale è un’imminenza sovrastante specifica. […] Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, l’esserci non se la crea accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo essere. Se l’esserci esiste, è anche già gettato in questa possibilità. […]. L’esser-gettato nella morte gli si rivela nel modo più originario e penetrante nella situazione emotiva dell’angoscia. Un’angoscia davanti alla morte è angoscia davanti al poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile. […] L’angoscia non dev’essere confusa con la paura davanti al decesso. Essa non è affatto una tonalità emotiva di ‘depressione’, contingente, casuale, alla mercé dell’individuo; in quanto situazione emotiva fondamentale dell’esserci, essa costituisce l’apertura dell’esserci al suo esistere come esser-gettato per la propria fine. Si fa così chiaro il concetto esistenziale dei morire come esser-gettato nel poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile, e si approfondisce la differenza rispetto al semplice scomparire, al puro cessare di vivere e all’esperienza vissuta dei decesso. […] Un’interpretazione pubblica dell’esserci dice: “Si muore”; ma poiché si allude sempre a ognuno degli Altri e a noi nella forma dei Si anonimo, si sottintende: di volta in volta non sono io. Infatti il Si è il nessuno. […] Il morire, che è mio in modo assolutamente insostituibile, è confuso con un fatto di comune accadimento che capita al Si. Questo tipico discorso parla della morte come di un “caso” che ha luogo continuamente. Esso fa passare la morte come qualcosa che è sempre già “accaduto”, coprendone il carattere di possibilità e quindi le caratteristiche di incondizionatezza e di insuperabilità. Con quest’equivoco l’esserci si pone nella condizione di perdersi nel Si proprio rispetto al poter-essere che più di ogni altro costituisce il suo se-Stesso più proprio. Il Si fonda e approfondisce la tentazione di coprire a se stesso l’essere-per-la-morte più proprio. Questo movimento di diversione dalla morte coprendola domina a tal punto la quotidianità che, nell’essere-assieme, “i parenti più prossimi” vanno sovente ripetendo al “morente” che egli sfuggirà certamente alla morte e potrà far ritorno alla tranquilla quotidianità del mondo di cui si prendeva cura. Questo “aver cura” vuol così “consolare il morente”. Ci si preoccupa di riportarlo nell’esserci, aiutandolo a nascondersi la possibilità del suo essere più propria, incondizionata e insuperabile. Il Si si prende cura di una costante tranquillizzazione nei confronti della morte. In realtà ciò non vale solo per il “morente” ma altrettanto per i consolanti. […] Il Si non ha il coraggio dell’angoscia davanti alla morte. […] Nell’angoscia davanti alla morte, l’esserci è condotto davanti a se stesso in quanto rimesso alla sua possibilità insuperabile. Il Si si prende cura di trasformare quest’angoscia in paura di fronte a un evento che sopravverrà. Un’angoscia, banalizzata equivocamente in paura, è presentata come una debolezza che un esserci sicuro di sé non deve conoscere. […] Un essere-per-la-morte è l’anticipazione di un poter-essere di quell’ente il cui modo dì essere è l’anticiparsi stesso. Nella scoperta anticipante di questo poter-essere, l’esserci si apre a se stesso nei confronti della sua possibilità estrema. Ma progettarsi sul poter essere più proprio significa poter comprendere se stesso entro l’essere dell’ente così svelato: l’anticipazione dischiude all’esistenza, come sua estrema possibilità, la rinuncia a se stessa, dissolvendo in tal modo ogni solidificazione su posizioni esistenziali raggiunte.
[Tratto da Essere e Tempo ]
PASSI TRATTI DALLE OPERE
Apparente ovvietà dell’essere
Quello di essere è un concetto ovvio. In ogni conoscere, in ogni asserzione, in ogni comportamento [che ci pone in rapporto] con l’ente, in ogni comportamento che ci pone in rapporto con noi stessi si fa uso di “essere”, e l’espressione è “senz’altro comprensibile”. Tutti comprendono cosa significhi: “Il cielo è azzurro”, “Sono contento”, e così via. Ma questa comprensione media non dimostra che un’incomprensione. Essa sta a denunciare che in ogni comportamento e in ogni modo di essere che ci ponga in relazione con l’ente in quanto ente si nasconde a priori un enigma. Il fatto che già sempre viviamo in una comprensione dell’essere e che, nel contempo, il senso dell’essere continua a restare avvolto nell’oscurità, attesta la necessità fondamentale di una ripetizione del problema del senso dell’”essere”.
(Heidegger, Essere e tempo)
Hölderlin e il colloquio
L’essere dell’uomo si fonda nel linguaggio (Sprache); ma questo accade (geschieht) autenticamente solo nel colloquio (Gespràche). […]Ma che cosa significa allora un “colloquio”? Evidentemente il parlare insieme di qualcosa. in tal modo che il parlare rende possibile l’incontro. Ma Hölderlin dice: “da quando siamo un colloquio e possiamo ascoltarci l’un l’altro”. Il poter ascoltare non è una conseguenza che derivi dal parlare insieme, ma ne è piuttosto, al contrario, il presupposto. Ma anche il poter ascoltare è in sé a sua volta orientato in relazione alla possibilità della parola e di essa ha bisogno. Poter discorrere e poter ascoltare sono cooriginari. Noi siamo un colloquio, e questo vuol dire: possiamo ascoltarci l’un l’altro. […] Ma l’unità di un colloquio consiste nel fatto che di volta in volta nella parola essenziale è, manifesto quell’uno e medesimo su cui ci troviamo uniti, sul fondamento del quale siamo uniti e siamo quindi autenticamente noi stessi. Il colloquio, con la sua unità, sorregge il nostro esserci.
(Heidegger, La poesia di Hölderlin)
Il modo di essere della verità e la presupposizione della verità
L’Esserci, in quanto costituito dall’apertura, è essenzialmente nella verità. L’apertura è un modo di essere essenziale dell’Esserci. “C’è” verità solo perché è fin che l’Esserci è. L’ente è scoperto solo quando, ed aperto solo fin che, in generale, l’Esserci è. […]Se si muove dal modo di essere della verità esistenzialmente intesa, diviene comprensibile anche il senso della presupposizione della verità. Perché noi dobbiamo presupporre che c’è la verità? Che significa “presupporre”? Che stanno a significare “dobbiamo” e “noi”? Che significa “c’è la verità”? “Noi” presupponiamo la verità non come qualcosa che stia “al di fuori” e “al di sopra” di noi e a cui noi ci rapporteremmo come ci rapportiamo ad altri “valori”. Non siamo noi a presupporre la “verità”, ma essa è ciò che rende ontologicamente possibile che noi possiamo esser siffatti da “presupporre” qualcosa. E’ la verità che rende possibile qualcosa come il presupporre.
(Heidegger, Essere e tempo)
La comprensione dell’essere e l’esserci nell’uomo
La comprensione dell’essere, definita così, in pochi tratti, si mantiene sul piano senza scosse e senza pericoli della più pura evidenza. E tuttavia, se la comprensione dell’essere non avesse luogo, l’uomo non sarebbe mai in grado di essere l’ente che è, anche qualora fosse dotato delle più straordinarie facoltà. L’uomo è un ente che si trova in mezzo all’ente, e vi si trova in modo tale, per cui l’ente che egli non è e l’ente che egli stesso è gli sono sempre già manifestati. A questo modo d’essere dell’uomo diamo il nome di esistenza. L’esistenza è possibile solo sul fondamento della comprensione dell’essere. Nel rapportarsi all’ente che egli non è, l’uomo si trova già davanti l’ente come ciò che lo sostiene, ciò cui si trova assegnato, ciò che, con tutta la sua cultura e la sua tecnica, egli non potrà mai, in fondo, signoreggiare. Assegnato all’ente diverso da lui, l’uomo non è in fondo, padrone nemmeno dell’ente che egli stesso è.
(Heidegger, Kant e il problema della metafisica)
La critica a Cartesio
[…]Cartesio sa bene che l’ente non si manifesta innanzitutto nel suo essere autentico. “Innanzitutto” è dato questo pezzo di cera, che ha un certo colore, un certo sapore, che è duro, freddo e risonante. Ma tutto ciò e, in genere, ogni dato sensibile, è privo d’importanza ontologica. Satis erit, si advertamus sensuum perceptiones non referri, nisi ad istam corporis humani cum mente coniunctionem, et nobis quidem ordinarie exibere, quid ad illam externa corpora prodesse possint aut nocere. I sensi non ci fanno conoscere l’ente nel suo essere, ma denunciano semplicemente l’utilità o la dannosità delle cose presenti nel mondo “esterno” nei confronti dell’essere umano corporeo. Nos non docent, qualia (corpora) in seipsis existant. I sensi non ci informano sull’ente nel suo essere.
(Heidegger, Essere e tempo)
La “voce della coscienza”
Un’analisi approfondita della coscienza la rivela come una chiamata. Il chiamare è un modo del discorso. La chiamata della coscienza ha il carattere del richiamo dell’Esserci [semplificando: dell’uomo] al suo più proprio poter essere e ciò nel modo del risveglio al suo più proprio essere-in-colpa […] Alla chiamata della coscienza corrisponde un sentire possibile. La comprensione del richiamo si rivela come un voler-avere-coscienza […] Inoltre non dobbiamo dimenticare che il discorso, e quindi anche la chiamata, non implicano necessariamente la comunicazione verbale […]. Quando l’interpretazione quotidiana parla di una ‘voce’ della coscienza non intende alludere a una comunicazione verbale che, difatti, non ha luogo; qui ‘voce’ significa ‘dare a comprendere’. Nello sforzo di aprire, proprio della chiamata, c’è un momento di urto, di brusco risveglio. Chi è chiamato, lo è dalla lontananza”
(Heidegger, Essere e tempo)
Originarietà della poesia
L’essenza dell’arte è la Poesia. Ma l’essenza della Poesia è l’instaurazione [Stiftung] della verità. Instaurare qui è inteso in un triplice significato: come donare, come fondare, come iniziare. L’instaurazione è reale solo nel salvaguardare. Pertanto ad ogni modalità dell’instaurare corrisponde una modalità del salvaguardare. Qui non è possibile che delineare a larghi tratti questa struttura dell’arte, e sempre relativamente ai risultati raggiunti nella determinazione dell’essenza dell’opera.
(Heidegger, Sentieri interrotti)
Perché i poeti?
“… e perché i poeti [wozu Dichter] nel tempo della povertà?”, chiede l’elegia di Hölderlin Pane e vino. Oggi comprendiamo a stento la domanda. Come potremo intendere la risposta che Hölderlin dà? […]Con la venuta e il sacrificio di Cristo ha avuto inizio, secondo la concezione storica di Hölderlin, la fine del giorno degli Dei. È caduta la sera. Da quando i “tre che sono uno”: Ercole, Dioniso e Cristo, hanno lasciato il mondo, la sera del tempo mondano va verso la flotte. La notte del mondo distende le sue tenebre. Ormai l’epoca è caratterizzata dall’assenza di Dio, dalla “mancanza di Dio”. […] La mancanza di Dio significa che non c’è più nessun Dio che raccolga in sé, visibilmente e chiaramente, gli uomini e le cose, ordinando in questo raccoglimento la storia universale e il soggiorno degli uomini in essa. Ma nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di peggiore ancora. Non solo gli Dei e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà perché diviene sempre più povero.[…]
(Heidegger, Sentieri interrotti)
Potenzialità dell’essere
La possibilità come esistenziale non significa un poter-essere indeterminato del genere della “libertà indifferente” (libertas indifferentiae). L’Esserci, in quanto emotivamente situato nel suo essere stesso, è già sempre insediato in determinate possibilità e, in quanto è quel poter-essere che è, ne ha già sempre lasciate perdere alcune; rinuncia incessantemente a possibilità del suo essere, riesce a coglierne talune oppure fallisce. Ciò significa che l’Esserci è un esser-possibile consegnato a se stesso, una possibilità gettata da cima a fondo. L’Esserci è la possibilità di esser libero per il più proprio poter-essere. L’esser-possibile è trasparente a se stesso secondo le modalità e gradi diversi.
(Heidegger, Essere e tempo)
NORBERTO BOBBIO

Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze (Politica e cultura, 1955)
VITA E OPERE
Norberto Bobbio è nato a Torino il 18 ottobre 1909 da Luigi, medico-chirurgo, originario di Rivalta Bormida (in provincia di Alessandria), primario all’ospedale San Giovanni, uno dei più noti chirurghi della città. Gli anni della sua formazione vedono Torino come centro di grande elaborazione culturale e politica. Al Liceo Massimo D’Azeglio conosce Vittorio Foa, Leone Ginzburg e Cesare Pavese . All’università diventa amico di Alessandro Galante Garrone. Si laurea in legge e in filosofia. Dopo aver studiato Filosofia del diritto con Solari, insegna questa disciplina a Camerino (1935-38),a Siena (1938-40) e Padova (1940-48). Il suo peregrinare per l’Italia lo porta a frequentare vari gruppi di antifascisti. A Camerino conosce Aldo Capitini e Guido Calogero e comincia a frequentare le riunioni del movimento liberalsocialista. Da Camerino si trasferisce a Siena dove collabora con Mario delle Piane, e infine nel 1940 a Padova, dove diventa amico di Antonio Giuriolo. Collabora inoltre con il gruppo torinese di Giustizia e Libertà, con Foa, Leone e Natalia Ginzburg, Franco Antonicelli, Massimo Mila. Successivamente nel 1942 aderisce al Partito d’Azione. A Padova collabora con la Resistenza frequentando Giancarlo Tonolo e Silvio Trentin. Viene arrestato nel 1943. Nel dopoguerra insegna Filosofia del diritto all’Università di Torino (1948-72) e Filosofia della politica, sempre a Torino, dal 1972 al 1979. Dal 1979 è professore emerito dell’Università di Torino e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei; dal 1966 è socio corrispondente della British Academy. La scelta di non essere protagonista della vita politica attiva non ha però mai impedito a Bobbio di essere presente e partecipe: al contrario è stato punto di riferimento nel dibattito intellettuale e politico dell’ultimo trentennio. Nel 1966 sostiene il processo di unificazione tra socialisti e socialdemocratici. Nel 1984 il filosofo apre una forte polemica con la “democrazia dell’applauso” varata da Bettino Craxi nel Congresso di Verona e Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica Italiana. Nel luglio del 1984 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Norberto Bobbio ha ottenuto la laurea ad honorem nelle Università di Parigi, di Buenos Aires, di Madrid (Complutense), di Bologna, di Chambéry. È stato a lungo direttore della “Rivista di filosofia” insieme con Nicola Abbagnano. Il grande filosofo italiano è scomparso il 9 gennaio 2004 all’età di 94 anni. Personalità umile, sebbene in vita abbia chiesto che i suoi funerali venissero celebrati in forma strettamente privata, molti sono stati gli italiani e le personalità ufficiali, tra cui il Presidente Carlo Azeglio Ciampi , che hanno reso omaggio al senatore a vita visitando la camera ardente allestita (con il consenso dei figli) presso l’Università di Torino.
“Con Norberto Bobbio scompare la coscienza critica della sinistra italiana. È stato l’«oracolo» al quale, periodicamente, e soprattutto nei momenti più critici della recente storia italiana, politici e intellettuali della sinistra hanno fatto ricorso. Sempre sorprendendoli, gettando nel pensiero politico l’inquietudine di chi – come lui – sentiva di appartenere alla categoria di uomini che non sono mai contenti di se stessi. L’eredità della riflessione politica lasciata da Bobbio alla sinistra italiana è riassumibile in una via che lui stesso ha chiamato «la politica dei diritti».” [Corriere della sera – 10/01/2004]
Forse il più bel ritratto di Bobbio lo dobbiamo a lui stesso, che così si descrisse:
“‘Dalla osservazione della irriducibilità delle credenze ultime ho tratto la più grande lezione della mia vita. Ho imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare. E poiché sono in vena di confessioni, ne faccio ancora una, forse supeflua: detesto i fanatici con tutta l’anima.”
Opere: L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, Torino, 1934; Scienza e tecnica del diritto, Torino, 1934; L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938; La consuetudine come fatto normativo, Padova, 1942; La filosofia del decadentismo, Torino, 1945; Teoria della scienza giuridica, Torino, 1950; Politica e cultura, Torino, 1955; Studi sulla teoria generale del diritto, Torino, 1955; Teoria della norma giuridica, Torino, 1958; Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960; Il positivismo giuridico, Torino, 1961; Locke e il diritto naturale, Torino, 1963; Italia civile, Torino, 1964; Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965; Da Hobbes a Marx, Napoli, 1965; Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino, 1960, 1990 (nuova ed.); Saggi sulla scienza politica in Italia, Torino, 1969; Diritto e Stato nel pensiero di E. Kant, Torino, 1969; Una filosofia militante: studi su Carlo Cattaneo, Torino, 1971; Quale socialismo, Torino, 1977; I problemi della guerra e le vie della pace, Bologna, 1979; Studi hegeliani, Torino, 1981; Il futuro della democrazia, Torino, 1984; Maestri e compagni, Firenze, 1984; Il terzo assente, Torino, 1988; Thomas Hobbes, Torino, 1989; L’età dei diritti, Torino, 1989; Destra e sinistra, Roma, 1994.
IL PENSIERO
Filosofo, giurista e politologo, professore per lunghi anni all’università di Torino, Norberto Bobbio è una delle più illustri figure della cultura del Novecento italiano. Il suo pensiero etico-politico è caratterizzato fin dai suoi esordi da una profonda fede, insieme teorica e pratica, nel principio della responsabilità civile della riflessione intellettuale. Su questo fondamento Bobbio ha elaborato durante gli anni della guerra le sue proposte teoriche in polemica contro i vari orientamenti della filosofia novecentesca, dall’idealismo all’esistenzialismo. Per Bobbio, infatti, la crisi contemporanea non può essere compresa nè attraverso una ” decadente ” meditazione sull’esistenza individuale, come egli sostiene nell’opera La filosofia del decadentismo (1944), nè attraverso una nuova escatologia storica, ma solo ritornando alla lezione del razionalismo metodologico illuministico . Ecco allora che la riflessione di Bobbio, prendendo le distanze dal pensiero idealistico, quale sapere “accademico”, “retorico” e non concretamente riformatore, criticando gli aspetti irrazionalistici dell’esistenzialismo e quelli utopistici del marxismo, si è andata sempre più orientando verso la filosofia analitica anglosassone, che egli applica allo studio del linguaggio giuridico (proposizioni prescrittive). La raccolta di scritti su Politica e cultura , pubblicata negli anni ’50, preciserà la sua posizione su questo importante tema. I filosofi e gli intellettuali in genere, scrive Bobbio, debbono ” seminare dubbi, non già raccogliere certezze ” : in Politica e cultura Bobbio scrive che ” il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Di certezze- rivestite della fastosità del mito o edificate con la pietra dura del dogma- sono piene, rigurgitanti, le cronache della pseudo-cultura degli improvvisatori, dei dilettanti, dei propagandisti interessati. Cultura significa misura, ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere, e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo dal quale dipenda, in modo irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva. Vi è qui uno degli aspetti del ‘tradimento dei chierici’; e il più importante, a mio avviso, perchè non è limitato dal mondo contemporaneo ma si riconnette alla figura romantica del filosofo-profeta: trasformare il sapere umano, che è necessariamente limitato e finito, e quindi richiede molta cautela insieme con molta modestia, in sapienza profetica. Donde deriva la posizione, così frequente tra i filosofi, di ogni problema in termini di alternativa, di aut-aut, di opzione radicale. O di qua o di là. Ascoltate il piccolo sapiente che respira la nostra aria satura di esistenzialismo: vi dirà che i problemi non si risolvono, ma si decidono. E’ come dire che il nodo- questo nodo aggrovigliatissimo dei problemi dell’uomo nella società di oggi- non essendo possibile scioglierlo, bisogna tagliarlo. Ma, appunto, per tagliarlo, non è necessaria la ragione (che è l’arma dell’uomo di cultura). Basta la spada “.Non si tratta dunque di essere profeti, ma osservatori della realtà capaci di descriverne le strutture. L’impegno dell’intellettuale consiste appunto in questo lavoro di analisi e descrizione, nel porre in questione le pretese assolutizzanti delle diverse ” versioni del mondo ” in contrasto fra loro e, soprattutto, nel demistificare ogni sintesi ultima e definitiva. Ecco allora che Bobbio propone un modello di ” filosofia militante ” come “filosofia del dubbio”, e una teoria dell’impegno dell’intellettuale come militante della ragione: ” non vi è nulla di più seducente, oggi, che il programma di una filosofia militante contro la filosofia degli ‘addottrinati’. Ma non si confonda la filosofia militante con una filosofia al servizio di un partito che ha le sue direttive, o di una chiesa che ha i suoi dogmi, o di uno stato che ha la sua politica. La filosofia militante che ho in mente è una filosofia in lotta contro gli attacchi, da qualsiasi parte provengano- tanto da quella dei tradizionalisti come da quella degli innovatori- alla libertà della ragione rischiaratrice. […] al di là del dovere di entrare nella lotta, c’è, per l’uomo di cultura, il diritto di non accettare i termini della lotta così come sono posti, di discuterli, di sottoporli alla critica della ragione “. Criticando sia ogni engagement strumentale ad effimeri o unilaterali fini pratico-politici, sia un esercizio libero ma disimpegnato e irresponsabile della cultura, Bobbio identificava il lavoro intellettuale nella difesa delle condizioni di esistenza e di sviluppo della cultura stessa. Fra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60, Bobbio scrive opere significative di teoria generale del diritto e della giustizia, divenendo un convinto sostenitore di un ” positivismo giuridico ” inteso come analisi rigorosa dei sistemi normativi esistenti: egli tratta di ciò in svariate opere, quali Teoria della norma giuridica (1958), Teoria dell’ordinamento giuridico (1960), Il positivismo giuridico (1961), Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965). Agli stessi anni risalgono importanti saggi su Hobbes, Marx, Mosca, Pareto, la classe politica e la democrazia: ricordiamo la curiosa e geniale teoria bobbiana. fa notare che in ogni epoca ci sono categorie di pensiero fondamentali che , talvolta , sono così forti da costringere a servirsi di esse anche chi non la pensa così perchè altrimenti non verrebbe compreso , visto che tutti si avvalgono di quelle categorie . Bobbio, nel caso di Hobbes, nota come il pensatore seicentesco si serva di categorie giusnaturalistiche particolarmente in voga all’ epoca per poi fornire un contenuto sostanzialmente giuspositivista ( giuspositivismo: non c’ é alcun diritto naturale, ma solo diritti imposti dagli Stati ); in realtà Hobbes propugna tesi giuspositiviste camuffandole da giusnaturaliste : in ultima istanza ciò che é giusto o sbagliato lo é perchè lo decide il sovrano e non perchè di per sè sia giusto o sbagliato. La convinzione di fondo che aleggia nella filosofia bobbiana è che, dopo Hegel, per evitare ogni cedimento ad atteggiamenti dogmatici o metafisici, la sola via che la filosofia può percorrere è la continuazione del razionalismo metodologico dell’Illuminismo, garanzia di rigore e di impegno. Questo “neoilluminismo” investe altri campi, come la storia della filosofia e delle dottrine politiche, la storia della cultura e degli intellettuali nell’Italia contemporanea, nonchè il dibattito politico sui temi di attualità (la pace, la democrazia, la guerra ecc.), nella convinzione che la partecipazione al dibattito pubblico sia necessaria per ampliare il dialogo e il pluralismo, che sono alla base della convivenza democratica. Ed è riflettendo sulla democrazia realizzatasi in Italia nel dopoguerra che nel 1970, presentando una raccolta di suoi scritti su Carlo Cattaneo, egli traccia un lucido e amaro bilancio di un’intera generazione di intellettuali: ” inseguimmo le ‘alcinesche seduzioni’ della Giustizia e della Libertà; abbiamo realizzato ben poca giustizia e forse stiamo perdendo la libertà “. Si tratta di un giudizio per un verso direttamente ispirato agli eventi politici di quegli anni, per un altro verso connesso a una nuova problematizzazione del ruolo della cultura e dell’intellettuale nel progresso della società civile. Certo, anche nei suoi interventi successivi Bobbio ribadirà che il primo ufficio degli intellettuali è l’indagine razionale (neutra) dei mezzi, non già l’indicazione dei fini. Ma discutendo nuovamente il rapporto democrazia-socialismo (uno dei nodi cruciali del suo pensiero più recente) egli fornirà una nuova interpretazione del compito etico-politico della riflessione: un compito indicato nell’elaborazione di concezioni insieme giuste e realizzabili intorno agli obiettivi e alle regole della convivenza civile. Tale indicazione è accompagnata da una valutazione assai cauta ed equilibrata del marxismo , ovvero della dottrina che maggiormente era parsa approfondire lo studio della realtà sociale. Da un lato Bobbio apprezza certi princìpi filosofici generali dell’opera marxiana (soprattutto in Da Hobbes a Marx , 1965) e l’istanza emancipativa presente (anche se troppo spesso in modi pesantemente condizionati da istanze di tutt’altro genere) nei movimenti politici ispiratisi a quell’opera: e Bobbio ha in mente, oltre alla dittatura staliniana, gli eventi della Cina comunista. Egli disse in merito in un’intervista: ” Quando accadde in Cina quel fatto che suscitò orrore quasi dovunque, e cioè l’uso delle armi per fermare gli studenti che a piazza Tienanmen manifestavano il loro dissenso dal governo comunista cinese, io scrissi su La Stampa un articolo in cui dicevo che il comunismo era una ‘utopia capovolta’, perché era un’utopia di liberazione degli esseri umani che si era capovolta nel suo contrario, e cioè nella costrizione e nell’oppressione degli esseri umani. Però, in quello stesso articolo, scrivevo anche che i motivi per i quali il comunismo era nato sono ancora vivi. Sono in grado le democrazie che governano i Paesi più ricchi del mondo di risolvere i problemi che il comunismo non è riuscito a risolvere? Questo è il problema. Il comunismo storico è fallito, non discuto. Ma i problemi restano, proprio quegli stessi problemi che l’utopia comunista aveva additato e ritenuto fossero risolvibili. Questa è la ragione per cui è da stolti rallegrarsi della sconfitta e fregandosi le mani dalla contentezza dire: ‘L’avevamo sempre detto!’. O illusi, credete proprio che la fine del comunismo storico (insisto sullo “storico”) abbia posto fine al bisogno e alla sete di giustizia? La democrazia ha vinto la sfida del comunismo storico, ammettiamolo. Ma con quali mezzi e con quali ideali si dispone ad affrontare gli stessi problemi da cui era nata la sfida comunista? “. Tra l’altro, Bobbio è stato anche accusato per aver equiparato nazismo e comunismo, ma egli ha notato che se il risultato dei due totalitarismi fu pressochè il medesimo, diversi furono gli obiettivi che si erano prefissi: ” Certamente c’è una differenza importante tra i due movimenti: magari usavano gli stessi mezzi atroci e disumani, ma mentre nel nazismo erano ugualmente condannabili sia i mezzi sia i fini, invece nel comunismo lo erano i mezzi non i fini, spesso nobili (liberazione dall’oppressione dei rapporti di lavoro, pari dignità sociale dei cittadini) “. Bobbio non esita a denunciare nel marxismo sia la carenza di un’adeguata teoria delle istituzioni mediante le quali esercitare il potere in uno stato evoluto, sia il mancato sviluppo teorico-pratico del duplice nesso democrazia-socialismo e libertà-giustizia. Ciò su cui un pensiero autenticamente riformatore deve impegnarsi è invece proprio l’elaborazione dei quadri concettuali in rapporto ai quali una società può evolversi in direzione liberal-socialista, nonchè, sul piano pratico, l’estensione degli istituti e dei costumi democratici nella società contemporanea: Bobbio esprime queste convinzioni in Quale socialismo? (1976) e Il futuro della democrazia (1984).
“AUTOBIOGRAFIA”
“Cultura è equilibrio intellettuale, riflessione critica, senso di discernimento, aborrimento di ogni semplificazione, di ogni manicheismo, di ogni parzialità.” Questa frase di Bobbio, estrapolata da una lettera da lui mandata a Giulio Einaudi nel settembre 1868, rappresenta con chiarezza la linea lungo la quale si è sempre mosso sia nella sua attività intellettuale che nel suo impegno politico. Questa “libertà intellettuale” è parte della concezione altissima di libertà che ha sempre guidato le sue scelte e che in questa Autobiografia appare il filo conduttore di tutta una vita. Gli anni della sua formazione vedono Torino come centro di grande elaborazione culturale e politica. I nomi di amici o compagni di scuola, di interlocutori con cui Bobbio inizia a riflettere e a discutere sul significato e sul valore della libertà (che proprio in quegli stessi anni inizia ad essere conculcata) sono quelli su cui si fonda la civiltà intellettuale dell’Italia contemporanea. L’impegno antifascista si fa sempre più attivo, irrinunciabile l’azione in un momento in cui non era eticamente lecita qualsiasi forma di neutralità, naturale lo sbocco in “Giustizia e Libertà”, binomio mai scindibile, né nella concezione dello Stato, né nell’elaborazione del pensiero politico se ancora nel 1995 per l’Einaudi esce un saggio dal titolo “Eguaglianza e libertà”. “Ogni uomo ha la possibilità di differenziarsi dagli altri secondo la propria legge intrinseca, che è la propria libertà e quindi di essere valutato in modo corrispondente alla sua differenziazione”, e ancora, “In democrazia tutti sono ugualmente liberi. Ugualmente: l’avverbio è fondamentale. Questa uguaglianza richiede, a mio parere, il riconoscimento anche dei diritti sociali, a partire da quelli essenziali (istruzione, lavoro, salute), che rendono fra l’altro possibile un migliore esercizio dei diritti di libertà”. La citazione di queste due frasi, scritte da Bobbio a distanza di anni, la prima nel 1942 e la seconda nel 1984, mostrano la coerenza di una vita totalmente spesa nell’affermazione della necessità imprescindibile di coniugare questi due valori come invece la storia del Novecento non ha mai saputo fare. La definizione di intellettuale data nel 1966 come di “colui che incarna o dovrebbe incarnare lo spirito critico… il seminatore di dubbi, l’eretico per vocazione” va però collegata all’altro giudizio: “bisogna saper distinguere la vocazione minoritaria da un rigido, ostinato e in fine dei conti sterile atteggiamento scismatico” e da qui la decisione di sostenere la unificazione del Partito Socialista. La scelta di non essere protagonista della vita politica attiva non ha però mai impedito a Bobbio di essere presente e partecipe, anzi punto di riferimento nel dibattito intellettuale e politico dell’ultimo trentennio. Nel 1984, il filosofo apre una forte polemica con la “democrazia dell’applauso” varata da Craxi nel Congresso di Verona e Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica, scrivendo a Valeria Cova, moglie del filosofo dice: “Glielo dica, glielo dica, i suoi giudizi sono anche i miei” e nel luglio dello stesso anno lo nomina senatore a vita. Nel 1996, il 2 giugno, esce su La Stampa l’ultimo articolo di Bobbio in qualità, come scrive lui stesso in questa Autobiografia, di “filosofo militante”. Oggi, in questo libro, si dichiara molto scettico “del nuovo per il nuovo”, dichiara la difficoltà di lettura dell’attualità politica, ammettendo anche la poca “voglia di capire” che lo accompagna. Eppure dà indicazioni su quelli che, secondo lui, sono i problemi più gravi che oggi l’Italia deve affrontare: la questione dell’amministrazione della giustizia, il sistema scolastico, i servizi. La conclusione del libro è poi un messaggio importante sempre, alla luce di quella che Bobbio definisce essere la sua “certezza del dubbio”: “La storia umana, tra salvezza e perdizione, è ambigua. Non sappiamo neppure se siamo noi i padroni del nostro destino”. Sempre in quest’opera Bobbio scrive: “In un dato momento della nostra vita – i venti mesi che separano l’8 settembre 1943 dal 25 aprile 1945 – siamo stati coinvolti in eventi più grandi di noi. Dalla totale mancanza di partecipazione alla vita politica italiana, cui ci aveva costretto il fascismo, ci siamo trovati, per così dire, moralmente obbligati a occuparci di politica in circostanze eccezionali, che sono quelle dell’occupazione tedesca e della guerra di Liberazione. La nostra vita è stata sconvolta. Tutti noi abbiamo conosciuto vicende dolorose: paura, fughe, arresti, prigionia; e la perdita di persone care. Perciò dopo non siamo più stati come eravamo prima. La nostra vita è stata divisa in due parti, un “prima” e un “dopo”, che nel mio caso sono quasi simmetriche, perché il 25 luglio 1943, quando cadde il fascismo, avevo trentaquattro anni: ero giunto nel “mezzo del cammin” della mia vita. Nei venti mesi fra il settembre 1943 e l’aprile 1945 sono nato a una nuova esistenza, completamente diversa da quella precedente, che io considero come una pura e semplice anticipazione della vita autentica, iniziata con la Resistenza, alla quale partecipai come membro del Partito d’azione. Quando dico “noi” intendo una generazione di intellettuali che, come me, ha vissuto il passaggio fra due contrapposte realtà italiane”.
CHE COSA E’ LA DEMOCRAZIA?
DOMANDA: Professor Bobbio, se la democrazia fosse tanto inflazionata nella realtà così come lo è come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale; ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell’Atene di Pericle e dei Soviet di Lenin; c’è la democrazia liberale, quella socialista, c’è la democrazia cristiana. Possiamo tentare di dare una definizione minima, ma precisa, di questo termine?
BOBBIO: Io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima della democrazia, ma che sia necessario. Se vogliamo metterci d’accordo, quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo esser tutti d’accordo. Io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale: vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive: 1) tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente; 2) la decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d’accordo per dire dove c’è democrazia e dove democrazia non c’è.
DOMANDA: Quindi si può parlare di democrazia, sia che si tratti di decidere in un condominio sia che si tratti di decidere una legge dello Stato?
BOBBIO: Ha detto benissimo: un’associazione, una qualsiasi associazione. Qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si prendono le decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcuni, anche da uno solo, l’importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole.
DOMANDA: Quando Lei dice queste cose mi viene in mente che effettivamente nel mondo esistono alcuni – forse neanche troppi – Stati democratici: ma all’interno di questi Stati democratici – penso a tutti gli apparati della produzione, gli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole alle caserme, ecc. – io non ci ritrovo molte delle due regole.
BOBBIO: Lei effettivamente ha ragione: qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che la democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore una società democratica dovrebbe essere democratica – cioè dovrebbe avere queste regole – nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà nella maggior parte delle democrazie non è avvenuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire quest’estensione delle regole democratiche? E’ la fabbrica. All’interno della fabbrica non esiste un regime democratico: le decisioni vengono prese da una parte sola, dall’altra parte c’è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese, da tutte, da tutte le parti che sono in gioco in quel in quel centro di potere.
DOMANDA: Quindi Lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione della propria vita produttiva?
BOBBIO: Io credo che questo sia l’ideale limite della democrazia.
(Tratto dall’intervista “Che cos’è la democrazia?” – Torino, Fondazione Einaudi, giovedì 28 febbraio 1985)
I NOVANT’ANNI DEL FILOSOFO
Auguri al filosofo che compie novant’anni. Questo giornale, il sottoscritto compreso, lo vuole fare anche aggiungendovi una nota di simpatia, di affetto e soprattutto di gratitudine per il dialogo che Bobbio ha avuto con i nostri lettori specialmente negli ultimi dieci anni, durante i quali ha accompagnato con i suoi ragionamenti, nei momenti alti e in quelli bassi, il cammino sofferto e niente affatto concluso della sinistra italiana verso mete peraltro ancora incerte. Ma il coro degli elogi nasconde una insidia, quella della giubilazione e della archiviazione. Lo sa bene “Bindi” in persona (ormai il nomignolo privato è stato ufficializzato da un titolo della “Stampa”) che in queste circostanze mette sempre in guardia con il dialetto della sua Torino: “Esageruma nen”. Non esageriamo. E si capisce perché lo fa. Se ti capita di diventare un “grande vecchio”, specialmente se sei una “figura carismatica della cultura” e magari anche della “sinistra” e, in fin dei conti, “dell’intero paese” il tuo sistema nervoso viene esposto a un rischio molto serio. Se sei abituato agli attacchi duri, anche ai colpi bassi e a quelli bassissimi, e se hai imparato a pararli da vero spadaccino (come Bobbio indubbiamente è, dietro quell’aria da vecchio, ultra-vecchio lamentoso), quando viene la stagione delle lodi generalizzate è istintiva una certa diffidente preoccupazione. Un rovente articolo polemico sai come affrontarlo, ma da una esaltazione scriteriata delle tue doti, chi mai ti salverà? Se appartieni alla categoria dei “grandi vecchi” gli imbarazzi più seri te li provoca la dabbenaggine dei tuoi fan (qualcuno li chiama “bobbiani”, qualcun altro spregiativamente “bobbisti”), specialmente se hai un carattere difficile e una mentalità molto esigente, come appunto il nostro festeggiato. Vogliamo vedere, per esempio, quanti scriveranno, come è stato già fatto, che Bobbio è il “Papa laico” degli italiani? In questi casi il danno è insidioso, l’iperbole provoca arrabbiature tra i cattolici, fastidio tra gli avversari, imbarazzo tra i propri cari. Insomma un disastro. Ma non c’è solo questa perturbazione psicologica, c’è anche il fatto che la celebrazione dei novant’anni rende quasi irresistibile l’idea di un bilancio dell’opera del filosofo, e magari, ahinoi!, di un bilancio politico e morale di una vita. Roba da far tremare. L’uscita di un meritorio volume riassuntivo del suo pensiero politico, a cura di Michelangelo Bovero per Einaudi, apparentemente facilita l’impresa, prima o poi inevitabile, ma in realtà la rende ancora più ardua, Come scavare una sintesi sistematica da una produzione così gigantesca? Proprio necessario? Ecco perché, nella circostanza, mi è balenata davanti l’idea di trascurare il tema dei “media” di Bobbio e di cogliere l’occasione dei novant’anni per parlare dei suoi difetti. Lasciamo dunque stare per il momento il suo contributo alla teoria democratica, le sue celebri critiche al Pci di Togliatti, le analisi dei vizi strutturali del marxismo. Trascuriamo assiduità scientifica ed accademica, rigore e continuità dell’impegno civile, chiarezza del linguaggio, limpidezza concettuale e tutta la valanga di libri e articoli che hanno fatto di Bobbio li “grande vecchio” che è e occupiamoci solo dei difetti. Tento di farne un elenco e mi accorgo che non è poi così difficile, anzi ce n’è uno che si impone e li riassume tutti: Bobbio è una persona contraddittoria. Che cosa vuol dire? Che dice e fa cose contrastanti tra loro nella vita di tutti i giorni come nella teoria e nella politica. Per esempio: Bobbio è una star dei media, anche se dice peste e corna (come Giovanni Sartori) delle aberrazioni mediatiche e scandalistiche della politica e dei giornali. Lo riconoscono per strada anche se esce ormai raramente, il tassista gli chiede l’autografo, se dice una cosa viene riferita, rimbalza in tv, sui giornali. Lo cercano tutti i giorni per un appello, per una dichiarazione, per salvare i tali o talaltri archivi, per la guerra e la pace, per il Museo egizio a Venaria, contro il Museo egizio a Venaria. Lui si lamenta in continuazione ma intanto colava il rapporto con i media in modo più professionale di una diva. Proprio così. Sincero nel lamentarsi, sincero nel concedersi, anche se con un dosaggio meditato. Sa come si confeziona una sound-byte, una battuta che diventa slogan sui giornali, quasi come sapeva fare Pertini, molto meglio di Casini, Veltroni, D’Alema, che sui media ci sono tutti i giorni, e persino di Cossiga, altro professionista della scena, E sa fare anche i titoli: vedi la celebre “utopia capovolta” dell’89. Quando Bobbio disse poi, Berlusconi in trionfo nel 1994, che la televisione è “naturaliter di destra”, sapeva benissimo di esagerare, eppure ha funzionato. E’ la sound-byte. Esce il “Libro nero sul comunismo”. Tutti si aspettano che lui dica “no, è una operazione propagandistica, la cavalca Berlusconi, vade retro.”. E invece il contrario. Il volumone di Courtois ha fatto centro, ecco la dimostrazione: dovunque il comunismo ha avuto il potere, sono state violenze, tragedie, massacri. Riecco Bobbio che occupa la scena per qualche settimana. Il “Corriere della sera” di Mieli lo accusa di tersitismo ovvero di fare il menagramo antitaliano? E lui replica: siete plebei. Di nuovo titoli. La differenza con Cossiga è che quello occupa la scena con gioia, Bobbio invece lo fa lamentandosi. Ed è sincero in tutti e due i casi, dunque contraddittorio. Ma vogliamo sondare il suo “dualismo” (scusate se vi sembra un eufemismo) anche ai piani alti della teoria e della politica? Ecco qua: Bobbio è socialista non c’è dubbio, anche se col punto di domanda “Quale socialismo?”. Eppure andatevi a vedere la sua voce “élite, teoria delle” nel Dizionario di politica e troverete squadernata la sua simpatia per gli elitisti italiani Mosca e Pareto. Sono vere tutte e due le facce del suo pensiero. Come la mettiamo? Dice bene Gustavo Zagrebelsky: Bobbio pensa e insegna a pensare per dicotomie: pubblico-privato Stato-società, libertà-giustizia, individuale-collettivo. Ma, aggiungo io, fa molto di più, entra in tutte e due i ruoli della dicotomia, la mantiene aperta, la lascia lavorare, ne prolunga l’esistenza all’infinito. Fa due parti in commedia. E insegna, non a scegliere l’uno o l’altro degli estremi, ma piuttosto a guardar gli errori di un lato stando da quell’altro e viceversa. Guarda la catastrofe del comunismo e del socialismo di stato dal punto di vista del liberalismo e dell’individualismo di Hayek e Von Mises. Implacabile. Ma poi guarda anche le miserie inegualitarie delle società liberali dal punto di vista di Marx. E non rinuncia mai al punto di vista opposto. E’ un appassionato socialista ma anche un rigoroso liberale e non rinuncia a nessun delle due visioni. Se le porta dietro. E’ come un genitore severo nell’educazione dei figli, che imponga regole di ferro e punisce la disobbedienza, ma poi si lamenti se i ragazzi non sono de ribelli, degli audaci capaci di sfidare l’ira del padre (è un esempio puramente teorico, non so proprio se, come padre, si comportato in questo modo. Questo lo dicano Luigi, Andrea e Marco. E la loro madre Valeria). Me lo immagino agli esami (non l’ho mai visto in azione come insegnante) chiedere allo studente di illustrargli i benefici della democrazia rispetto agi altri regimi e poi, ascoltate le risposte alla domanda tranello scaraventargli addosso la lista lunghissima dei vizi della democrazia: poteri occulti, corruzione, le promesse non mantenute di libertà, eguaglianza e via recriminando. Mi immagino anche il tranello opposto: mi parli delle promesse non mantenute della democrazia L’ho visto invece mettere in difficoltà gli organizzatori di un convegno dedicato al liberal-socialismo – che è dopotutto, e giustamente, uno dei modi per definire il suo pensiero politico e quindi ispirato fondamentalmente alle sue idee. Prese la parola, nell’intervento ovviamente più atteso di tutto l’incontro, per sostenere serenamente che, dopo decenni di sofferta riflessione, era giunto alla conclusione che il liberal-socialismo “non esiste”. Vani i tentativi di farlo recedere. Vogliamo andare ancora più su ai piani alti dei suoi massimi referenti filosofici? Benissimo, ci troviamo il moralismo trascendentale di Kant, ma se scaviamo, neanche poi tanto, vediamo che il padre del “dover essere” convive nella testa di Bobbio con il padre di tutti i “realisti” che è Thomas Hobbes, autore che gli è non meno caro. E, di conseguenza sulla scena delle vicende politiche, lo vedrete alternativamente tenere le parti dei rapporti di forza reali contro le ingenue pretese del “dover essere”, ma subito dopo dare addosso a chi non ha alcuna passione morale e si adagia nella contemplazione dei rapporti di forza. Hobbes contro Kant anche a proposito della guerra del Kosovo: non possiamo non essere d’accordo con gli americani per i bombardamenti Nato sulla Serbia (Hobbes). Ma provate a dirgli, come ho fatto, che questo significa allora accettare la fine di una prospettiva istituzionale universalistica (Kant) per cui il compito di intervenire tocca in linea di principio all’Onu. E lo sentirete arrabbiarsi perché se non si difende l’Onu (Kant) siamo nelle mani della pura forza, dell’Impero, del Leviatano (Hobbes).Ma provate a dirgli che allora non doveva approvare la guerra della Nato… Ecco perché quando Perry Anderson ha definito il suo pensiero “un composto chimico instabile”, tutto sommato l’idea gli è piaciuta. Finisco qui con le contraddizioni, anche se la lista dei difetti non vi sembra abbastanza esaudente e cattiva. Mi fermo anche per un’altra ragione. Non voglio che al nostro prossimo colloquio Bobbio diventi troppo diplomatico e mi guardi in cagnesco: “Non mi devo dimenticare che sei anche un giornalista” (dove “anche” sta, credo, per un apprezzamento). E poi, dopo tutto, oggi è la sua festa di compleanno. Se poi, invece, parlare dei difetti di Bobbio vi è sembrato un modo subdolo per illustrare meglio i suoi meriti, questo è un tema che affronteremo un’altra volta. Auguri.
RENE’ GIRARD

Vita
René Girard nacque ad Avignone, in Francia, nel 1923.Ha studiato a Parigi all’Ecole des Chartres in cui divenne archivista-paleografo nel 1947. Ha studiato poi negli Stati Uniti dottorandosi in storia nel 1950 all’Indiana University. Divenne “incaricato” in questa stessa università come anche nella Duke University, fu assistente al Bryn College, professore alla State University di New York (Buffalo) e al dipartimento delle lingue romanze dello John’s Hopkins University (Maryland),dal 1981 é professore di lingua, letteratura e civiltà francese alla Stanford University.
Opere:
Mensogne romantique et vérité romanesque
Pubblicò questo libro nel 1961, in esso le sue tesi rimangono circoscritte allo studio del romanzo moderno.Individua l’iter del desiderio umano attraverso una mimesi di dinamica triangolare (esso muovendosi verso l’oggetto é guidato da un mediatore, per cui l’uomo desidera sempre secondo “l’altro”).Egli studia le opere di Dostoevskij e individua già il nesso fra desiderio e religione:l’assolutizzazione del desiderio crea il sacro e la divinità.
La violence et le sacré
Nel 1972 Girard pubblica questo libro. Quest’opera attrae l’attenzione del mondo intellettuale, poiché l’autore osa criticare Lévi-Strauss e Sigmund Freud,ma anche perché con essa offre le basi di una nuova teoria della religione. Soprattutto con lo studio dei miti e dei riti, egli dà i fondamenti scientifici alle intuizioni precedenti, ossia alla dinamica del desiderio e della violenza che considera ormai come cause sempre presenti dei riti e dei sacrifici delle religioni primitive. In tal modo il ciclo della violenza trova il suo epilogo, la cultura e la società la loro fondazione e riorganizzazione sotto la protezione minacciosa del sacro inteso come proiezione della violenza. La violenza si accende per “desiderio mimetico”,per il quale nella società tutti desiderano ciò che hanno o che desiderano gli altri. All’origine della società umana Girard individua infatti un assassinio sacrificale e alla vittima sacrificale vengono riconosciuti attributi divini e sacrali, proprio perchè la sua uccisione funge da mezzo per sopire la violenza. Scaricando su un capro espiatorio la violenza che oppone ciascuno a tutti gli altri, placa i conflitti interpersonali e fonda il vincolo sociale. Il sacro assume quindi grande valore di coesione e la religione è quindi “il sentimento che la collettività ispira ai suoi membri, ma proiettato fuori dalle coscienze che lo provano, e oggettivato”. La religione è quindi un insieme di simboli e riti che hanno per contenuto fondamentale i valori di fondamento della società.
Des choses cacheés depuis la fondation du monde
A questo punto l’autore si trova pronto ad ampliare la sua teoria in direzione del giudeo-cristiano e persino di tutta la cultura. Questo libro, pubblicato nel 1978 sotto forma di interviste fatte dai due ricercatori psichiatri J. Michel Oughourlian e Guy Lefort, suscita subito un grande clamore. In quest’opera di antropologia fondamentale, l’autore, riprendendo la sua teoria precedente, si spinge verso le cose ultime nascoste “fin dalla creazione del mondo”, custodite dalla parola biblica, ma rese di difficile lettura a causa delle interpretazioni precedenti ove, evidentemente per lui, ha operato una certa forma di meccanismo vittimario. Leggendo i Vangeli non più come una storia sacrificale, Girard dimostra che soltanto la rivelazione cristiana, svelando il meccanismo del capro espiatorio, rivela la radice unica del sociale, del religioso e del sacro, nonché la loro natura.
Le bouc émissaire
Pubblicato nel 1982, non aggiunge nulla di nuovo alla sua teoria. In questo libro l’autore dimostra che quel misconoscimento che permetteva la designazione del capro espiatorio, inizia a non funzionare più.La vittima, uscendo dalla sua passività, proclama la sua innocenza e “diventa l’Agnello di Dio”. In tal modo anche l’uomo diventa il solo responsabile della violenza, il sacro trova la sua immanenza e Dio la sua vera trascendenza.
La route antique des hommes pervers
L’opera è stata pubblicata nel 1985 e vi è un’attenta analisi del libro di Giobbe, nel quale trova conferma alle sue teorie.
Girard individua il concetto mimetico-rivale della violenza nell’ uomo e nella società (la violenza diventa per contagio “mimetismo di folla”). Cristo è delineato come vittima perfetta ed innocente che, rivelandosi attraverso il logos di Dio, sta dalla parte delle vittime.
Premessa
Girard resta soprattutto legato ad un tentativo che si autodefinisce come un’ipotesi di antropologia generale razionalisticamente protesa ad una ‘spiegazione’ unitaria dell’insieme dei comportamenti dell’umanità, vale a dire una ‘reinterpretazione globale’ ove concorrono letteratura, etnologia e psicologia. Credo infatti che se Girard suscita interesse nella cultura contemporanea è proprio per il suo approccio antropologico allo studio della religione e per la sua nuova interpretazione del sacrificio elaborata coniugando teorie diverse.
Questo, spero, giustificherà il seguente studio, guidato da un interesse esclusivo per l’interpretazione girardiana del sacrificio e per il suo approccio alla religione sul versante dell’antropologia socio-culturale. In esso: una breve e volutamente parziale sintesi della sua interpretazione del sacrificio (§ 1), parti dedicate agli studiosi – Durkheim e Freud – che più hanno pesato sulla sua formazione ai quali esplicitamente si richiama ma dai quali anche si distacca (§ 2, § 3) e una a Burkert che si è occupato del sacrificio cruento e a cui è interessante accostare la teoria girardiana (§ 4), in vista di un approfondimento della metodologia che lo studioso francese ha adottato nell’indagine dei fenomeni religiosi e dell’alternativa fenomenologica alla lettura sociologico-funzionalista presentata da Girard (§ 5).
§ 1. L’interpretazione girardiana del sacrificio
1.1.Una nuova teoria del religioso
Girard porta il fenomeno religioso, punto sia di partenza che di arrivo della sua ricerca, al centro dell’interesse dell’antropologia contemporanea. Egli sviluppa una nuova e ‘rivelatrice’ teoria sulla religione essenzialmente in quattro opere legate da un rapporto molto stretto.
Nel 1961 ha pubblicato un primo volume di saggi letterari, Menzogna romantica e verità romanzesca,1 ove le sue tesi non rivelano ancora tutto il loro aspetto innovativo in quanto circoscritte allo studio del romanzo moderno. Nel libro è fondamentale l’intuizione (di antropologia e psicologia interindividuale) che il desiderio umano è sempre mimesis (imitazione): il desiderio è ‘triangolare’, per cui tra il soggetto desiderante e l’oggetto desiderato esiste un mediatore che indica gli oggetti da desiderare. Tutti i comportamenti, quelli individuali, quelli sociali e quelli dell’intera cultura umana, possono essere ricondotti al triangolo del desiderio. Lo stesso desiderio diventa poi principio di critica letteraria che consente di delineare una storia della letteratura: quest’ultima consente di leggere le grandi tappe della storia moderna e poi dalla storia alla metafisica che vi sta dietro e rivela che le assolutizzazioni dei desideri degli uomini sono diventate dèi. Solo dieci anni dopo, quando nel 1972 esce La violenza e il sacro2, il mondo intellettuale si interessa di Girard, sia perchè osa criticare pensatori come Freud e Lévi-Strauss, sia perché getta le basi di una nuova teoria del religioso. Girard, che aveva già teorizzato che il desiderio fa nascere un altro desiderio e una violenza fa nascere un’altra violenza, ora mostra come, per liberarsi da questo circolo vizioso, siano nate le istituzioni religiose tradizionali e soprattutto il sacrificio. E’ in questa seconda importante opera, che contiene il nucleo fondamentale del suo pensiero, che egli descrive il meccanismo della vittima espiatoria per mezzo del quale, potendo la violenza cambiare direzione e sfogarsi su un oggetto di ricambio, la società si libera dalla violenza. In Francia il pensiero girardiano diventa oggetto di discussione vivace e contraddittoria solo nel 1978, quando viene pubblicato Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo3, un grosso volume di interviste rilasciate a discepoli ed amici, in cui Girard riprende tutta la sua precedente teoria e dimostra che solo la rivelazione cristiana permette di svelare la natura del sociale, del religioso, della violenza primitiva. Nel suo libro del 1982, Le bouc émissaire,4 non aggiunge nuovi elementi sostanziali alla sua teoria: la verità del mito viene confermata con la verità dei testi di persecuzione, i quali iniziano a demistificare gli schemi sacrificali in quanto la storia dell’Occidente si è sviluppata da un testo (il testo della rivelazione giudeo-cristiana) che contiene le verità decisive sui desideri dell’uomo e sui meccanismi della violenza. La Bibbia contraddice la religione sacrale sul punto limitato ma essenziale che la vittima è innocente, per cui il misconoscimento che permetteva la designazione della vittima espiatoria non può più funzionare: Dio ritorna nella sua trascendenza e l’uomo ridiventa il solo responsabile della violenza. Questo scritto si presenta quindi come un’ulteriore postilla esplicativa all’ipotesi mimetica e al tentativo, che aveva già compiuto, di estenderla alla spiegazione della genesi di ogni ordine sociale e culturale.
1.2. I1 sacrificio
Girard ritiene che 1’azione sacrificale sia necessariamente ‘misteriosa’, sottoposta cioè ad un misconoscimento: i fedeli non conoscono e nemmeno devono conoscere il ruolo che nei sacrifici è svolto dalla violenza. Si rivela perciò necessario, come primo passo, “ritrovare i rapporti conflittuali che il sacrificio e la sua teologia dissimulano”5. Girard propone un’interpretazione del sacrificio come “violenza di ricambio”: cita gli antropologi Lienhardt e Turner che, a seguito di ricerce sul campo, riconoscono nel sacrificio “una vera e propria operazione di transfert collettivo che si effettua a spese della vittima e che investe le tensioni interne”6. Per delineare tale rapporto sacrificio/violenza lo studioso francese introduce il fondamentale concetto di vittima sostitutiva: poiché per spiegare il sacrificio sia le osservazioni fatte sul campo sia la riflessione teorica inducono a rifarsi all’ipotesi della sostituzione sacrificale che ha lo scopo di “ingannare la violenza”7, Girard si chiede se “il sacrificio rituale non sia fondato su una sostituzione” per allontanare la violenza “da certi esseri che si cerca di proteggere”8. Alcuni sistemi rituali sostituiscono gli esseri umani minacciati dalla violenza con animali, altri sistemi li sostituiscono invece con altri esseri umani giacché “in fondo non c’è nessuna differenza essenziale tra sacrificio umano e sacrificio animale”9. Per avvalorare la tesi della sostituzione uomo-animale Girard cita come esempio la religione dei Nuer e dei Dinkal0; per quella della sostituzione uomo-uomo cita invece la Grecia del V secolo e riporta la Medea di Euripide. Una volta poste le vittime umane e quelle animali sullo stesso piano chiaramente vanno poi ricercati i criteri in base ai quali si effettua la scelta di una qualsiasi vittima. Emerge che tutte le vittime “devono somigliare a coloro che esse sostituiscono”l1 e vanno scelte in base ai criteri di “piena appartenenza alla società” e di “vendetta”. A questo secondo principio Girard dedica ampio spazio e giunge a definire il sacrificio come “una violenza senza rischio di vendetta”l2, in quanto dalla documentazione analizzata ricava che si usano sempre persone o animali ‘non vendicabili’.
La vendetta costituisce una minaccia insopprimibile, è “un processo infinito, interminabile”. Girard classifica in tre categorie tutti i mezzi messi in atto dagli uomini per proteggersi da una vendetta interminabile: i mezzi preventivi, gli impedimenti alla vendetta, il sistema giudiziario. Tutti codesti procedimenti, che permettono agli uomini di moderare la loro violenza, presentano delle analogie: in quanto nessuno di loro è estraneo alla violenza si può riconoscere “l’identità positiva della vendetta, del sacrificio e della penalità giudiziaria”l3. Finché non si crea un organismo che possa sostituirsi alla parte lesa e riservarsi la vendetta sussiste però “il pericolo di una escalation interminabile”. Nei popoli primitivi, per i quali non esiste un sistema giudiziario, è il sacrificio ad aiutare a tenere a bada la vendetta: il sacrificio è perciò, nella lotta contro la violenza, uno strumento di prevenzione che “polarizza le tendenze aggressive su vittime reali o ideali, animate o inanimate, mai suscettibili comunque di essere vendicate”l4. In queste società l’accento cade sulla prevenzione poiché i mali che la violenza rischia di scatenare sono molto grandi e i rimedi aleatori: e la sfera del preventivo è anzitutto quella religiosa. Il religioso mira sempre a placare la violenza e ad impedirle di scatenarsi; e poiché la prevenzione religiosa spesso può assumere un carattere violento, Girard conclude che violenza e sacro sono inseparabilil5. Ma il sacrificio come prevenzione della violenza decade là ove si istituisce un sistema giudiziario anche se, chiaramente, può venir praticato ancora a lungo ma allo stato di forma pressoché vuota. Girard sottolinea che generalmente noi incontriamo il sacrificio a questo stadio e di conseguenza riteniano che le istituzioni religiose non abbiano alcuna funzione reale: “poiché minimizziamo il pericolo della vendetta noi non sappiamo a che cosa possa servire il sacrificio”16, non riusciamo cioè a conoscerne la funzione. Solo quando l’intervento di un’autorità giudiziaria diventa costrittivo gli uomini si liberano dal tremendo dovere della vendetta, anche se nel sistema penale in realtà non vi è alcun principio di giustizia che differisca da quello di vendettal7. I1 sistema giudiziario riesce a razionalizzare, a suddividere, a limitare, a manipolare la vendetta, senza pericolo: non esita mai a colpire in pieno la violenza perché su di essa possiede un monopolio assoluto18. Ma poi, nel suo sviluppo, l’intervento giudiziario perde il carattere di “terribile urgenza” e se il suo significato rimane lo stesso può però offuscarsi e persino scomparire del tutto: in realtà il sistema funziona meglio se si perde coscienza della sua funzione19. Poiché esigiamo un rapporto diretto tra la colpevolezza e la punizione noi crediamo di cogliere una verità che sfugge ai primitivi, mentre siamo invece noi a non comprendere la minaccia, molto reale nel mondo primitivo, della escalation della vendetta20. Una società primitiva, che è esposta ad un tale aumento progressivo della vendetta, si vede costretta ad adottare nei confronti di questa violenza certi atteggiamenti per noi incomprensibili: e di qui il grande valore del sacrificio. Il rituale ha pertanto la funzione di purificare la violenza, cioè di ingannarla e di dissiparla su vittime che non rischiano di essere vendicate21. Sul piano della violenza troviamo l’identità del male e del rimedio: ma gli uomini non riescono a comprendere tale dualità, hanno bisogno di distinguere la buona violenza da quella cattiva, vogliono ripetere senza tregua la prima per eliminare la seconda. Pertanto per essere efficace la violenza sacrificale deve assomigliare il più possibile alla violenza non sacrificale.
1.3.La crisi sacrificale
Il sacrificio esige perciò che vi sia un’apparenza di continuità tra la vittima realmente immolata e gli altri esseri umani a cui tale vittima viene sostituita22. Talvolta si assiste però al rovesciamento catastrofico del sacrificio: ad esempio, il vero tema della Follia di Eracle di Euripide – dove Eracle in un momento di follia mentre offre un sacrificio uccide la sua prima moglie Megara ed i figli – è il fallimento di un sacrificio, è la violenza sacrificale che prende una brutta piega. Il sacrificio attira la violenza sulla vittima e poi la lascia spandersi tutt’attorno: il sacrificio allora non è più atto a svolgere il proprio compito, ma ingrossa il torrente della violenza impura senza riuscire nemmeno più a canalizzarla. Anche nelle Trachinie di Sofocle, nell’episodio della tunica di Nesso inviata alla giovane Iole da Deianira per riconquistare l’amore del marito Eracle, la violenza si scatena contro quegli stessi esseri che il sacrificio avrebbe dovuto proteggere. In entrambe le opere un’impurità particolare è legata al guerriero che rientra nella città, ebbro ancora delle carneficine alle quali ha da poco partecipato: i1 guerriero che torna a casa rischia di portare la violenza di cui è impregnato all’interno della comunità. Se si esamina attentamente il meccanisno della violenza nelle due tragedie ci si accorge che il sacrificio quando ‘prende una brutta piega’ provoca una reazione a catena23. I1 ritorno del guerriero si lascia interpretare in termini sociologici o psicologici: le due tragedie ci presentano così in forma quasi aneddotica fenomeni che non hannno senso se non a livello dell’intera comunità24. Con la nozione di crisi sacrificale si possono pertanto chiarire certi aspetti della tragedia che evoca la crisi sacrificale soltanto attraverso figure leggendarie i cui contorni sono fissati dalla tradizione. La disputa tragica è una disputa senza soluzione: “la tragedia è l’equilibrio della bilancia della violenza, non della giustizia”25. Tra gli antagonisti tragici non vi sono differenze perché vengono cancellate dalla violenza: ciascuno ricorre alle stesse tattiche, usa gli stessi metodi e mira alla distruzione del proprio avversario, contribuendo così tutti alla distruzione di quell’ordine che tutti pretendono di consolidare26.
Nella religione primitiva e nella tragedia opera lo stesso principio, sempre implicito ma fondamentale, che l’ordine e la pace27 riposano sulle differenze culturali. Non sono le differenze, ma è la loro perdita a provocare una rivalità e una lotta incontrollabili tra gli uomini di una stessa società. La crisi sacrificale, ossia la perdita del sacrificio, si definisce come crisi delle differenze, cioè dell’ordine culturale (che non è che un sistema organizzato di differenze) nel suo insieme. Una volta perduta tale differenza si perde pure quella fra violenza impura e violenza purificatrice e allora non esiste più purificazione possibile e la violenza impura, che è contagiosa, si diffonde nella comunità28. Anche la tragedia, che si radica in una crisi del rituale e di tutte le differenze, parla quindi della distruzione dell’ordine culturale. Essa può aiutarci nella comprensione di tale crisi e di tutti i problemi, da essa inseparabili, della religione primitiva che ha sempre l’unico scopo di impedire il ritorno della violenza reciproca: la tragedia fornisce dunque una via di accesso privilegiata ai grandi problemi dell’etnologia religiosa29. Contrariamente a quanto accade nel pensiero moderno, per il pensiero primitivo l’assimilazione della violenza alla non-differenziazione è un fatto immediatamente evidente. Girard analizza uno dei fenomeni religiosi più spettacolari sul piano dell’etnologia religiosa: il fatto che in numerose società primitive i gemelli ispirano uno straordinario terrore30. Ma non c’è da stupirsi che i gemelli facciano paura, poiché essi sembrano annunciare la violenza indifferenziata, cioè il pericolo maggiore per qualunque società primitiva. Anche gli esempi mitologici, letterari, storici, sono quasi tutti esempi di conflitto: la presenza di fratelli nemici in certi miti greci e nelle tragedie ci suggerisce una presenza costante della crisi sacrificale riportata con unico stesso meccanismo simbolico31. Girard, che considera i miti come delle riletture a ritroso fatte a partire dall’ordine culturale nato dalla crisi, ritiene che nei miti le tracce della crisi sacrificale siano però più difficilmente decifrabili che nella tragedia. In essa, spiegazione sempre parziale dei motivi mitici, il poeta fa invece rinascere la reciprocità violenta: tutto diventa antagonismo nel tentativo di riequilibrare ciò che il mito rende squilibrato. La tragedia, diffondendo e moltiplicando la violenza all’infinito, riconduce tutti i rapporti umani all’unità di uno stesso antagonismo tragico, tendendo così a dissolvere i temi del mito nella loro violenza originaria: la tragedia è strettamente legata alla violenza, è “figlia della crisi sacrificale”32.
1.4.La vittima espiatoria
Per delineare la figura della vittima espiatoria Girard analizza il mito di Edipo attraverso l’analisi della tragedia Edipo re di Sofocle.
Nella tragedia l’ira è presente ovunque: non è Edipo ad avere il monopolio dell’ira, giacché non vi sarebbe disputa tragica se anche gli altri protagonisti non andassero in collera. Le loro ire seguono quelle dell’eroe solo con un certo ritardo, per cui si è tentati di riconoscere in loro “giuste rappresaglie, ire seconde e perdonabili rispetto all’ira prima e imperdonabile di Edipo. Ma l’ira di Edipo è sempre preceduta e determinata da un’ira anteriore. E nemmeno questa è veramente originaria”33. La sola differenza tra Edipo e i suoi avversari sta nel fatto che Edipo, poiché è il primo ad entrare in gioco nella tragedia, è sempre in anticipo sugli altri. Ciascuno si crede capace di padroneggiare la violenza mentre in realtà è la violenza che trascina successivamente tutti i protagonisti inserendoli, sebbene inconsapevoli, nel gioco di quella reciprocità violenta a cui credono sempre di sfuggire. I protagonisti della tragedia si riducono tutti all’identità di una stessa violenza e sono ugualmente responsabili poiché tutti partecipano alla distruzione dell’ordine culturale; ognuno vede nell’altro l’usurpatore di una legittimità che crede di difendere ma che in realtà non smette di indebolire34.
Il mito non pone però esplicitamente il problema della differenza ma lo risolve tramite il parricidio e l’incesto. Nel mito non si parla infatti di identità e di reciprocità tra Edipo e gli altri: di Edipo si può affermare però almeno una cosa che non è valida per nessun altro e cioè che egli solo è colpevole del parricidio e dell’incesto. Queste colpe si presentano come un’eccezione così mostruosa che Edipo non assomiglia a nessuno e nessuno assomiglia ad Edipo: ma la sua caduta non è una mostruosità eccezionale, bensì è il risultato della sconfitta nello scontro tragico35. Sono pertanto il parricidio e l’incesto a completare il processo dell’indifferenziazione violenta. In primo luogo il parricidio è l’instaurazione della reciprocità violenta tra padre e figlio, è la trasformazione del rapporto paterno in fraternità conflittuale. Assorbendo persino il rapporto tra padre e figlio la reciprocità violenta non lascia più nulla fuori del suo raggio: assorbe quel rapporto facendone una rivalità non per un oggetto qualsiasi ma per la madre, vale a dire per l’oggetto più formalmente riservato al padre e più rigorosamente vietato al figlio. In secondo luogo anche l’incesto è una violenza estrema che distrugge la differenza principale entro la famiglia36. Il parricidio e l’ incesto acquisiscono quindi il loro significato soltanto entro la crisi sacrificale e in relazione ad essa: entrambi mascherano più che chiarire la crisi sacrificale. I delitti di Edipo significano la fine di ogni differenza ma diventano, per il fatto di essere attribuiti ad un individuo particolare, una nuova differenza, la mostruosità del solo Edipo. Alla violenza reciproca ovunque diffusa il mito sostituisce la tremenda trasgressione di un individuo unico, Edipo, che è il responsabile per eccellenza delle sventure della città: il suo ruolo è quello di un vero e proprio capro espiatorio umano. Una sola vittima può pertanto sostituirsi a tutte le vittime potenziali: tutti i rancori sparsi su tanti individui differenti convergono così su un unico individuo, sulla vittima espiatoria. Quanto siano sottovalutati gli effetti della violenza collettiva37 ci è mostrato dalla presenza del mito edipico in tempi e luoghi differenti, dal carattere imprescrittibile dei suoi temi, dal rispetto quasi religioso di cui la cultura moderna continua a circondarlo. I1 meccanismo della violenza reciproca può essere descritto come un circolo vizioso in termini di vendetta e di rappresaglia dal quale la comunità, una volta inseritasi, non è più in grado di uscire. Finché entro la comunità vi è un capitale di odio e di diffidenza accumulati, gli uomini continuano ad attingervi: ciascuno si prepara contro l’aggressione probabile del vicino e interpreta i suoi preparativi come la conferma delle sue tendenze aggressive.
Alla violenza va riconosciuto un carattere mimetico di intensità tale che la violenza non potrebbe morire da sé una volta innestata nella comunità. Gli uomini tendono a convincersi che uno solo di loro è responsabile di tutta la mimesis violenta, che in lui si trova la macchia che li contamina tutti: distruggendo la vittima espiatoria gli uomini crederanno allora possibile sbarazzarsi del loro male ed effettivamente se ne libereranno poiché tra loro non ci sarà più la violenza fascinatrice. Girard ritiene che noi moderni concediamo invece solo un’importanza minima al meccanismo della vittima espiatoria, poiché essa dissimula agli uomini la verità della loro violenza38; egli sente la violenza come qualcosa di ‘comunicabile’. Per guarire la città bisogna identificare ed allontanare l’essere impuro la cui presenza contamina tutta la città: è cioé necessario che tutti si mettano d’accordo sull’identità di un unico colpevole e sono il parricidio e l’incesto a procurare alla comunità ciò di cui essa ha bisogno per cancellare la crisi sacrificale39.
La funzione del sacrificio descritta da Girard richiede “il fondamento della vittima espiatoria, ossia dell’unanimità violenta; nel sacrificio rituale la vittima realmente immolata svia la violenza dai suoi oggetti naturali che si trovano all’interno della comunità. Ma a chi è sostituita questa vittima?”40. La vittima rituale non è mai sostituita né a un membro della comunità né alla comunità intera, ma viene sempre sostituita alla vittima espiatoria. Poiché tale vittima viene sostituita a tutti i membri della comunità, la sostituzione sacrificale svolge proprio il ruolo che già le è stato attribuito: tramite la vittima espiatoria protegge tutti i membri della comunità dalle loro rispettive violenze. La violenza originaria è unica e spontanea, mentre i sacrifici rituali sono invece molteplici e ripetuti41. I1 sacrificio rituale è pertanto fondato su una duplice sostituzione: la prima, che non si scorge mai, è la sostituzione di tutti i membri della comunità a uno solo e poggia sul meccanismo della vittima espiatoria; la seconda, la sola propriamente rituale, si sovrappone alla prima e sostituisce alla vittima originaria una vittima appartenente a una categoria sacrificale. Va messo in evidenza che la vittima espiatoria è interna alla comunità mentre la vittima rituale è esterna. Riconosciamo infine il carattere fondamentalmente mimetico del sacrificio rispetto alla violenza fondatrice42: la violenza, per conservare la sua efficacia, deve affascinare e perciò nel rito la violenza reale persiste ancora, anche se esso è essenzialmente orientato verso l’ordine e la pace. Persino i riti più violenti mirano realmente a scacciare la violenza, in quanto se i riti sono violenti si tratta sempre di mettere in atto una violenza minore a baluardo di una violenza peggiore; i riti cercano sempre di riallacciarsi alla pace più grande che la comunità conosca, quella che dopo l’uccisione risulta dall’unanimità attorno alla vittima. Il rito è possibile perché gli uomini fanno sempre una differenza entro la violenza: il rito elegge una certa forma di violenza come ‘buona’ e necessaria all’unità della comunità, contrapposta ad un’altra violenza che rimane ‘cattiva’ perché resta assimilata alla cattiva reciprocità.
1.5. La ripetizione rituale
Analizzando il fenomeno religioso Girard si imbatte continuamente in due fondamentali componenti, il mito e il rito, delle quali è importante riuscire a conoscere il rapporto che le lega. Due sono le tesi che gli studiosi contrappongono: una riconduce il rituale al mito43, l’altra riconduce il mito al rituale44. L’ipotesi storico-genetica secondo cui “il mito dipende dal rito” o, più ampiamente, i miti sono intimamente associati ai rituali, ove si tende chiaramente a privilegiare il rito nei confronti del mito, è stata abbozzata da Robertson Smith45 ed ottiene poi ampi consensi quando viene accettata dal Frazer e assunta come presupposto fondamentale del Ramo d’oro46. A favore di questa teoria si schierano poi classicisti47, storici delle religioni del vicino Oriente48 e antropologi49. A proposito di questo rapporto mito-rito Girard riporta la tesi di Hubert e Mauss che “riconduce al rituale non solo i miti e gli dèi ma, in Grecia, anche la tragedia e le altre forme culturali”50. I1 sacrificio appare quindi a Hubert e Mauss51 come l’origine di tutto il religioso, per cui i due antropologi non ritengono necessario interessarsi né dell’origine né della funzione del sacrificio. Si dedicano invece alla descrizione sistematica dei sacrifici dalla quale emerge che la somiglianza dei riti nelle diverse culture che praticano il sacrificio è stupefacente e che le variazioni da cultura a cultura non sono mai sufficienti per compromettere la specificità del fenomeno. Girard critica quella che definisce come ‘posizione rinunciataria’ dei contemporanei che accettano la tendenza prefigurata da Hubert e Mauss di descrivere il sacrificio al di fuori di ogni cultura particolare, come se si trattasse di una specie di tecnica52 e non si preoccupano più né di riferire il rituale al mito né il mito al rituale. Girard rimpiange la curiosità dei predecessori perché “non basta dichiarare formalmente inesistenti certi problemi con una benedizione puramente ‘simbolica’, per insediarsi, senza incontrare opposizioni, nella scienza. La scienza non è una soluzione di ripiego rispetto alle ambizioni della filosofia, una saggia rassegnazione. E’ un’altra maniera di soddisfare quelle ambizioni”53. Si rallegra invece del fatto che di tanto in tanto si levi però una voce, cita ad esempio quella di Jensen, a ricordare la stranezza di un’istituzione quale il sacrificio, dal momento che “ci saranno volute esperienze particolarmente sconvolgenti per portare l’uomo a introdurre nella sua vita atti tanto crudeli. Quali ne furono i motivi? … Il pensiero mitico ritorna sempre a ciò che è accaduto la prima volta, all’atto creatore, ritenendo a giusto titolo che è quello a fornire su un dato fatto la testimonianza più viva”54.
Allontanandosi dalla ‘rinuncia’ di Mauss e avvicinandosi a Jensen nel ritenere importante stabilire ciò che è accaduto la prima volta, Girard approfitta per specificare ulteriormente la sua tesi fondamentale. Innanzitutto crede che a questo punto sia obbligatorio chiedersi se “la prima volta non sia realmente accaduto qualcosa di decisivo. Bisogna ricominciare a porre le domande tradizionali in un quadro rinnovato dal rigore metodologico dei nostri tempi”55. Se esiste un’origine reale che i miti non smettono di rammentare e che i rituali non smettono di commemorare, deve trattarsi di un evento che ha fatto sugli uomini un’impressione che, sebbene sia cancellabile dal momento che essi finiscono per dimenticarla, è tuttavia molto forte. La molteplicità delle “commemorazioni rituali che consistono in una condanna a morte fa pensare che l’evento originario sia di norma un’uccisione”56. Un pò ovunque si ritrovano tracce della tesi che fa del rituale l’imitazione e la ripetizione di una violenza unanime e in realtà basta porla in evidenza per chiarire nelle forme rituali e mitiche certe analogie che passano spesso inosservate: spicca ad esempio che in uno straordinario numero di sacrifici deve essere soddisfatta l’esigenza di partecipazione collettiva, perlomeno sotto forma simbolica57. La considerevole uniformità dei sacrifici fa inoltre pensare che si tratti proprio dello “stesso tipo d’uccisione in tutte le società”58. La soluzione proposta da Girard è, ancora una volta, rintracciabile nella crisi sacrificale e nel meccanismo della vittima espiatoria. E’ a questo punto che si presenta nuovamente allo studioso francese l’occasione di delineare ancora piu chiaramente la sua posizione funzionalista: benché il religioso sia l’unica istituzione sociale di cui la scienza non sia mai riuscita ad individuare l’autentica funzione, egli identifica la funzione del religioso nel perpetuare o nel rinnovare gli effetti del meccanisno della vittima espiatoria, ossia nel mantenere la violenza fuori dalla comunità. Girard pensa che la violenza contro la vittima espiatoria potrebbe essere fondatrice nel senso che, ponendo fine al circolo vizioso della violenza, avvia un altro circolo vizioso, quello del sacrificio rituale, che potrebbe essere proprio quello dell’intera cultura. Tutti i miti d’origine che si rifanno all’uccisione di una creatura mitica affermano, anche se non apertamente, che la violenza fondatrice costituisce realmente l’origine di tutto ciò che gli uomini tendono maggiormente a preservare: è una violenza dunque ad essere indicata come la fondatrice dell’ordine culturale59. L’individuazione del meccanismo della vittima espiatoria permette di comprendere che i sacrificatori mirano allo scopo di riprodurre il più esattamente possibile il modello di una crisi anteriore che si è risolta grazie al meccanismo della vittima espiatoria. Tutti i pericoli che minacciano la comunità vengono assimilati alla crisi sacrificale, il pericolo più terribile che possa affrontare una società. “Il rito è la ripetizione di un primo linciaggio spontaneo che ha riportato l’ordine nella comunità perchè ha ricreato contro la vittima espiatoria e attorno ad essa l’unità perduta nella violenza reciproca”60 .
Fra gli esempi portati da Girard al fine di avvalorare la sua tesi interessante è quello sui sacrifici animali. Poichè ritiene che non ci sia differenza essenziale tra il sacrificio umano e il sacrificio animale, Girard pensa che anche il sacrificio animale possa definirsi come mimesi di un omicidio collettivo fondatore. Allo scopo di mostrare che anche un sacrificio animale ha per modello la morte di una vittima espiatoria si rivolge a una società in cui il sacrificio è ancora vivo ed “è stato descritto da un etnologo competente”61. Lo studioso francese si riferisce a Lienhardt che ha dettagliatamente descritto parecchie cerimonie sacrificali osservate tra i Dinka e che “definisce la vittima come scapegoat, un capro espiatorio che diviene il veicolo delle passioni umane”62: “è nel momento immediatamente precedente la morte fisica della bestia, quando l’ultima invocazione risuona più alta e la lancia viene conficcata più in profondità, che quelli che partecipano alla cerimonia sono più chiaramente membri di un solo corpo indifferenziato, tesi ad un unico scopo comune. Dopo l’uccisione della vittima i loro caratteri individuali, le loro differenze personali e familiari e le diverse esigenze e diritti pertinenti al loro status appaiono di nuovo chiaramente”63. L’etnologo in questo passo, descrivendo il sacrificio Dinka, intendeva delineare le fasi di aggregazione e di segmentazione che caratterizzano la maggior parte dei rituali: gli individui e i gruppi si riuniscono per rappresentare un rituale durante il quale abbandonano gradualmente il loro senso di identità separata per sentirsi parte di una più vasta totalità sociale unita da legami di parentela, di commensalità, di scopo comune. Lienhardt osserva che il momento in cui finisce l’aggregazione e comincia la fase di segmentazione è quello in cui la vittima viene uccisa e la sua carne divisa: la segmentazione sociale coincide con la divisione sacrificale della carne, mentre l’aggregazione fa riferimento ad una vittima intera che contiene già nel suo corpo la potenzialità di essere divisa in pezzi differenti. Anche Girard sottolinea “l’esigenza di partecipazione collettiva, perlomeno sotto forma simbolica”64 dei rituali e conclude che la funzione del sacrificio “non solo permette ma richiede il fondamento della vittima espiatoria, ossia dell’unanimità violenta”65. La funzione essenziale del rito consiste nell’evitare il ritorno della crisi sacrificale e nel convertire la violenza ‘cattiva’ e ‘contagiosa’ in valori culturali positivi: “il rito elegge una certa forma di violenza come ‘buona’, palesemente necessaria all’unità della comunità, di fronte a un’altra violenza che rimane ‘cattiva’ perché resta assimilata alla cattiva reciprocità”66.
Dunque Girard individua uno speciale rapporto fra rito e mito, un rapporto in funzione del quale l’azione rituale è interpretata come ripetizione, rinnovamento, ricostituzione di un modello prototipico. L’atto sacrificale diventa ripetizione rituale di sacrificio: in tal senso il rituale sacrificale di tipo ripetitivo potrebbe rientrare nei riti di rifondazione di beni ed istituti culturali, nella misura in cui il sacrificio costituisce un istituto che conserva e garantisce una struttura culturale67. E’ invece del tutto assente l’aspetto del ricordo, della commemorazione, della memoria: è costante l’oblio dei meccanismi costitutivi del sacro, nascosti dalla testualità mitica e dai comportamenti sacralizzati. I testi mitico-religiosi, i racconti delle gesta eroiche dei fondatori, i riti studiati dall’etnologia, sono l’ambito in cui la verità nascosta del meccanismo fondatore è presente ma non del tutto chiara, poiché viene occultata dalla necessità stessa del suo funzionamento. Il polarizzarsi della violenza collettiva su una vittima espiatoria68 dà vita ad un sistema di rappresentazione articolato in miti e riti con strategie che saranno poi prolungate anche nel lavoro e nella scienza. “La ‘rottura epistemologica’ ci permette di non riconoscere nel rito il nostro educatore di sempre, il primo e fondamentale modo d’esplorazione e di trasformazione del reale”69. Se il meccanismo della vittima vuole avere successo deve dissimularsi: la verità del capro espiatorio (la sua innocenza) è sovversiva in quanto presenta l’inerme e dilacerato corpo della vittima come mezzo per attuare la riconciliazione del gruppo sociale.
§ 2. L’eredità di E. Durkheim
Nell’approccio al fenomeno religioso Girard è debitore della tradizione dell’indirizzo sociologico francese che difficilmente può venir separato da E. Durkheim, orientato ad una ‘spiegazione’ del religioso entro il quadro sociale. Ecco in breve i punti di contatto e di distacco.
La fondazione positivistica delle scienze sociali operata da Durkheim ha influenzato profondamente una delle più importanti tradizioni della sociologia contemporanea. Il presupposto principale da cui Durkheim parte consiste nella convinzione che, ontologicamente, i fatti sociali sono ‘cose’ e quindi simili ai fatti naturali, per cui il mondo sociale presenta un’oggettività che può venir indagata col metodo scientifico. Postulando tale ‘oggettività’ Durkheim è convinto che si possono scoprire gli effettivi processi della società e che, in tale compito, lo scienziato sociale deve dascrivere i fatti sociali e le loro reciproche relazioni come se gli fossero estranei, ossia eliminando tutto ciò che possa inerire alla propria soggettività. Pertanto l’attività scientifica che ha per oggetto la società si presenta come indipendente dalla società stessa e tale indipendenza è il presupposto fondamentale per individuare le leggi della società. Questa è anche la posizione di Girard che con la sua ‘nuova’ teoria sul religioso ritiene di essere in grado di proporre una ‘spiegazione’ oggettiva e può pertanto essere accostata ad un tentativo complesso di critica della ideologia ‘religiosa’ nello studio dei fenomeni religiosi.
Un altro aspetto dell’eredità durkheimiana in Girard. Durkheim ha affermato che la sociologia è una scienza dello stesso tipo delle altre, il cui fine ultimo è la scoperta di relazioni generali fra i fenomeni: questa capacità di non dissociare il lavoro pratico da quello teorico, di mettere l’osservazione al servizio della spiegazione, è il frutto più prezioso dell’ ‘origine filosofica’ della sociologia francese. Kroeber aveva attribuito all’origine filosofica della sociologia francese la sua ripugnanza alla ricerca sul terreno e le aveva rimproverato di basarsi su concetti falsamente generali, come quello di ‘dono’ o di ‘sacrificio’, in realtà attinti dal senso comune. Quando Kroeber paragona Mauss che utilizza concetti come ‘dono’ o ‘sacrificio’ ad un fisico che si accontenti di nozioni della vita quotidiana come ‘piatto’ o ‘rotondo’, intende porre in discussione la legittimità stessa delle scienze unane a compiere generalizzazioni che non siano storicamente limitate70. Se non ci si potesse svincolare dal particolarismo della storia culturale per formulare ipotesi su questioni generali, se non si potesse leggere anche in un solo caso, benché ben scelto e significativo, una risposta capace di assumere valore universale, allora la grande ambizione di un’analisi delle società alla ricerca di elementi nascosti e fondamentali che sono costitutivi dei fenomeni verrebbe a cadere. La sociologia di Durkheim indica una via verso una scienza che aspiri a leggi universali, tra il vuoto genericismo della filosofia sociale ed il rinunciatario particolarismo della storia culturale. Sembra che Girard tenti di conciliare l’aspirazione di Durkheim alla sociologia come scienza con la prudenza critica rivolta contro tutte le generalizzazioni non documentabili: solo le conoscenze accumulate dagli etnografi possono offrire una solida base documentaria su cui verificare ogni possibile ipotesi e realizzare la costituzione di una scienza sociale che in Durkheim si era rivelata come un fecondo auspicio. In Girard emergono molte spie dell’intenso dialogo promosso fra sociologia e antropologia culturale: si trova ad esempio confermato piu volte l’interesse per l’organizzazione sociale e per i sistemi di parentela71. Questi pochi esempi bastano per mostrare la ricchezza delle problematiche che confluiscono nella formazione del pensiero di Girard e per sottolineare la tendenza a fondere un’attenzione al particolare con ipotesi esplicative di carattere generale, che mostrano quanto grande sia il debito di Girard verso la sociologia francese, soprattutto verso la maggiore disponibilità di quest’ultima per il momento della teoria in quanto tale.
Il ruolo riconosciuto alla sociologia di Durkheim non impedisce a Girard di prendere però le distanze dal sociologo francese soprattutto su due punti fondamentali: in primo luogo, tiene distinte la ricerca delle origini da quella delle funzioni, il punto di vista storico da quello logico; in secondo luogo, non contrappone l’individuo alla società, l’approccio psicologico a quello sociologico.
Quanto alla distinzione origine/funzione, essa non è affatto assente in Durkheim72, ma è vista alla luce di un rapporto di complementarità tra i due concetti, dato che l’individuazione delle funzioni mira solo a ribadire quanto già messo in luce dall’analisi genetica. Se è vero che solo nella struttura interna di una società si trovano le cause degli altri fatti sociali73 è anche vero che gli elementi di tale struttura ed i loro rapporti si rivelano unicamente ad un’analisi genetica che ne ricostruisca il processo di formazione, che si basa sull’evoluzione sociale che in Durkheim non è però né rettilinea né mossa dalla tendenza ad uno scopo, ma è invece retta da cause meccaniche. Per quanto riguarda il fenomeno religioso nella teoria sociologica di Durkheim non interessa scoprirne l’origine storica, ma piuttosto “le cause sempre presenti da cui dipendono le forme essenziali del pensiero e della prassi religiosa”74: l’intento del sociologo francese è di individuare la causa in assoluto astraendo da ogni contingenza storica e pertanto egli preferisce decidere del valore e del significato della religione in quanto tale piuttosto che della sua origine storica. Invece Girard, benchè ne veda un legame, tiene separate l’origine e la funzione del sacrificio: riguardo alla prima ritiene sia necessario rifarsi a “quanto è accaduto la prima volta”75. Riguardo la seconda Girard individua una funzione reale del sacrificio che si propone a livello dell’intera collettività in quanto “è l’intera comunità che il sacrificio protegge dalla sua stessa violenza”76: peculiare del sacrificio è pertanto la funzione di “placare le violenze intestine, d’impedire lo scoppio dei conflitti”77. I1 sacrificio, comportamento definito in un insieme collettivo, ha pertanto preso in Girard consistenza sociale e culturale: gli attribuisce una natura riducibile alla vita sociale e utile al suo progresso in base ad una documentazione etnografica. Dunque, riguardo al rapporto origine/funzione, la separazione tra punto di vista logico e punto di vista storico, non reperibile in Durkheim, denuncia l’influenza su Girard di molteplici fonti quali gli antropologi Malinowski e Radcliffe-Brown.
Più complesso è il problema relativo al rapporto individuo/società, perché implica una discussione sulla natura dei fatti sociali. Ad esempio, Durkheim spiega la proibizione dell’incesto interpretando quella che in certe popolazioni, ma non in tutte, può essere stata l’origine di tale proibizione come la funzione universale e permanente in virtù della quale essa si perpetua. Inoltre, stabilendo una contrapposizione tra il carattere non intenzionale dei processi collettivi di evoluzione sociale e la intenzionalità dell’agire individuale, non tiene conto del fatto che non tutti i processi psichici sono anche coscienti e che proprio a livello inconscio gli psicoanalisti e i linguisti hanno reperito dei sistemi che sono da un lato collettivi e retti da leggi come quelli che i sociologi pretendono di ritrovare nei fatti sociali e dall’altro orientati ad uno scopo come quelli che gli psicologi ricostruiscono nelle personalità degli individui. Se nel pensiero durkheimiano la soluzione data non è univoca, rimane però costante la tesi che la sociologia si occupa di quella classe di fatti che risultano dall’associazione degli individui: concessi alla psicologia i fatti riconducibili agli individui in quanto individui, restano sempre dei modi di essere che sono irriducibili agli individui in quanto singoli, ma sono risultanti esclusivamente dal fatto che essi sono associati e costituiscono un’unità di nuovo genere. Sia nella sociologia religiosa sia nella sociologia della conoscenza, la spiegazione sociologica riconduce sempre i fatti umani al modo di essere dei raggruppamenti di individui. Non stupisce dunque che Durkheim abbia progressivamente accentuato l’importanza del concetto di ‘coscienza collettiva’78 ed abbia spostato il suo interesse verso le società primitive ricche di una maggiore effervescenza di sentimenti collettivi79. Per Durkheim maturo la società non è tanto una associazione di individui quanto di coscienze individuali da cui risulta una sorta di ipercoscienza, mentre lo stesso ambiente sociale viene inteso come fatto essenzialmente di idee, valori, abitudini e tendenze comuni80. L’accento passa dalla morfologia alla fisiologia sociale, dalla struttura sociale alle rappresentazioni collettive81: la sociologia è sempre più una sorta di psicologia collettiva. Nel suo pensiero passando da La divisione del lavoro sociale a Le forme elementari della vita religiosa la soluzione varia: si accentuano tendenze82 che portano la sociologia religiosa a diventare, e non a caso, il principale campo d’indagine perché, se la società è essenzialmente una comunanza di sentimenti, pensieri e valori, si può comprendere come in dio, secondo la nota ipotesi delle Forme, gli uomini non adorino che la società stessa e come la religione sia il germe di tutte le istituzioni sociali83. Questa tesi costituisce l’asse portante delle Forme e rappresenta l’implicito punto di raccordo dei suoi due grandi temi: da un lato l’identificazione della società con dio (sociologia religiosa) e dall’altro lato con il concetto di totalità, base di tutte le categorie logiche (sociologia della conoscenza). I due temi solo apparentemente corrono paralleli lungo tutta l’opera: in realtà il tema specifico dell’opera, l’analisi del totemismo australiano, ne costituisce già un punto d’incontro, perché il totem, prima forma del ‘sacro’, è simultaneamente il nome e l’emblema del clan. Questo duplice ruolo del totem da un lato indica che se uno stesso simbolo può significare contemporaneamente dio e la società elementare (il clan), allora dio e la società sono la stessa cosa; dall’altro indica che l’origine della società, della religione84, della conoscenza e del linguaggio costituisce un processo unico e perciò il primo dio è anche il primo simbolo ed il primo concetto85. In questa prospettiva il sacrificio viene interpretato come il momento in cui l’aggregazione del gruppo e la polarizzazione psicologica che ne deriva agiscono in modo tale che ogni individuo si sente pervaso dalla forza collettiva che di solito percepisce come esterna, da cui deriva lo stato di effevescenza collettiva che si determina; Girard accenna a questo parlando dell’antagonismo ‘contagioso’ di tutti contro tutti entro la tragedia greca86. Dunque, riguardo al rapporto individuo/società il discorso si rivela complesso: Girard da un lato avverte l’esigenza, in parte stimolata da Mauss e dall’antropologia americana, di un più stretto rapporto tra sociologia e psicologia; dall’altro lato però la direzione nella quale cerca soluzione al suo problema è ancora fortemente debitrice del concetto durkheimiano di società intesa come sistema di valori. La problematica di Girard resta dunque durkheimiana sia perché intende proporre una teoria originale sulla genesi della religione sia perché intende l’antropologia come una scienza sia perché suo oggetto restano forme collettive di rappresentazione e di condotta. La continuità con Durkheim è però interrotta su alcuni punti decisivi: un accordo non del tutto precisato da Girard ma comunque importante fra antropologia e psicologia; il delinearsi, sia pure ancora allo stato embrionale, della tematica natura/cultura. Ampio spazio è dedicato al processo di ominizzazione: il meccanismo vittimario è per Girard un processo di ominizzazione che permette la crescita della comunità umana, è lo spazio del fragile discrimine tra animalità e umanità.
§3. L’eredità di Freud
Alcuni temi portanti del pensiero di Girard – quello della violenza e quello del meccanismo della vittina espiatoria e dei suoi rapporti con la psicologia interindividuale – mostrano, implicitamente o esplicitamente, la loro derivazione da alcune intuizioni del pensiero di Freud. Girard parte dalle tesi freudiane ma poi le supera rimproverando al fondatore della psicoanalisi di aver soltanto intuito la forza operativa della visione mimetica del desiderio che però rimane poi inefficace sia nel caso del complesso di Edipo sia nel caso dell’uccisione collettiva dell’orda primitiva. Ora, in sintesi, presento le affinità e le differenze dalla teoria freudiana della quale Girard si occupa ampiamente e a più riprese87.
3.1.La proibizione dell’incesto
Girard ritiene che l’elaborazione mitica e rituale, benché suscettibile nei particolari di infinite variazioni, non può non ruotare intorno ad alcuni grandi temi tra i quali la proibizione dell’incesto. Anche nel caso dell’incesto il pensiero rituale ripete il meccanismo fondatore e l’azione rituale ha come funzione unica ed essenziale quella di evitare il ritorno della crisi sacrificale. A proposito di tale proibizione Girard sostiene l’inevitabilità della sua teoria mostrando, anche se non esplicitamente, l’inconsistenza delle altre88: quella del Tylor89, del Morgan90, di Westermack91, di Freud92, di Malinowski93, di Durkheim94, di Lévi-Strauss95. Fra tutte queste interpretazioni Girard sceglie di riprendere nei dettagli quella freudiana, di cui riconosce la validità per certi aspetti ma da cui poi si distacca. Lo studioso francese ritiene che sia stata l’assenza quasi assoluta del tema dell’incesto nella cultura occidentale alla fine del diciannovesimo secolo a suggerire a Freud che tutta la cultura umana è sottoposta al desiderio universale e universalmente rimosso di commettere l’incesto materno; a confermare tale ipotesi interviene la presenza dell’incesto nella mitologia primitiva e nei rituali. Freud, dietro l’incesto del mito edipico, intuiva qualcosa di essenziale per ogni cultura umana; per Girard nel campo dei miti e delle religioni non si può attribuire alla psicoanalisi nessun altro successo paragonabile a questo, per quanto parziale e limitato esso sia. Ma la psicoanalisi non è mai riuscita a mostrare come e perché l’assenza dell’incesto in una determinata cultura significherebbe esattamente la medesima cosa che la sua presenza in molte altre96; Girard è invece convinto che l’incesto generalizzato rappresenta il termine assoluto della crisi sacrificale.
Lo studioso francese ritiene che la sua concezione mimetica del sacrificio non sia mai assente in Freud, anche se non arriva mai a trionfarvi poiché Freud insiste invece sull’altro polo del suo pensiero in favore di un desiderio rigidamente oggettuale, cioè dell’inclinazione libidica per la madre. La prima identificazione descritta da Freud ha per oggetto il padre e chiarisce che il bambino manifesta un grande interesse per il padre e lo innalza a suo ideale. Evidente è la somiglianza tra 1’identificazione con il padre e il desiderio mimetico girardiano in quanto entrambi consistono nella scelta di un modello97 che indica al discepolo l’oggetto del suo desiderio col desiderarlo egli stesso: il desiderio mimetico non è radicato né nel soggetto né nell’oggetto ma in un terzo (il rivale) che desidera a sua volta e di cui il soggetto imita il desiderio. Per Girard in tutti i desideri oltre ad un soggetto ed un oggetto c’è anche un terzo termine, il rivale, che desidera lo stesso oggetto del soggetto. La rivalità non è il frutto di una convergenza accidentale di due desideri sullo stesso oggetto: in realtà il soggetto desidera l’oggetto perché lo desidera il rivale stesso. E’ il rivale che, desiderando questo o quell’oggetto, lo indica al soggetto come estremamente desiderabile. Perciò il desiderio, ricalcato su un desiderio-modello, è essenzialmente mimetico: elegge lo stesso oggetto del modello. Ma due desideri che convergono sullo stesso oggetto si ostacolano scambievolmente e ciò sfocia automaticamente nel conflitto.
L’identificazione di cui parla Freud è un desiderio che cerca una propria realizzazione per mezzo dell’appropriazione degli oggetti del padre: il figlio cerca di sostituire il padre sotto ogni aspetto e quindi anche nei suoi desideri, desiderando ciò che il padre desidera. Nella prima definizione Freud insiste che l’identificazione con il padre è anteriore a qualsiasi scelta di oggetto e che soltanto dopo l’identificazione con il padre viene l’inclinazione libidica per la madre. Sono pertanto individuate due origini del desiderio per la madre: la prima è il mimetismo, cioè l’identificazione con il padre; la seconda è la libido direttamente fissata sulla madre98. Per constatare che Freud si allontana dalla via del desiderio mimetico che gli si apre innanzi, Girard suggerisce di leggere la definizione stessa del complesso di Edipo ove si trova una strana indicazione: quando il figlio si scontra con l’ostacolo paterno la sua identificazione finisce per confondersi con il desiderio di sostituire il padre anche presso la madre. Colpisce questo ‘anche presso la madre’ in quanto è evidente che, se nella fase dell’identificazione il figlio già voleva sostituire il padre sotto ogni aspetto, voleva sostituirlo anche presso la madre99: secondo Girard questa leggera incongruenza dissimula qualcosa di molto importante. Egli fa sfociare il pensiero di Freud in uno schema mimetico che fa del padre il modello del desiderio; poiché è il padre che designa al figlio il desiderabile col desiderarlo egli stesso, il figlio non può evitare di desiderare tra le altre cose anche la madre. Ma Freud, dopo aver implicitamente suggerito una tale lettura mimetica, non la formula mai apertamente e scrivendo ‘anche presso la madre’ implicitamente la respinge: è quest’ultima parte di frase a neutralizzare ogni possibile interpretazione mimetica dell’identificazione. Un’attenta lettura della definizione del complesso di Edipo in due diversi testi freudiani100 rivela che non ci troviamo davanti, come potrebbe sembrare, ad un fedele riassunto una dell’altra: sono differenziate da elementi apparentemente minimi ma in realtà importanti. L’analisi girardiana mette in rilievo che Freud nel primo testo respinge gli elementi mimetici presenti, mentre nel secondo testo rafforza l’inclinazione libidica ma, anzichè presentarla come il risultato di un primo contatto con l’identificazione, inverte l’ordine dei fenomeni ed esclude in tal modo formalmente il nesso di causa e effetto suggerito dal primo testo. Il secondo testo quindi, a spese delle migliori intuizioni del primo, finisce per eliminare tutti gli effetti mimetici101.
Inoltre Girard evidenzia anche un altro aspetto: poichè il discepolo e il modello si dirigono verso lo stesso oggetto, tra il discepolo e il modello si avrà uno scontro violento. E’ però ‘innocentemente’ che il discepolo si porta verso l’oggetto del suo modello e che vuole sostituire il padre anche presso la madre: semplicemente obbedisce all’imperativo di imitazione che gli viene trasmesso dalla cultura e dal modello stesso102. Soltanto l’adulto può interpretare l’intenzione del bambino come un desiderio di usurpazione, dal momento che la interpreta entro un sistema culturale che non è però ancora quello del bambino. I1 rapporto modello/discepolo esclude già per definizione l’uguaglianza che renderebbe la rivalità concepibile nella prospettiva del discepolo; quest’ultimo imita i desideri del modello ma è incapace di ravvisarvi qualcosa di analogo al suo stesso desiderio103. Chiaramente il desiderio dell’ incesto non può essere un’idea del bambino, ma è evidentemente l’idea dell’adulto. La prima interposizione del modello tra il discepolo e l’oggetto deve costituire un’esperienza particolarmente ‘traumatizzante’ perché il discepolo non è in grado di effettuare l’operazione intellettuale che l’adulto gli attribuisce. In realtà, trovandosi ad affrontare l’ira del modello, il discepolo è obbligato a scegliere tra se stesso e il modello ed è evidente che sceglierà quest’ultimo in quanto giustifica l’ira dell’idolo con la propria insufficienza. I1 discepolo si crede colpevole anche se senza sapere esattamente di che cosa e sentendosi indegno di possedere l’oggetto desiderato, lo sentirà più desiderabile che mai. L’orientamento del desiderio verso gli oggetti protetti dalla violenza dell’altro si è così iniziato ed il legame che in questo modo si stringe tra il desiderabile e la violenza potrebbe non sciogliersi mai104. I1 punto focale della critica girardiana è il rimproverare a Freud di restare attaccato, malgrado le apparenze, ad una filosofia della coscienza: “l’elemento mitico del freudismo è la coscienza del desiderio parricida e incestuoso”105.
Freud ha insomma dapprima tentato di sviluppare il complesso di Edipo sulla base di un desiderio per metà oggettuale e per metà mimetico, da cui deriva la strana dualità dell’identificazione con il padre e dell’inclinazione libidica per la madre. Il fallimento di tale compromesso spinge Freud a fondare l’Edipo su un desiderio puramente oggettuale e a riservare gli effetti mimetici per un’altra formazione psichica, il Super-io, che non è che la ripresa dell’identificazione con il padre a cui Freud non vuole rinunciare del tutto106. Nei testi freudiani ritorna più volte il concetto fondamantale di ‘ambivalenza’ che tradisce contemporaneamente sia la presenza della configurazione mimetica (in cui sono inseparabili l’identificazione, la scelta dell’ oggetto e la rivalità) sia l’incapacità del pensatore ad articolare correttamente i rapporti dei tre elementi della figura (il modello, il discepolo e l’oggetto che si contendono). Il termine ambivalenza compare alla fine di entrambe le definizioni del complesso di Edipo e perciò Girard conclude che Freud si rifugia nella nozione di ambivalenza ogni volta che la contraddizione del desiderio mimetico gli fa pressioni e gli si impone senza che egli riesca a chiarirla. Dietro l’ ‘ambivalenza’ in Freud c’è dunque un’intuizione parziale ma reale del desiderio mimetico107: Girard è pertanto convinto che la sua lettura della proibizione dell’incesto non sia stata veramente rifiutata da Freud, ma semplicemente non sia stata scorta in quanto “essa sembra così semplice e naturale, una volta che la si è individuata, che Freud non avrebbe mancato di prenderla in considerazione, se non altro per rifiutarla, se fosse veramente giunto fino ad essa. La verità è che non vi è arrivato”108. Girard ritiene che Freud resti abbagliato da ciò che gli appare come la sua scoperta cruciale che gli impedisce però di impegnarsi a fondo sulla via della mimesis che rivelerebbe chiaramente la natura mimetica del parricidio e dell’incesto: comunque in Freud l’intuizione del desiderio mimetico pur non trionfando mai non lo lascia però nemmeno mai tranquillo. Girard conclude che il sorgere della psicanalisi è storicamente determinato dall’avvento del moderno e che la maggior parte dei fenomeni raggruppati intorno al ‘complesso di Edipo’, anche se l’origine loro attribuita è mitica, hanno un’unità reale e un’intellegibilità che rivela pienamente la lettura mimetica. Il complesso di Edipo è occidentale e moderno “così come sono occidentali e moderne la neutralizzazione e la sterilizzazione relative di un desiderio mimetico sempre più libero dai suoi impedimenti ma sempre imperniato sul padre e suscettibile in quanto tale di ricadere su certe forme di equilibrio e di stabilità”109.
3.2.La lezione di Totem e Tabù
Come è noto in Totem e Tabù Freud applica alla psicologia collettiva o Volkerpsychologie i risultati della psicoanalisi, presupponendo la validità anche nel campo socio-psicologico del principio di Haeckel per cui l’ontogenesi ricapitola la filogenesi110: trasferisce cioè la scoperta del complesso edipico dal campo individuale a quello collettivo. Nel quarto saggio di Totem e Tabù (I1 ritorno del totemismo nell’infanzia) Freud tenta anche la ricostruzione storica del grande crimine appoggiandosi alla tesi di Darwin sull’orda primitiva e ad alcune intuizioni di Robertson Smith sul significato del rito totemico. L’ipotesi del parricidio commesso dagli uomini in età arcaica, nel quale la civiltà avrebbe trovato la propria origine, è celebre: in essa traspare la stretta relazione di corrispondenza istaurata da Freud nei due sensi, tra ontogenesi e filogenesi. Infatti, secondo l’ordine della ratio cognoscendi il complesso edipico individuato nei singoli nevrotici contemporanei precede e guida la scoperta della sua origine storica e secondo l’ordine della ratio essendi è l’origine storica del complesso che ne spiega il persistere nei contemporanei. Tale continuità è secondo Freud resa possibile dall’ipotesi della trasmissibilità di generazione in generazione di una specie di ‘psiche collettiva’111, qualcosa in più della ‘coscienza collettiva’ di Durkheim, poiché implica chiaramente l’ipotesi lamarckiana della trasmissione ereditaria di alcune esperienze storicamente acquisite112. Ereditarietà ed esperienza individuale in Freud si corrispondono e si integrano reciprocamente in modo che nell’individuo l’educazione, cioè l’esperienza del proprio ambiente sociale, nega la libertà pulsionale e si limita a rafforzare uno sviluppo già ereditariamente segnato113: l’opera della civiltà anziché contrastare e reprimere l’opera della natura ne è il risultato. Se nell’uomo è presente un conflitto, come testimonia la psicoanalisi, esso non è dovuto per Freud al contrasto fra natura e civiltà, fra libertà interiore e coercizione esterna, ma è dovuto all’insopprimibile dualismo delle pulsioni umane naturali, cioè ad una scissione che è originaria della stessa natura umana.
La famosa dottrina freudiana sull’origine della civiltà giunge a Girard attraverso le critiche di molti studiosi fra cui Kroeberl14, Malinowskil15, Lévi-Straussl16. Girard è concorde con la critica contemporanea pressoché unanime nel considerare inaccettabili le tesi sviluppate in Totem e Tabù, in quanto Freud si concede in anticipo tutto ciò di cui il libro si sente chiamato a rendere conto: l’orda primitiva di Darwin è una caricatura della famiglia e il monopolio sessuale del maschio dominatore già coincide con le future proibizioni dell’incesto. Ma per Girard una lettura attenta rende inoltre evidente la bizzarria che l’omicidio nel libro c’è ma non è utile, almeno sul piano in cui si suppone debba servire. Se l’argomento del libro è la genesi dei divieti sessuali l’omicidio non giova affatto a Freud e gli crea invece delle difficoltàl17. Soltanto l’ipotesi girardiana del meccanismo della vittima espiatoria permette di comprendere perché man mano che si compie l’immolazione sacrificale si passi dal ‘crimine’ alla ‘santità’. Girard ritiene che Freud non viene ingannato dalla sua intuizione quando essa gli suggerisce di riferire tutti gli enigmi a un omicidio reale ma, mancando il meccanismo essenziale, non arriva poi ad elaborare la sua scoperta in modo soddisfacente: il pensatore tedesco non riesce a superare la tesi dell’uccisione unica e preistorica che, se presa alla lettera, conferisce all’insieme un carattere fantasiosol18. I1 dinamismo di Totem e Tabù si orienta verso una teoria generale del sacrificio119: il sacrificio si presenta come un atto che si compie al posto di un altro che nelle normali condizioni culturali nessuno né osa né desidera commettere ed è proprio questo che Freud, imprigionato nel problema dell’origine, cessa paradossalmente di vedere. Egli vede che bisogna far risalire il sacrificio a un evento ben più vasto ma poi l’intuizione dell’origine, poiché non si sviluppa completamente, è incapace di concludersi e gli fa perdere ogni senso della funzione. Girard ritiene che “per conciliare la funzione con la genesi, per svelarle completamente l’una per mezzo dell’altra, occorre impadronirsi della chiave universale che Freud elude sempre: solo la vittima espiatoria può soddisfare tutte le esigenze a un tempo”l20.
Lo studioso francese si interessa anche del passo di Totem e Tabù che riporta l’interpretazione globale di Freud sul genere tragico: “l’eroe della tragedia deve soffrire. Era oberato dalla cosiddetta ‘colpa tragica’… Egli deve soffrire perché è il progenitore, l’eroe della grande tragedia primordiale”l21. Sotto molti aspetti questo testo si spinge più avanti in direzione della vittima espiatoria ed intere frasi coincidono con la lettura girardiana: non bisogna tuttavia esagerare la convergenza delle due letture, quella di Freud e quella di Girard perché, superato un certo punto, la differenza ricompare. Girard ritiene che fra tutti i testi moderni sulla tragedia greca quello di Freud, sebbene sia un fallimento, sia quello che probabilmente si avvicina di più alla comprensione della verità. Girard è convinto che la sua nuova lettura “può tenere conto di tutto ciò che vede Freud, ma tiene anche conto di tutto ciò che sfugge a Freud e non sfugge a Sofocle. Tiene conto infine di tutto ciò che sfugge a Sofocle, di tutto ciò che determina il mito nel suo insieme e di tutte le prospettive che si possono prendere su di esso, comprese quella psicoanalitica e quella tragica: il meccanismo della vittima espiatoria”l22. Ovviamente esaminare un testo nella prospettiva del meccanismo della vittima espiatoria e considerarlo nei termini di violenza collettiva, significa interrogarsi più su ciò che il testo omette che su ciò di cui tiene conto123. Nell’opera freudiana si dice che un giorno il Padre dell’orda primitiva è stato assassinato: si tratta quindi di un parricidio che è il delitto che Freud crede di ritrovare nella tragedia greca proiettato dai criminali sulla loro vittima. Girard ritiene che non si potrebbe immaginare una convergenza più perfetta tra la concezione della tragedia difesa in Totem e Tabù e l’argomento dell’Edipo re: sarebbe appropriato nominare il caso Edipo che invece Freud non cita nemmeno poiché non può utilizzare l’Edipo re nel contesto di un’interpretazione che riallaccia la tragedia ad un parricidio effettivo senza rimettere in causa l’interpretazione ufficiale della psicanalisi che fa dell’Edipo re il semplice riflesso dei desideri inconsci dei quali viene formalmente esclusa ogni realizzazione124. I1 silenzio sull’Edipo re costituisce una specie di sospensione critica intorno alla teoria psicoanalitica, così come era stato nel caso del desiderio mimetico. Se l’opera almeno formalmente fallisce è a causa della psicoanalisi, del fardello di dogmi che il pensatore trasporta con sé e di cui non può sbarazzarsi. L’ostacolo principale ad interferire con la lettura della tragedia è innanzitutto il significato paterno che contamina la scoperta essenziale e che trasforma l’uccisione col1ettiva in un parricidio125. Dunque, anche Totem e Tabù passa molto vicino alla tesi del meccanismo della vittima espiatoria difesa da Girard come fondamento di ogni ordine culturale e quindi come la vera origine di tutto il religioso e dei divieti dell’incesto: convinzione di Girard è che tale tesi sia anche lo scopo fallito di tutta l’opera di Freud a cui, pur senza mai raggiungerlo, tende sempre126.
§ 4. Confronto con l’ipotesi sociologica di Burkert
Nella prefazione dell’ottobre 1980 all’edizione italiana di Homo necans, lo stesso autore auspica “il confronto e la discussione dell’opera, così affine per il suo tema, di René Girard, La violenza e il sacro“127: è perciò interessante vedere ora la tesi di Burkert per individuarne le affinità col pensiero girardiano. Nel primo basilare capitolo di Homo necans, anche se in apparenza potrebbe costituire una trattazione indipendente dal resto del libro, Burkert teorizza ciò che emerge poi nelle singole ricerche dei capitoli seguenti, in modo che ipotesi e applicazione si confermino a vicenda. Dopo il tentativo di spiegare storicamente e funzionalmente il complesso rituale di caccia, il sacrificio e il culto dei morti, all’autore diventerà possibile interpretare vari gruppi di riti greci sotto diversi aspetti. Altri filologi oltre Burkert hanno infatti rinunciato ad analizzare nella cultura greca solo gli aspetti di razionalità che fondano le categorie di pensiero che struttura la nostra società per esaminare invece anche gli aspetti che soprattutto nell’ambito religioso accostano il sistema sociale greco alle società che vengono ancora definite ‘primitive’. Burkert dimostra che il rituale greco occupa una posizione di primo piano nell’organizzazione della vita sociale della comunità civica128: non vi è infatti né tappa nella vita individuale né svolta nell’attività economica o sociale che nell’antichità non sia stata celebrata con un rituale. Poiché all’interno di questa pluralità di pratiche religiose il sacrificio occupa un posto centrale, tutte le analisi di Homo necans si volgono verso le pratiche sacrificali.
Burkert parte dalla considerazione che “tutti gli ordinamenti e le forme di potere della società umana si fondano su una violenza istituzionalizzata”129: questo vale anche per la religione in cui incombe, affascinante, la violenza sanguinaria. L’atto di devozione consiste essenzialmente nel versare sangue: “non è nella pia condotta di vita, o nella preghiera, o nel canto o nella danza che il dio viene vissuto con la massima intensità, bensì nel colpo d’ascia mortale, nel sangue che scorre, nelle cosce che arrostiscono”130. L’esperienza fondamentale del “sacro” è individuabile nell’uccisione di vittime per cui l’homo religiosus agisce e prende consapevolezza di sè in quanto homo necans. Per Burkert la vera “azione” è l’atto dell’uccisione ed il sacrificio è indubbiamente la forma più antica dell’azione religiosa: l’autore riporta una descrizione dettagliata dello svolgimento di un ‘normale’ sacrificio greco alle divinità olimpiche analizzandone le varie fasi131 e numerosi esempi a sostegno della sua definizione del sacrificio come “atto di uccisione”. Poi Burkert passa a presentare la sua originale spiegazione genetica. Parte dalla costatazione della stretta analogia tra certe cerimonie sacrificali e gli usi dei popoli cacciatori: “la continuità tra caccia e rito sacrificale si manifesta con particolare insistenza negli elementi del rituale”132. Alcuni presupposti sociali e psicologici sono necessariamente dati dalla situazione dei cacciatori primitivi: il programma biologico dei primati provvedeva in modo insufficiente al nuovo modo di vita che viene affrontato dall’uomo con l’utilizzazione di mezzi artificiali come le armi e con l’ordinamento sociale che porta ad una rigida differenziazione dei sessi. Burkert individua pertanto nel passaggio alla caccia il mutamento ecologico decisivo intervenuto tra i restanti primati e l’uomo: “la preistoria ci ha dato un quadro: l’uomo diventò uomo attraverso la caccia, attraverso l’atto dell’uccisione”l33. La distruttività umana non è un fenomeno accidentale e l’uomo, per non rimanerne vittima, non può che accettarla socializzandola tramite la sua ritualizzazione. Richiamandosi ad alcune osservazioni dell’etologia finisce poi per formulare una teoria del sacrificio fondata sulla dialettica di colpa e riparazione. Nelle popolazioni di cacciatori accessibili all’osservazione etnologica spicca chiaramente il senso di colpa nei confronti della vittima uccisa; tentativi di scusa e riparazione sono contenuti nel rituale134, che spesso passa bruscamente al grottesco, al punto che Meuli ha coniato il concetto di “commedia dell’innocenza”135. Di fronte all’esperienza della distruzione della vita come mezzo di sopravvivenza (uccidere per mangiare) il cacciatore neolitico scarica il proprio senso di colpa ritualizzando l’atto dell’uccisione sotto forma di sacrificio. Dopo la presentazione di questa tesi Burkert dedica ampia parte del testo ad esempi portati per avvalorare la sua tesi con un continuo raccordo dei dati storico-filologici con le indicazioni dell’etologia, dell’antropologia e della psicoanalisi. Per quanto riguarda il rapporto mito-rito Burkert riconosce che sotto il profilo dello sviluppo storico i riti sono molto più antichi dei miti, in quanto risalgono sino al mondo animale, mentre il mito divenne possibile solo molto più tardi con la facoltà specificamente umana del linguaggio. Rimane però la costatazione che un racconto di fatti in quanto tale è qualcosa di nuovo rispetto ai riti biologicamente comprensibili: per questo il mito non deriva immediatamente dal rituale136. Indubbiamente mito e rito si connettono con successo proprio in quanto forme di tradizione culturale. Burkert ritiene che il mito non è di per sè necessariamente una parte del rituale (come voleva l’indirizzo della myth and ritual School), mentre invece si può parlare di mito anche al di fuori della celebrazione di un rituale: solo la questione opposta, se cioè tutti i miti greci rimandino a loro volta a rituali, è controversa. Conclude che, pur con mezzi espressivi molto differenti, il rito è ordinatore quanto il mito: come la leggenda esso organizza la realtà, la scandisce e le dà un senso.
Come unico esempio delle analisi di Burkert137 ricordo la sua interpretazione della tradizione romana dell’uccisione di Romolo da parte dei primi senatori come un mito di fondazione della società romana, nel quale trova conservati importanti elementi del racconto proto-indoeuropeo della creazione. In questo saggio Burkert si ispira al mito proto-indoeuropeo della creazione138 che racconta come il primo sacerdote officiò il primo sacrificio nel quale le vittime erano il primo re suo fratello e il primo bovino. Si noti che mentre il sacrificio perfetto comprende sia una vittima animale sia una vittima umana come nel primo sacrificio, l’offerta animale sarà poi per lo più considerata sufficiente. Il fatto del primo re comunque ci interessa in particolare perché, secondo il mito, dal suo corpo fu creato il mondo: non solo il mondo naturale (dagli occhi il sole, dal sangue il mare, dalla carne la terra) ma anche il mondo sociale (dalla testa la classe dei sacerdoti e dei regnanti, dal torace e dalle braccia quella dei guerrieri, dalle parti inferiori del suo corpo quella della gente comune)139. Secondo tale interpretazione i materiali di etnologia religiosa mostrano quindi come il sacrificio protoindoeuropeo dovesse essere inteso come una ripetizione rituale della creazione ed insieme sociogonia e cosmogonia. Durante tali riti le vittime, umane o animali, venivano uccise e smembrate e i loro corpi venivano poi suddivisi con la più grande cura e parti delle membra venivano distribuite agli uomini e mangiate; era il diverso valore e prestigio dei vari tagli di carne a rappresentare la posizione gerarchica dell’individuo o del gruppo. Tralasciando gli altri possibili significati molti studiosi si interessano solo del fatto che ad ogni sacrificio l’ordine sociale viene riconfermato, essendo il sacrificio così come altri rituali un meccanismo potentissimo volto alla conservazione della società: in questo caso ogni sacrificio proto-indoeuropeo viene dunque interpretato come la ripetizione della creazione ed il rinnovamento della società e del cosmo140. Burkert si inserisce in questa tematica esaminando certe tradizioni romane: nella citata uccisione di Romolo ha richiamato in particolare l’attenzione sulla distribuzione delle parti del corpo a ogni senatore, sottolineando che le famiglie patrizie fondate dai primi senatori avrebbero da allora in poi costituito il nerbo della società romana. Così finché Romolo visse incarnò da solo la totalità romana, ma grazie alla sua morte, una morte quasi sacrificale caratterizzata dallo spargimento di sangue e dallo smembramento avvenuto in un tempio, quella totalità fu infranta e le varie famiglie assunsero i diversi ruoli come diverse membra dello stato. L’interpretazione del mito giunge fin qui, ma l’analisi di Burkert si spinge ancora più in là arrivando a paragonare la storia dello smembramento di Romolo a vari rituali fra i quali le Feriae Latinae141, uno dei più antichi sacrifici italici. Le Feriae erano un rituale di solidarietà e gerarchia nel quale si celebravano nello stesso tempo la coesione della Lega latina e il diverso prestigio dei suoi membri142. Sia nelle Ferie che nel racconto mitico dello smembramento di Romolo Burkert riscontra motivi simili: in entrambi i casi un corpo viene tagliato a pezzi, proprio come la societa è fatta di tante parti o segmenti.
Questo cenno alla teoria di Burkert permette di fare alcune considerazioni sul metodo che ha adottato nell’approccio al fenomeno religioso. In primo luogo si può affermare che Burkert inquadra la propria analisi in una prospettiva storica secondo la quale la religione conserva il ‘ricordo’ del passato. All’origine, frutto dell’aggressività innata dell’uomo, si colloca un atto fondamentale: uccidere per mangiare, per cui l’uomo si definisce come homo necans. Ma a questo atto del primo cacciatore si accompagna immediatamente un senso di colpa: di qui nasce il valore sacro dell’atto di uccisione, che diventa rito e prende così la forma di un sacrificio con la precisa funzione di riparazione e di discolpa. In secondo luogo si può dire che la dimensione storica si articola poi in una prospettiva funzionale. Il valore sacro del rito di morte risale ai tempi in cui la caccia costituiva l’attività fondamentale dell’uomo. Il metodo è quindi chiaro: alcuni operatori semantici corrispondenti a certi atti fondamentali, come cacciare, uccidere, mangiare, sono messi in relazione gli uni con gli altri secondo la linea storica e si combinano per formare nelle sue varie concretizzazioni il sacrificio, che è visto da Burkert come l’atto religioso per eccellenza. Manca però l’interrogativo sullo statuto di questi operatori143. Quindi in Burkert si è cercato di collegare la prospettiva storica con una prospettiva funzionale. A Burkert la religione, in quanto mantiene il suo aspetto costante di tradizione che si modifica ma che mai viene sostituita completamente dal nuovo, sembra uno straordinario fattore di stabilizzazione sociale nella realtà storica. In questo rapporto con la realtà sociale, tuttavia, la religione non assolve solo una semplice funzione di specchio riflettente: sembra piuttosto correlata a strati più profondi della convivenza umana e ai suoi presupposti psichici144. A questo punto è possibile rendersi conto dei limiti che pesano sulle analisi etologico-psicanalitiche dei riti di sacrificio: si basano sul concetto di iterazione rituale, simulata e sublimata, di quegli atti violenti cui gli uomini dovevano abbandonarsi quando fondavano la loro stessa umanità. Il simbolismo sacrificale replicherebbe l’atto primigenio di distruzione violenta per ripetere in forma volontaria un delitto emblematico e per poterlo religiosamente espiare. La tesi di Burkert, ampiamente articolata nel suo Homo necans, lascia intendere che la violenza rituale non viene soppressa in virtù del rito ma viene riprodotta e trasferita in una cornice sacra allo scopo di poter legittimamente profanare il mondo. E’ in parte la tesi di Girard con l’importante differenza che per lo studioso francese gestire religiosamente la violenza serve a rigenerare la religione e il sacro, non ad ampliare la legittimità del mondo profano, sia pure sotto la protezione di quello sacro, come è per Burkert.
§ 5. Conclusione
5.1.L’approccio antropologico di Girard allo studio della religione
Negli ultimi decenni c’è stata un’invasione nello studio delle religioni, e di conseguenza anche del rituale e del sacrificio145, da parte della sociologia, della psicologia e soprattutto dell’antropologia socio-culturale. Quest’ultima, nata dallo studio dei costumi e del comportamento dei popoli primitivi, si è ampiamente allargata incorporando in sé elementi sociologici, psicologici, etnologici, linguistici, simbolici e in particolare elementi religiosi. Pur nelle sue contraddizioni, nell’incertezza dei limiti, nella continua variazione delle definizioni, il movimento antropologico assume pertanto una enorme importanza per le scienze religiose sia per alcune determinate istanze che propone nello studio dei fenomeni religiosi sia per il consistente numero di studi di storici delle religioni che più o meno legittimamente vengono ascritti agli indirizzi antropologici. A proposito del primo contributo mi limito a dire che, pur nella diversità e spesso inconciliabilità delle prospettive, l’approccio antropologico suggerisce un’interessante metodologia d’indagine che si volge ai fenomeni religiosi studiandoli nel loro diretto e costante rapporto vitale con tutti gli altri elementi che formano un organismo culturale o sociale. Emerge cioè in modo indubbiamente positivo la consapevolezza che l’indagine del religioso non può più rinunciare all’esigenza di analisi del quadro umano più vasto e completo che costantemente esprimono il rito e il mito. A proposito del secondo contributo è positiva la specializzazione dell’antropologia nello studio dei rituali religiosi in relazione al loro valore per l’individuo e la società in quanto l’antropologia socio-culturale, “ponendosi come studio dei costumi ed in generale dell’ethos dei popoli, ha una sua concretezza che altre scienze umane non possiedono ed inoltre si pone in linea con il comportamento rituale, che appare anzitutto un’azione o un complesso di azioni di carattere simbolico che – almeno ad una prima indagine – non è dissociabile dal contesto socio-culturale in cui si manifesta”146. E’ inoltre evidente che la polivalenza semantica del rituale è stata causa di molte difficoltà sia per una definizione e classificazione del rito in antropologia culturale sia perché è accaduto che “interpretazioni a volte contrastanti o comunque diverse apparissero tutte plausibili”147.
Oggi l’antropologia si muove prevalentemente nelle fasi funzionale, strutturale, simbolica, spesso con rapporti fra le diverse dimensioni. I tre indirizzi, pur partendo dalla precomprensione comune che la religione vada studiata in rapporto alla cultura, si differenziano poi notevolmente: l’ipotesi funzionale, per la quale la religione serve alla società; l’ipotesi strutturale, per la quale la religione va decodificata, in quanto è un tipo di codificazione inconscia; l’ipotesi simbolica, che tiene conto di un minimum religioso. Chiaramente non è qui possibile elencare nelle loro peculiarità le differenti interpretazioni antropologiche del religioso148: basti dire che fra loro il funzionalismo antropologico, che si presenta con una grande varietà di differenziazioni, è la corrente che oggi meglio rappresenta l’antropologia ed è la più disposta a studiare il rituale come un’azione simbolica di estrema importanza all’interno della società. Il suo campo di ricerca preferenziale è dato quindi dalla religione nella sua globalità di manifestazioni, organizzazioni, simboli a livello sociale, ma in cui particolare rilievo assumono i riti come azioni simboliche con rilevanza sociale.
Anche Girard si interroga sull’uomo in rapporto alla sua ritualità dal versante dell’antropologia socio-culturale: analizzando il suo pensiero è emersa una posizione che si può definire di integrazione delle linee sociologico-funzionalista-psicologica. Si è visto come già a partire da Durkheim la sociologia ha dedicato la propria attenzione al ruolo dei riti e in particolare del rito religioso nella società, nella convinzione che la società diventa consapevole di se stessa attraverso un’azione comune e che pertanto a intervalli regolari deve confermare i sentimenti e le idee collettive che costituiscono la sua unità149. Fu poi Radcliffe-Brown a sviluppare nel modo più conseguente questa prospettiva funzionale: una società può sussistere solo in virtù di un sistema di concetti e sentimenti collettivi che vengono sviluppati proprio grazie all’influenza della società sull’individuo150. In antitesi a questo concetto funzionalistico di rito si è posto quello della psicologia del profondo che muove dall’osservazione di azioni ossessive nevrotiche151. Sembra tuttavia che l’opposizione tra queste proposte sia più nella prospettiva che nell’oggetto stesso: infatti Girard coniuga ed integra la formulazione della domanda sul piano sociologico funzionale con la ricerca psicologica freudiana. E’ emerso che nel pensiero girardiano il fenomeno religioso costituisce sia il punto di partenza sia il punto di arrivo della sua ricerca (§1). Di partenza, perchè l’oggetto sacralizzato è il prodotto della soluzione collettiva che gli uomini danno alla loro conflittualità mimetica, quindi costituisce la genesi di ogni fondazione; di arrivo, perchè nel corso della storia evolutiva del sacro il suo significato è stato nascosto e quindi le sue tracce vanno reperite risalendo le varie tappe dell’attività mitopoietica delle civiltà umane. La storia delle religioni interessa Girard per questo motivo: è la storia del ‘misconoscimento’ dei meccanismi costitutivi del sacro, sommersi dalla testualità mitica e dai comportamenti sacralizzati (§1, 1.5). Per lo studioso francese il sacro si articola pertanto nei due momenti del divieto e del rituale: il divieto si applica agli oggetti del desiderio che possono scatenare i comportamenti mimetici e il rituale si presenta come ripetizione simulata del meccanismo di regolazione della crisi ottenuta con l’omicidio collettivo.
Gli ultimi studi di antropologia ed ecologia possano giustificare una collocazione della teoria del sacrificio di Girard all’interno di una concezione socio-ecologica del rituale. I riti sacrificali sono una specificazione dei riti di offerta di cibo e riguardano più in particolare il sacrificio di animali. Potrebbero essere una delle forme più antiche di rituale, quel rituale per eccellenza da cui, secondo Burkert o Girard, ha avuto origine il senso religioso in quanto tale. La tesi di Girard può quindi essere inserita in un equilibrio che si ritrova all’interno del sociale per sconfiggere l’aggressività e la violenza: egli vede il sacrificio come “equilibratore” delle forze competitive e antagoniste, in grado di riportare l’ordine e di ristabilire l’armonia. La teoria girardiana è complessa e, se teniamo conto delle variazioni a cui è stata sottoposta in questi ultimi anni, si presenta come un lavoro in fieri; nelle sue opere più recenti il francese ha cercato di mettere a fuoco, con una precisione che dall’una all’altra si è fatta sempre maggiore, il meccanismo del capro espiatorio, quel pensiero che per lui è stato l’essenziale negli oltre vent’anni passati da La violenza e il sacro. Fondamentale rimane comunque la funzione ecologica del rito in un contesto ove si ha bisogno di autoproteggersi dalla distruttività e dalla violenza.
5.2.Il metodo di Girard
L’interpretazione di Girard ha spesso interessato i critici che, a proposito di questioni che si riferiscono direttamente al suo pensiero152, si sono volti su due piste: la prima consiste in un confronto con l’intero sistema delle idee di Girard153 e la seconda, molto più frequente, in un confronto con alcuni aspetti settoriali presi in considerazione dalla sua interpretazione sintetizzante154. In questo ultimo caso si sono scritti molti saggi soprattutto sul concetto di sacrificio, l’idea chiave attorno a cui si sviluppa tutta la teoria del francese ed inoltre su problemi teologici e su quelli di esegesi biblica. La sua interpretazione del sacrificio mi suggerisce una riflessione sul metodo che ha adottato nel suo approccio antropologico al fenomeno religioso. Mi limito ad individuare due aspetti del suo metodo: la pretesa di ‘scientificità’ ed il carattere ‘riduttivo’ delle sue analisi.
a)L’aver reso manifesto grazie alla sua teoria il ‘misconoscimento’ del meccanismo, costitutivo del sacro, della vittima espiatoria, porta Girard a sottolineare con insistenza il carattere strettamente scientifico del suo lavoro, in quanto pensa di aver raggiunto un principio di spiegazione universalmente e definitivamente valido per l’insieme dei fenomeni umani. Ritiene che la sua lettura possieda ‘una forza prodigiosa’ e di aver trovato “la spiegazione ultima della mitologia, non solo perché all’improvviso non vi è più nulla d’oscuro e tutto diventa intelligibile e coerente, ma perchè si comprende, nello stesso momento, perché i credenti dapprima, e sul loro esempio i non credenti poi, sono sempre passati vicino al segreto, peraltro così semplice, di ogni mitologia”155. Sembra che in tal modo Girard ritorni all’ideale della ‘scientificità oggettiva’ in un contesto sociologico-funzionalista, in cui ci si interessa soprattutto alle azioni, al comportamento, all’intreccio dei bisogni e alla trama dei significati in parallelo con la vita rituale. Tra gli studi su Girard si trova sia chi conferisce valore di ‘scientificità ipotetica’ alla tesi dello studioso francese156 sia chi vi riconosce ‘un ibridismo assai poco scientifico’157. In realtà Girard si inserisce in quella tendenza generale della posizione scientifica degli ultimi secoli descritta da Apel come il tentativo costante di ridurre dei fenomeni spirituali come il linguaggio, l’arte, la religione, il diritto, a qualche cosa di più semplice: cioè un tipo di causazione di carattere psicologico, fisiologico, biologico158. Intorno al dilemma “spiegare o comprendere” la religione si scontrano oggi gli studi di epistemologia: chi difende la ‘spiegazione’ cerca quella scientificità che si basa sui concetti di regolarità universale, ripetibilità e controllo sperimentale che consentono di fare previsioni ‘oggettive’; chi difende la ‘comprensione’ ha a che fare con nozioni quali controllo sociale, senso, soggettività, intenzionalità, orientamento di fini e “si dichiara tributario dell’ermeneutica contemporanea impegnata a rivendicare una propria area di originalità alle scienze dello spirito”159. Entro tale problematica è possibile riconoscere nella ipotesi sociologica funzionalista girardiana una spiegazione di tipo causale, in quanto “il rapporto causa-effetto è visto nella relazione inconscia del comportamento che ‘sacrifica’ per mantenere o riportare l’ordine sociale, in un rigido rapporto di causazione”160.
b)Due momenti della visione girardiana si presentano come ‘riduttivi’ nell’approccio ai fenomeni religiosi.
In primo luogo il metodo di Girard consiste in “una specie di avventura antropologica”161 che si basa su un confronto tra il materiale della letteratura soprattutto classica (riferimenti alla tragedia della Grecia classica) con il repertorio etnografico recente (cita etnologi come Lienhardt, Evans-Pritchard) e con le tesi di vari antropologi. Tramite codeste connessioni Girard soddisfa l’esigenza di trovare soprattutto le strutture unificanti della violenza e dei suoi meccanismi. L’evidente attenzione agli aspetti formali unificanti lo porta a presentare la violenza come principio rivelatore di una costante universale. Il pensiero girardiano si caratterizza pertanto per una tendenza alla sintesi, alla riduzione: si sforza non di sottolineare le diversità ma di ridurre la diversità e la complessità di un fenomeno all’unità. Per Girard la semplificazione e l’organizzazione dei dati del sapere costituiscono lo scopo della scienza, in quanto “la ricerca scientifica è riduttrice oppure non è niente”162.
In secondo luogo mi sembra che Girard non abbia introdotto elementi religiosi, filosofici o teologici nello studio del sacrificio per concentrare ogni sforzo di ‘spiegazione’ del fenomeno religioso sulla realtà sociale e culturale cui esso è congiunto. Nei socio-antropologi a cui Girard si ispira vi è la tendenza costante a leggere la religione all’interno dell’universo simbolico culturale che una data società si costruisce e la propensione a considerare la religione in questo contesto mai come pura ma sempre applicata e cioè funzionale alla ricerca di risposte plausibili in mancanza di altre in vista della composizione dell’intero simbolico-culturale. Anche da Girard la religione viene interpretata dunque dal punto di vista sociologico-funzionalistico. Si tratta di un approccio che si concentra sull’aspetto socioculturale e che si risolve pertanto in uno studio riduttivo del fenomeno religioso: il valore funzionale e quello sociologico possono infatti essere solo ‘un’ aspetto della realtà o di una istituzione, ma non la possono esaurire completamente.
5.3.L’alternativa fenomenologica
Passo ora alla sintetica presentazione di un’alternativa che si riferisce ad una tesi feconda ed innovativa: l’individuazione in Girard di “una lettura quasi ermeneutica”163 e l’individuazione di “una fenomenologia latente nell’antropologia funzionale”164.
A favore di “una lettura quasi ermeneutica” parto dalla considerazione che nelle ultime pagine de La violenza e il sacro Girard dichiara esplicitamente che la sua tesi risponde a tutte le esigenze di “un’ipotesi scientifica”, che essa si pone cioè su un piano eminentemente positivo che è in grado di unificare tutti i fatti etnologici. Ritiene che la sua ‘lettura’ del sacrificio non abbia il carattere di una interpretazione ermeneutica “perchè si ha interpretazione ermeneutica finché la domanda resta senza risposta”165. Ma, nonostante questa sua opposizione al metodo ermeneutico, la sua interpretazione dei fenomeni religiosi “è suggerita da precise pre-comprensioni di ordine sociologico e non può perciò esibirsi fuori da un contesto ermeneutico”166. Se usiamo il termine ermeneutica in accezione non storica ma eminentemente categoriale per designare qualsiasi posizione filosofica sulla realtà sociale che assuma a categoria fondamentale dell’azione quella di senso, vediamo Girard inserirvisi suo malgrado. In realtà le assunzioni gnoseologiche che caratterizzano ermeneutica e positivismo sono profondamente differenti e costituiscono due diversi modi di concepire l’uomo e la società: qui la scelta cade a favore dell’ermeneutica, che sembra conferisca più senso al mondo sociale. A sostegno della tesi di un Girard visto in contesto ermeneutico cito solo il fatto che la questione del ‘senso’ in realtà interessa profondamente lo studioso francese, che vede in esso un aspetto essenziale ed ineludibile per l’uomo e che critica aspramente il momento attuale del non-senso: “non si vuole più privare gli uomini della sessualità ma di qualcosa di cui hanno ancora più bisogno, il senso. L’uomo non vive solo di pane e di sessualità. Il pensiero attuale è la catastrofe suprema, perché è la castrazione del significato. Tutti sono lì a sorvegliare il vicino per sorprenderlo in flagrante delitto di credere in qualsiasi cosa”167. Inoltre, e la torsione sociologica del pensiero di Girard è evidente, nel suo pensiero acquistano grande importanza le nozioni soggettive, implicate dall’ ‘azione’, di scelta, responsabilità, senso, convenzione, evidenza, possibilità, fine, regola, intenzione, motivi, valori, norme, tutte fondamentali anche nella prospettiva ermeneutica.
Per sostenere la possibilità di “una fenomenologia latente nell’antropologia funzionale” si parte da due tesi. Quella secondo cui “ogni rito ha carattere simbolico-ludico, non è funzionale nel suo fulcro, non è produttivo, non è diretto ad altro, non ha uno scopo, è senza rinvii, è in-utile rispetto a tutte le dimensioni funzionali, utilitaristiche, strumentali, sociali e quella (che sta di rincalzo e a complementarietà alla prima) che consiste nell’affermare che proprio in questa dimensione profondamente ludica, inutile, sta l’esperienza della trascendenza e di Dio”168.
Già negli ultimi decenni del secolo scorso l’attenzione degli etnologi fu attratta dalle numerose testimonianze dei nessi che sussistono fra i vari tipi di gioco e di feste e le forme della vita religiosa, soprattutto di taluni riti e cerimoniali che vengono espressamente qualificati come giochi sacri169. Anche gli antropologi hanno intravisto questo lato non funzionale del rito: il senso del “gioco” e la sua “serietà” sono comprensibili solo sullo sfondo del tema del sacrificio. Il gioco, la festa, la gratuità si possono comprendere in tutta la loro valenza antropologica solo se messi in connessione con la liberazione dall’angoscia, come celebrazione dello “scampato pericolo”, della fine della paura o della fatica o dell’oppressione. Nel 1912 anche Durkheim formulava alcune tesi sul rapporto gioco-religione e spiegava la presenza degli elementi ludici all’interno delle religioni come un aspetto specifico delle stesse, le quali hanno anche la funzione di divertire, di offrire una specie di ricreazione ai fedeli170. Scopriva l’elemento essenziale di adesione ad un ‘altro mondo’, ad ‘un’altra realtà’ che è comune sia al rito sia al gioco, nella misura che entrambe si proiettano in una dimensione che è diversa da quella normale. Come tappa fondamentale rimane poi il saggio di Huizinga171 sull’homo ludens, inteso proprio come categoria della specie umana, analoga a quella dell’homo faber o dell’homo sapiens. Huizinga stabilisce la fondamentale identità fra culto e gioco. Per quanto specificamente riguarda il rapporto che ci interessa e prescindendo dalle altre caratterizzazioni del gioco che presenta, va detto che per lui il gioco ha carattere non utilitario, è ‘disinteresse’ poiché è fuori della vita ordinaria e del processo di immediata soddisfazione dei bisognil72. Tutta la sua analisi rappresenta un’identificazione di fondo fra gioco e rito e, alla ricerca di una differenza fra le due manifestazioni, si ricollega, anche se senza dichiararlo, alla tesi di quel “qualche cosa in più o qualche cos’altro”l73 che già Durkheim poneva come indice di differenza tra i fenomeni puramente ludici e quelli ludico-sacrali: dice che si tratta di “un elemento spirituale in più, difficilissimo da definire con precisione”174. Siamo sul piano di ricerca di quella componente inspiegabile, irrazionale, emotiva, emozionale, che gli studiosi precedenti hanno chiamato commozione, solennità, serietà: “nella rappresentazione qualche cosa d’invisibile, d’inesprimibile si concreta in forma reale, bella, sacra”175. Stabilisce anche un prima e un poi nei rapporti fra gioco e culto: “il giocare in sé fu il fatto primario”176 e dentro il gioco viene ad inserirsi il senso di un atto sacro. L’azione sacra di ogni tempo “rimane per alcuni suoi aspetti compresa nella categoria del gioco, ma in tale subordinazione non va perduto nulla della sua sacralità”177.
Un altro tentativo di delineare il rito oltre che rispetto alla ripetitività anche rispetto alla non-utilità si trova in Cazeneuve, al quale “il rito sembra essere un’azione che si ripete secondo regole invariabili e la cui esecuzione non sembra produrre effetti utili”178. Tuttavia rimane il fatto che ricorrere alla categoria dell’utile non aiuta a chiarire completamente il fenomeno religioso in quanto le condizioni che definiscono l’agire rituale e le funzioni che esso soddisfa e i mezzi che impiega rivelano una necessaria pratica propria degli scopi utilitari, così che fra il rito e l’atto utile è possibile osservare anche talune coincidenze179. In questo senso Cazeneuve precisa ulteriormente che “il rito è un atto la cui efficacia (reale o presunta) non si risolve nella concatenazione di causa e effetto. Se è utile, non lo è per vie puramente naturali ed è per questo che si differenzia dalla pratica tecnica”180. A proposito di tale rapporto gioco-rito Girard si rifà a Caillois e alla sua suddivisione dei giochi in quattro categorie che corrispondano ai quattro momenti principali del ciclo rituale181. Si sofferma poi sui giochi d’azzardo che ritiene corrispondono alla risoluzione sacrificale: questi sono i soli giochi veramente specifici dell’uomo, mentre tutte le altre forme di gioco sono presenti anche nella vita animale, anche se “la sola cosa che ‘manca’ al rito animale è l’immolazione sacrificale, e la sola cosa che manca all’animale per diventare umano è la vittima espiatoria”182.
La tesi di Girard si articola partendo da due presupposti di carattere genetico: primo, che i riti sono nati tutti come riti di sacrificio; secondo, che all’inizio vi sarebbe stata una violenza sociale che avrebbe dato avvio ad un accumulo di differenze e di conseguenza ad una catena di vendette. Il sacrificio e il rito avrebbero il compito di porre termine alla situazione originaria di tensione riportando l’armonia nella comunità. Ma in che modo il sacrificio e il rito sarebbero in grado di far compiere all’umanità questo passaggio dalla violenza all’armonia? La soluzione avverrebbe in quanto ci si accorderebbe sulla vittima espiatoria, atta ad interrompere la catena delle vendette. Girard, riferendosi allo studio sul sacrificio di Hubert e Mauss in cui si descrive l’atteggiamento di fronte alla vittima sacrificale183, dice che il sacrificio sarebbe una violenza senza rischio di ulteriore vendetta. Il sacrificio interrompe la violenza grazie ad un capro espiatorio e questo rituale, una volta compiuto, non deve poi ripetersi per un numero infinito di volte. “E’ criminale uccidere la vittima perché essa è sacra… ma la vittima non sarebbe sacra se non la si uccidesse”: questo terrribile e paralizzante circolo si incontra subito quando si esamina la realtà del sacrificio. Nelle Baccanti di Euripide, tragedia greca incentrata sul culto di Dioniso, Girard vede la crisi sacrificale, la “festa che si mette male” con l’annullarsi delle differenze e lo scatenarsi sempre più convulso della violenza184: quando la festa non svolge la sua funzione catartica finisce per prendere una brutta piega ed invece che liberare dalla violenza la incentiva e la aumenta. Sotto tale prospettiva l’antropologo francese vede nella “deritualizzazione” della festa nella società d’oggi (il pensiero corre immediatamente ai “riti” odierni degli stadi) una “non improbabile sindrome di ritorno alla violenza primitiva”. Scrive che “è opportuno osservare che la cecità moderna a proposito della festa, e del rito in genere, non fa che prolungare una certa evoluzione che è quella poi del momento religioso stesso. Via via che si cancellano gli aspetti rituali, la festa si limita sempre più a quella grassa licenza di svago che tanti osservatori moderni hanno deciso di vedere in essa”. Osseva che “la disgregazione dei miti e dei rituali … è provocata da una crisi sacrificale e dietro alle apparenze gioiose e fraterne della festa, priva di qualsiasi riferimento alla vittima espiatoria e all’unità in essa rifatta, non vi è più che il modello della crisi sacrificale e della violenza reciproca”185. Ogni rituale religioso manifesta quindi il suo carattere funzionalistico in rapporto al sociale, anzi, a partire dalla ritualità si può costruire una teoria del sorgere e del maturare di una cultura. Ma Girard mette in guardia: se tutto proviene dal rito, ogni sua alterazione, ogni perdita dell’elemento sacrificale può portare alla distruzione dell’umanità stessa.
Dunque, se il gioco è una dimensione essenziale del rito, quest’ultimo “in questa sua peculiarità non appare più manipolabile dall’antropologia funzionale. … Ma in che modo l’in-utilità del rito può parlarci del valore originario del rito stesso, in ordine all’esperienza di Dio? … Che cos’è propriamente senza rinvio e inutile? L’inutile per eccellenza è appunto Dio, il quale non ammette rinvii, non tende ad altro… E in questa ritrovata dimensione ludica-rituale l’esperienza di Dio sarà presente, sarà anzi incontenibile”186. Si è visto come nella visione antropologico-funzionalista vi sia attenzione unicamente per ciò che la religione compie, non per ciò che significa. “L’antropologia funzionale, in definitiva, deve almeno rendersi consapevole che essa studia ciò che la religione ‘fa’, non ciò che la religione ‘è’, problema quest’ultimo che essa deve lasciare aperto per le altre metodologie di ricerca”187: per la fenomenologia della religione che ha come punto focale “la concezione del sacro come di una realtà non del tutto razionale“188. Questo elemento permetterà alla fenomenologia di salvaguardare la specificità della religione contro tutti i tentativi di spiegazione ‘scientifica’ e contro tutte le tendenze riduzionistiche della religione ad altra cosa189. Mysterium, tremendum, fascinans, augustum: con questi concetti si può cercare, sulle orme di Rudolf Otto190, di definire l’esperienza del sacro i cui elementi sono tra loro connessi nel modo più avvincente ed efficace proprio nel rituale sacrificale. Se “soltanto dove c’è esperienza del sacro vi è ritualità”191 e se il rito, in quanto non-funzionale nella sua qualità di ‘gioco’ sfugge alle analisi dell’antropologia funzionale, allora la tesi fenomenologica, del resto latente nell’ antropologia funzionale, è ”la vera alternativa antropologica”192.
MIMETISMO E RIVELAZIONE
A cura di Angelo Pianca
Girard in primo luogo definisce la natura umana come mimetica poiché le azioni delle persone sono intraprese esclusivamente in quanto viste fare da un modello. L’uomo è l’individuo desiderante per eccellenza, ogni suo movimento si basa sull’essere secondo l’altro, sull’omologarsi ai costumi, alle mode, ai pensieri e alle azioni di chi gli sta accanto. Si può constatare come la differenza principale tra persona ed animale, non consista essenzialmente nell’intelligenza, ma nella natura dei movimenti: si parla quindi di mero appetito che guida la bestia e di desiderio che definisce l’uomo. Il concetto di desiderio è totalmente diverso da quello di appetito: si vuole qualcosa perché la vuole anche l’altro, è il principio mimetico che muove l’individuo nella sua socialità. L’animale invece agisce secondo appetiti dettati dall’istinto, l’uomo invece osserva e successivamente imita. Ad esempio il fatto che in un certo periodo storico si sia preferito un determinato tipo di vestiario e in un altro uno del tutto opposto non significa che i gusti delle persone si siano modificati in quanto l’essenza di un dato abito non piace più qualche anno dopo, ma perché la tendenza generale della maggioranza è propensa verso un altro modello di abito in quel preciso momento. Le cose che noi vogliamo avere non le desideriamo in sé, ma perché sono possedute dal singolo modello a cui ci omologhiamo. Si parla poi di rapporto triangolare per intendere quella situazione che vede un individuo desiderare di possedere un oggetto che un altro dispone. C’è quindi uno stretto rapporto tra persona desiderante-oggetto desiderato-modello imitato tale da provocare inevitabilmente uno scontro nel momento in cui l’oggetto non sia divisibile e usufruibile da entrambi. Girard parla infatti di modello-ostacolo quando esso impedisce ad un terzo il godimento di una cosa o di una persona unica.
Dopo aver brevemente delineato il presupposto su cui è costruito il pensiero dell’antropologo francese, presupposto che sarà adottato anche da Eric Gans come si vedrà successivamente, è ora necessario introdurre il tema che interessa primariamente la mia “ricerca”: il meccanismo vittimario o del capro espiatorio. Intendo infatti sostenere la vicinanza del pensiero girardiano alle posizioni di molti filosofi del diritto ed in modo particolare a quelle che sanciscono la centralità della persona, l’inviolabilità dei diritti umani, la necessità di un sistema giuridico garantista, del giusto processo e dell’abolizione di ogni aspetto processuale che rappresenti una “giustizia” sommaria ed arbitraria. Girard afferma che il sacro, la religione ed i miti nascono in seguito al processo vittimario che si concretizza in specifiche situazioni in cui si trova la comunità sociale. E queste determinate situazioni non sono altro che momenti di grave crisi intestina che mina la solidità del gruppo umano e la sua stessa sopravvivenza. Ad esempio una grave carestia o una pestilenza. Sono periodi che sconvolgono la tranquilla esistenza delle persone che, incapaci di farvi fronte, necessitano di un escamotage grazie al quale ricomporre la crisi riconciliando gli animi. Qui entra in gioco la trascendenza che si manifesta all’interno del meccanismo vittimario che ora delineerò. Girard propone questa teoria antropologica analizzando i comportamenti umani durante una crisi collettiva. Conclude che in ogni occasione simile ci si trova di fronte ad una precisa tipologia di risoluzione del problema che funziona così: le singole rivalità tra gli uomini degenerano velocemente dando vita ad un desiderio unanime e indifferenziato di vendetta. Il propagarsi del sentimento di vendetta è definito come contagio mimetico che si spande a macchia d’olio all’interno della comunità colpendo qualsiasi cittadino anche il meno coinvolto. Successivamente viene a costituirsi una folla contagiata pronta a scegliere una singola vittima contro cui polarizzare tutto l’odio generatosi. E’ interessante soffermarsi su questa folla: ci troviamo di fronte ad una massa di uomini che, esasperati dalla crisi interna, si uniscono in preda a frenesia mimetica in quanto l’essere secondo l’altro fa in modo che da un gruppo ristretto e circoscritto di “contestatori” si passi alla formazione di una collettività pronta a lasciarsi andare ad un episodio di violenza. Una volta individuata la vittima essa viene sacrificata, linciata dalla comunità in preda a mimetismo violento e degenerato ed in seguito a questo atto finale si verificherà la ricomposizione della situazione conflittuale. E’ ora necessario approfondire il sistema vittimario considerando i motivi che portano alla scelta dello specifico capro espiatorio e il motivo per cui la folla non si sottragga dal compiere un atto barbaro contro un proprio simile. Innanzitutto Girard, analizzando sia singoli miti e soprattutto molteplici eventi storici, è giunto alla conclusione che la folla in preda a frenesia mimetica sceglie le proprie vittime non in base ad un criterio di colpevolezza provata, ma a seconda di caratteristiche fisico-biologiche. Quindi non si ricorre ad un normale procedimento incriminante tipico dei processi democratici, ma ci si scaglia contro un individuo che, da una prima analisi esteriore, è la causa potenziale della crisi che ha investito la comunità. Basti ricordare le accuse agli ebrei di aver contaminato le città diffondendo la peste: già in partenza i Giudei sono visti in modo tutt’altro che positivo dalla maggiorparte delle varie congregazioni civili e sarà sufficiente una testimonianza anche falsa o lacunosa per far scatenare la vendetta della folla. Un altro esempio è dato dalla persecuzione dei minorati, o degli stessi ebrei da parte dei nazisti: persone inermi ma accusate di corrompere la purezza della razza ariana cavallo di battaglia delle teorie nazionalsocialiste. Come si vedrà più avanti il meccanismo vittimario, seppur implicito, è magistralmente descritto da Manzoni sia nei Promessi Sposi sia nella Storia della colonna infame in merito alle condanne dei presunti untori. Tuttavia non è sufficiente un mero difetto fisico per scatenare la violenza della massa accecata dal mimetismo. Infatti, considerando ad esempio lo specifico episodio degli untori si può notare come solo dopo le testimonianze, poco importa se fallaci ed assurde, i singoli accusati vengono “processati” e condannati: è necessaria la parvenza, anche minima, di colpevolezza per dare vita alla scintilla che porta all’immolazione. Nella parte dedicata a Manzoni sarà esposto più dettagliatamente questo meccanismo mettendo in risalto la potenza del contagio mimetico: dalla testimonianza di due sole donne si arriverà a raccogliere un vero e proprio dossier di accuse rilasciate da svariati cittadini, questo è spiegabile perché ciascuno, imitando il modello iniziale, in una situazione di crisi quale la pestilenza, fa di tutto per ricordare anche un episodio minimale tale da incriminare il presunto untore; saranno formulate accuse anche perché il sospettato è stato visto camminare in modo strano. E’ evidente come in momenti di crisi intestina il rapporto triangolare non provochi la rivalità tra persona desiderante e modello invidiato perché tutti si riconoscono danneggiati allo stesso modo e in cerca di giustizia allo stesso modo: tutti sono in quest’occasione amici di tutti anche se nella quotidianità spesso non è così. Il contagio mimetico comporta questo tipo di aggregazione apparentemente spontanea. La folla una volta scelta la propria vittima è unita e sicura che il sacrificio di essa sia giusto e soprattutto utile alla ricomposizione della crisi. Questo perché, una volta contagiati, gli uomini sono letteralmente accecati e perciò incapaci di rendersi conto del male che stanno andando a fare, dell’estrema ingiustizia ed infondatezza della violenza contro il capro espiatorio. Ma il motivo principale è che il meccanismo vittimario ha sempre funzionato da quando vi si è ricorsi: la situazione conflittuale è sempre stata ricomposta, seppur momentaneamente, consentendo la conciliazione delle genti. Viene spontaneo chiedersi come mai il meccanismo vittimario riesca a riportare la pace tra gli uomini attraverso un omicidio o un’espulsione dalla comunità. Bisogna analizzare il modo in cui viene sacrificata la vittima e la successione degli eventi dopo l’esecuzione dell’atto. Si rende però necessario, in questo momento, specificare come se da un lato la prima fase del processo vittimario fin qui esaminata sia uguale per qualsiasi singolo episodio di tale natura, dall’altro è differente invece la fase conclusiva a seconda se si prende in considerazione un episodio mitologico o un episodio avvenuto in età cristiana dove per età cristiana s’intende tutta la storia dell’umanità che inizia con la Rivelazione, con il messaggio di Cristo e dei Vangeli. Di questo tratterò a breve. Girard afferma che il denominatore comune dei vari miti consiste in due transfert: il primo, detto anche transfert di aggressività, consiste nella lapidazione o l’espulsione della vittima da cui deriva un beneficio concreto per l’intera comunità (la ricomposizione della crisi e la seguente pace, seppur temporanea), mentre il secondo, detto transfert di divinizzazione, pone fine al processo e consiste nella venerazione della vittima immolata da parte della comunità riappacificata, venerazione giustificata dal potere conciliatorio del capro espiatorio. “Le divinizzazioni mitiche si spiegano perfettamente per opera del ciclo mimetico, e si basano sulla capacità che hanno le vittime di polarizzare la violenza. (…) Se il transfert che demonizza la vittima è potentissimo, la riconciliazione che ne consegue è così improvvisa e perfetta da apparire miracolosa e da suscitare un secondo transfert che si sovrappone al primo, il transfert di divinizzazione della vittima”[1]. Il problema che nasce ora è molto rilevante: infatti, come ho sopra sottolineato, quasi sempre le tregue conseguite con il meccanismo vittimario sono temporanee, di breve durata. Ne consegue quindi un nuovo ricorso al capro espiatorio e così via in una serie di violenze ininterrotte. Secondo Girard è a causa di questo risvolto temibile che si rende necessario un intervento dall’esterno di qualcuno capace di svelare il processo vittimario rendendo i membri delle folle consci del male che vanno a fare e dell’inutilità di simili episodi di violenza arbitraria. Tuttavia per svelare ciò si deve essere immuni al contagio mimetico che colpisce gli uomini in modo da osservarne il funzionamento per poi descriverlo e rendere dotte le persone “accecate”. E’ chiaro come una persona con tale capacità debba essere meta-umana poiché uno degli aspetti consustanziali all’individuo è quello di essere preda del mimetismo, si prospetta perciò un intervento della trascendenza. E questa persona è Gesù, la seconda persona della Trinità che è uomo e allo stesso tempo fatto della stessa sostanza del Padre. Si può già adesso intuire il ruolo primario e fondamentale dei Vangeli e della Bibbia all’interno della storia dell’umanità. Tuttavia è ancora prematuro trattare in modo dettagliato ed approfondito del ruolo di Cristo nel pensiero girardiano in quanto è preferibile proporre un paio di esempi concreti di meccanismo vittimario estraneo alla Rivelazione cristiana per poi meglio comprendere l’innovazione e le caratteristiche di questo evento memorabile che ha segnato la storia del mondo.
Girard in più d’un libro presenta come chiaro paradigma di capro espiatorio l’episodio della lapidazione di Efeso narrato da Flavio Filostrato nel suo testo “Vita di Apollonio di Tiana”. In questo libro sono raccolte le descrizioni dei momenti più significativi della vita di questo guru del II sec. d.C. che fu successivamente citato addirittura dai gruppi pagani come esempio inconfutabile della superiorità della loro religione rispetto al Cristianesimo. Innanzitutto la lapidazione di Efeso è posta in essere in un periodo in cui la città è assalita da una tremenda pestilenza tale da mietere moltissime vittime trai cittadini. Ecco il presupposto fondamentale: una grave crisi interna irrisolvibile attraverso normali procedure che mette in pericolo la sussistenza della stessa comunità. Leggiamo poi queste righe tratte dall’opera di Filostrato: ” -Fatevi coraggio, perché oggi stesso metterò fine a questo flagello- (la pestilenza). E con tali parole condusse (Apollonio) l’intera popolazione al teatro, dove si trovava l’immagine del dio protettore. Lì egli vide quello che sembrava un vecchio mendicante, il quale astutamente ammiccava gli occhi come se fosse cieco, e portava una borsa che conteneva una crosta di pane; era vestito di stracci e il suo viso era imbrattato di sudiciume. Apollonio dispose gli Efesi attorno a sé, e disse: -Raccogliete più pietre possibili e scagliatele contro questo nemico degli dei-. Gli Efesi si domandarono che cosa volesse dire, ed erano sbigottiti dall’idea di uccidere uno straniero così palesemente miserabile, che li pregava e supplicava di avere pietà di lui. Ma Apollonio insistette e incitò gli Efesi a scagliarsi contro di lui e a non lasciarlo andare. Non appena alcuni di loro cominciarono a colpirlo con le pietre, il mendicante che prima sembrava cieco gettò loro uno sguardo improvviso, mostrando che i suoi occhi erano pieni di fuoco. Gli Efesi riconobbero allora che si trattava di un demone e lo lapidarono sino a formare sopra di lui un grande cumulo di pietre. Dopo qualche momento Apollonio ordinò loro di rimuovere le pietre e di rendersi conto di quale animale selvaggio avevano ucciso. Quando dunque ebbero riportato alla luce colui che pensavano di aver lapidato, trovarono che era scomparso, e che al suo posto c’era un cane simile nell’aspetto a un molosso, ma delle dimensioni di un enorme leone. Esso stava lì sotto i loro occhi, spappolato dalle loro pietre, e vomitando schiuma come fanno i cani rabbiosi. A causa di questo la statua del dio protettore, Eracle, venne posta proprio nel punto dove il demone era stato ammazzato”. Ho messo in evidenza graficamente alcune parole significative dalle quali si possono comprendere i meccanismi classici del sistema vittimario. Questo brano rappresenta chiaramente come in seguito ad una situazione di grave crisi intestina (pestilenza) la folla in preda al panico si fa plagiare da un individuo, Apollonio, al quale sono attribuiti strani poteri magici. Tuttavia l’elemento fondamentale è che Apollonio, conoscendo molto bene il funzionamento del sistema del capro espiatorio, si pone nei confronti della città in modo emblematico: convince la gente che uccidendo un singolo individuo i problemi sarebbero scomparsi. Infatti una volta scelta la vittima riesce facilmente a far vedere alla folla oramai contagiata dal mimetismo (si comporta come vuole il guru) quello che egli stesso vuole che sia osservato, ossia che non si tratta di un uomo ma di un demone che in quanto tale è responsabile della pestilenza e dell’odio verso la comunità. Non a caso il capro espiatorio scelto è un mendicante straniero, vestito di stracci, sporco e apparentemente cieco. Rappresenta quella tipologia di persona che sta agli antipodi della comunità sociale, è il classico emarginato mal visto in genere da tutti. Proprio per questo gli Efesi possono convincersi della colpevolezza del pover’uomo, se fosse stato invece una persona di spicco non sarebbe probabilmente scattata alcuna scintilla tale da innescare l’atto violento. A riprova di ciò in un primo momento i cittadini non capiscono perché debbano ammazzare barbaramente, senza prove, il mendicante, rimangono sbigottiti ed increduli e sembra che Apollonio non riesca nel suo intento. Ora si presenta un altro problema: perché la folla unanime si scaglia improvvisamente contro la vittima lapidandola? Perché dopo le pressanti parole di Apollonio che tendono a distogliere l’attenzione dall’atto violento in sé parlando del mendicante come nemico degli dei qualcuno scaglia la prima pietra, qualcuno maggiormente contagiato e non di meno plagiato compie il gesto fondatore auspicato dal fomentatore? Successivamente tutti gli altri imitando il modello appena creatosi diventano talmente sicuri della colpevolezza dell’individuo che scorgono nei suoi occhi il fuoco, un segno demoniaco che accresce ancor più i sospetti: ora non resta che completare la lapidazione. Il brano si conclude con la ricomposizione del conflitto, con la conciliazione della folla ed un sentimento di giustizia che è stata fatta. Non bisogna sottovalutare la presenza nel testo della figura di Eracle: come visto sopra il meccanismo vittimario dei miti prevede un transfert di divinizzazione che permette, attraverso il riconoscimento della trascendenza della vittima, di nascondere e di far passare in secondo piano il transfert violento e barbaro cosicché la folla non comprenda il male commesso così da permettere un’ulteriore ricorso al capro espiatorio quando sarà richiesto. Tuttavia il “miracolo” di Apollonio non rientra nella tipologia dei miti classici, come ad esempio il Dionisismo, ma presenta delle differenza essenziali che lo rendono un mito incompleto e di conseguenza incapace di nascondere pienamente la violenza commessa dalla massa. Infatti dopo la lapidazione gli Efesi non sembrano riconoscere al mendicante ucciso, anzi all’animale che sembra aver preso il suo posto, alcuna forza divina. Ed è proprio per questo che viene subito posizionata la statua di Eracle sul posto. Non ci si trova di fronte ad un meccanismo completo e spontaneo, ma ad un abbozzo di mito che proprio per questa deficienza permette di rendere ancor più chiara e comprensibile a noi la barbaria e l’aggressività esperita contro il capro espiatorio.
Adesso è necessario parlare brevemente del Dionisismo per comprendere quale sia l’essenza di un mito “originale”, le differenze con la lapidazione di Efeso e soprattutto la necessità dell’intervento salvifico dei Vangeli.
Girard, prima di parlare dei Baccanali, premette che per afferrare pienamente tale fenomeno bisogna esporre il significato antropologico delle feste. Le persone, nelle feste più generali, si riuniscono accomunate da caratteristiche comuni quali l’appartenenza ad un gruppo di amici, ad una società precisa ecc. e all’interno del “convivio” le differenze tra i vari partecipanti vengono a mancare in quanto tutti sono uguali e partecipi della festa. Notiamo quindi uno stato di comunione di idee, azioni e quant’altro si vuole. La caratteristica più importante del ritrovarsi insieme consiste nella trasgressione: i limiti imposti dalla vita quotidiana in cui ognuno occupa un ruolo per così dire istituzionale passano ora in secondo piano permettendo il realizzarsi di azioni fuori dal normale che infrangono regole, divieti o anatemi imposti ad esempio dalla morale o dal ruolo ricoperto. La festa rappresenta il gioco della violenza attraverso la trasgressione: “In quasi tutte le società vi sono feste che conservano a lungo un carattere rituale. L’osservatore moderno vi ravvisa soprattutto la trasgressione dei divieti. (…) La trasgressione va iscritta nel quadro più vasto di un generale annullamento delle differenze: le gerarchie familiari e sociale sono temporaneamente soppresse o invertite. I figli non obbediscono più ai genitori, i domestici ai padroni, i vassalli ai signori. (…) L’annullamento delle differenze, come ci si può aspettare, è spesso associato alla violenza e al conflitto. (…) Imperversano i disordini e la contestazione”[2]. Tale analisi antropologica è valida anche per i Baccanali identificati da Girard come feste i cui elementi sociali sono stati sopra elencati. Le baccanti costituiscono un gruppo di persone unite dalla comunione con Dioniso raggiungibile attraverso il rituale descritto magistralmente da Euripide nella sua celebre tragedia. Ecco perché la festa mantiene sempre il proprio carattere rituale anche se in vari gradi di importanza ed evidenza. Nel caso specifico il tema dell’opera euripidea consiste nel rito bacchico, nello sparagmoV del capro espiatorio. Il carattere festivo dei Baccanali è evidente in quanto i vecchi si confondono con i giovani, le donne con gli uomini tradizionalmente superiori, ma esclusi da questo rito, i belli con i brutti. Questo è permesso dalla potenza unificatrice del dio: attraverso un potente contagio mimetico posto in essere dalla “sue fedeli” baccanti asiatiche che imperversando a Tebe ne introducono il culto. Dioniso è conscio di quello che va a fare, egli vuole contagiare le tebane per farsi riconoscere dio a tutti gli effetti da Penteo, re della città, il quale si ostina a non volerlo venerare. Si crea di conseguenza un rapporto conflittuale iniziale tra Penteo e Dioniso, rapporto che avrà il proprio epilogo tragico con l’immolazione del re da parte delle baccanti accecate dall’estasi dionisiaca che altro non è che il contagio mimetico come descritto da Filostrato nella Vita di Apollonio. Come gli Efesi accecati vedono nel mendicante un demone, così le Menadi tebane, anch’esse accecate, scambiano Penteo con un animale (in questo caso un leone), animale che costituisce il capro espiatorio di ogni rituale dionisiaco. Tra Bromio (sinonimo di Bacco) ed il re di Tebe intercorre una rivalità tipica dei doppi: l’uno odia l’altro, ma ne è necessariamente attratto per il raggiungimento del proprio scopo. In questo caso la superiorità del dio, trascendente, è rivelata in quanto egli, immune al contagio mimetico e fondatore di esso, attende il passo falso di Penteo, umano e aperto al contagio, che ad un certo punto non resiste dal restare escluso dal rituale segreto e misterioso che si svolge alla porte della città. Ecco che le Menadi vedono in lui, uomo, il capro espiatorio perfetto: quella persona pericolosa per l’unità del gruppo. Il baccanale sul Citerone quindi degenera, com’è potenzialmente possibile in una normale festa, nella violenza: Penteo viene smembrato consentendo alle Menadi di venire in comunione con il proprio dio e terminare il rituale. Ecco il doppio transfert automatico ed inconscio che qualifica come mito il Dionisismo: all’immolazione del capro espiatorio (transfert dell’aggressività) segue il riconoscimento della trascendenza della vittima che consente la comunione con Dioniso attraverso il corpo smembrato (transfert di divinizzazione spontaneo). Il dio ha raggiunto il proprio scopo: farsi vendetta. Un primo raffronto tra i due esempi concreti qui riportati riguarda la vittima; il medicante di Efeso appare a tutti innocente, mentre Penteo è in qualche modo doppiamente colpevole, da un lato di non venerare una divinità, dall’altro di aver infranto le regole del baccanale travestendosi da donna per parteciparvi: la violenza conclusiva appare giustificata. Le baccanti, ad eccezione di Agave, al risveglio dall’estasi dionisiaca non si rendono conto del male fatto in quanto la comunione con Dioniso ha nascosto tale meccanismo. Si può notare come fino a questo momento i miti per raggiungere la pace sociale scacciano la violenza con altra violenza. Non è presente né un processo alla vittima, né la possibilità per essa di difendersi: se questo fosse consentito allora il mito non sarebbe concluso, il disordine sociale imperverserebbe ancora. Ma non può essere possibile nemmeno una società votatasi alla violenza totale.
Ed ecco il ruolo fondamentale di Cristo: egli essendo della stessa sostanza del Padre, possedendo un’essenza metafisica è immune al contagio mimetico potendo così osservare il meccanismo vittimario dall’esterno in modo tale da svelarne la violenza, la barbaria, il male e l’insensatezza. I Vangeli perciò spazzano via i miti rivelandone il meccanismo, rivelando che la vittima sacrificata ingiustamente non è colpevole, non deve essere immolata poiché la violenza non scaccia la violenza, ma la crea, contribuisce a costituire un circolo vizioso nel segno della violazione dei diritti umani. Il capro espiatorio è anch’esso una persona, è una creatura di Dio. Girard analizza, nella sua ultima opera[3], i Vangeli dal punto di vista antropologico sottolineando il primato dell’insegnamento Giudaico-Cristiano che si vota al rispetto della persona, alla tutela delle vittime innocenti e immolate ingiustamente: “La Resurrezione di Cristo corona e porta a termine il sovvertimento e la rivelazione della mitologia, dei riti, di tutto ciò che assicura la fondazione e la perpetuazione delle culture umane. I Vangeli rivelano tutto quello di cui gli uomini hanno bisogno per comprender la loro responsabilità nelle infinite violenze della storia umana e nelle religioni menzognere che ne derivano. (…) L’elaborazione mitica si fonda su un’ignoranza, anzi su un’inconsapevolezza persecutoria che i miti non arrivano mai a identificare, dal momento che ne sono dominati”[4]. Bisogna però specificare che Girard non è un autore metafisico, ma che analizzando antropologicamente i comportamenti umani, si rende conto dell’eccezionale “scoperta” che i Vangeli e la Bibbia fanno sempre su un piano meramente antropologico.
L’autore francese identifica l’età pre cristiana (quella dei miti) con il Regno di Satana: Satana è il portatore di violenza per eccellenza, è il padre dei miti e della menzogna, è il fondatore del meccanismo vittimario in quanto lo sostiene e ne è il fondamento. Cristo si rivolge così alle genti parlando di Satana: “Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” (Gv.8, 43-44). Non bisogna però intendere Satana dal punto di vista religioso, ma da quello meramente antropologico: egli è il portatore di scandali per eccellenza dove per scandalo s’intende il meccanismo vittimario e le sue inevitabili conseguenze tragiche. Satana è, prendendo alla lettera i testi evangelici, il Re delle Tenebre: secondo Girard le tenebre non sono altro che una metafora per indicare la condizione di accecamento della folla in preda a frenesia mimetica che non sa quello che fa! Ecco perché Cristo in punto di morte chiede perdono per i suoi aguzzini che non sanno quello che fanno: sono ancora incapaci di comprendere il male che vanno a commettere e che le folle hanno commesso in secoli di storia caratterizzata dai miti e dal processo vittimario. “E’ la famosa frase che Gesù pronuncia dopo essere stato crocefisso: -Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno- (Luca, 23, 34). Come per le altre frasi di Gesù, dobbiamo guardarci dallo svuotare queste parole dal loro senso fondamentale riducendole a una formula retorica, a un’iperbole lirica. Ancora una volta bisogna prendere Gesù alla lettera. Egli descrive l’incapacità, da parte della folla scatenata, di vedere la frenesia mimetica che la scatena. I persecutori credono di << far bene >> e sono convinti di operare per la verità e la giustizia, credono di salvare in tal modo la loro comunità”[5]. Ma come riesce Gesù a svelare il meccanismo vittimario consentendo agli Apostoli di descriverlo nella sua brutalità nei Vangeli? Girard per rispondere a questa essenziale domanda analizza la persecuzione di Cristo da un punto di vista antropologico raffrontandola con il classico processo del capro espiatorio tipico della mitologia. Innanzitutto sostiene che fino al momento della Resurrezione il procedimento è quasi uguale: la comunità giudaica si sente minacciata dalle predicazioni di Cristo ed individua in lui un perfetto capro espiatorio. Pilato, comprendendo la situazione critica venutasi a creare, preferisce assecondare la folla ostile a Gesù mettendo la sua sorte in mano al popolo. In preda a frenesia mimetica il popolo, unanime, lo condanna a morte. Anche i discepoli sembrano essere inglobati nel contagio mimetico: infatti Pietro rinnega il suo Maestro non volendo contestare l’opinione comune nel rischio di essere immolato anch’egli. Tuttavia la vera unicità del messaggio cristiano sta nella Resurrezione: se il primo transfert, quello dell’aggressività è stato compiuto, quello conclusivo invece viene evitato, per la prima volta il meccanismo vittimario è sconfitto, Satana è stato sconfitto. Già il Venerdì Santo i fenomeni atmosferici descritti dai Vangeli al momento della morte di Cristo fanno sorgere una minoranza contestataria: alcuni persecutori si rendono conto del proprio errore, capiscono che hanno commesso un atto ingiustificato, riconoscono l’unicità di colui che hanno crocefisso. Ma questo non sarebbe sufficiente. Dopo tre giorni Gesù appare, Risorto, agli Apostoli, porta con sé il dono della Grazia, lo Spirito Santo, la Redenzione dell’umanità colpevole per secoli di aver messo a morte o espulso ingiustamente dei loro simili, degli uomini anch’essi figli di Dio. Attraverso i Vangeli Matteo, Marco, Luca e Giovanni fanno conoscere il messaggio di Cristo, rendono consapevoli le comunità della falsità del Regno di Satana (mitologia, processo vittimario) e del primato del Regno di Dio che è il Regno dell’Amore, del Perdono, della vita pacifica, del riconoscimento dei diritti umani, del riconoscimento dell’inviolabilità della persona in quanto creatura divina. Non ci devono essere più vittime espiatorie, mai più sacrifici inconsistenti e ininfluenti per il raggiungimento della pace sociale. Il Cristianesimo segna il trionfo della Croce e la sconfitta di Satana che “cade come la folgore”, vede infrangere il suo principato votatosi alla violenza mimetica: “Il trionfo della Croce non è ottenuto in alcun modo con la violenza, ma al contrario è il frutto di una rinuncia così totale alla violenza che quest’ultima può scatenarsi a sazietà su Cristo, senza sospettare di rendere palese proprio con il suo comportamento ciò che le sarebbe vitale nascondere, senza sospettare che tale scatenamento le si ritorce stavolta contro, perché sarà registrato e rappresentato nella maniera più esatta nei resoconti della Passione (i Vangeli)”[6]. Ed ancora: “La sofferenza sulla Croce è il prezzo che Gesù accetta di pagare per offrire all’umanità questa rappresentazione vera dell’origine di cui resta prigioniera, e per privare a lunga scadenza il meccanismo vittimario della sua efficacia”[7]. Qualora non ci fossero stati i Vangeli l’umanità sarebbe tutt’ora sottoposta ai processi che culminano con il sacrificio del capro espiatorio, con atti di pseudo-giustizia sommaria, con atti di usurpazione del potere: “E’ laddove non è rappresentata che la frenesia mimetica può esercitare un ruolo generatore per il fatto stesso che non è rappresentata. (…) Le società mitico-rituali sono prigioniere di una circolarità mimetica alla quale non possono sottrarsi proprio perché non la identificano”[8]. Gesù, con i suoi comportamenti, istituisce un contro-modello cristiano che, opponendosi a quello tipico della mitologia, fa sì che chi lo segue interrompe il ciclo di violenza satanico infrangendo la barriera della folla unanime che si scaglia contro il capro espiatorio. Per la prima volta una minoranza contestataria segue Cristo e non la folla, segue il modello buono. Imitare Cristo significa imitare indirettamente Dio.
Oltre alle sostanziali differenze che ho fin qui menzionato Girard sostiene che se da un lato nei miti la narrazione vede come soggetto la folla scatenata contro una vittima colpevole, i Vangeli invece narrano le vicende di Cristo, soggetto, come vittima innocente sacrificata per il bene dell’umanità. Si potrebbe pensare che anche la Crocifissione faccia parte del meccanismo “violenza scaccia violenza” e ciò non è sbagliato, ma se nella mitologia questo circolo è infinito, sempre necessario, con la morte di Gesù invece esso ha termine una volta per tutte: la violenza tutti contro uno non sarà più, almeno in teoria, fondamentale, Cristo ha rivelato ed introdotto il Regno dell’Amore di Dio, del rispetto per la persona umana ei suoi diritti.
Tuttavia la storia sembrerebbe contraddire la teoria girardiana: analizzando ad esempio le persecuzioni razziali, l’Olocausto, i processi per stregoneria ed i roghi medievali si potrebbe concludere che il messaggio di Gesù è stato ininfluente e insignificante. Queste sono infatti le maggiori argomentazioni utilizzate da chi si oppone al Cristianesimo definendolo una religione che non condanna la violenza e che non presta la dovuta attenzione alle vittime sacrificali. Tuttavia l’antropologo francese specifica come queste accuse non sussistano: la rivoluzione concreta operata dai Vangeli e dalla Bibbia consiste nell’aver formato una minoranza contestataria, anche esigua come ad esempio erano ab origine gli Apostoli, capace di riconoscere i tentativi di meccanismo vittimario (consustanziali all’uomo) e di conseguenza ferma nel condannarli. Qualora non ci fossero stati gli anti nazisti il progetto di Hitler avrebbe trionfato: il mondo avrebbe visto lo sterminio degli Ebrei come un qualcosa di giusto e necessario! Lo stesso vale per i roghi medievali condannati attualmente dal Santo Padre che più d’una volta ha chiesto perdono per la morte di vittime innocenti. Ed è in questo frangente che si deve introdurre il discorso sul sistema giuridico a cui Girard dedica varie pagine nelle sue opere. Innanzitutto afferma quanto segue: “Esaminiamo in primo luogo il piatto della bilancia che contiene i nostri successi: dall’alto Medioevo in poi, tutte le grandi istituzioni umane si evolvono nel medesimo senso, il diritto pubblico e privato, la legislazione penale, la pratica giudiziaria, lo statuto giuridico delle persone. All’inizio tutto si modifica assai lentamente, ma il ritmo si accelera sempre più nel corso del processo e, se esaminiamo le cose nel loro insieme, vediamo che l’evoluzione va sempre nella stessa direzione, l’addolcimento delle pene, la protezione crescente delle vittime potenziali. La nostra società ha abolito la schiavitù e poi l’asservimento. (…) Ogni giorno si varcano nuove soglie. (…) L’unica voce sotto la quale si può raccogliere ciò che sto qui sintetizzando alla rinfusa, e senza alcuna pretesa di completezza, è la preoccupazione verso le vittime”[9]. Questa preoccupazione per le vittime innocenti è in linea con quanto il Regno di Dio prevede ossia il perdono ed il rispetto reciproco. E di conseguenza tali aspetti andranno sicuramente a costituire i molteplici sistemi giuridici tipici dello stato democratico fondato grazie all’insegnamento cristiano.
Girard sostiene che la funzione principale del sistema giuridico è quella di allontanare il grave pericolo della vendetta in quanto, basti considerare le società arcaiche, qualora sia innescato un meccanismo di giustizia privata basato sul ricambiare il torto subito tale spirale di violenza sarà potenzialmente interminabile. Si darebbe avvio così ad un blood feud, ad una concatenazione di singoli episodi di vendetta che potrebbero portare all’estinzione della comunità sociale: “C’è un circolo della vendetta che noi non sospettiamo neppure a qual punto gravi sulle società primitive. Per noi tale circolo non esiste. Perché un simile privilegio? A questa domanda è possibile offrire una risposta categorica sul piano delle istituzioni. E’ il sistema giudiziario che allontana la minaccia della vendetta. Non sopprime la vendetta: la limita effettivamente a una rappresaglia unica il cui esercizio è affidato a un’autorità suprema e specializzata nel suo campo. Le decisioni dell’autorità giudiziaria s’impongono sempre come l’ultima parola della vendetta”[10]. Come si può notare per l’antropologo francese, anche all’interno delle istituzioni giuridiche, è praticata una particolare tipologia di vendetta: una vendetta pubblica, che più che vendetta è preferibilmente definibile come tutela degli interessi statali e della comunità in generale. Un sistema che non preveda alcuna pena sembra una mera utopia, infatti sarebbe plausibile solo qualora l’uomo vivesse nel rispetto dei diritti altrui, in pace e concordia, ma tale ipotesi è subito scartata perché sia sulla base delle teorie ad esempio di Hobbes, Locke o Rousseau, sia soprattutto in base al pensiero girardiano possiamo realizzare come l’uomo non sia un essere buono di natura, ma aperto ai conflitti. Poco importa che questi conflitti derivino da guerre intestine, o dalla minaccia al diritto di proprietà, o dal degenerare di rapporti mimetici triangolari. Quello che importa è ribadire che una società priva di organi giurisdizionali garanti della pace, del rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali non può esistere senza lo spettro di conflitti bellici interpersonali. Quello ipotizzato da Girard sembra essere uno stato basato sui principi dello stato di diritto quali separazione dei poteri, sovranità impersonale della legge e rispetto della persona umana poiché solo uno stato democratico è in grado di garantire un potere indipendente e sovrano alla magistratura in modo tale da far sì che le sentenze siano definitive, accettate da tutti e di conseguenza tutrici dei diritti della comunità. La magistratura ha il monopolio della violenza, è l’unico organo titolare del potere di emettere condanne per prevenire cicli infiniti di vendette private. Le sentenze si rifanno così all’idea di giustizia assoluta, a quel principio supremo che consente, per il bene del popolo, il ricorso alla violenza, ad una violenza legale, legittima e trascendente proprio perché ispirata da un’idea assoluta.
Successivamente sono degne di nota le seguenti parole: “Nel sistema penale non vi è alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta. E’ il medesimo principio ad agire nei due casi, quello della reciprocità violenta, della retribuzione. O tale principio è giusto e la giustizia è già presente nella vendetta, oppure non c’è giustizia in nessun caso. Di colui che si fa vendetta da solo, la lingua inglese asserisce: He takes the law into his own hands << prende la legge nelle sue stesse mani >>. Non c’è differenza di principio tra vendetta privata e vendetta pubblica, ma vi è un’enorme differenza sul piano sociale: la vendetta pubblica non è più vendicata; il processo è finito; il pericolo di escalation è scongiurato”[11]. Ecco l’innovazione proposta dalle società civili: impedire un circolo vizioso e potenzialmente fatale di singole vendette private intraprese dai vari gruppi familiari delegando la funzione giurisdizionale a singoli organi da tutti riconosciuti. La vendetta consiste in un ricorso al sacrificio, al polarizzare su un’unica vittima i dissidi e l’odio delle parti in conflitto. Girard riassume così i mezzi messi in atto dagli uomini per proteggersi dalla vendetta interminabile: “1. i mezzi preventivi riconducibili tutti a deviazioni sacrificali dello spirito di vendetta; 2. gli accomodamenti e gli impedimenti alla vendetta, come composizioni, duelli giudiziari, ecc, la cui azione curativa è ancora precaria; 3. il sistema giudiziario la cui efficacia curativo è senza pari”[12].
L’ultima considerazione la vorrei riservare a quanto l’antropologo francese afferma in merito alla pena di morte. Girard premette che il linciaggio, il cui funzionamento ho esposto in precedenza portando l’esempio della lapidazione di Efeso, rappresenta un meccanismo di giustizia collettiva pre-giuridico: infatti il transfert dell’aggressività consiste spesso nel linciaggio della vittima espiatoria che quindi è parte integrante del meccanismo vittimario. Come già visto tale meccanismo è tipico delle società arcaiche, antecedenti il messaggio cristiano, che svolgono le loro pratiche giuridiche quasi esclusivamente mediante azioni di violenza privata vendicatrice. Non rappresentano per lo più un’eccezione nemmeno i tribunali dell’antica Grecia in quanto gli elementi arcaici di essi sono troppo forti per poter consentire il paragone tra giustizia delle poleiV e sistemi giuridici moderni (basti pensare al Pritaneo, tribunale che giudicava gli imputati in contumacia sentenziando la distruzione dell’arma, o in genere alla consuetudine di far svolgere i processi all’aperto per evitare una contaminazione dell’intera comunità, oppure anche alla prassi che vedeva l’imputato di omicidio seguire il processo solo da un’imbarcazione sul mare per sottolineare la volontà di preservare la società da contaminazione). Il linciaggio, come violenza collettiva, non da spazio alla giustizia processuale sia perché essa non è prevista, sia perché l’immolazione della vittima avviene in brevissimo tempo. La pena di morte, istituzione ancora presente in molti stati moderni, è vista da Girard come nient’altro che un sacrificio non riconosciuto come tale, come una moderna forma di linciaggio reso legale e legittimo. Il potere giuridico si affida ancora alla pena di morte perché pressato dal mimetismo della massa che la richiede come strumento di giustizia, come proiezione dell’arcaico sacrificio espiatorio tanto condannato dal Cristianesimo. Sembra quasi un paradosso la sussistenza della pena capitale in stati democratici di matrice cristiana. Tuttavia, da un punto di vista euristico, si potrà facilmente constatare come l’esecuzione del condannato non provochi ulteriori dissidi e conflitti all’interno della società, ma come invece sia uno strumento di maggiore coesione e certezza che “giustizia è stata fatta”. Questo perché conserva nel suo essere le caratteristiche principali del sacrificio rituale che come Girard ha dimostrato ha sempre riportato la pace nella comunità fin dalla fondazione del mondo.
La prospettiva di Girard per il futuro, alla luce degli attuali episodi di violenza nel mondo, si concretizza nella viva speranza che l’uomo sappia disporre intelligentemente della propria libertà: auspica un ritorno alla Bibbia, ai Vangeli, gli unici scritti realmente depositari di un insegnamento millenario ma sempre attuale, ossia il rispetto per il prossimo e la tutela di ogni vittima potenziale. L’umanità deve in questo momento come in nessun altro seguire Cristo, seguire il Regno di Dio, il Regno dell’Amore e del Perdono.
[1] R.Girard, Vedo Satana cadere come la folgore, tr. it. Adelphi, Milano 2001, pp.165-166.
[2] R.Girard, La violenza e il sacro, tr. it. Adelphi, Milano 1980, pp.161-162.
[3] Ossia Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi 2001.
[4] R. Girard, Vedo Satana cadere come la folgore, tr. it. Adelphi, Milano 2001, pp. 168-169.
[5] R. Girard, ibid., p. 169.
[6] R.Girard, ibid, pp.184-185.
[7] R.Girard, ibid, p.187.
[8] R.Girard, ibid, p.189.
[9] R.Girard, ibid, pp.217-218.
[10] R.Girard, La violenza e il sacro, tr. it. Adelphi, Milano 1980, p.31.
[11] R.Girard, ibid.
[12] R.Girard, ibid., p.37.
NOAM CHOMSKY

BIOGRAFIA
Ebreo americano di origine russa, Chomsky nacque a Filadelfia il 7 dicembre 1928. Il padre William scappò dalla Russia nel 1913 per evitare di venire arruolato nell’esercito zarista. Fu proprio William Chomsky, studioso di ebraismo e linguaggio ebraico, ad influenzare il figlio nei suoi studi. Ma più influente, nello sviluppo di Noam come pensatore e come attivista, fu forse la madre, Elsie Simonofsky. La sensibilità politica della madre lo motivò, fin dalla giovane età, ad interessarsi a quell’area che comprende la società e la politica. E l’intera famiglia Chomsky fu inoltre sempre attivamente coinvolta nell’attività culturale ebrea. Noam e il fratello David furono quindi profondamente marcati da una eccezionale vita familiare. Nel 1945 Noam cominciò a studiare all’Università di Pennsylvania (filosofia, matematica). Sebbene entusiasta del suo percorso di studi, si scoraggiò presto, perché scoprì che le strutture istituzionali che egli aveva così detestato alle scuole superiori erano largamente replicate all’università. Costernato dalla sua esperienza di studente, egli rifletté sulla possibilità di lasciare il college per recarsi in Palestina, forse in un Kibbutz, per contribuire allo sviluppo di una comunità arabo-israelitica all’interno di una struttura socialista. Chomsky era contrario all’idea uno stato ebraico in Palestina. Una creazione di questo tipo avrebbe comportato la necessità di dividere il territorio e marginalizzare, sulla base della religione, una significante porzione della sua popolazione oppressa e povera; egli era più propenso ad unire le popolazioni sulla base dei principi socialisti. Tra i vari movimenti sociali presenti in Palestina, uno che lo interessò molto fu il movimento di lavoro cooperativo. L’approccio che i suoi aderenti presero per organizzare la società, che impiegava numerosi Kibbutzim, recava importanti similitudini col modello catalano come descritto da G. Orwell in “Omaggio alla Catalogna”. Così, le prime tendenze di Chomsky erano in linea con gli impulsi cooperativi e libertari piuttosto che con le visioni staliniste o trotskyste, che erano comunque molto popolari tra i gruppi della gioventù sionista. Chomsky però, nel 1947, incontrò Zellig Harris, un carismatico professore che condivideva molti dei suoi interessi e che avrebbe avuto una profonda influenza sulla sua vita. A causa di quest’incontro Chomsky rinunciò a partire per la Palestina e prolungò i suoi studi all’università. Sempre nel 1947 incontrò Carol Doris Schatz, sua futura moglie. Si specializzò in linguistica. Si laureò nel 1955 ed iniziò ad insegnare al MIT, il Massachussets Institute of Tecnology, la fabbrica dei Nobel scientifici degli States. Dal 1966 è titolare, presso il MIT, della cattedra di lingue moderne e linguistica. Chomsky è il fondatore e il caposcuola del generativismo, un’interpretazione della linguistica che intende spiegare le leggi che governano il prodursi del linguaggio e che si oppone alla linguistica strutturalista funzionalista. L’obiettivo di questa teoria è sviluppare una grammatica in grado di generare frasi, come il parlante di un linguaggio è in grado di produrre un numero virtualmente infinito di frasi usando il numero finito di parole e il numero finito di regole grammaticali di sua conoscenza. In questo contesto emergono quelle istituzioni e quegli individui che hanno in vario modo formato il pensiero di Chomsky e il suo approccio alla produzione linguistica e sociale. In primo luogo, la maggior parte della filosofia di base e le tendenze che hanno informato il lavoro di Chomsky furono poste nel 1961, quando egli era appena trentatreenne. Secondo, fu in questo frangente che Chomsky raggiunse la statura di intellettuale affermato e divenne un professore di ruolo al MIT. Produzioni relative al ruolo dell’accademia, e le relazioni tra l’accademia e il contesto sociale, cominciarono ora ad avere una più grande importanza per lui. Terzo, in questo periodo Chomsky entrò nel pubblico dibattito concernente la politica estera degli Stati Uniti, e facendo questo assunse il ruolo di osservatore e denunciatore dei casi di corruzione. Chomsky era a questo punto preparato per mettere la sua conoscenza nel campo dell’avanzamento sociale. Chomsky ha, nel corso degli anni, inseguito il suo primo interesse: il ruolo dell’accademia e la funzione dell’università nella società contemporanea. È stato veloce a notare il grado di collusione fra intellettuali e politiche dello stato, anche quando queste politiche sono chiaramente oppressive, violente o illegali. Egli assicura che c’è un deliberato tentativo da parte degli intellettuali e dei rappresentanti del governo (e dei giornalisti, sebbene in modi differenti) di mascherare i fatti semplici con un linguaggio ottuso, in modo da tenere la “folla” fuori gioco. Questo deliberato oscurantismo dei fatti è, nella sua visione, tipica del periodo cosiddetto post-moderno, e sintomatico di un problema molto più grande che concerne il controllo sociale. Parallelamente al suo prioritario approccio alle istituzioni scolastiche, c’è un rifiuto in Chomsky (virtualmente per le stesse ragioni) del socialismo autoritario, dei governanti illuminati, e di altri organi che tentano di dettare alla gente ciò che essa dovrebbe considerare come il proprio interesse. Dall’inizio degli anni ‘60 Chomsky è impegnato in un numero imprecisato di dibattiti roventi, affrontando gruppi pro-Israele, gruppi anti-comunisti, gruppi pro-guerra fredda, suscitando violente reazioni. Come conseguenza egli ha dovuto prendere delle precauzioni, inclusa la protezione della polizia in borghese. In prima fila nelle lotte della sinistra radicale americana, è da sempre impegnato nell’analisi e nella contestazione del colonialismo americano (culturale e non solo) e nella critica del sistema mediatico e del suo impatto sulla società.
IL PENSIERO
Il grande obiettivo filosofico che Noam Chomski si pone, a partire dall’opera Le strutture della sintassi (1957), è quello di impiegare gli strumenti della logica per costruire una teoria generale della struttura linguistica, concepita non già come mero repertorio di dati fissi (come avviene nella linguistica strutturalista), bensì come dispositivo o insieme di regole che presiedono alla produzione e ripetizione indefinita di frasi all’interno di una lingua. Infatti un bambino non si limita a riprodurre frasi che ha già ascoltato in precedenza, ma arriva a decidere autonomamente della correttezza grammaticale anche di frasi che non ha mai sentito, ovvero a capirle, ed è in grado di costruire nuove frasi. La teoria del meccanismo stimolo/risposta – di cui si avvale il comportamentismo – può spiegare solamente la capacità di riprodurre frasi già sentite, non però quella di produrre frasi nuove. Questa capacità – da Chomski detta “competenza” – si specifica in una lingua particolare, ma è universale e si fonda su una grammatica universale che esclude come umanamente impossibili certe grammatiche, proprio come in ambito fonologico sono escluse (poiché impossibili) determinate combinazioni di suoni. La competenza è data, più che dalla performance (cioè l’esecuzione) ossia dalla produzione di frasi nella propria lingua, dall’avere a disposizione certi princìpi, ossia un insieme di strutture e processi mentali che rendono possibile tale produzione. Un bambino non è capace di dire quali siano tali princìpi, ossia le regole del linguaggio che egli ha imparato ad usare: secondo Chomski, ciò vuol dire che la competenza linguistica si fonda sul possesso di una conoscenza implicita innata delle regole della grammatica universale, in base alle quali si è in grado di distinguere tra ciò che è grammaticalmente corretto e ciò che non lo è. In Linguistica cartesiana (1966), Chomski ravvisa un’antecedente di questa tesi nell’innatismo di Cartesio, ma rigetta radicalmente il dualismo su cui poggiava enigmaticamente la filosofia cartesiana, poiché Chomski è convinto che le idee innate consistano in una specie di programmazione del cervello a usare certe regole in modo da generare enunciati. Allora la teoria del linguaggio si assume il compito di portare alla luce la grammatica generativa, ovvero l’insieme dei princìpi e dei procedimenti coi quali, nelle svariate lingue, si costruiscono indefinitivamente le frasi. E a partire dallo scritto sugli Aspetti della teoria della sintassi (1965), Chomski distingue tra una struttura superficiale della lingua, la quale risiede nella rappresentazione del segnale fisico che noi diciamo o udiamo (ad esempio, “vieni”), e una struttura profonda, la quale produce la prima attraverso una serie di trasformazioni (combinazioni, cancellazioni, informazioni fonologiche che determinano la pronuncia, ecc). La struttura profonda può contenere elementi assenti in quella superficiale: ad esempio, in essa l’espressione “vieni” contiene anche l’elemento “tu”, che può essere assente da quella superficiale. In Riflessioni sul linguaggio (1976), Chomski ha tuttavia abbandonato questa terminologia, giacché essa può generare l’equivoco che “profondo” equivalga a qualcosa di metafisico, inaccessibile all’indagine, e “superficiale” a qualcosa di poco conto, irrilevante. In realtà, il caso della fonologia (riguardante una struttura di superficie, in quanto studia le combinazioni dei suoni) mette in luce come una tale struttura, sebbene sia “superficiale”, abbia un carattere di universalità, né più né meno della sintassi, la quale studia le regole di produzione delle frasi.
BRANI ANTOLOGICI
Il linguaggio è generato dalla grammatica
Dopo aver affermato che la funzione della memoria non è cosí determinante come si crede, Chomsky mette in evidenza l’importanza fondamentale della “competenza linguistica”, che si acquisisce dalla nascita. Essa consiste in “un insieme di regole che possiamo chiamare la grande matematica del linguaggio”. Comprendere frasi mai prima udite è possibile perché la grammatica possiede una componente sintattica, una morfologica e anche una semantica.
“Sulla base di un’esperienza limitata ai dati del discorso, ogni uomo normale ha sviluppato per se stesso una perfetta competenza nel suo linguaggio nativo. Questa competenza può essere rappresentata, in misura fino ad ora indeterminata, come un sistema di regole che possiamo chiamare la grammatica del suo linguaggio. Ad ogni espressione foneticamente possibile, la grammatica assegna una certa descrizione strutturale che specifica gli elementi linguistici di cui è costituita e le loro relazioni strutturali (oppure, in caso di ambiguità, piú descrizioni strutturali simili). Per alcune espressioni, la descrizione strutturale indicherà, in particolare, che sono frasi perfettamente costruite. Questa descrizione possiamo chiamarla il linguaggio generato dalla grammatica. Ad altre, la grammatica assegnerà descrizioni strutturali che indichino la maniera della loro deviazione dalla costruzione perfetta. Dove la deviazione è sufficientemente limitata, spesso può essere imposta un’interpretazione in virtú di relazioni formali con frasi del linguaggio generato. La grammatica, allora, è un mezzo che (in particolare) specifica l’infinita disposizione di frasi ben costruite e assegna a ciascuna di queste una o piú descrizioni strutturali. Forse dovremmo chiamare un tale mezzo grammatica generativa per distinguerla da esposizioni descrittive che presentano soltanto l’inventario degli elementi che appaiono nelle descrizioni strutturali, e le loro varianti contestuali. […] La grammatica generativa di un linguaggio dovrebbe, idealmente, contenere una componente sintattica centrale e due componenti interpretative, una componente fonologica e una componente semantica. La componente sintattica genera sequenze di minimi elementi funzionanti sintatticamente (seguendo Bolinger li chiameremo elementi formativi) e specifica le categorie, le funzioni e le interrelazioni strutturali degli elementi formativi e dei sistemi di elementi formativi. La componente fonologica converte in una rappresentazione fonetica una sequenza di elementi formativi di una specifica struttura sintattica. La componente semantica, corrispondentemente, assegna un’interpretazione semantica ad una struttura astratta generata dalla componente sintattica. Cosí ciascuna delle due componenti interpretative conduce una struttura generata sintatticamente ad un’interpretazione “concreta”, nel primo caso fonetica, nel secondo semantica […]. La grammatica nella sua totalità può cosí essere considerata, in conclusione, come un mezzo per accoppiare segnali rappresentati foneticamente con interpretazioni semantiche, attraverso la mediazione di un sistema di strutture astratte generate dalla componente sintattica. Cosí la componente sintattica deve procurare ad ogni frase (di fatto, a ogni interpretazione di ogni frase) una struttura profonda interpretabile semanticamente e una struttura superficiale interpretabile foneticamente, e, nel caso che queste siano distinte, l’affermazione della relazione tra queste due strutture”. [Current Issues in Linguistic Theory]
Struttura profonda e struttura superficiale del linguaggio
Noam Chomski è stato il fondatore e caposcuola della teoria generativista. In questa lettura egli osserva che una frase può essere interpretata per come essa è strutturata grammaticamente (componente sintattica) o per come essa esprime un pensiero (componente semantica). La prima è la struttura superficiale, la seconda è invece la struttura profonda.
“Il linguaggio ha un aspetto interno e uno esterno. Una frase può essere studiata dal punto di vista di come esprime un pensiero o dal punto di vista della sua forma fisica, cioè dal punto di vista della interpretazione semantica o di quella fonetica. Usando una terminologia recente, possiamo distinguere la “struttura profonda” di una frase dalla sua “struttura superficiale”. La prima è la struttura astratta sottostante che determina l’interpretazione semantica della frase; la seconda è l’organizzazione superficiale di unità che determina l’interpretazione fonetica e che è in relazione con la forma fisica dell’enunciato effettivo, cioè con la sua forma percepita o capita. […] La struttura profonda, che esprime il significato, è comune a tutte le lingue, cosí almeno si sostiene, in quanto è un semplice riflesso delle forme di pensiero. Le regole trasformative, che convertono le strutture profonde in strutture superficiali, possono differire da una lingua all’altra. Naturalmente, la struttura superficiale risultante da queste trasformazioni non esprime direttamente le relazioni di significato delle parole, tranne nei casi piú semplici. È la struttura profonda sottostante all’enunciato effettivo – una struttura puramente mentale – che è portatrice del contenuto semantico della frase”. [Current Issues in Linguistic Theory]
Sulla logica di Port-Royal
Coloro che verso la metà del ‘600 si rifugiarono a Port-Royal insieme a Pascal, in particolare Arnauld e Nicole, pubblicarono un trattato di logica e uno di grammatica. A quest’ultimo, che valuta molto positivamente, Chomsky afferma di ispirarsi.
“Intendo parlare di una determinata corrente di pensiero del diciassettesimo e diciottesimo secolo e delle conseguenti grammatiche “universali” o “filosofiche”: esse derivano da una certa filosofia dello spirito, di origine essenzialmente cartesiana. Esattamente come per le ricerche contemporanee sulla grammatica generativa, la grammatica universale dei filosofi di Port-Royal sorse soprattutto da una reazione contro l’atteggiamento strettamente “descrittivo”, secondo il quale la descrizione linguistica avrebbe come unico oggetto i dati del linguaggio attualizzato. In tal caso la linguistica si limiterebbe a fornire una ordinata presentazione di tale oggetto. Al contrario, la celebre Grammaire générale et raisonnée di Port-Royal rappresenta essenzialmente un tentativo di convertire lo studio del linguaggio in una specie di “filosofia naturale”, in contrasto con coloro che, come Vaugelas, non vi vedevano altro che una specie di storia naturale. La grammatica di Port-Royal si preoccupa quindi non solo di registrare e di descrivere l’uso, ma anche di spiegarlo. Per spiegare i fenomeni linguistici è necessario stabilire i principi generali da cui essi derivano. La grammatica, dunque, dev’essere “generale” e “ragionata” a un tempo. Tali principi generali costituiscono di fatto una ipotesi, empiricamente verificabile, sulla classe dei linguaggi umani possibili. La verifica dell’ipotesi può esser fatta in due modi: da un lato, dimostrando che essa è compatibile con la diversità delle lingue umane; dall’altro, dimostrando che essa è abbastanza efficace da render conto dei fenomeni particolari. Tale ricerca di una grammatica universale fu condotta con la preoccupazione di apportare una prova dimostrativa dell’uno e dell’altro punto ma, beninteso, nei limiti delle conoscenze disponibili a quell’epoca e delle tecniche allora praticate. Nel corso di tali studi, i grammatici del tempo misero in evidenza un certo numero di proposte precise, relative alla struttura del linguaggio e all’uso che ne vien fatto. Si ritiene generalmente che queste proposte siano state confutate, o che il successivo sviluppo della linguistica abbia messo in luce la loro mancanza di portata pratica. Ch’io sappia, ciò non è affatto vero. O meglio, esse sono semplicemente cadute in dimenticanza, in quanto l’attenzione dei linguisti si è rivolta ad altri oggetti e in quanto, in modo particolare nella generazione che ci ha immediatamente preceduti, il campo della linguistica generale si è ridotto al punto di escludere i problemi che interessavano i promotori della grammatica universale, perlomeno in linea di principio. La grammatica di Port-Royal stabilisce una distinzione tra ciò che volentieri chiameremmo la “struttura superficiale” di una frase e la sua “struttura profonda”. La prima concerne la organizzazione della frase in quanto fenomeno fisico. La seconda interessa il sostrato strutturale astratto che ne determina il contenuto semantico, e che è presente allo spirito allorché la frase viene emessa o percepita. In tal modo, la struttura superficiale della frase tipo Dio invisibile ha creato il mondo visibile ci indica che abbiamo a che fare con una forma del tipo soggetto-predicato, con un soggetto complesso e un predicato anch’esso formato da piú termini. La sua struttura profonda rivela invece un sistema di tre giudizi, e precisamente: che Dio ha creato il mondo (proposizione principale), che Dio è invisibile e che il mondo è visibile (proposizioni incidentali alla proposizione principale). La struttura intima, il sostrato, che racchiude il contenuto semantico, è dunque un sistema di tre proposizioni, sistema che è presente alla mente quando la frase reale viene emessa e compresa. Ognuna delle tre proposizioni elementari che compongono il sostrato è, come la struttura superficiale della frase completa, del tipo soggetto-predicato. Una struttura profonda che comporti un certo numero di proposizioni elementari, organizzate secondo determinati rapporti in vista di un determinato senso, è convertibile in una struttura superficiale mediante una serie di operazioni formali che possiamo chiamare “trasformazioni grammaticali”. Nel caso particolare esemplificato sopra, queste trasformazioni comprenderebbero una operazione di relativizzazione (la quale, applicata separatamente alla struttura profonda in questione, dà: Dio che è invisibile ha creato il mondo che è visibile) e una seconda operazione, facoltativa, per eliminare “che è” e (in alcuni casi) procedere all’inversione del nome e dell’aggettivo. In maniera analoga, si dimostrerà come una frase quale scio malum esse fugiendum abbia per base un sostrato che contiene la proposizione incidentale malum est fugiendum; le costruzioni infinitive hanno con il verbo la stessa relazione che le proposizioni relative hanno con il nome”. [Alcune costanti della linguistica]
PETER SLOTERDIJK

A cura di Roberta Musolesi
“Oggi il cinico appare come una figura di massa: un tipo sociale medio nel grado più alto di un’elevata sovrastruttura“.
Peter Sloterdijk è considerato uno dei più importanti innovatori del pensiero filosofico contemporaneo e la sua fama nei circoli culturali e filosofici tedeschi è uguagliata attualmente solo da quella di Gadamer, Habermas e Marquard. Si tratta tuttavia di una figura controversa e considerata, da parte di una ristretta cerchia di studiosi e pensatori, lontana dal rigore proprio della filosofia accademica, anche a causa della propensione per tematiche normalmente non affrontate in ambito universitario.
NOTE BIOGRAFICHE
- Peter Sloterdijk nasce il 26 giugno del 1947 a Karlsruhe.
- Dal 1968 al 1974 studia Filosofia, Germanistica e Storia a Monaco e ad Amburgo.
- Si laurea nel 1975 ad Amburgo con una tesi sulla filosofia e la storia della letteratura autobiografica moderna.
- Dal 1980 scrive numerose pubblicazioni e si interessa di teoria del tempo, di filosofia della cultura e della religione, di teoria dell’arte e di psicologia.
- Nel 1992 diviene professore di Filosofia e Teoria dei Media presso la Scuola Superiore della Forma di Karlsruhe.
- Dal 1993 dirige l’Istituto di Filosofia della cultura all’Accademia dell’Arte figurativa di Vienna.
- Dal 2001 è Rettore dell’Accademia dell’Arte e del Design di Offenbach.
- Dal gennaio del 2002 dirige la trasmissione radiofonica “Il Quartetto Filosofico” con Rüdiger Safranski.
- Nel 1993 e nel 2000 riceve il premio Ernst-Robert-Curtius per la saggistica.
- Nel 2001 riceve il premio Christian-Kellerer per l’impegno e il lavoro filosofico.
- È stato professore ospite presso il Bard College di New York, il Collège International de Philosophie di Parigi e presso la Scuola superiore della Tecnica a Zurigo.
LE OPERE
L’opera più conosciuta di Sloterdijk è la Critica della ragion cinica, pubblicata nel 1983 con enorme successo di pubblico e di critica. Le sue opere si caratterizzano per lo stile narrativo originale e per i contenuti innovativi, che hanno condotto molti critici a paragonarlo a pensatori come Schopenhauer e Oswald Spengler.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
- Kritik der zynischen Vernunft, 1983
- Der Zauberbaum. Die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785, 1985
- Der Denker auf der Bühne. Nietzsches Materialismus, 1986
Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, 1987 - Zur Welt kommen – zur Sprache kommen, Frankfurter Vorlesungen 1988
- Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik, 1989
- Vor der Jahrtausendwende. Berichte zur Lage der Zukunft, Hrsg., 2 Bände, 1990
- Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch zur Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart, Hrsg. zusammen mit Thomas H. Macho, 2 Bände, 1991
- Weltfremdheit, 1993
- Im selben Boot. Versuch über die Hyperpolitik, 1993
- Falls Europa erwacht, 1994
- Philosophie Jetzt!, Reihe in 20 Bänden, Gesamtherausgeber, 1995-97
- Selbstversuch. Peter Sloterdijk im Gespräch mit Carlos Oliviera, 1996
- Der starke Grund zusammen zu sein. Erinnerungen an die Erfindung des Volkes, 1998
- Sphären I – Blasen, 1998
- Sphären II – Globen, 1999
- Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, 1999
- Die Verachtung der Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft, 2000
- Über die Verbesserung der guten Nachricht. Nietzsches fünftes Evangelium. Rede zum 100. Todestag von Friedrich Nietzsche, 2000
- Die Sonne und der Tod. Dialogische Untersuchungen mit H.-J. Heinrichs, 2001
- Tau von den Bermudas. Über einige Regime der Einbildungskraft, 2001
- Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, 2001
- Luftbeben. An den Quellen des Terrors, 2002
- Sphären III – Schäume, Pluralistische Sphärologie, 2002
- Im Weltinnenraum des Kapitals, 2005
OPERE E ARTICOLI TRADOTTI IN ITALIANO
o Critica della ragion cinica, trad.it. A.Ermanno, a cura di M.Perniola, Milano, Garzanti 1993
o L’ultima sfera, Breve storia filosofica della globalizzazione, Carocci, Roma 2002
o Regole per il parco umano, Una replica alla lettere di Heidegger sull’umanismo in aut aut, n° 301-302, 2001, p. 132.
IL PENSIERO
LA “CRITICA DELLA RAGION CINICA”: KINICISMO VS CINICISMO
Peter Sloterdijk prende radicalmente le distanze dalle questioni principali della metafisica, della logica e dell’epistemologia. Dal suo punto di vista, i grandi temi, come Dio, l’universo, la teoria, la prassi, il Soggetto, l’Oggetto, il corpo, lo spirito, ecc.., si sono rivelati essere storicamente “mezze verità” e semplici nomi pressochè vuoti di contenuto e l’obiettivo che la sua filosofia si pone è quello invece di occuparsi di tutti gli aspetti della vita apparentemente “bassi”, prosaici e privi di significato. Secondo Sloterdijk, il tempo e la storia hanno lasciato sull’umanità una traccia, quella del cinismo, la cui interpretazione e comprensione spetta ai filosofi. Nella prima parte della sua opera principale, la Critica della Ragion Cinica, l’autore mostra come la perdita di fiducia nei confronti dei valori assoluti, manifestatasi, ad esempio, storicamente con il nichilismo, abbia in effetti avuto origine con l’Illuminismo, accompagnato, a suo avviso, da un accentuato atteggiamento cinico. Nella seconda parte, molto più voluminosa della prima, vengono invece illustrati esempi di atteggiamento cinico evidenti nei processi culturali; questi esempi sono analizzati sulla base di quattro diversi criteri, fisionomia, fenomenologia, logica ed esempi storici, e ci forniscono un quadro completo delle varianti e della complessità del cinicismo. Importante è comunque l’analisi di due concetti che, pur condividendo tratti comuni, appaiono dal suo punto di vista contrapposti: il cinicismo, ritenuto dal Sloterdijk essere prevalente nella realtà contemporanea, e il kinicismo, che l’autore difende come valida alternativa al primo. Secondo Sloterdijk, l’Illuminismo avrebbe portato con sé, e per un periodo di tempo molto prolungato, la distruzione di ogni ideale, di ogni valore assoluto e di ogni verità. Più la mentalità illuministica si affermava nella cultura, più prendeva piede quel modo di pensare nihilistico che progressivamente ha determinato la messa in discussione di tutti gli ideali e i valori. L’Illuminismo appare tuttavia, agli occhi di Sloterijk, come una scienza malinconica, che, seppur non intenzionalmente, conduce l’umanità a una condizione di rilassatezza, debolezza e stagnazione. Egli, nella sua opera, nel tentativo di contribuire a risollevare le sorti dell’umanità e a farla risorgere dallo stato di debolezza in cui attualmente versa, propone una sorta di “gaia scienza”, in contrapposizione alla “scienza triste” dell’Illuminismo, triste in quanto responsabile della distruzione di tutto ciò in cui gli uomini credevano e sui quali costruivano e fondavano le loro esistenze. Nell’opera, l’autore procede pertanto a una critica serrata, precisa e dettagliata nei confronti delle religioni, delle illusioni metafisiche e delle sovrastrutture idealistiche. Relativamente, ad esempio, alla religione, egli afferma che tutte le religioni sono costruite sul terrore e sulla paura; tutti gli esseri umani si sentono impotenti di fronte alle forze della natura e, per questo, cercano rifugio in entità che ritengono essere più forti e più potenti. A un certo punto, però, uomini ambiziosi, politici esperti e filosofi iniziano a trarre vantaggio dall’ingenuità delle persone e inventano, per questo motivo, divinità fantastiche e crudeli, che non hanno altra funzione se non quella di far conservare loro il controllo sugli esseri umani.
Rispetto invece alla coscienza di sé e all’Io, egli afferma che non si tratta altro che di una costruzione borghese. Infatti, nel momento in cui la borghesia ha detto “Io” è emerso chiaramente l’orgoglio del lavoro e della produttività, orgoglio fondato sulla consapevolezza tutta borghese di essere una classe sociale migliore della corrotta classe nobiliare e delle masse incolte. Sloterdijk vede emergere storicamente un nuovo Io politico anche in seno al movimento operaio, Io che ha assunto caratteristiche non molto diverse da quelle dell’Io borghese e che ha parlato per lungo tempo il medesimo linguaggio. Anche per la classe operaia, questo Io è stato costruito sui grandi ideli della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, ma anche l’Io della classe operaia possiede un’incontrastabile volontà di potere.
Il messaggio che Sloterdijk vuol far emergere è che ogni classe sociale sviluppa una morale perfettamente funzionale ai propri interessi, ma, nel momento in cui alcune individui iniziano a compiere scelte morali non tanto perché utili, quanto piuttosto perché più vicine al proprio modo di essere, essi cominciano a manifestare atteggiamenti cinici. Ma mentre il cinismo antico si coniugava con la satira e la risata (pensiamo ai Cinici come Diogene di Sinope), ed era quindi un atteggiamento estremamente vivo e vitale, il cinismo attuale conduce invece alla tristezza, alla depressione e al pessimismo, in definitiva a quello che Sloterdijk definisce “cinismo” e che ora ha assunto una notevole rilevanza nella nostra società.
Che cos’è per Sloterdijk il cinismo? Con tale termine, bisogna intendere una falsa coscienza illuminata, una coscienza cioè che ci conduce a mettere in discussione i principi assoluti in cui non crediamo più, ma che, nello stesso tempo, non ci consente di individuare solide basi per l’azione e per la conduzione della quotidianità e ci porta pertanto alla tristezza e alla depressione. Secondo Sloterdijk, il Cinicismo è ora un problema comune, universalmente diffuso nel mondo occidentale industrializzato, e l’origine del suo sviluppo deve essere ricercata nell’educazione che riceviamo a scuola e all’università, istituzioni responsabili, a suo avviso, di formare giovani intelligenti e preparati, ma completamente immotivati e senza prospettive. Nella nostra formazione, infatti, noi entriamo in contatto con un’enorme varietà di modelli di vita diversi, molti dei quali fondati su precisi valori metafisici o religiosi; l’educazione quindi ci pone in una situazione schizofrenica in quanto ci consente di provare differenti stili di vita, nessuno dei quali però appare chiaramente giustificato ed è per questo che ognuno di noi finisce per compiere scelte non sostenute da convinzioni profonde. Appare evidente che, secondo Sloterdijk, il Cinicismo si configura come un fenomeno di massa, diffuso in particolare all’interno delle classi sociali medie e medio-alte, e ciò perché esso, a suo avviso, può svilupparsi solo fra coloro che godono di una posizione di autorità, come religiosi, filosofi o scienziati, in definitiva tutti coloro che fanno riferimento ad un’ideologia astratta e ad un sistema assoluto.
Sloterdijk, accanto alla nozione di Cinicismo, introduce il concetto di kinicismo. Esso, nella sua accezione classica, era inteso fondamentalmente come impertinenza, come insolenza di fronte a ogni pretesa autorità. Il kinicismo infatti si è manifestato attraverso comportamenti che ora non potrebbero essere socialmente accettati, come mettersi le dita nel naso o emettere flatulenze. La figura di Diogene di Sinope, secondo Sloterdijk, ha dato inizio ad un processo di resistenza nei confronti dei discorsi manipolati ed artefatti delle filosofie “ufficiali” e nei confronti della “linguistificazione” dell’universalità cosmica che rappresentava, nei fatti, la principale occupazione dei filosofi. Diogene, in definitiva, comincia ad avere esperienza non solo della delusione nei confronti delle astrazioni idealistiche, ma anche dell’inconsistenza dell’atteggiamento mentale limitato alla satira e reagisce assumendo atteggiamenti apertamente maleducati, di quella maleducazione colorata che contraddistingue appunto il kinicismo. Diogene vive nella botte, si masturba in pubblica, rigetta la proprietà privata, risponde in maniera insolente ad Alessandro Magno.
Il Kinico, infatti, accomunato al cinico per ciò che concerne la consapevolezza della crisi dei valori, argomenta e dibatte con tutto il suo corpo, specialmente con le parti più infime e meno considerate.
Il kinicismo, in definitiva, secondo Sloterdijk, altro non è che una dura replica all’idealismo egemonico, replica che non si propone sotto forma di argomentazione “contro”, bensì come una forma di vita “contro”. Le dita nel naso e le flatulenze sono gesti che ciascuno di noi dovrebbe evitare di fare in pubblico e che sono consentiti unicamente in uno spazio privato; chi infrange queste convenzioni, è additato come un maleducato: e la maleducazione è oggi una connotazione fortemente negativa. La parola “impertinente” ha tuttavia acquisito un’accezione negativa solo in questi ultimi secoli; orginariamente, ad esempio nell’antica Germania, stava a indicare una forma attiva e produttiva di aggressività, rivolta nei confronti del nemico, e secondo Sloterdijk la perdita di vitalità della nostra cultura si riflette proprio nella storia di questa parola.
Vitalità, affermazione della vita, vivere pienamente sono quindi concetti collegati al kinicismo, come tipicamente riferibili a esso sono le riflessioni espresse unicamente attraverso il corpo e non verbalmente; la difficoltà a rispondere a questo genere di argomenti fece sì che né Platone né Socrate fossero in grado di relazionarsi con Diogene, ritenuto troppo diverso, e l’unica possibile reazione per Platone fu quella del disprezzo, che lo condusse a definire Diogene un “Socrate impazzito”, definizione che implica annientamento, ma che in effetti si traduce nel più alto riconoscimento.
In conclusione, per delineare in modo definitivo in che cosa consista il kinicismo per Sloterdijk, è possibile affermare che, analogamente al cinicismo, è una posizione realista e di rifiuto dell’idealismo, ma che, diversamente dal cinicismo che rende l’essere umano triste e depresso in quanto parte di un ordine precostituito in cui egli stesso non crede, rende l’uomo felice e allegro.
Si potrebbe essere tentati di replicare a Sloterdijk che tale difesa del kinicismo appare in effetti come una posizione non matura, che colloca l’uomo al di fuori delle responsabilità sociali, quindi irrealizzabile, né più né meno di un sogno. A tale replica, Sloterdijk risponde menzionando tre diverse situazioni in cui l’impertinenza propria del kinicismo può essere praticata e tollerata: le feste, l’università e gli ambienti bohemienne. Si tratta, a suo avviso, per la tolleranza che in tali ambienti vige, di tre importantissime valvole di sfogo per ogni essere umano. Le antiche feste, come il Carnevale, furono infatti, per i poveri, come una sorta di surrogato della rivoluzione: uno stravagante re veniva eletto per governare un regno dai valori completamente rovesciati, dove ricchi e poveri avevano la possibilità di far venire alla luce i loro sogni, dimenticandosi della verità, dell’educazione e delle regole. Le istituzioni sociali, secondo Sloterdijk, non sarebbero sopravvissute e non potrebbero sopravvivere a lungo senza questo genere di momenti, e ciò è ancora ampiamente dimostrato dal Carnevale brasiliano e dalle feste indiane.
Relativamente alle università, queste fino al Medioevo rappresentavano importanti centri in cui si formavano le più vivaci intelligenze, le menti più stravaganti e personalità sufficientemente furbe per comprendere che non era il caso di essere troppo riempite di nozioni.
Lo spirito bohemienne, infine, fenomeno relativamente recente, svolse un ruolo fondamentale nel regolare le tensioni fra arte e società borghese. Il bohemienismo fu lo spazio da cui fu possibile per molti testare la vita e allontanarsi dalle regole, usare la libertà al fine di elaborare il rifiuto della società borghese e individuare uno spazio sociale in cui vivere pienamente la propria vità.
Sloterdijk tuttavia ritiene che attualmente queste tre diverse dimensioni non siano più in grado di svolgere adeguatamente il loro ruolo; da molto tempo, infatti, le feste e lo stesso Carnevale non appaiono più come come viaggi in un “mondo invertito”, bensì come voli in mondi sicuri, come anestetici da usare nei confronti di un mondo costantemente invertito e colmo di ogni genere di assurdità. Anche lo spirito bohemienne è morto, relegato e nascosto ormai nei modi di vivere impertinenti delle sottoculture, e anche le università sono ormai spente.
Secondo Sloterdijk, la mutilazione degli impulsi impertinenti indica che la società è entrata in uno stadio di serietà organizzata, in cui i presupposti per una vita veramente consapevole sono completamente bloccati. Noi viviamo, a suo avviso, in un “realismo musone”, che non desidera e non vuole essere tenuto vivo e che gioca il ruolo della rispettabilità. La provocazione si è ormai esaurita e siamo entrati in uno stato di pubblico e rispettabile torpore.
Il criticismo di Sloterdijk consiste proprio nel sottolineare come le tradizionali istituzioni aperte al kinicismo non siano più in grado di assolvere al loro compito e tenta, nel contempo, di introdurre nuovamente l’impertinenza ed elementi dello stile di vita proprio del kinicismo nella nostra società, al fine di rendere le nostre vite allegre e vive. Non vuole certamente fare del kinicismo una nuova religione, ma mira esclusivamente ad accrescere la sua rilevanza, e così facendo va decisamente oltre lo spirito illuminista e la presunta modernità che animano la società e la cultura occidentali. Per queste ragioni, si può definire la posizione assunta da Sloterdijk nella sua Critica della Ragion Cinica come postmoderna.
“BREVE STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE”: IL MONDO E’ SEMPRE STATO “GLOBAL”
Secondo Sloterdijk, l’intera storia dell’Occidente può essere vista come una lunga sequenza di ondate di globalizzazione: dal suo punto di vista, ciò che ora viene mitizzato dietro questo concetto e presentato come se fosse una novità, non è altro che una tardiva interpretazione di avvenimenti molto più ampi. Egli parla infatti non solo di “archeologia”, ma anche di “metafisica” della globalizzazione: già nel De monarchia di Dante, a suo avviso, si fa cenno a un’umanità globalizzata, a un genere umano agitato da tante sventure e tendente in opposte direzioni e Il giro del mondo in ottanta giorni di J. Verne poteva essere concepito solo in uno spazio e in un mondo visti come globalizzati. Secondo Sloterdijk, nel momento in cui la Terra ha svelato la sua sfericità, ha cessato di essere bella e perfetta, ma è sicuramente divenuta più interessante ed è per questo che nell’Età moderna non sono più i metafisici, bensì i geografi e i navigatori coloro cui spetta il compito di fornire una corretta immagine del mondo. Il mercato globale ha avuto origine proprio con le scoperte geografiche, momento in cui, secondo il nostro autore, il denaro inizia a girare intorno alla Terra e l’allargarsi degli orizzonti dell’uomo inizia a divenire ragione di profitto. In questo panorama, di spaesamento e di crescente sfruttamento, l’uomo non può far altro che sentirsi disorientato per la perdita di contatto con un mondo che gli appare completamente diverso da quello gli è stato tramandato e con la perdita del legame con la terra e con il mondo l’essere umano perde drammaticamente anche la sua consistenza. La contingenza e l’incertezza, dopo questa mutazione antropologica senza precedenti, divengono quindi, per Sloterdijk, i tratti più evidenti della condizione umana.
LE “SPHÄREN”: LA FILOSOFIA DELLE “SFERE”
I due volumi di Sphären rappresentano per Sloterdijk un nuovo tentativo di elaborare una visione generale della storia umana e della condizione moderna. Le “sfere”, le “bolle”, i “globi”, sono i contenitori attraverso i quali l’uomo pensa se stesso nel mondo, alla ricerca di un “involucro” protettivo che lo “immunizzi” dai pericoli che vengono dall’esterno: dal ventre materno allo stato sociale, l’uomo è infatti sempre guidato dalla ricerca di sicurezza.
L’opera è stata concepita come una trilogia: il primo volume ha come sottotitolo Bolle e tratta della teoria dell’intimità, il secondo ha come sottotitolo Globi e affronta il tema della metafisica dal punto di vista della filosofia europea classica, il terzo volume, ancora da pubblicare, avrà come sottotitolo Schiuma e in esso verrà descritto un mondo in cui si sono esaurite le possibilità di interpretare il tutto a partire dall’intimità.
Dalla pubblicazione della Critica della Ragion Cinica, Sloterdijk opera una presa di distanza dalla filosofia della contestazione per ricercare ed elaborare una teoria di tipo storico e antropologico. In Sfere, in particolare, emerge il tentativo di procedere da una teoria dello spazio costruita a partire da basi psicanalitiche, cioè da una teoria dello spazio interiore, per approdare ad una concezione generale del mondo e della storia umana. In quest’opera egli cerca di dimostrare che gli uomini, così come gli altri mammiferi, sono esseri che derivano “dall’interno”, nel senso che si costituiscono all’interno della madre, “approfittando” della protezione biologica che il corpo della madre offre. La struttura stessa della memoria umana mostra, secondo Sloterdijk, che noi rimaniamo profondamente legati a quest’idea di madre e pretendiamo che anche al di fuori di essa ci venga garantito lo stesso benessere provato nel ventre materno prima della nascita. Sfere è il tentativo di raccontare la storia umana a partire da questo concetto.
Secondo Sloterdijk, il mondo moderno è un mondo in cui l’assoluta esteriorità e l’estraneità hanno preso il sopravvento sulla familiarità e la vicinanza; nell’era post-metafisica, gli uomini non possono più costruire nulla a partire dalla loro esigenza di intimità e debbono fare i conti col fatto che, ovunque siamo o ci troviamo, ci viene incontro l’estraneo. A differenza di quel che pensava Hegel, oggi, secondo Sloterdijk, non c’è alcuna strada sicura che ci riporti a casa da questa estraneità.
FABBRICARE L’UOMO?
Sloterdijk, suscitando scandalo in Germania, ha proposto alcune riflessioni sulla relazione uomo-animale, a partire da due eventi di cronaca: l’uccisione di milioni di capi di animali a causa del diffondersi in Europa della sindrome della “mucca pazza” e l’inizio delle manipolazioni genetiche che hanno portato alla clonazione della pecora Dolly.
Sloterdijk interpreta questi due eventi come tappe nella realizzazione di una nuova futura “antropotecnica” che porterà, a suo avviso, a pianificare l’evoluzione della specie umana. Tale affermazione, ovviamente molto forte, va interpretata alla luce del suo particolare concetto di humanitas, secondo cui l’uomo, così come lo conosciamo, altro non sarebbe che il prodotto di tecniche di addomesticamento, addestramento ed educazione altamente selettive (si vedano, ad esempio, nell’ambito dell’addestramento scolare, il leggere, lo scrivere, il contare, lo stare seduti, ecc..). Oggi, momento in cui il potere “modellante” e “plasmante” delle teniche educative appare in declino, sembra emergere, a suo avviso, un nuovo progetto di allevamento-addomesticamento di tipo genetico ed è ipotizzabile, dal suo punto di vista, che una nuova tecnologia possa arrivare a pianificare e a progettare le caratteristiche dell’umanità, fino a cancellare il fatalismo e la casualità e sostituirli con la nascita opzionale e la selezione prenatale.
Si tratta di una prospettiva inquietante, che tuttavia il pensiero critico deve, secondo Sloterdijk, analizzare senza illusioni, ma anche senza perdere contatto che quella prospettiva umanistica che poggiava (e poggia ancora) sull’idea della stabilità (la casa, la terra, gli animali domestici, ecc..) e sull’educazione attraverso la lettura e le lettere in generale. Storicamente, con la costruzione della casa, inizia il rapporto dell’uomo con gli animali e, in particolare, con gli animali domestici: questi non vengono solo addomesticati, ma anche addestrati ed allevati e l’animale domestico diviene lo specchio dell’addestramento/educazione dell’uomo.
L’addestramento altro non è che un’antropotecnica di carattere umanistico, cui potrebbe subentrare, secondo l’autore, un’antropotecnica di tipo genetico; in ogni caso comunque l’uomo si trova a fare i conti con l’animale, quello domestico in un caso, quello mostruoso della manipolazione genetica nell’altro.
Il problema che si pone ora è quello della valutazione delle antropotecniche: come fare a stabilire che quella umanistica tradizionale è preferibile rispetto a quella genetica? Non potrebbe essere quest’ultima la più adatta a produrre quei caratteri di umana tolleranza che si ritiene siano il miglior risultato dell’educazione? Per tali interrogativi, certamente destabilizzanti e provocatori, Peter Sloterdijk è diventato la personalità più controversa della scena culturale tedesca e Jürgen Habermas, indignato per la conferenza di Sloterdijk dal titolo “Il parco degli esseri umani – lettera di risposta sull’Umanesimo”, è stato il primo a dichiarargli guerra.
IMMANUEL WALLERSTEIN

A cura di Chiara Mangiarini e Diego Fusaro
Formazione e carriera accademica.
Immanuel Wallerstein nacque a New York nel 1930. Nella città natia frequentò la Columbia University, dove conseguì, nel 1951, la laurea di primo livello (Bechelor of Arts), nel 1954, la laurea di secondo livello (Master of Arts) e, nel 1959, la laurea di livello maggiore.
A seguito dell’assegnazione di quest’ultimo titolo, lavorò in quell’università come docente fino al 1971, anno in cui divenne professore di sociologia alla McGill University.
A partire dal 1976, occupò la cattedra di sociologia alla Binghamton University (SUNY), che lasciò nel 1999 per dirigere il centro “Fernand Braudel” per gli studi di Economia, Analisi storica e Civilizzazione.
Nel corso della sua carriera, Wallerstain tenne diversi corsi come visiting professor nelle Università di tutto il mondo, fu insignito di più titoli onorari, fu – a intermittenza – direttore degli studi alla Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, infine, fu presidente, dal 1994 al 1998, dell’Associazione Internazionale di Sociologia.
Tra le principali opere di Wallerstein, ricordiamo: Africa, The Politics of Independence (1961), The Capitalist World-Economy (1979), Antisystemic Movements (1989), con Etienne Balibar Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (1991), After Liberalism (1995), The End of the World As We Know It (1999). L’opera più importante di Wallerstein si intitola The Modern World-System, in tre volumi, composti dal 1974 al 1989.
Pensiero.
Wallerstein intraprese la sua carriera come studioso ed esperto delle vicende post-coloniali dell’Africa. A tale argomento, dedicò le sue pubblicazioni fino ai primi anni ’70, quando cominciò ad acquisire fama di storico e teorico dell’economia capitalista globale a livello macroscopico.
Le sue prime critiche al capitalismo, così come la difesa dei “movimenti anti-sistema”, hanno contribuito a renderlo, al pari di Noam Chomsky e Pierre Bourdieu, una “eminenza grigia” del movimento contro la globalizzazione, tanto all’interno, quanto all’esterno della comunità scientifica.
La sua opera più importante, Il Sistema del Mondo Moderno, fu pubblicata in tre volumi, usciti rispettivamente nel 1974, nel 1980, e nel 1989. Per la loro stesura, Wallerstein attinse principalmente da tre tendenze di pensiero:
a) Karl Marx, che Wallerstein ricalca nell’enfatizzare l’importanza dei fattori economici e il loro predominio sui fattori ideologici nelle politiche globali.
b) Lo storico francese Fernand Braudel, che aveva descritto lo sviluppo e le implicazioni politiche dell’estensione della rete di scambio economico nell’Impero dell’antichità.
c) Infine, presumibilmente, l’esperienza e le impressioni personali, raccolte grazie al suo proprio lavoro attorno al periodo post-coloniale in Africa, e le sue svariate teorie riguardo alle cosiddette “nazioni in via di sviluppo”.
Un aspetto del suo lavoro per il quale Wallerstein è sicuramente degno di merito, è l’aver previsto, già durante la Guerra Fredda, la crescente gravità del contrasto tra Nord e Sud del mondo.
Egli, tuttavia, rifiutò la nozione di “terzo mondo”, sostenendo, invece, l’esistenza di un unico mondo, regolato da una complessa serie di relazioni economiche, “economia (o sistema) mondiale”, nelle quali la dicotomia ‘capitale-lavoro’ e l’accumulazione di un capitale sempre maggiore, spiegano gli attriti esistenti.
Wallerstein colloca l’origine del sistema mondiale moderno nel nord-ovest europeo del XVI secolo. Allora, un lieve vantaggio nell’accumulazione capitalistica di Inghilterra e Francia, dovuto a specifiche circostanze politiche alla fine dell’epoca feudale, mise in moto un processo di espansione graduale, il cui risultato fu un’unica rete o sistema di scambio economico globale tutt’oggi esistente. Uno sviluppo maggiore ricorse durante l’epoca dell’imperialismo, che, di fatto, portò ogni area della terra a contatto con l’economia capitalista di stampo europeo.
Il sistema capitalistico mondiale è, comunque, distante dall’omogeneità in termini culturali, politici ed economici; esso è, anzi, caratterizzato da fondamentali differenze di sviluppo civile e di incremento di potere politico e capitale. Contrariamente alle teorie positive di modernizzazione e capitalismo, Wallerstein non concepisce queste differenze se non come meri residui o irregolarità che possono essere superate solo quando il sistema evolverà tutto insieme.
Un importane elemento inerente al sistema mondiale è la permanente suddivisione del mondo in centro, semi-periferia e periferia (le aree che sono rimaste sino ad ora al di fuori della ricchezza del sistema mondiale, vi entrano in forma di periferia.)
Vi è una divisione fondamentale e istituzionalmente stabilita tra il lavoro del ‘centro’ e quello della ‘periferia’: mentre il centro gode di un alto livello di sviluppo tecnologico e di prodotti di complessa fattura, il ruolo della ‘periferia’ è di fornire materie prime, prodotti agricoli e manodopera a basso costo proprio agli agenti del ‘centro’. Allo steso modo si verifica lo scambio economico tra i due poli: la ‘periferia’ è infatti costretta a vendere i suoi prodotti a basso prezzo, ma, allo stesso tempo, deve comprare i prodotti del ‘centro’ a prezzi comparativamente alti. Uno stato di cose, questo, non equo, che, una volta instauratosi, tende a stabilizzarsi per gli inerenti, e quasi deterministici, vincoli.
Lo status di ‘centro’ e quello ‘periferia’ non sono, tuttavia, prerogativa fissa di determinate aree geografiche. Esso può infatti mutare in base alle condizioni: vi è una zona, chiamata semi-periferica, che si comporta come periferia in relazione al centro e come centro in relazione alla periferia (alla fine del XX secolo questa zona dovrebbe contenere, l’Est europeo, la Cina, il Brasile).
Una conseguenza dell’espansione del sistema economico mondiale, è il continuo mutamento della richiesta del prodotto, quindi, della manodopera. Le risorse naturali, la terra, il lavoro e le relazioni umane sono sta gradualmente spogliate del loro valore “intrinseco” e trasformate in merce di scambio da mercato, che detta il loro valore di scambio.
Se Marx aveva guardato al conflitto di classe all’interno dello Stato nazionale, Wallerstein allarga la prospettiva, estendendola all’intero globo e, in particolare, riferendola ai rapporti che si instaurano tra gli Stati. In particolare, Wallerstein è convinto che il capitalismo generi su scala mondiale, cioè nel “sistema mondiale” (“World System”), quelle contraddizioni che Marx s’era limitato a individuare sul piano dello Stato nazionale. La distinzione fondamentale sulla quale poggia il pensiero del nostro autore è quella tra gli “Imperi mondiali” (“World Empires”) e le “economie mondiali”: gli “Imperi mondiali” sono quelli che si creano a seguito di grani conquiste militari e il cui fine è lo sfruttamento delle risorse degli Stati sottomessi. Un “Impero mondiale” era, ad esempio, l’Impero romano. Finché i Paesi sottomessi pagano i tributi richiesti dall’Impero, essi possono mantenere una certa autonomia, come nel caso delle province dell’Impero romano. Secondo Wallerstein, gli “Imperi mondiali” erano tipici delle epoche anteriori al XV-XVI secolo, quando il capitalismo moderno non s’era ancora affermato: è nel 1400, in particolare con le banche toscane, che nascono il moderno sistema capitalistico e la sua nuova mentalità (quasi diremmo, hegelianamente, il nuovo Zeitgeist). A ben vedere, nota Wallerstein, l’organizzazione degli Imperi era ardua e caratterizzata da un’intrinseca debolezza: nella fattispecie, essendo assai dispendioso mantenere in vita gli Imperi, essi finivano irrimediabilmente per entrare in conflitto reciproco e per tramontare.
Il “sistema dell’economia” mondiale è strutturato diversamente: esso ha, al suo “centro”, una limitata serie di Stati aventi potenze militari simili; questi Stati sono in reciproca concorrenza economica e militare. Nel “sistema dell’economia” mondiale, v’è poi una “periferia” composta da Stati più deboli, i quali forniscono a quelli del centro le risorse materiali e la manodopera a basso prezzo. Si tratta di Stati che vengono sfruttati da quelli del centro: e tale distinzione tra Stati centrali e Stati periferici rispecchia la distinzione marxiana tra la classe degli sfruttatori (i borghesi) e quella degli sfruttati (i proletari), ancorché la prospettiva sia ora portata su scala mondiale e sul livello “macro” degli Stati.
Wallerstein riconosce anche, accanto al centro e alla periferia, l’esistenza di una “semiperiferia” composta da Stati di secondo piano, che si trovano a cavallo tra la periferia e il centro e, in forza di ciò, sono caratterizzati da una certa instabilità: Stati di questo tipo (il Brasile, la Cina) avanzano rapidamente verso il centro, svolgendo un’importante funzione di cerniera tra Stati del centro e Stati della periferia.
Come già s’è avuto modo di accennare, gli Stati del centro hanno i più grandi mercati, i posti di lavoro meglio retribuiti, dispongono di un alto livello tecnologico, di una rete di imprese ben organizzata. Gli Stati della periferia, invece, si trovano in una posizione subordinata: essi hanno le risorse prime (ad esempio, il petrolio) che servono al centro. Quest’ultimo sfrutta la periferia, poiché essa è sottosviluppata e priva di capitale utile per poter finanziare le infrastrutture (trasporti, comunicazione, internet, ecc). Lo scontro di classe tra sfruttati e sfruttatori teorizzato da Marx è da Wallerstein spostato sul livello degli Stati, nella misura in cui gli Stati del centro sfruttano quelli della periferia. Curiosamente, anche Herbert Marcuse, che come Wallerstein fu un vero e proprio idolo per gli studenti in rivolta nel ’68, tratteggiò una situazione di questo genere ne L’uomo a una dimensione (1964), chiarendo come lo scontro di classe avesse assunto la forma di lotta tra Paesi ricchi e Paesi poveri.
Sulle orme di Marx, Wallerstein è convinto che il sistema capitalistico sia ineluttabilmente destinato a crollare: ma prima che ciò possa accadere, occorre che esso abbia assoggettato il mondo intero. In particolare, la saturazione dei mercati, l’abbassamento della produzione, il crescente impoverimento dei Paesi della periferia sono la spirale da cui il sistema capitalistico non può più uscire.
Il pensiero di Wallerstein ha suscitato dure critiche, e non solo da parte dei circoli neo-liberali o conservatori, ma anche da parte di storici che hanno rilevato come alcune delle sue asserzioni siano storicamente inesatte. Così, ad esempio, alcuni critici ritengono che Wallerstein tenda a dimenticare la dimensione culturale, riducendola a quella che alcuni definiscono “ideologia ‘ufficiale’ degli stati”, facilmente riconducibile a mere rappresentazioni degli interessi economici.
In ogni caso, e nondimeno, la sua teoria attira un forte interesse da parte dei movimenti contro la globalizzazione.
L’AUSTROMARXISMO
A cura di Lara Malavasi
Nella lettura degli scritti degli autori “austro-marxisti” si rimane fortemente sorpresi a motivo di alcune singolari affinità tra le situazioni dei primi decenni del XX secolo, da essi descritte, e quelle della nostra epoca.
Per questo, al di là della loro particolare prospettiva socialista, alcuni dei criteri di analisi e giudizio di Adler, Bauer e Renner circa il mondo sociale, politico e religioso del tempo non appaiono per niente sorpassati.
Basti pensare, ad esempio, alla ricerca tuttora in corso nelle società europee sia dell’Est che dell’Ovest – ma anche in quelle sudamericane e africane più o meno sviluppate o in via di sviluppo – della cosiddetta “terza via” tra socialismo e capitalismo, e all’interno del socialismo, tra posizioni radicali rivoluzionarie e quelle moderate della socialdemocrazia, che questi pensatori austromarxisti avevano già intrapreso all’inizio del secolo.
Sorprendentemente attuale anche la denuncia, fatta da Bauer, del rapporto distorto e inquietante tra politica e affari di fine secolo in Austria – di cui era responsabile principalmente il partito liberale, e in parte, anche il giovane partito cristiano-sociale – per far fronte alla quale egli invoca la creazione e formazione di una nuova classe politica, che già nel 1907 egli chiamava “Partito delle mani pulite”.
Non minore validità conserva il discorso di Adler, Bauer e Renner circa la Religion Privatsache e la prassi di potere della Chiesa.
Limitandoci alle situazioni delle società europee, che hanno conosciuto una lunga stagione di liberalismo e laicismo, in queste, nonostante i precetti laicisti, permangono tuttora evidenti tratti confessionali religiosi negli Stati e camuffati interessi di statalismo clericale nelle Chiese. Residui “confessionali” e “statalistici” di clericalismo secolare, che impediscono ancora oggi, da un lato, una complessiva emancipazione democratica allo Stato, e dall’altro, la piena libertà, alla Chiesa, di esercizio della propria religione.
Sul movimento austromarxista si è parlato e si parla veramente poco, e si è scritto ancor meno.
L’obiettivo che ci proponiamo in questa sede non è quello di esaurire la spiegazione del pensiero austromarxista in poche righe, ma solo di darne una panoramica generale, nel modo più chiaro possibile.
Approfondire singolarmente il pensiero di ognuno dei tre autori citati, oltre ad essere un’impresa ardua, credo non possa, sostanzialmente, interessare granché. Trovare, però, un leit-motiv comune, forse può destare maggiore interesse in relazione all’ampia panoramica di intrecci politici/religiosi di cui siamo sempre più spettatori; privati, spesso, del tempo per una sana e razionale riflessione.
CONTESTO
Agli inizi del XX secolo l’Austria appare già avviata sulla inevitabile via del tramonto della dinastia asburgica. Un tempo caratterizzato da una serie di fenomeni sociali, politici e culturali di grande inquietudine e insieme di grande interesse.
Si assiste all’emergere prepotente della nuova classe lavoratrice, che va crescendo nelle grandi città, soprattutto a Vienna, ponendo nuovi problemi sociali (scuole, case, assistenza sanitaria…) e si assiste, al tempo stesso, al riesplodere dello scontento delle classi tradizionali (contadini, artigiani, commercianti…) e dei nuovi ceti medi (liberi professionisti, funzionari e impiegati pubblici).
Di queste forze, esigenze e rivendicazioni si fanno interpreti i nuovi protagonisti politici: i due grandi partiti di massa, quello socialista e quello cristiano-sociale, all’inizio ostacolato, ma poi accettato, ispirato e sostenuto anche dal clero.
A questo contesto politico e sociale fa da sfondo una vivacità culturale della capitale austriaca senza precedenti, espressione di energie intellettuali liberate proprio dalla medesima crisi dell’Impero e dalla nuova situazione politica e sociale conflittuale. È proprio questo il fulcro del movimento austromarxista.
L’austromarxismo nasce a Vienna, attorno alle riviste “Marx Studien” (1904) e “Der Kampf” (1907), presentandosi inizialmente come corrente di pensiero marxista e, più tardi, a partire dalla Prima Guerra Mondiale ma soprattutto in occasione della caduta dell’impero austroungurico e sull’onda della vittoria della Rivoluzione Russa, assumerà connotati sempre più marcatamente politici, fino ad identificarsi con la componente interna di sinistra del partito socialista austriaco.
I suoi esponenti, tra i quali principalmente Karl Renner (1870-1950), Otto Bauer (1881-1938), Max Adler (1873-1937), critici verso la socialdemocrazia tedesca e, nello stesso tempo, nei confronti del bolscevismo, si misero alla ricerca di una “terza via”, che evitasse i difetti del revisionismo bernsteniano e insieme l’atteggiamento profondamente radicale del leninismo. Il primo, rischiava, per così dire, di irretire il socialismo tra le maglie del capitalismo, senza farlo mai decollare, il secondo invece appariva loro inadeguato ed estraneo alla situazione e alla società austriaca di allora.
Il problema non era solo quello di dare risposte politiche concrete agli scottanti e urgenti problemi sociale e politici del momento, ma anche quello di giustificarle nella coerenza della propria ideologia marxista. D’altra parte, non era molto chiaro a quell’ epoca di crisi anche del marxismo quale fosse o dovesse essere il vero marxismo. Gli austromarxisti, pur richiamandosi inequivocabilmente a Marx, e quindi presentandosi come “ortodossi” non intesero però dogmatizzare il pensiero di Marx chiudendolo in un “sistema rigido”; ma vi si ispirarono come ad una forma “attivamente operante (…) in sviluppo”.
Tentarono, per un verso, di liberare il marxismo dall’impostazione materialistico-economicistica della Seconda Internazionale e, per altro verso, di conferirgli una visione teorica più ampia, che gli consentisse di aprirsi a orizzonti più vasti. Capirono che ciò sarebbe stato possibile solo mediante una traduzione ed elaborazione dei presupposti filosofici del marxismo nella direzione dell’etica, della filosofia della storia e della scienza. E su questi terreni Kant e Hegel si presentavano loro come interessanti e inevitabili punti di riferimento e confronto.
Questa revisione in senso neohegeliano e neokantiano doveva servire loro anche come efficace credenziale presso i circoli culturali dei pensatori liberali viennesi del tempo. Questi, infatti, ancora persistevano nell’ignorare e snobbare il marxismo, ritenendolo non degno di attenzione, perché estraneo alla tradizione della cultura europea. Innestare Marx sul filone del pensiero classico tedesco, tramite il collegamento con i suoi maggiori rappresentanti, Kant e Hegel, poteva sortire come effetto collaterale anche quello di creare un terreno di confronto tra intellettuali liberali e pensatori marxisti del tempo.
E’ in questo contesto che va quindi collocata e spiegata la revisione del marxismo e del socialismo operata dagli esponenti dell’austromarxismo, sia sul piano dei principi dottrinali, sia su quello delle strategie politiche. E se Max Adler può ritenersi a giusto motivo il revisore più radicale della critica filosofica marxista della religione, Otto Bauer e Karl Renner possono essere considerati i revisori più aperti delle strategie socialiste sul terreno delle politiche religiose.
Renner e Bauer si dimostrano, infatti, gli osservatori più interessati, i critici più attenti all’evoluzione storico-culturale, sociale e politica, allora in corso nel mondo cattolico, e si rivelano gli strateghi più accorti nell’ideare, suggerire e praticare una nuova linea politica nei suoi confronti.
Fin dai loro primi scritti sulla questione religiosa, tutti e tre avvertono l’esigenza di cercare e realizzare una via democratica al socialismo. Si formano la convinzione che, in un paese a grande maggioranza cattolica come l’Austria, questa via non sia percorribile senza l’aggregazione di una parte consistente degli strati proletari e piccoli e medi borghesi credenti. Si propongono, allora di capire fondamentalmente due cose:
– quali di questi strati sia possibile avvicinare e guadagnare alla causa del socialismo
– su che cosa far leva e a quali mezzi ricorrere per aggregarli.
A questo scopo essi compiono una triplice indagine: da una parte, operano una sorta di vivisezione sociale e politica del cattolicesimo austriaco, dall’altra tentano un’analisi e insieme una valutazione della dottrina sociale del cristianesimo e, contemporaneamente, quasi a presupposto di queste loro analisi storico-sociali, avviano – Max Adler in particolare – una revisione del rapporto teorico tra marxismo e religione in generale.
In conclusione, si può evidenziare il punto focale che accomuna Renner, Bauer ed Adler, ovvero l’assunzione della religione come affare privato.
Religion Privatsache diviene, presto, la bandiera politica di tutti i partiti e movimenti socialisti.
Una formula , appunto, e niente più, con la quale essi riproponevano la concezione laica dello Stato, tipica del liberalismo, e suggerivano al movimento operaio un atteggiamento di tolleranza e indifferenza. Soltanto a partire dagli inizi del secolo e ad opera di Adler e Bauer direttamente, e Renner indirettamente, la formula diventa oggetto di un più serio approfondimento e di un più impegnativo dibattito.
Religion Privatsache è il Leit-motiv comune, ricorrente in quasi tutti i loro interventi sul tema religioso, fino a diventare, in Adler, il concetto fondativo della propria filosofia della religione, e in Bauer e Renner la via più adeguata per la soluzione della questione religiosa, vista nei suoi aspetti culturali e social-politici.
Scopo ultimo della loro insistenza su questi motivi della religione come affare privato è il ridimensionamento della chiesa, non tanto come religione, quanto come organizzazione di potere.
IVAN ILLICH
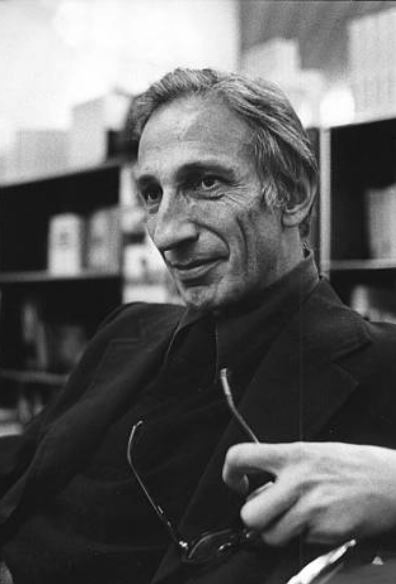
Vita
Ivan Illich (Vienna, 4 settembre 1926 – Brema, Germania, 2 dicembre 2002), austriaco di nascita e messicano d’adozione, è stato non solo un anarchico, ma anche un sociologo, filosofo, linguista (conosceva una decina di lingue), teologo e storico delle istituzioni. Nato a Vienna da un padre cattolico di origine croata, Ivan Peter Illich, e dalla madre ebrea sefardita, Ellen Regenstreif-Ortlieb, Ivan Illich trascorre un’infanzia tranquilla grazie alle buone disponibilità economiche della famiglia. Poliglotta sin da ragazzo (l’italiano, lo spagnolo, il francese e il tedesco furono da lui appresi da bambino, in seguito imparò il croato, la lingua dei suoi nonni, il greco antico e il latino, oltre allo spagnolo, il portoghese, l’hindi, l’inglese ed altre lingue). Tra il 1936 e il 1941 vive principalmente a Vienna con la nonna materna, poi a causa delle leggi razziali naziste è costretto a lasciare l’Austria per recarsi a Firenze con la madre, dove contribuisce alla lotta partigiana. In Toscana, nonostante non abbia mai avuto un buon rapporto con le istituzioni scolastiche e con la disciplina in genere, termina le scuole superiori e inizia l’Università. Proprio in questo periodo decide anche di farsi sacerdote: tra il 1942 e 1946 frequenta i corsi di teologia all’Università Gregoriana in Vaticano. Viene ordinato sacerdote e, dopo aver rifiutato un incarico diplomatico nella Santa Sede, ottiene il suo primo incarico, quello cioè di gestire una parrocchia a Manhattan (New York), dove vi è un’altissima prevalenza di portoricani con gravi difficoltà economiche sulle spalle. Il contatto con gli emarginati lo aiuta a riflettere sulle ingiustizie sociali e sui meccanismi che controllano i principi dell’esclusione e dell’alienazione. Nello stesso periodo entra in contatto con il filosofo Jacques Maritain. Nel 1956 diviene vice rettore dell’Università di Puerto Rico, ma nel 1960 decide di lasciare il paese a causa di gravi divergenze con la gerarchia ecclesiastica (Illich era per la Chiesa troppo attivo politicamente, inoltre era favorevole alla diffusione dei preservativi). L’anno seguente fonda a Cuernavaca, in Messico, il Centro interculturale di documentazione (Cidoc) che ha il compito di preparare i preti e i volontari alle missioni in America Latina. Illich, pur fondando le proprie basi culturali nel cristianesimo, si oppone duramente alle politiche colonialiste americane, che condannano ad un eterna povertà milioni di uomini e donne, alla guerra, alle banche e alle multinazionali; questo suo impegno lo fa divenire sospetto alla CIA, al governo americano e al Vaticano (subì anche alcuni misteriosi attentati ai quali riuscì sempre a sfuggire). Nel 1968 il Santo Uffizio gli intenta un procedimento, da cui esce prosciolto; Illich decide di abbandonare la veste sacerdotale, continuando la critica alle istituzioni ecclesiastiche e troncando ogni rapporto tra il Cidoc e la Chiesa. Nel 1999 il «New York Times» pubblica una sua lettera in cui egli annuncia pubblicamente di voler rinunciare a titoli, benefici e servizi ecclesiastici, anche se non chiede, e non chiederà mai, la riduzione allo stato laico. Inizia a questo punto una fase molto intensa in cui diffonde il proprio pensiero: tiene conferenze, scrive articoli e saggi. Nel 2002, il 2 dicembre, affetto da un tumore al volto da oramai quasi vent’anni, Illich muore improvvisamente, probabilmente per un arresto cardiaco. Tra le sue opere più importanti, ricordiamo le seguenti: Deschooling Society (1971; Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile?); Energy and Equity (1974; Elogio della bicicletta), Medical Nemesis (1976, Nemesi medica. L’espropriazione della salute), Toward a History of Needs (1978, Per una storia dei bisogni), Shadow Work (1981, Lavoro ombra), Gender (1982, Genere. Per una critica storica dell’uguaglianza), H2O and the Waters of Forgetfulness (1985, H2O e le acque dell’oblìo), ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (1988), In the Mirror of the Past (1992, Nello specchio del passato), In the Vineyard of the Text: A Commentary to Hugh’s Didascalicon (1993, Nella vigna del testo), The Rivers North of the Future – The Testament of Ivan Illich as told to David Cayley (2005, I fiumi a nord del futuro. Testamento raccolto da David Cayley).
Pensiero
Al fondamento del pensiero di Ivan Illich vi è la sua formazione teologica, che tuttavia non gli ha impedito di esercitare la propria coscienza critica all’interno della Chiesa di Roma (egli dichiarò il proprio distacco a partire dal 1969, ma senza chiedere la riduzione allo stato laicale). Illich ha svolto un’indagine radicale sugli effetti perversi dello sviluppo tecnologico moderno, concentrandosi in particolare sull’inefficienza del sistema scolastico, sulla ipermedicalizzazione e sulla crisi dei trasporti con conseguenti problemi ecologici e di salute. Illich sostiene che «quando un’attività umana esplicata mediante strumenti supera una certa soglia definita dalla sua scala specifica, dapprima si rivolge contro il proprio scopo, poi minaccia di distruggere l’intero corpo sociale. Occorre dunque determinare con chiarezza queste scale naturali e riconoscere le soglie che delimitano il campo della sopravvivenza umana». In sostanza, egli dice, che «la società, una volta raggiunto lo stadio avanzato della produzione di massa, produce la propria distruzione». Illich può essere considerato, insieme al suo amico Jacques Ellul, come uno dei principali ispiratori dei concetti di “post-sviluppo” (diffuso soprattutto da autori che hanno lavorato con Illich come Majid Rahnema o Gustavo Esteva), di “semplicità volontaria” e più recentemente di “decrescita sostenibile”. Egli propone come modello una “società conviviale” in cui né i privati né lo Stato possiedano alcun monopolio (istruzione, medicina, trasporti ecc.), consentendo ad ognuno di esercitare la propria creatività senza limitare la libertà altrui. In Nemesi medica, Illich intende la scienza medica come un’“impresa industriale” e come tale gestita e controllata da «produttori (medici, ospedali, laboratori farmaceutici) che incoraggiano la diffusione di procedimenti d’avanguardia costosi e complicati, e riducono così il malato e i suoi familiari allo stato di docili clienti». Il sistema medico incita quindi la popolazione «a lottare per ottenere una sempre maggiore quantità di cure, dispensate da professionisti in materia di igiene, prevenzione, anestesia o assistenza ai moribondi». Per Illich il male sta nella pretesa di voler gerarchizzare la medicina, impedendo l’autonomia degli individui e strutturandosi sul «monopolio di una gerarchia monolitica», la quale «si preoccupa di proteggere le sue frontiere incoraggiando la formazione di paraprofessionisti ai quali subappalta le cure che un tempo erano prestate dai familiari e amici del malato». Per l’anarchico austro-messicano la scienza medica ha creato un vero e proprio sistema feudale per difendere «il suo monopolio ortodosso dalla concorrenza sleale delle guarigioni ottenute con metodi eterodossi». In Nemesi medica, la critica è radicale riguardo all’esclusiva professionale che costringe la società alla dipendenza da una scienza monolitica ed eteronoma: la società capitalistica ha bisogno di medicalizzare la società, trasformando i sani in malati in nome del profitto. La medicalizzazione della malattia, continua Illich, fa delle «istituzioni di cura» una «grande maschera sanitaria» per «una società distruttrice» e che in questa maniera prende anche il controllo del potere individuale dei suoi cittadini/e, caratteristica questa della stessa società industriale. Gli specialisti ricollegano esclusivamente i nostri bisogni al centro del sistema economico, che è costituito dai servizi professionali e dai beni di consumo. In sostanza Illich pone la base della salute di ogni individuo nella sua autonomia personale, poiché egli è fortemente convinto che «in realtà, ogni giorno di più, il profano è in grado di curare il proprio prossimo e, in questo campo, solo una parte di ciò che occorre sapere è necessariamente materia d’insegnamento formale». In Descolarizzare la società Illich giunge alla conclusione non solo che l«’educazione universale mediante la scuola obbligatoria è impossibile», ma anche che nel sistema scolastico obbligatorio «si impara che tutto ciò che è prodotto da un’istituzione dominante vale e costa caro, anche quello che non si vede, come l’educazione o la salute. Si impara a valorizzare l’avanzamento gerarchico, la sottomissione e la passività, e persino la devianza-tipo che il maestro ama interpretare come sintomo di creatività». Lo Stato utilizza la scuola per condizionare le masse attraverso “l’educazione permanente” che, dal punto di vista morale, «è ancor meno accettabile della scuola di vecchio tipo», poiché è capace di «condizionamenti massicci ed efficaci, capaci di produrre in serie manodopera specializzata, consumatori di cultura docili e disciplinati, utenti rassegnati». Questi sistemi «celano una profonda distruttività», tendendo a demolire i valori più essenziali della società. Per Illich il sistema educativo ideale è quello che mette insieme il «sapere proveniente da relazioni creative tra l’uomo e il suo ambiente naturale» e il «sapere reificato dell’uomo agito dal suo ambiente attrezzato». La prima tipologia di sapere è il risultato delle relazioni che si sviluppano naturalmente tra le persone (es. l’apprendimento della lingua materna), la seconda «discende da un addestramento intenzionale e programmato» (es. l’apprendimento della matematica). In Genere, l’autore valorizza la differenza tra maschio e femmina, sostenendo che essa non deve essere alla base di una gerarchizzazione del rapporto, ma della pari dignità. L’erramento di quanti vogliono produrre l’uguaglianza negando la differenza (anziché la sua gerarchizzazione) è paragonata da Illich alla follia di quanti volessero rendere uguali la mano destra e la sinistra. In Convivialità, Illich difende le ragioni della comunità a tavola e del pasto conviviale come luogo di cultura e di civiltà.
Vai alla Parte 2

